il centro in periferia
di Marina Berardi, Domenico Copertino, Vita Santoro [*]
Premessa
Da qualche tempo si assiste, nel nostro Paese, alla produzione di discorsi e retoriche intorno alle cosiddette “aree interne”, un processo sollecitato da un lato, dall’attuazione di strategie di sviluppo nazionali e sovranazionali, e determinato, dall’altro, dall’interesse maturato da parte di differenti ambiti disciplinari e dalle progettualità sempre più diffuse, anche endogene, rivolte a territori fragili, marginali e soggetti a contrazione demografica. Tale processo è stato fortemente accelerato dall’attuale pandemia da COVID-19, tanto da esplodere in breve tempo, producendo miriadi di immaginari e narrazioni, quasi sempre poco rispondenti alle concrete e diseguali condizioni abitative e di vita delle comunità locali, come anche poco attenti alle dinamiche culturali e ai molteplici processi in corso, in primis quelli migratori. Si tratta di quegli stessi luoghi nei quali gli antropologi conducono talvolta le proprie ricerche e di quegli stessi processi che sono soliti osservare, documentare, descrivere, e sui quali producono essi stessi riflessioni e discorsi, contribuendo in tal modo e consapevolmente a consolidarne l’immaginazione e ad accrescere la pletora di etero ed auto rappresentazioni dei territori interni e marginali.
Allo scopo di dare un contributo alla discussione su un tema così complesso, mediante gli strumenti teorici e metodologici dell’antropologia, il panel intende sollecitare una riflessione che sia innanzitutto in grado di decostruire le retoriche mainstream riguardanti le aree interne (ad esempio l’estetica dei piccoli borghi, l’elogio della lentezza, gli abusati concetti di resilienza, decrescita felice e restanza, o, ancora, le pratiche del ritorno alla terra dei giovani e del south working). La proposta del panel mira, dunque, a raccogliere contributi e riflessioni critiche intorno a tali categorie diffuse nella produzione di discorsi che spaziano tra le discipline, generando nuovi sguardi e processi complessi. E intende farlo riflettendo su una possibile idea di futuro di queste aree, a partire dalle esperienze e dai contributi di antropologi che abbiano posto un focus sui luoghi ma soprattutto su chi li abita e li attraversa, in riferimento a questioni abitative, migratorie, produzione locale di saperi e saper fare, forme di neoruralità, processi di produzione e riproduzione dei patrimoni culturali e le pratiche associative ad essi collegate, stratificazioni di lunga durata (traducibili anche in dinamiche non omogenee di potere, nelle molteplici forme in cui può manifestarsi), azioni sui territori capaci di generare dinamiche culturali che passano anche attraverso, l’immaginazione individuale e collettiva dei luoghi.
Il panel è un invito riflessivo rivolto agli antropologi e alle antropologhe impegnati nei territori dei margini, nei quali emergono delle sovrapposizioni tra produzione locale del sapere e categorie formali e istituzionali, e in cui si esercitano forme di auto ed etero rappresentazione delle località[1].
In occasione dell’ultimo Convegno della SIAC, la Società Italiana di Antropologia Culturale, dal titolo Futuro. Antropologie del futuro, futuro dell’antropologia [2], abbiamo proposto un tema che riguarda le cosiddette aree interne, un tema che esercita già da qualche tempo un certo richiamo anche per le discipline demo-etnoantropologiche, come emerso peraltro con chiarezza durante i lavori del panel, oltre che di interesse per i tre convenors poiché intorno ad esso stanno producendo attualmente ricerche, analisi e riflessioni nell’ambito dei diversi progetti di ricerca nei quali sono impegnati[3].
Il panel n. 33 del Convegno SIAC si è svolto durante la mattinata del 24 settembre 2021 ed è stato suddiviso in due momenti, intervallati da una breve pausa. Nella prima parte del panel sono state presentate quattro relazioni: Letizia Bindi, a partire da una lunga esperienza di ricerca, ha proposto un intervento dal titolo Allevare futuro. Pastorizia, aree interne e rigenerazione territoriale; subito dopo, Daniele Ietri e Dorothy Zinn hanno discusso intorno agli esiti del progetto Studi sul Qui a Jovençan: il deep mapping per i territori dei margini; a seguire, Gianfranco Spitilli ha condiviso le sue riflessioni con Lo sguardo compartecipe. Un’antropologia del margine e della vulnerabilità; mentre Silvy Boccaletti ha illustrato la ricerca Pratiche e immaginari mobili nelle ‘montagne di mezzo’ italiane: riflessioni a partire dal caso di studio dell’Alpe di Blessagno (CO). Durante la seconda parte del panel ci sono stati altri tre interventi: Andrea Alberto Dutto e Gabriele Orlandi hanno proposto i risultati di una indagine congiunta su Retoriche dell’autenticità e trasmissione dei saperi costruttivi. Proposte per una nuova manualistica etnografica del patrimonio edilizio nelle Alpi piemontesi; Emanuele Di Paolo ha presentato delle considerazioni su Realtà e rappresentazione della società agropastorale dell’Appennino centrale; infine, Amina Bianca Cervellera ha condiviso le sue osservazioni relative a una ricerca sul tema Poetiche e politiche della vite. Il caso del Timorasso dei colli tortonesi.
Volendo provare a individuare possibili nessi tra le distinte declinazioni del tema comune che era stato proposto, emergono con chiarezza alcune parole chiave e taluni temi trasversali, a partire dai quali tenterò di tracciare una prima sintetica riflessione, che sarà approfondita in alcuni suoi aspetti specifici dagli altri convenors nei due paragrafi successivi dell’articolo, in particolare relativamente alle questioni di natura metodologica e alle produzioni discorsive.
Innanzitutto, nei contributi abbiamo ritrovato un esplicito fil rouge di considerazioni e interessanti riflessioni sulle questioni teoriche e concettuali di riferimento, spesso sovrapponibili, e che hanno fatto da guida alle molteplici attività di ricerca narrate; in alcuni contributi si è poi discusso di metodologie della ricerca (Bindi; Zinn-Ietri; Bocaletti); in altri, il focus è stato posto sul ruolo dell’antropologo (Bindi, Spitilli; Orlandi-Dutto) o comunque del ricercatore a vario titolo impegnato in terreni di indagine complessi, dinamici, glocali e stratificati (Di Paolo, Cervellera), quali possono essere o divenire quelli delle aree interne e marginali, e che richiedono di essere attentamente analizzati, osservati e agiti.
Come richiesto espressamente dalla call for paper e come sollecitato dal concept del panel, le tante esperienze di ricerca che, da una prospettiva multidisciplinare (nel nostro caso antropologica, geografica e architettonica) sono state descritte e poi approfondite durante l’appassionata e partecipata discussione finale, hanno posto l’accento su discorsi, immaginari, rappresentazioni e retoriche che si riferiscono alle aree interne. Da un lato sono state intese, per dirla con Michel Foucault (2004), come dispositivi di produzione di potere (Orlandi-Dutto; Bindi); dall’altro, sono state considerate come strumenti dei quali comunità locali, ma pure singoli individui, una volta incorporati, possono servirsi strategicamente nei processi di auto-rappresentazione (Cervellera; Zinn-Ietri) o in quelli di autodeterminazione (Di Paolo), soprattutto nel caso in cui si tratti di gruppi e collettività che provano ad affermare una visione eterodossa, differente o magari alternativa a quella ufficiale.
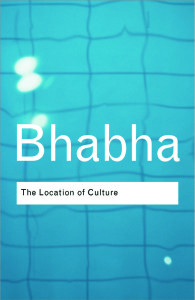 Nei contrasti polarizzati che governano la costruzione delle identità, le comunità locali hanno appreso da tempo ad adoperare le medesime categorie formali che altri hanno costruito e adottato per loro, hanno imparato a rappresentarsi rispetto alle collettività più ampie e strutturate di cui sono parte (Bhabha 2004), a immaginarsi e a re-immaginarsi ogni volta (Anderson 1983), a mettere talvolta in atto performance identitarie e a raccontarsi anche solo per “esserci” e non scomparire, per essere in altri termini considerati soggetti e non più solo oggetti delle pratiche più diffuse di rappresentazione.
Nei contrasti polarizzati che governano la costruzione delle identità, le comunità locali hanno appreso da tempo ad adoperare le medesime categorie formali che altri hanno costruito e adottato per loro, hanno imparato a rappresentarsi rispetto alle collettività più ampie e strutturate di cui sono parte (Bhabha 2004), a immaginarsi e a re-immaginarsi ogni volta (Anderson 1983), a mettere talvolta in atto performance identitarie e a raccontarsi anche solo per “esserci” e non scomparire, per essere in altri termini considerati soggetti e non più solo oggetti delle pratiche più diffuse di rappresentazione.
Si tratta di un processo inevitabile, e direi fisiologico, di fronte alle incertezze a cui ci costringe la contemporaneità e alle problematiche concrete che spingono molte piccole comunità e gruppi ad acquisire consapevolezza delle proprie condizioni e, mettendo in campo inaspettate capacità creative, a confrontarsi con le dinamiche e i processi globali (Clemente 2017), i quali tendono a impattare particolarmente nelle aree marginali, periferiche, in declino o in quelle di confine (Daas, Pool 2004), con ripercussioni in primis tra le fragilità umane e sociali che le abitano o che magari invece le attraversano solo per un periodo limitato di tempo (Balbo 2015).
Ulteriore tema emerso più volte durante i lavori del panel e sul quale mi soffermerò concisamente, è stato quello relativo alla patrimonializzazione di elementi e pratiche culturali. Si tratta di processi articolati che sono soliti costruirsi e moltiplicarsi anche nelle aree interne, anzi forse è proprio nei piccoli paesi soggetti a contrazione demografica e ad abbandono che sono in grado di assumere le forme più interessanti da indagare per noi antropologi; poiché, com’è noto, il patrimonio culturale costituisce uno degli ambiti privilegiati nei quali comunità, gruppi e individui (con riferimento alla declinazione dei portatori di interesse presente nella Convenzione Unesco del 2003) potrebbero essere in grado di divenire protagonisti delle politiche locali, finanche compiendo scelte autonome su di esso, se correttamente supportati (Convenzione di Faro, 2005).
I contributi presentati nel panel hanno fatto riferimento ai patrimoni culturali o ai molteplici processi a esso connessi, attribuendo al patrimonio una valenza e un peso differenti nelle distinte esperienze etnografiche descritte. Il patrimonio è stato ad esempio inteso in termini di dinamiche di riconoscimento e legittimazione principalmente istituzionale, ma non solo, finalizzata allo sviluppo di azioni di salvaguardia e valorizzazione e di processi partecipativi di coinvolgimento delle comunità, come nel caso della transumanza “patrimonializzata” (Bindi). Ma si è parlato anche di processi di auto-riconoscimento patrimoniale e turistico, si veda in tal senso il caso del pastoralismo abruzzese (Di Paolo), dove i giovani pastori manipolano consapevolmente i simboli identitari della tradizione pur in un contesto lavorativo e di pratiche pastorali del tutto mutato e globalizzato.
In questo caso la costruzione simbolica delle identità locali non si oppone alla globalizzazione, ma cerca di sfruttarne gli strumenti. Sono state poi anche descritte esperienze di usi del patrimonio culturale funzionali alla promozione di una certa modalità di sviluppo dei territori a fini per lo più turistici e che fanno leva sulla ormai stantia retorica della “autenticità” di luoghi, prodotti e saper fare (Cervellera), oppure che talvolta scelgono di inventare o reinventare ex novo le tradizioni locali, come pure di ibridare creativamente le pratiche locali con quelle di altri luoghi (Bocaletti) per attrarre in aree remote un maggiore flusso di turisti.
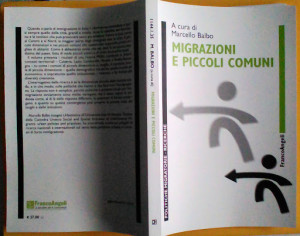 Talvolta, tuttavia, alcune forme di recupero delle tradizioni locali rischiano di innescare le stesse dinamiche di omologazione e standardizzazione delle identità locali che vorrebbero contrastare, con l’aggravante della costante eliminazione delle conflittualità, che pure sono presenti; e lo fanno mediante il meccanismo tortuoso di costruzione retorica e nostalgica di fittizie comunità “pacificate” o attraverso l’uso e la prassi dell’ambiguo e ambivalente paradigma della partecipazione. D’altro canto, siamo oramai ben consapevoli che gli stessi processi di costruzione del patrimonio culturale si pongono quale complesso discorso istituzionale, supportato da una sempre più articolata cornice normativa e giuridica di riferimento (di volta in volta regionale, nazionale o transnazionale), e pure come luogo privilegiato di governo del territorio e dei suoi abitanti e, in taluni casi, di palese controllo sociale delle comunità. Ad esempio, anche le progettualità che vorrebbero recuperare il saper fare locale spesso finiscono per contribuire alla produzione di un discorso e di forme di potere, evidenziando la predominanza degli oggetti e dei manufatti sui soggetti, e quindi sulle persone e il loro saper fare, come nel caso della manualistica prodotta per il recupero edilizio delle aree montane (Dutto-Orlandi). Quando, invece, e lo sappiamo molto bene, al centro delle iniziative e dei progetti dovrebbero esserci, oltre ai luoghi e ai manufatti, anzitutto i soggetti, e cioè le persone, plurali, mutevoli e relazionali, con il loro bagaglio di storie, memorie ed esperienze (Clemente 2020).
Talvolta, tuttavia, alcune forme di recupero delle tradizioni locali rischiano di innescare le stesse dinamiche di omologazione e standardizzazione delle identità locali che vorrebbero contrastare, con l’aggravante della costante eliminazione delle conflittualità, che pure sono presenti; e lo fanno mediante il meccanismo tortuoso di costruzione retorica e nostalgica di fittizie comunità “pacificate” o attraverso l’uso e la prassi dell’ambiguo e ambivalente paradigma della partecipazione. D’altro canto, siamo oramai ben consapevoli che gli stessi processi di costruzione del patrimonio culturale si pongono quale complesso discorso istituzionale, supportato da una sempre più articolata cornice normativa e giuridica di riferimento (di volta in volta regionale, nazionale o transnazionale), e pure come luogo privilegiato di governo del territorio e dei suoi abitanti e, in taluni casi, di palese controllo sociale delle comunità. Ad esempio, anche le progettualità che vorrebbero recuperare il saper fare locale spesso finiscono per contribuire alla produzione di un discorso e di forme di potere, evidenziando la predominanza degli oggetti e dei manufatti sui soggetti, e quindi sulle persone e il loro saper fare, come nel caso della manualistica prodotta per il recupero edilizio delle aree montane (Dutto-Orlandi). Quando, invece, e lo sappiamo molto bene, al centro delle iniziative e dei progetti dovrebbero esserci, oltre ai luoghi e ai manufatti, anzitutto i soggetti, e cioè le persone, plurali, mutevoli e relazionali, con il loro bagaglio di storie, memorie ed esperienze (Clemente 2020).
Se intendiamo le aree interne non più e non unicamente come marginali e vulnerabili, ma le guardiamo come nuove “centralità”, luoghi della complessità, della creatività e di inedite opportunità, è indubitabile che ogni tentativo di approccio al tema non possa non considerare ineludibile una adeguata conoscenza dei luoghi, della loro storia e dei cambiamenti in corso; in aggiunta alla evidenza che soltanto una ricerca etnografica di lungo periodo, con l’applicazione di metodologie in grado di coniugare esigenze progettuali con quelle conoscitive, sia in grado di restituire la densità delle aree interne.
Pertanto, allo scopo di sovvertire quello sguardo diffuso, dicotomico e stereotipato, che le definisce, e che rievoca quasi lo sguardo “orientalista interno” che Francesco Faeta (2005) aveva rilevato esserci rispetto alle rappresentazioni del Meridione d’Italia (inteso a lungo come luogo dell’arcaismo, della diversità e fuori dal tempo in contrapposizione all’immagine moderna del resto del Paese); e per provare a superare le categorie formali e istituzionali mediante le quali tali aree sono state finora raccontate, immaginate e identificate, si dovrebbe compiere uno sforzo e un impegno collettivi, che finora paiono essere mancati e che siano innanzitutto conoscitivi e di osservazione, e si dovrebbe partecipare alle vicende che le riguardano, smettendo forse di rappresentarle unicamente.
I relatori che hanno partecipato al panel sono stati in effetti concordi nel ritenere necessario un impegno che vada ben oltre i pur qualche volta apprezzabili, ma non sufficienti, progetti di cosiddetto “sviluppo” o di “rigenerazione territoriale” rivolti ai luoghi e alle comunità marginalizzate delle aree interne, mettendo in campo: una antropologia applicata intesa sempre come impegno pubblico (Dutto-Orlandi); non dimenticando mai di effettuare in primo luogo una etnografia delle istituzioni delle aree oggetto di studio (Bindi, Di Paolo); condividendo pur a fatica le sorti dei luoghi in cui si è scelto di vivere (Spitilli); adottando, infine, un posizionamento antropologico che sia al contempo emico ed etico, che sia realmente engaged e sia attuato mediante la pratica di una ricerca intensiva e thick (Zinn-Ietri), e, ove possibile, anche di carattere multidisciplinare (Bocaletti; Cervellera); infine, affrontando la decostruzione e riconcettualizzazione critica e politicamente impegnata delle nozioni abusate, come anche dei discorsi, delle narrazioni e delle rappresentazioni in uso.
Come sappiamo da tempo, in tal senso l’antropologo contribuisce consapevolmente egli stesso alla produzione discorsiva durante le sue ricerche etnografiche, in questo caso relativamente alle aree interne. Tuttavia, mentre si osservano i complessi processi in atto e al contempo si vuole partecipare ad essi, si dovrebbe provare sempre a mettere in atto una postura che sia anzitutto “critica”, analoga in un certo senso a quella che Berardino Palumbo (2009) aveva indicato in relazione all’ambito del patrimonio culturale.
Ed è attorno a tutti questi elementi di riflessione, solo accennati e in parte emersi con forza durante le discussioni del panel, che potrebbe forse giocarsi un tentativo di ridefinizione critica di quelle aree cosiddette interne del nostro Paese e del modo stereotipato di rappresentarle. Anche perché, pur marginali, isolate, depresse, minori e carenti dei servizi essenziali, esse sono molto più connesse al mondo globale di quanto si pensi e si possa immaginare, come ci ricorda spesso Pietro Clemente. E potrebbero aiutarci a contenere più agevolmente la contemporaneità da prospettive laterali e divergenti rispetto a quelle consuete, perché – come sappiamo bene – soltanto nei margini, sui confini e negli interstizi, riescono a coesistere intrecciate storie individuali e storie collettive, tradizione e innovazione, memorie del passato e nuove forme di creatività culturale, che possono divenire straordinari sguardi rivolti al futuro.
Elicitazioni performative
Riflettere criticamente intorno alla categoria culturale di area interna consente di diversificare e stratificare le diverse forme di rappresentazione sociale e culturale in cui prende forma la narrazione di sé e la narrazione collettiva, diventa altresì lo spazio interstiziale entro cui muoverci per decostruire le visioni monolitiche dei luoghi e riconsiderare la creatività culturale che è insita nei processi attraverso l’uso pubblico, collettivo e individuale delle stesse categorie culturali. Un corollario complesso di temi che tra l’altro ho avuto modo di considerare nell’ambito della mia ricerca di dottorato riguardante la percezione locale e le auto e etero rappresentazioni di fenomeni legati al declino demografico in alcuni piccoli paesi del Materano, in Basilicata.
Un aspetto, su cui vorrei soffermarmi, che emerge in alcuni degli interventi presentati al panel, riguarda le pratiche di elicitazione attraverso cui è possibile elaborare forme di autorappresentazione culturale ispirate anche alla community art (Marano 2013) e in particolar modo la map elicitation, la filmic geography, il deep mapping. Lorenza Pignatti in Mind the Map. Mappe, diagrammi e dispositivi cartografici (2011) scrive che «la cartografia è divenuta una sorta di “fenomenologia dello spirito”, secondo Karl Sclögel, dove le carte non sono solo ausili per gli storici, ma figurazioni e proiezioni del mondo che permettono di indagare e suggerire istanze critiche, ideologiche, esistenziali» (Pignatti 2011: 5). Quindi, se le mappe divengono figurazioni e proiezioni del mondo offrono anche la possibilità di orientarsi nella poetica dei luoghi, restituendone il senso, che a livello locale, vi si attribuisce attraverso storie, nomi, toponomastica formale e informale, soprannomi, dinamiche, processi anche conflittuali, visioni. L’uso delle mappe, pur essendo consolidato nell’ambito della ricerca antropologica e sociale è parte di una discorsività complessa che richiede molteplici livelli di lettura in cui è necessario articolare un discorso ampio che abbraccia la questione epistemologica e lo statuto degli strumenti di ricerca, delle pratiche e della performatività.
Un esempio – in ambito etnografico che ci viene offerto durante il panel – di questa stratificazione e profondità di lettura è dato dal deep mapping che mette in relazione letture locali del territorio e performance. Ne hanno discusso l’antropologa Dorothy Zinn e il geografo Daniele Ietri in un intervento dal titolo Studi sul Qui a Jovençan. Il deep mapping per i territori dei margini. Il deep mapping diventa «aspirazione e pratica» (Zinn 2020: 52), inserito nel frame teorico della tensione dialettica tra: emico e etico; insider a outsider; antropologia e arte performativa; Thick description e la Thin Ethnography; Deep e Flat.
Muovendosi lungo queste coordinate il deep mapping diviene strumento e discorso non per tradurre, scrive Dorothy Zinn che
«il lavoro di deep mapping [...] non vuole privilegiare una prospettiva interpretativa, e mette sullo stesso piano tante voci, elementi e modalità, senza la pretesa di arrivare a conclusioni perentorie, autorevoli e monologiche. Si tratta soprattutto a mio avviso, di un lavoro di evocazione, di suggestione (Bailey, Biggs 2012), che viene di gran lunga priorizzato rispetto a uno scopo analitico e una modalità analitica» (Zinn 2020: 54).
La mappa, che non è un universale, ma è un oggetto che incorpora rappresentazioni e proiezioni costruite culturalmente e che subisce profonde trasformazioni, attraverso l’elicitazione si àncora alla dimensione performativa recuperando anche il senso originario della parola mappa. Come rammenta Matvejević in Breviario Mediterraneo (2006)
«il termine mappa significava da principio un semplice pezzo di tela, che si agitava negli spettacoli dei circhi – viene forse dalla lingua punica, ma non se ne conosce l’esatta etimologia» (Matvejević 2006: 179).
Quando lavoriamo con le mappe non possiamo considerarle strumenti neutri e non possiamo dare per scontato di saperci orientare in esse. Google Maps ha per esempio indotto e introdotto un numero inimmaginabile di utenti che hanno incorporato il linguaggio che orienta nello spazio cartografico. La rappresentazione dello spazio è una rappresentazione linguistica a cui siamo stati alfabetizzati e quindi è determinata culturalmente. Per chi possiede uno smartphone è diventato abbastanza comune accedere alle mappe per trovare una strada, dirigersi in un luogo, trovare per parole chiave negozi, servizi, luoghi di interesse, condividere la propria posizione, lasciare indicatori a futura memoria, siamo in grado di spostarci in uno spazio bidimensionale e di proiettarci e muoverci in quello spazio.
Le sollecitazioni emerse in occasione del panel – che qui discuto in maniera molto liofilizzata – ci spingono a considerare che quando chiediamo alle comunità di costruire, guardare, immaginare attraverso l’ausilio di alcuni strumenti di elicitazione come possono essere le mappe di comunità, il deep mapping, la filmic geography – di cui ci ha parlato Silvy Boccaletti nel suo intervento Pratiche e immaginari mobili nelle “montagne di mezzo” italiane: riflessioni a partire dal caso di studio dell’Alpe di Blessagno (CO) – per connettere tempi, memorie e processi dobbiamo considerare che non stiamo guardando a dispositivi con dei significati fissi, ma al contrario stiamo attingendo a dei significati fluidi, polisemici e portatori di significati complessi. Tutto ciò ci aiuta a decostruire le categorie come quella di area interna, che era la domanda centrale da cui partiva il panel, e allo stesso tempo ci aiutano a decostruire le retoriche dell’emergenzialità che trovano nelle dinamiche di abbandoni e declino nuovi paradigmi semantici e estetici. Si avverte la necessità di recuperare e leggere la vulnerabilità e i processi creativi per stratificare lo sguardo nelle pratiche di vita quotidiana e nelle pratiche etnografiche.
 Pratiche etnografiche e produzioni discorsive
Pratiche etnografiche e produzioni discorsive
Una delle linee tematiche che, seguendo l’invito dei convenor, è stata seguita dai relatori, riguarda la produzione di un discorso sulle aree interne che, a partire dall’interazione tra ricerca accademica (e indipendente), mass-media, società civile, istituzioni e attori locali, veicola un diffuso modo di intendere e definire le aree interne e autorizza l’adozione di determinate politiche volte a governarle. In questa produzione discorsiva, gli antropologi giocano un ruolo centrale, che alcuni dei relatori hanno indagato in chiave riflessiva e che è stato discusso nelle relazioni.
Nell’intervento congiunto di Zinn e Ietri, il ruolo autorizzante delle rappresentazioni delle inner peripheries elaborate dall’etnografia, dal deep mapping e dal punto di vista interno degli attori di Jovençan è stato discusso in relazione all’idea di elaborare un progetto di rigenerazione futura a partire dalla costituzione di un archivio del presente. Se da una parte i deep mappers riportano il focus metodologico sulla “piccola” località (tradizionale luogo della ricerca etnografica) e vi conducono un’osservazione che dà luogo a thin descriptions, dall’altra gli antropologi, attraverso un approccio multisituato, mettono in relazione la località con contesti più ampi e flussi discorsivi globali, rendendo possibile l’approccio comparativo, la riflessività, lo studio delle interpretazioni locali dei messaggi globali (accademici, istituzionali, mediatici) e il passaggio alla thick description.
Cervellera individua nelle retoriche dell’autenticità legate alla produzione del Timorasso, nell’area di Tortona, un discorso autorizzante che, a partire dalla valorizzazione dei prodotti locali e attraverso una contesa di diversi attori (tra i quali anche centri di ricerca e Università) per accrescere il proprio capitale simbolico-culturale, porta alla mercificazione della ruralità e a processi di territorializzazione e de-territorializzazione.
Dutto e Orlandi indagano la manualistica dell’abitare le aree interne allo scopo di ricercarvi la produzione di un discorso autorizzante che passa attraverso i processi socio-tecnici delle pratiche edilizie e le genealogie delle conoscenze tecniche, ingegneristiche (ma anche non specialistiche) relative alle architetture locali. La ricerca antropologico-architettonica (se, seguendo ad es. Buchli 2013, si può parlare di un’antropologia dell’architettura) mette in luce il ruolo del manuale come dispositivo di potere, che entra in relazione con le conoscenze informali e media la relazione tra oggetti (edifici, materiali) e soggetti che producono, progettano, costruiscono e abitano l’ambiente edificato. Un passaggio chiave in questa indagine è legato alle modalità attraverso le quali il ruolo pubblico dell’antropologia contribuisce a inventare e governare le dinamiche interrelate che legano l’edilizia al paesaggio.
Il potere discorsivo delle autorappresentazioni elaborate dai pastori abruzzesi è stato analizzato da Di Paolo in relazione alla manipolazione di tali rappresentazioni, elaborate da attori sociali che, in ragione della lunga frequentazione di ricercatori, giornalisti, figure istituzionali interessate alla produzione e alla cultura agropastorale, sono diventati capaci di parlare di sé, di oggettivare alcuni elementi che ritengono centrali nella propria cultura (come il dono, la relazione uomo/animale, la toponomastica) e di attivare forme di agency collettiva e rivendicazioni.
L’intera relazione di Spitilli è relativa alle implicazioni della ricerca etnografica in un’area interna degli Appennini e al ruolo di un antropologo, che è insieme attore sociale e attivista politico, nell’elaborare un discorso su quest’area a partire dalla conoscenza condivisa (e dalle possibili soluzioni) intorno a questioni quali spopolamento e smarrimento del futuro.
L’interrelazione tra attori locali, società civile, centri di ricerca e istituzioni quali FAO, SNAI e UNESCO dà luogo a una produzione discorsiva relativa all’area interna dell’Appennino centromeridionale che Bindi analizza concentrandosi su alcuni progetti di salvaguardia (per es. come Riabitare il tratturo), sulla mediatizzazione del fenomeno e sulle pratiche museali finalizzate a diffondere la conoscenza della cultura agropastorale di diverse aree italiane (come ad esempio l’Ecomuseo della pastorizia di Pontebernardo). Questa produzione discorsiva autorizza politiche di gestione e promozione delle aree interne che pongono al centro modelli di nuova ruralità legati al patrimonio bio-culturale.
Nella produzione discorsiva sulle aree interne vanno indagati in chiave antropologica anche alcuni concetti (come political mobility, metro-montagna, montagna di mezzo, indagati da Boccaletti) apparentemente finalizzati a ridurre la complessità di questi contesti; la ricerca etnografica può contribuire a superare un approccio assimilativo teso a evidenziare gli aspetti “globali” delle aree interne, promuovendo piuttosto una prospettiva conoscitiva finalizzata a comprendere le specificità di queste aree, la dimensione della differenza e della trasformazione culturale nel tempo, le questioni del significato e delle nuove forme di soggettività legate a forme di cosmopolitismo alimentare e di turismo culturale.
Dialoghi Mediterranei, n. 52, novembre 2021
[*] L’articolo è stato pensato nella sua struttura complessiva dai tre autori. Tuttavia, eccetto la premessa e la bibliografia che sono frutto di lavoro congiunto, nello specifico il primo paragrafo è attribuibile a Vita Santoro, il secondo a Marina Berardi e il terzo e ultimo paragrafo a Domenico Copertino.
Note
[1] Il testo in Premessa è il contenuto dell’abstract proposto a SIAC per il Convegno Nazionale del 2021. La proposta, selezionata e approvata da SIAC, ha consentito la organizzazione del Panel n. 33 e, mediante la call for paper, ha sollecitato l’interesse di quanti hanno inviato i propri contributi che sono stati presentati e poi discussi durante la seconda giornata di lavori del convegno.
[2] Si veda http://www.siacantropologia,it
[3] In particolare, i tre convenors sono insieme coinvolti, a vario titolo e in aggiunta a un più ampio gruppo di antropologi e a colleghi afferenti ad altre discipline, nel progetto di ricerca RI.P.R.O.VA.RE Riabitare i paesi. Strategie operative per la valorizzazione e la resilienza delle aree interne, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare su Bando, a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, e sviluppato dall’Università della Basilicata con le Università di Salerno e Napoli Vanvitelli.
Riferimenti bibliografici
Anderson Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londra, Verso, 1983.
Angioni Giulio, Assandira, Sellerio, Palermo, 2004.
Balbo Marcello (a cura di), Migrazioni e piccoli comuni, Franco Angeli, Milano, 2015.
Bhabha Homi K., Dissemination: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation, in The Location of Culture, Routledge, 2004 (1994): 139-170.
Buchli Victor, An anthropology of architecture, London, Bloomsbury, 2013.
Clemente Pietro, Communitas, in «Antropologia Museale», anno 2015-2016, n. 37-39, 2017: 11-15.
Clemente Pietro, Persone, in Cersosimo Domenico, Donzelli Carmine (a cura di), Manifesto per Riabitare l’Italia, Donzelli, Roma, 2020: 183-188.
Clemente Pietro, Paese/Paesi, in Mario Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, Bari-Roma, Laterza, 1997: 3-39.
Daas Veena, Pool Deborah (eds.), Anthropology in the Margins of the State, Santa Fe: School of American Research Press, 2004.
Faeta Francesco, Questioni italiane. Demologia, antropologia, critica culturale, Torino, Boringhieri, 2005.
Foucault Michel, L’ordine del discorso e altri interventi, Torino, Einaudi, 2004 (ed. or. 1971).
Ietri Daniele, Mastropietro Eleonora (a cura di), Studi sul qui. Deep mapping e narrazioni dei territori. Stagione 1, Mimesis, Milano, 2020.
Marano, Francesco, L’etnografo come artista. Intrecci fra antropologia e arte, Roma, CISU, 2013.
Matvejević Predrag, Breviario mediterraneo. I traffici dei mercanti, le migrazioni delle anguille, fughe di popoli e nascita di idee, leggende, architettura, storia, paesaggi, Milano, Garzanti, 2017 (ed. or. 1987).
Palumbo Berardino, Patrimonializzare, in «Antropologia Museale», n. 22, anno 8, 2009: XXXVIII – XL.
Pignatti Lorenza (a cura di), Mind the Map. Mappe, diagrammi e dispositivi cartografici, Milano, Postmedia, 2011.
Teti Vito, Quel che resta. L’Italia dei paesi tra abbandoni e ritorni, Donzelli, Roma, 2017.
Zinn Dorothy Louise, Studi sul Qui a Jovençan: Deep Mapping o Thin Ethnography? in Ietri D., Mastropietro E. (a cura di), Studi sul qui. Deep mapping e narrazioni dei territori. Stagione 1, Mimesis, Milano, 2020: 50-65.
_____________________________________________________________
Marina Berardi, fotografa e dottoranda presso l’Università degli studi della Basilicata con un progetto di ricerca antropologica su politiche, retoriche e processi di abbandono in alcuni piccoli paesi della Basilicata. Ha conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione in Beni DEA dopo la laurea in Discipline etnoantropologiche all’Università degli studi di Roma La Sapienza. Nel 2016 ha partecipato alla Missione Archeologica Italo-Irachena dell’Università di Roma “La Sapienza” ad Abu Tbeirah (Iraq) come antropologa culturale e fotografa. Lavora come antropologa visuale su patrimonio immateriale e materiale, spopolamento e cultura materiale. Alcune opere fotografiche hanno ricevuto menzioni e premi in ambito nazionale e internazionale. Nel 2019 è tra le vincitrici del concorso fotografico MAVI (Museo Antropologico Visivo Irpino). Dal 2019 è Photo Essay Editor di Visual Ethnography. Nel 2020 è stata co-curatrice del volume Michele Mulieri. Una stanchezza da meditare edito da CISU.
Domenico Copertino, dottore di ricerca in Antropologia culturale, è ricercatore presso l’Università degli Studi della Basilicata, dove insegna Antropologia delle religioni, Antropologia del Medio Oriente e Antropologia culturale. Ha condotto ricerche etnografiche in Siria e in Tunisia, studiando in particolare il patrimonio storicoculturale in Medio Oriente, la diffusione dell’associazionismo islamico dopo le rivoluzioni del 2011, le politiche islamiche contemporanee, le migrazioni internazionali dei musulmani. È socio ordinario di SIAC e membro del comitato editoriale di Archivio di Etnografia e della redazione di Antropologia. Oltre a numerosi articoli comparsi in riviste di antropologia e volumi collettanei, ha pubblicato Cantieri dell’immaginazione. Vita sociale e forme dello spazio in Medio Oriente (2010) e Antropologia politica dell’Islam. Da‘wa e jihad in Tunisia e nel Medio Oriente contemporaneo (2017).
Vita Santoro, PhD, è antropologa culturale. Presso l’Università degli studi della Basilicata è docente a contratto di Antropologia culturale, assegnista di ricerca per il Progetto PRIN Migrations, blurring boundaries, and home-making: Anthropological analysis of the rituals/migrations nexus in Southern Italy ed è membro del team della Cattedra Unesco in Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of Knowledge. È anche docente a contratto di Antropologia del patrimonio presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Dal 2018 al 2020 è stata assegnista di ricerca nell’ambito del Progetto I- DEA per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e precedentemente ha svolto attività di ricerca in Basilicata, Abruzzo, Brasile e Catalogna. I suoi temi di ricerca riguardano: antropologia museale e dei patrimoni culturali, antropologia urbana e del paesaggio, antropologia della scrittura, antropologia delle migrazioni. È socia ordinaria di SIAC, membro del Direttivo di SIMBDEA e coordina dal 2013 la redazione della rivista Archivio di Etnografia.
______________________________________________________________











