Il ruolo delle riviste nella nostra società può essere definito a diversi livelli. In questa riflessione scegliamo di privilegiare quello politico. In questa prospettiva è indispensabile partire dal tema dell’opinione pubblica, per chiederci come influiscano su di essa gli odierni mezzi di comunicazione e quale possa essere, in questo contesto comunicativo, la funzione delle riviste.
La nascita dell’opinione pubblica
Nella modernità lo Stato non coincide più, come nell’antica Grecia, con la comunità strutturata delle persone che ne fanno parte ed è diventato una entità a sé stante.
Ciò che per i Greci era la polis, nel mondo moderno si è, in un certo senso, scisso da un lato in un apparato burocratico impersonale – il “palazzo” – che sovrasta e controlla dall’alto i cittadini (perciò si chiama “sovrano”, “che sta sopra”), dall’altro nel complesso intreccio delle relazioni umane che costituiscono la società. Questo implica una separazione della politica dalla vita sociale. Quando Aristotele diceva che l’uomo è zoon politikon non intendeva altro che il membro della comunità civile. Se noi ci troviamo in difficoltà nel tradurre quella espressione – “animale politico” oppure “animale sociale” – è perché nella nostra esperienza ormai le due cose non coincidono più. La politica, ricondotta allo Stato, non costituisce più l’orizzonte onnicomprensivo dei rapporti quotidianamente intessuti dai singoli e che coinvolgono tutti, ma è diventata un settore specifico di attività, in cui si “entra” come in qualsiasi altra professione.
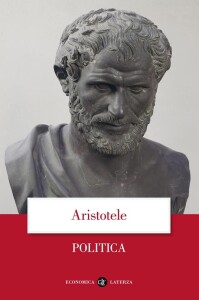 A sua volta, quell’insieme di relazioni e di attività che chiamiamo “società”, essendo ormai spogliata della dimensione politica che la orientava direttamente al bene comune della polis, ha piuttosto a che fare con la soddisfazione dei bisogni individuali, che i Greci identificavano con il privato e che delegavano agli schiavi e alle donne.
A sua volta, quell’insieme di relazioni e di attività che chiamiamo “società”, essendo ormai spogliata della dimensione politica che la orientava direttamente al bene comune della polis, ha piuttosto a che fare con la soddisfazione dei bisogni individuali, che i Greci identificavano con il privato e che delegavano agli schiavi e alle donne.
È significativo, a questo proposito, il ruolo decisivo assunto da quella che Aristotele chiama oikonomia, “legge della casa” (da oikos e nomos), che per noi è diventata il tessuto connettivo di un nuovo tipo di “pubblico”, non più politico ma sociale. In esso, la realizzazione di sé viene cercata nel lavoro e nel matrimonio, cioè in ambiti che, per Aristotele, riguardano solo “la vita” nel suo senso biologico (in altri termini, la mera sopravvivenza), e non “la vita buona”, pienamente umana, che solo la politica secondo lui può realizzare.
Un effetto di questa scissione del pubblico in una sfera statale e in una sociale è l’eclisse del concetto originario di politica, che era caratterizzato dal riferimento al fine condiviso del bene comune. Per quanto riguarda lo Stato moderno, al suo posto tende a imporsi la logica machiavellica del potere, indipendentemente dai fini, che culmina nel trionfo della “ragion di Stato”; per quanto riguarda la società, prevale il perseguimento degli interessi privati o corporativi da parte di singoli e di gruppi.
È alla luce di questo processo che si capisce l’emergere nell’età moderna dell’opinione pubblica come «la mediatrice tra lo Stato e le esigenze della società»[1]. Si può dare opinione pubblica, infatti, solo là dove Stato e società non coincidono più. Al tempo stesso, la sua nascita si rende necessaria per collegare le due sfere. In essa, infatti, viene alla luce ed è valorizzata la valenza politica di ciò che non è statale. Attraverso di essa i membri della comunità civile, pur non gestendo ormai direttamente il governo, come nell’antica polis, hanno però un ruolo nel controllarne l’operato e nell’influire sul suo orientamento
Può rivivere così nell’opinione pubblica l’originario spirito della politica come ambito del logos, in cui «tutto si decideva con le parole e la persuasione e non con la forza e la violenza» e come esperienza «di un modo di vita nel quale solo il discorso aveva senso e nel quale l’attività principale dei cittadini era di parlare tra loro» [2]. A fronte della logica dello Stato sovrano moderno, caratterizzata dall’esercizio del potere e dal suo avere «il monopolio della violenza»[3], la società rivendica un ruolo attivo fondato sulla capacità dei suoi membri di confrontarsi e discutere, al di là dei loro fini particolari, al bene comune, in una prospettiva che non è solo quella della gestione degli strumenti in vista di questo o quell’obiettivo, ma della ragionevolezza degli stessi obiettivi, oltre che di mezzi impiegati per raggiungerli.
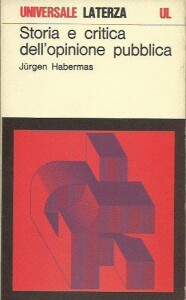 È alla fine del XVII e all’inizio del XVIII secolo che tutto ciò accade. Si diffonde in diversi Paesi d’Europa l’abitudine di incontrarsi in luoghi di riunione – i caffè in Inghilterra, i salotti in Francia, le società conviviali in Germania – «dove la letteratura e l’arte della conversazione erano tenute in forte considerazione» e che «rappresentavano – particolarmente i salotti francesi – luoghi dove l’autorità dell’argomento soppiantava l’autorità del titolo». E non si tratta di scambi puramente privati, perché «questa discussione è “pubblica” nel senso che essa aspira a determinare il bene pubblico» [4].
È alla fine del XVII e all’inizio del XVIII secolo che tutto ciò accade. Si diffonde in diversi Paesi d’Europa l’abitudine di incontrarsi in luoghi di riunione – i caffè in Inghilterra, i salotti in Francia, le società conviviali in Germania – «dove la letteratura e l’arte della conversazione erano tenute in forte considerazione» e che «rappresentavano – particolarmente i salotti francesi – luoghi dove l’autorità dell’argomento soppiantava l’autorità del titolo». E non si tratta di scambi puramente privati, perché «questa discussione è “pubblica” nel senso che essa aspira a determinare il bene pubblico» [4].
Si aprono così degli spazi – e non solo materiali – e per il confronto razionale, il dibattito, l’argomentazione: tutto ciò, appunto, che aveva spinto Aristotele a definire l’uomo al tempo stesso come animale politico e come animale dotato di logos – di parola e di pensiero –, stabilendo un’implicita equivalenza tra queste due espressioni. Fu così che «l’opinione pubblica emerse come una nuova forma di autorità politica, con la quale la borghesia poteva sfidare il governo assoluto» [5].
Tutto ciò ha un particolare rilievo per quella forma di governo che è la democrazia. Essa, fin dalla sua formulazione fondativa, dovuta a Rousseau, è caratterizzata dalla tensione fra l’esigenza di tener conto della maggioranza numerica e la convinzione che la “volontà generale” non può identificarsi soltanto con una somma delle aspirazioni individuali, più o meno arbitrarie, perché è veramente tale solo se ha una sua intrinseca razionalità. Questo comporta un vincolo insuperabile: mentre il monarca assoluto può infischiarsene dell’opinione pubblica e delle sue istanze, maturate nel confronto razionale, il governante democratico non può prescinderne e deve rispondere alla società delle proprie scelte.
 Il ruolo dei giornali nella formazione e nella espressione dell’opinione pubblica
Il ruolo dei giornali nella formazione e nella espressione dell’opinione pubblica
Un ruolo fondamentale, in questo rapporto tra Stato e opinione pubblica, hanno avuto storicamente i giornali e l’attività che, da essi, ha preso il nome di “giornalismo”. Esso contribuisce in modo significativo all’esistenza dell’opinione pubblica, dandole innanzi tutto ciò di cui essa ha assoluto bisogno per esercitare la sua funzione politica, vale a dire una corretta informazione. Solo così i membri della società possono esercitare un controllo effettivo sull’attività degli organi dello Stato.
Ma la funzione del giornalismo non si riduce a quella di “informare”. Esso contribuisce anche a “formare” l’opinione pubblica, attraverso la ricchezza e la varietà dei diversi punti di vista e delle esigenze che maturano nella società e che sui mezzi di comunicazione possono incontrarsi e scontrarsi. Peraltro i giornali, oltre a informare e formare l’opinione pubblica, le permettono anche di esprimersi, dando voce alle sue reazioni, alle sue richieste, alle sue proteste, che, senza di essi, resterebbero confinate nel privato e che invece così assumono una rilevanza politica
Ad avere il primato, in questo modo di concepire il giornalismo, è il logos di cui già prima si parlava. Dove con questo termine, derivante dal verbo greco legein – che vuole dire “parlare”, “pensare”, ma anche “collegare”, “unire i diversi” –, si intende la comunicazione propriamente umana in quanto implica un discorso articolato, razionale, e perciò anche capace di stabilire relazioni significative non soltanto tra i pensieri, ma anche tra le diverse esperienze della persona, sottraendole al gioco disordinato delle emozioni immediate e consentendo così prese di posizione più coerenti e meditate di fronte agli eventi.
Solo così – ed è ancora il frutto del logos – è possibile anche il formarsi della comunità come luogo di uno scambio basato non solo sulle pulsioni istintive, ma su valutazioni e impegno condivisi, in vista della costruzione di un bene comune. Come già aveva osservato Aristotele, quando scriveva:
«È chiaro quindi per quale ragione l’uomo è un animale politico (zoon politikon) molto più di ogni ape e di ogni capo d’armento (…). L’uomo, solo tra gli animali, ha la parola (logon]: la voce indica quel che è doloroso e gioioso e pertanto l’hanno anche gli altri animali (e in effetti, fin qui giunge la loro natura, di avere la sensazione di quanto è doloroso e gioioso e di indicarselo a vicenda), ma la parola è fatta per esprimere (…) il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune (koinonia) di questi costituisce la famiglia e lo Stato» [6].
Ma proprio perché frutto di quel collegamento tra i diversi che è il logos, la koinonia, la comunione da cui scaturisce l’autentica comunità non implica in alcun modo uniformità. In questo senso lo stesso Aristotele osserva che una società politica «non consiste solo d’una massa di uomini, bensì di uomini specificamente diversi, perché non si costituisce uno Stato di elementi uguali» [7]. Soltanto là dove si dà una reale pluralità di voci, l’opinione pubblica ha buone probabilità di avere offerta la più ampia gamma possibile di interpretazioni dei fatti e di proposte.
Su questa linea, Hannah Arendt ha scritto:
«La realtà della sfera pubblica si fonda nella presenza simultanea di innumerevoli prospettive e aspetti in cui il mondo comune si offre, e per cui non può essere trovata né una misura comune né un comune denominatore. Infatti, sebbene il mondo comune sia il comune terreno d’incontro, quelli che vi sono presenti hanno in esso diverse posizioni, e la posizione di uno non può coincidere con quella di un altro, più di quanto lo possa la posizione di due oggetti. L’essere visto e l’essere udito dagli altri derivano la loro importanza dal fatto che ciascuno vede e ode da una diversa posizione. Questo è il significato della vita pubblica» [8].
 Vi è un’autentica vita politica in senso democratico solo là dove la società civile partecipa consapevolmente, in questo stile pluralistico, alla valutazione e alla elaborazione delle scelte relative al bene comune, e non si limita a delegare queste scelte a un gruppo di rappresentanti, per quanto qualificati, nel momento del voto. Senza dire che soltanto una società civile capace di una tale consapevole partecipazione sarà poi in grado di eleggere i propri rappresentanti in base a criteri che non siano quelli del particolare interesse dei singoli e delle corporazioni se non, addirittura, del mero clientelismo. E per questo il giornalismo ha un ruolo decisivo.
Vi è un’autentica vita politica in senso democratico solo là dove la società civile partecipa consapevolmente, in questo stile pluralistico, alla valutazione e alla elaborazione delle scelte relative al bene comune, e non si limita a delegare queste scelte a un gruppo di rappresentanti, per quanto qualificati, nel momento del voto. Senza dire che soltanto una società civile capace di una tale consapevole partecipazione sarà poi in grado di eleggere i propri rappresentanti in base a criteri che non siano quelli del particolare interesse dei singoli e delle corporazioni se non, addirittura, del mero clientelismo. E per questo il giornalismo ha un ruolo decisivo.
La trasformazione del giornalismo nel nuovo contesto della comunicazione sociale
Alla luce di queste considerazioni, si manifesta in tutta la sua problematicità, per le sorti della politica e in particolare per quelle della democrazia, l’avvento di un nuovo modo di fare giornalismo che, in parte sull’onda delle nuove tecnologie, in parte in corrispondenza alla logica della società di massa, rischia di venir meno alla sua funzione di informare, formare ed esprimere l’opinione pubblica.
Lo scenario è quello di una rivoluzione che ha investito il mondo della comunicazione, prima dominato dalla carta stampata, con l’irrompere di nuovi strumenti, cominciando, già all’inizio del secolo scorso, dalla radio, per passare poi alla televisione, arrivando, a cavallo tra il secondo e il terzo millennio, ai computer, ai tablet e agli smartphone. Si situa in quest’ultima fase la nascita della “rete” e lo sviluppo dei social, che ha inciso in modo determinante sia sulla informazione e la formazione dell’opinione pubblica che sulle modalità della sua espressione.
In questo quadro anche il giornalismo non poteva non trasformarsi profondamente. Non solo e non tanto perché le testate hanno dovuto adottare le nuove modalità mediatiche, aggiungendo o sostituendo alla versione cartacea quella digitale, quanto perché i giornalisti sono state spinti a modificare il loro stesso stile comunicativo in funzione del nuovo clima comunicativo in cui operavano.
Così, in una civiltà che ormai ha dato il primato all’immagine rispetto alla scrittura, è nato il “giornalismo-spettacolo”, una formula che sarebbe apparsa inconcepibile al tempo in cui ancora si distingueva la ricerca della verità dei fatti dall’attività creativa, in funzione dei gusti degli spettatori, propria dello spettacolo. Un passo decisivo in questo senso è stato l’avvento della televisione commerciale, il cui stile – a cui poi si è uniformata anche quella pubblica – è stato caratterizzato dalla ricerca indiscriminata dell’audience.
 Da qui la rinunzia ad ogni forma di comunicazione che possa contrariare gli umori e le convinzioni della gente. «In occasione di una lezione che ho tenuto in Germania non molti anni fa» – racconta Karl Popper, in un libretto in cui denunzia con forza il pericolo che la televisione può rappresentare – «ho incontrato il responsabile di una televisione (…). Ebbi con lui una discussione durante la quale sostenne alcune orribili tesi (…) Diceva per esempio: “Dobbiamo offrire alla gente quello che la gente vuole” (…) Egli credeva che le sue tesi fossero sostenute dalle “ragioni della democrazia”» [9].
Da qui la rinunzia ad ogni forma di comunicazione che possa contrariare gli umori e le convinzioni della gente. «In occasione di una lezione che ho tenuto in Germania non molti anni fa» – racconta Karl Popper, in un libretto in cui denunzia con forza il pericolo che la televisione può rappresentare – «ho incontrato il responsabile di una televisione (…). Ebbi con lui una discussione durante la quale sostenne alcune orribili tesi (…) Diceva per esempio: “Dobbiamo offrire alla gente quello che la gente vuole” (…) Egli credeva che le sue tesi fossero sostenute dalle “ragioni della democrazia”» [9].
Non stupisce che, in questa logica, si sia affermata l’idea della cosiddetta “post-verità” – una espressione che gli Oxford Dictionaries hanno indicato come “parola dell’anno”, per il 2016 – indicante un’«argomentazione, caratterizzata da un forte appello all’emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende a essere accettata come veritiera, influenzando l’opinione pubblica» [10]. Il concetto di verità si reggeva, in definitiva, sulla differenza irriducibile tra realtà e invenzione. Ma, nella cultura post-moderna, proprio questa contrapposizione è stata rimessa in discussione.
Si apre così il campo a tutte le manipolazioni tipiche di una società di massa. E con la verità viene meno lo spazio per quel pluralismo che abbiamo visto essere carattere essenziale dell’opinione pubblica e che è possibile, come osserva ancora Hannah Arendt, – solo là dove
«esiste un mondo di cose tra coloro che lo hanno in comune, come un tavolo è posto tra quelli che vi siedono intorno; il mondo (…) mette in relazione e separa gli uomini nello stesso tempo. La sfera pubblica, in quanto mondo comune, ci riunisce insieme e tuttavia ci impedisce, per così dire, di caderci addosso a vicenda. Ciò che rende la società di massa così difficile da sopportare non è, o almeno non è principalmente, il numero delle persone che la compongono, ma il fatto che il mondo che sta tra loro ha perduto il suo potere di riunirle insieme, di metterle in relazione e di separarle» (ivi, 39).
Il giornalismo avrebbe il compito di aprire lo spazio di questa realtà che accomuna e al tempo stesso differenzia, consentendo ai singoli di entrare in rapporto con la realtà invece di restare prigionieri delle proprie caotiche emozioni. Se invece è tutto proteso a solleticarle e a sollecitarle, non c’è più comunità e non c’è nemmeno una vera opinione pubblica, ma solo un gioco di reazioni emotive sganciate dalla verità delle cose e dalla ricerca del fine comune.
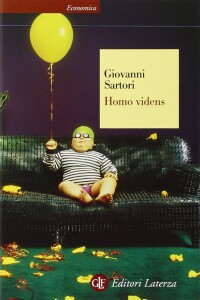 Naturalmente ciò si verifica in misura diversa da giornale a giornale. Ce ne sono di più seri, che riescono a controllare questo rischio, e altri che invece vi cadono in pieno. Significativo, da parte di questi ultimi, l’abitudine di piazzare in prima pagina titoli eclatanti e spesso allarmistici, che non trovano poi riscontro nel contenuto effettivo dell’articolo. Soprattutto in questi casi, i messaggi tendono ad assumere la forma di flashes isolati, privi delle argomentazioni e delle giustificazioni che sarebbero necessarie per dar loro la forma del logos. Si cerca la notizia ad effetto, spesso prescindendo dalle prove della sua fondatezza. Il destinatario vien concepito come un consumatore distratto di cui bisogna attirare l’attenzione, ma che non sarebbe interessato a seguire un ragionamento articolato e tanto meno a valutare i pro e contro di una tesi. Emblematico lo stile dei dibattiti televisivi, dove, nella maggior parte dei casi, non c’è posto per un reale confronto ragionevole tra opinioni diverse, ma solo per lo scontro esagitato tra gli interlocutori.
Naturalmente ciò si verifica in misura diversa da giornale a giornale. Ce ne sono di più seri, che riescono a controllare questo rischio, e altri che invece vi cadono in pieno. Significativo, da parte di questi ultimi, l’abitudine di piazzare in prima pagina titoli eclatanti e spesso allarmistici, che non trovano poi riscontro nel contenuto effettivo dell’articolo. Soprattutto in questi casi, i messaggi tendono ad assumere la forma di flashes isolati, privi delle argomentazioni e delle giustificazioni che sarebbero necessarie per dar loro la forma del logos. Si cerca la notizia ad effetto, spesso prescindendo dalle prove della sua fondatezza. Il destinatario vien concepito come un consumatore distratto di cui bisogna attirare l’attenzione, ma che non sarebbe interessato a seguire un ragionamento articolato e tanto meno a valutare i pro e contro di una tesi. Emblematico lo stile dei dibattiti televisivi, dove, nella maggior parte dei casi, non c’è posto per un reale confronto ragionevole tra opinioni diverse, ma solo per lo scontro esagitato tra gli interlocutori.
È un circolo vizioso. Il venir meno del logos nella comunicazione ha, a sua volta, degli effetti sulle capacità di ascolto e di riflessione dei destinatari. Un giornalismo che si fonda sui titoli ad effetto e sulla girandola sempre in moto dell’ultima notizia favorisce lo scadimento delle capacità critiche e indebolisce sia la disponibilità all’ascolto, sia l’attitudine alla calma riflessione. È la stessa abbondanza dei messaggi e la velocità vertiginosa con cui si accavallano a determinare questo effetto, rendendo difficile – in molti casi praticamente impossibile – un serio discernimento critico che evidenzi il loro differente significato e valore.
Si può essere disinformati per una carenza o per un eccesso di informazione. La nostra società, a differenza di quelle del passato, vive il secondo problema. Nella selva di notizie che affolla, saturandoli, gli spazi dell’attenzione e della memoria, diventa arduo per il destinatario mettere a fuoco l’essenziale. Si spiega così perché, malgrado l’enorme accrescimento delle fonti, «lettori e telespettatori sono sempre più confusi e smarriti. Questo formidabile sistema mondiale dell’informazione non sembra in grado di fornire al pubblico quegli elementi indispensabili perché si formi un’opinione sulle vicende che attraversano il nostro mondo» [11].
 Il ruolo delle riviste nel panorama giornalistico odierno
Il ruolo delle riviste nel panorama giornalistico odierno
Alla luce di questo quadro problematico acquistano un particolare significato le caratteristiche di quel tipo di comunicazione giornalistica che si realizza attraverso le riviste, sia cartacee che on line. Chiaramente, queste caratteristiche implicano anche dei limiti, primo fra tutti la loro minore aderenza alla cronaca. Il loro ritmo di pubblicazione che, a differenza di quello dei quotidiani, è dilazionato nel tempo, non consente loro di seguire l’attualità.
Per contro, però, sono liberate dall’ansia di inseguirla. Niente corsa allo scoop. E questo comporta la possibilità di uno sguardo d’insieme sullo svolgersi degli eventi, grazie a cui cogliere ciò che veramente è stato importante. Tanto più che il senso della maggior parte di questi eventi si manifesta solo nei loro sviluppi successivi, che la cronaca, legata all’oggi, non è ancora in grado di prevedere.
Perciò, normalmente non si legge una rivista alla ricerca di informazioni sui fatti, ma di chiavi di lettura che consentano di interpretarli. In realtà anche quotidiani si pongono questo compito. «Di per sé l’informazione non fa capire» [12]. Non è vero, perciò, che sia sufficiente un resoconto asettico ottenuto “sovrapponendo fatti a fatti” Anzi, si può dare – si dà – un’informazione sui fatti che svia, con la sua stessa sovrabbondanza, rispetto ai problemi veramente decisivi, annegando le notizie veramente rilevanti in un mare di altre futili e determinando una specie di anestesia dell’opinione pubblica.
Da qui lo sforzo di ogni forma seria di giornalismo di tentare di dare un senso a ciò che viene narrato nella cronaca. Ma dove prevale la velocità della notizia e l’esigenza del resoconto è più difficile dare spazio a letture di questo tipo, abbozzate, di solito, negli editoriali, ma sempre in rapporto ai fatti del giorno. Le riviste – o almeno la maggior parte di esse – puntano, invece, su un lavoro di ricostruzione di ampio respiro, che mira innanzi tutto alla interpretazione dei processi in corso.
È un approccio che non favorisce certo il ricorso alla post-verità o alle fake news di cui è costellata l’informazione quotidiana, perché mira a sollecitare la riflessione critica dei lettori, più che le loro reazioni emotive, e si fonda perciò su argomentazioni articolate e sul confronto con la realtà. Ciò passa attraverso la sfida della complessità, che le riviste, per essere all’altezza del loro compito, devono accettare. «La maggior parte dei media non tiene conto di quanto sia complessa la realtà» [13]. Sui quotidiani e sui notiziari televisivi si tende a riferire i fatti come se la “notizia” non fosse il ritaglio, effettuato in una massa sconfinata e caotica di dati, sulla base di una scelta operata dal giornalista e, più a monte, dal direttore della testata. In questo modo raramente i fruitori dell’informazione sono messi in condizione di percepire che quella che stanno ricevendo è solo una possibile lettura dell’immenso fluire degli eventi, rispetto alla quale altre, abbastanza diverse, sarebbero egualmente possibili. Il giornalismo rischia, così, di dare una ricostruzione, tanto unilaterale quanto condizionante, della realtà entro cui la gente si trova a vivere.
La rivista si può permettere, data la maggiore consistenza dei suoi articoli, di dare al lettore la percezione di rimandi e legami con altri eventi “fuori campo” – per usare un linguaggio cinematografico –, ma che sono decisivi per contestualizzare i dati presenti nello spazio inquadrato. Consentendogli così di intravedere altri possibili punti di vista sul medesimo argomento e portare con sé, al termine della lettura, delle domande sulle contraddizioni che attraversano la realtà.
In questo modo si coinvolgono i destinatari della notizia nella sua costruzione ultima, che deve avvenire in definitiva dentro di loro, ad opera della loro intelligenza e della loro personale partecipazione emotiva, invece di propinare una pillola già confezionata, che deve soltanto essere inghiottita così com’è.
Da quanto detto emerge quale può essere oggi il ruolo politico – che non è l’unico, ma che in questo momento storico si presenta particolarmente urgente – delle riviste. In una società tentata dall’astensionismo, per un verso, dal populismo per un altro verso, drammaticamente frammentata dal gioco dei particolarismi che annullano la visione del bene comune e al tempo stesso omologata da mode, slogan e luoghi comuni, le riviste possono fornire gli strumenti per ricostituire in modo critico un “mondo comune”, favorendo una responsabile e intelligente partecipazione politica. E aiutare le persone a «ricostruire incessantemente, senza illusioni né scoraggiamenti, gli spazi del dialogo» [14].
Dialoghi Mediterranei, n.61, maggio 2023
Note
[1] J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, tr. it. A. Illuminati, F. Masini e W. Perretta, Laterza, Bari 1977: 44-45.
[2] H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, intr. A. Dal Lago, tr. it. S. Finzi, Bompiani, Milano 1989: 20-21.
[3] G. Martignetti, voce “Violenza”, in Grande Dizionario Enciclopedico UTET, vol. XX, Torino 1991: 93.
[4] V. Price, L’opinione pubblica, tr. it. R. Riccardi, Il Mulino, Bologna 2004:17.
[5] Ivi:17.
[6] Aristotele, Politica I, 2, 1253 a.
[7] Ivi, II, 2, 1261 a
[8] H. Arendt, Vita activa, cit.: 42-43.
[9] K. Popper, Una patente per fare tv, in K. Popper – J. Condry, Cattiva maestra televisione, intr. G. Bosetti, I libri di Reset, Milano 1996: 36.
[10] Enciclopedia Treccani, voce «Post-verità».
[11] D. Demichelis – A. Ferrari – R. Masto – L. Scalettari, L’informazione deviata. Gli inganni dei mass media nell’epoca della globalizzazione, Zelig, Milano 2002: 23.
[12] G. Sartori, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Laterza, Bari 1999: 53.
[13] C. J Bertrand, con C. Di Martino e S. Sica, La “morale” dei giornalisti. Deontologia dei media e qualità del prodotto editoriale, tr. it. C. Di Martino e S. Sica, Franco Angeli, Milano 2004:118.
[14] G. Savagnone, Comunicazione oltre il mito e l’utopia. Per una cultura conviviale, Edizioni Paoline, Milano 1997, p.180. Per chi volesse approfondire il discorso svolto in questo articolo, mi permetto di rinviare anche al mio Sotto il segno di Hermes. La comunicazione giornalistica dal conflitto alla democrazia, Editrice Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.
_____________________________________________________________
Giuseppe Savagnone dal 1990 al 2019 è stato direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della cultura di Palermo, di cui oggi cura il sito «www.tuttavia.eu, pubblicandovi settimanalmente un editoriale nella rubrica “Chiaroscuri”. Scrive per quotidiani e periodici e collabora con «Tv2000», «Radio in Blu», «Radio Vaticana» e «Radiospazionoi». Nel 2010 ha ricevuto il premio «Rocco Chinnici» per l’impegno nella lotta contro la mafia. Tra le sue pubblicazioni, Quel che resta dell’uomo. È davvero possibile un nuovo umanesimo?, Cittadella Editrice, Assisi 2015; Il gender spiegato a un marziano, Edizioni Dehoniane, Bologna 2016; Cercatori di senso. I giovani e la fede in un percorso di libertà, Edizioni Dehoniane, Bologna 2018, Il miracolo e il disincanto. La provvidenza alla prova, Edizioni Dehoniane, Bologna 2021.
______________________________________________________________








