di Alessandro D’Amato
«…era il periodo in cui venivano abbattuti per fare largo alle serre. Andando, per esempio, verso il mare si attraversava questa campagna sanguinolenta, … cioè, questi carrubi che hanno all’interno…, hanno come la carne umana, il sangue, braccia spezzate. In quel momento, credo ne abbiano raso al suolo migliaia»[1]. Così Piero Guccione descrive, dandole forma e voce, la sofferenza espressa dall’albero di carrubo, specie che fu vittima, a cavallo degli scorsi anni settanta e ottanta, della scellerata scelta umana di intervenire a ogni costo sul paesaggio ibleo, per impiantarvi quel modello serricolo che tuttora ne caratterizza la visuale, interrompendo l’estasi del viaggiatore che percorra le campagne delle province di Ragusa e Siracusa.
L’incanto di un territorio, dunque, violentato in modo irreversibile per far posto a quel manto di legno e plastica che le cronache recenti hanno assiso a simbolo di altre forme di violenza e sfruttamento, perpetrate nei confronti delle nuove “schiave” della moderna agricoltura (Mangano 2014).
Le aree corrispondenti al Val di Noto ancor oggi censiscono circa l’80% dei carrubi presenti in tutta Italia, con alcuni esemplari, secolari e monumentali, che superano i duemila anni di vita o i dieci metri di altezza. Si pensi, nell’area del territorio di Modica, al ‘carrubo di Caschetto’, dell’età di circa mille anni, o al ‘carrubo di Iozia’, alto ben undici metri e con circa sei secoli di vita alle spalle. Oppure, in territorio di Rosolini, il ‘carrubo di Favarotto’ che, con i suoi duemila anni di vita, è certamente il più longevo carrubo di Sicilia e, probabilmente, del Mediterraneo [2]. Tale longevità ha alimentato negli anni alcune credenze popolari, tra le quali quella in base alla quale «il Carrubo non muore mai […] perché il fuoco solamente può cancellare il Carrubo dal suo posto; e bisogna che il fuoco ne distrugga totalmente la ceppaia, perché non lo veggiate rinascere dalle sue ceneri» (Avolio 1875: 491-492).
Per secoli, il sistema zootecnico ibleo ha utilizzato i baccelli di carrubo come alimento privilegiato; gli stessi bovini da sempre pascolano su distese ombreggiate dalle fronde di tale albero. Addirittura, grazie agli appunti di viaggio dell’abate Paolo Balsamo, sappiamo che nel XVIII secolo, per un certo periodo di tempo, il commercio di carrube provenienti dai territori dei dintorni di Vittoria fu notevole, per poi scemare rapidamente a causa di un abbattimento dei prezzi che orientò verso un utilizzo di tali frutti «per la nutrizione dei majali, dei cavalli, e di altri animali» (Balsamo 1969: 88). Attorno al carrubo sono state scritte importanti pagine della propria storia, delle proprie credenze popolari, del proprio sistema culturale ed economico, autentico microcosmo attorno al quale le famiglie iblee organizzavano, in passato, buona parte delle proprie attività quotidiane, così come testimoniato dal racconto Il carrubo, di Maria Occhipinti (1993: 15-60), antesignana delle lotte femminili in un territorio in cui le rivendicazioni sociali non sempre hanno avuto successo e facilità di azione.
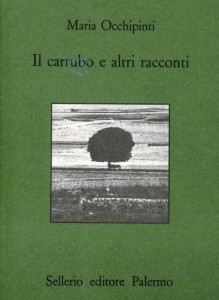 Il nome scientifico della specie è ceratonia siliqua. Entrambi i termini caratterizzanti tale nome (l’uno di origine greca, l’altro latina), richiamerebbero, a una prima analisi, la forma del frutto. In latino, infatti, siliqua non è altro che il baccello, mentre il termine ceratonia deriverebbe dal greco keras (che significa corno, secondo alcuni anche in questo caso per la forma del frutto)[3], ma potrebbe anche richiamare, secondo altre interpretazioni, il termine keraunós, che significa fulmine. Difatti, una leggenda greca vuole che l’albero del carrubo abbia avuto origine proprio a seguito di un fulmine che colpì il corno di un toro. E ancora oggi, gli anziani dell’area iblea sono convinti che gli alberi di carrubo attraggano in modo particolare i fulmini e, dunque, non vadano realizzate abitazioni nelle immediate vicinanze degli stessi.
Il nome scientifico della specie è ceratonia siliqua. Entrambi i termini caratterizzanti tale nome (l’uno di origine greca, l’altro latina), richiamerebbero, a una prima analisi, la forma del frutto. In latino, infatti, siliqua non è altro che il baccello, mentre il termine ceratonia deriverebbe dal greco keras (che significa corno, secondo alcuni anche in questo caso per la forma del frutto)[3], ma potrebbe anche richiamare, secondo altre interpretazioni, il termine keraunós, che significa fulmine. Difatti, una leggenda greca vuole che l’albero del carrubo abbia avuto origine proprio a seguito di un fulmine che colpì il corno di un toro. E ancora oggi, gli anziani dell’area iblea sono convinti che gli alberi di carrubo attraggano in modo particolare i fulmini e, dunque, non vadano realizzate abitazioni nelle immediate vicinanze degli stessi.
D’altronde, la credenza popolare vuole l’albero di carrubo come dotato di particolari significati simbolici e sede di poteri magico-soprannaturali. Esso è uno dei luoghi privilegiati dalle fate e dai demoni, che lo scelgono come residenza elettiva. Pertanto, è fortemente sconsigliato addormentarsi nei pressi di tale albero, un po’ come accade con il noce, che richiama quel “noce di Benevento”, celebre per essere ritenuto il luogo di ritrovo delle streghe.
In linea di massima, dunque, le credenze popolari del passato hanno associato al carrubo alcune caratteristiche non esattamente positive. Ad esempio, pare fossero di legno di carrubo le croci alle quali furono crocifissi i due ladroni posti ai fianchi di Gesù Cristo, così come lo stesso Giuda pare si impiccò a un ramo di carrubo, «circostanza ch’è bastata probabilmente presso il volgo a farlo ritenere come un albero malauguroso, efficacissimo ad attirare i fulmini ed abitato dalle fate» (Bianca 1881: 10). In realtà, sappiamo che l’albero al quale si impiccò Giuda, il Siliquastro o, appunto, Albero di Giuda, non fu un carrubo vero e proprio, ma un suo parente prossimo, botanicamente parlando [4]. Tra l’altro, il caratteristico colore rosso del legno di carrubo ha ulteriormente inciso nella diffusione di miti e credenze popolari simbolicamente connesso a tale cromatismo. In una delle innumerevoli versioni delle storie dei Paladini di Francia raccolte in Sicilia, Gano di Magonza cerca di convertire al Cristianesimo i tre spagnoli di religione islamica, Marsiliu, Buluvanti e Faliaruni, predicando loro all’ombra delle fronde di un albero di carrubo. Tuttavia, fattosi agevolmente distrarre dai tre, come segno divino di disapprovazione nei confronti di Gano, l’albero iniziò a sudare e i suoi frutti a sprizzare sangue (Pitrè 1889, I: 292-293).
Altrettanto diffusa è la credenza in base alla quale le cadute dall’albero di carrubo risultano inevitabilmente fatali, tant’è che ne è derivato il lemma dialettale scarrubbari, che significa sia cadere rovinosamente (Pitrè 1875: 348) che scaricare addosso, materialmente o metaforicamente, a qualcuno (Pitrè 1889, III: 296).
 Inoltre, non è rara la credenza secondo cui, in prossimità di un albero di carrubo, vi sia nascosta una truvatura, vale a dire un tesoro segreto interrato in chissà quale circostanza. La leggenda più celebre, in tal senso, è quella che riguarda il re normanno Guglielmo II (meglio noto come Guglielmo “il Buono”), il quale, impegnato in una battuta di caccia nei pressi di Monreale, si fermò a riposare al riparo dell’ombra di un carrubo. Qui, nel sonno, gli comparve la Madonna, la quale gli rivelò che scavando al di sotto dell’albero sarebbe emerso un tesoro, da utilizzare per l’edificazione di un tempio in suo onore. Risvegliatosi, Guglielmo fece sradicare immediatamente l’albero e, trovato il tesoro, ordinò di costruire quel Duomo di Monreale che oggi è riconosciuto, in Sicilia e nel mondo, come uno dei capolavori dell’architettura normanna:
Inoltre, non è rara la credenza secondo cui, in prossimità di un albero di carrubo, vi sia nascosta una truvatura, vale a dire un tesoro segreto interrato in chissà quale circostanza. La leggenda più celebre, in tal senso, è quella che riguarda il re normanno Guglielmo II (meglio noto come Guglielmo “il Buono”), il quale, impegnato in una battuta di caccia nei pressi di Monreale, si fermò a riposare al riparo dell’ombra di un carrubo. Qui, nel sonno, gli comparve la Madonna, la quale gli rivelò che scavando al di sotto dell’albero sarebbe emerso un tesoro, da utilizzare per l’edificazione di un tempio in suo onore. Risvegliatosi, Guglielmo fece sradicare immediatamente l’albero e, trovato il tesoro, ordinò di costruire quel Duomo di Monreale che oggi è riconosciuto, in Sicilia e nel mondo, come uno dei capolavori dell’architettura normanna:
«andava un giorno il giovinetto principe a cacciagione, secondo suo costume, nella suburbana villa di Monreale, non più di quattro miglia… dalla reggia distante. Dal cacciare lasso, al rezzo di fronzuto carrubbio si mette a riposar poco sopra la chiesa di Ciriaca, quando ecco a lui dal sonno sorpreso la madre di Dio di celeste luce raggiante in sogno gli appare, ed additandogli, che in quel luogo i paterni tesori nascondevansi, amorosamente lo esorta a seguitare dalla cristiana pietà l’intrapresa carriera, e il manifestato danaro ad impiegare in usi sacri ed in alleggiamento dei sudditi. Destato Guglielmo fa voto di fabbricare alla stessa Vergine in quel medesimo luogo un tempio. I tesori scoverti far fede alla celeste apparizione. Non si frappone indugio. Il re dà a costruire ecc. (Testa 1769, cit. in Pitrè 1875: 37).
Quella appena riportata, tuttavia, non è la sola leggenda siciliana di truvature connessa alla presenza del carrubo, così come ci dimostra Emanuele Amodio nel suo volume ‘A Truvatura. Mappe del tesoro nascosto nella Contea di Modica e dintorni. Ne è un esempio paradigmatico il tesoro nascosto, risalente ai tempi del sultano Maometto II (metà XV secolo), sotterrato nei pressi della fontana del carrubo, vicino all’abitazione di “Venti miglia”, in territorio di Licodia Eubea, per recuperare il quale sarebbe sufficiente scavare per 14 palmi al di sotto di due grosse «balati bianchi» collocate su di una piana posta a ponente, rispetto alla facciata dell’abitazione stessa (Amodio 1987: 47-48).
 Al di fuori dell’area iblea, apprendiamo da Pitrè di due leggende di truvature riferibili al territorio di S. Pietro Clarenza, provincia di Catania: in entrambe il tesoro è rappresentato da una grande quantità di carrube trasformate in oro. In particolare, risulta di un certo interesse quella ribattezzata “truvatura di S. Leonardo”, perché rispetta tutti i canoni tipici delle leggende plutoniche [5], dall’atrocità con cui il tesoro è stato incantato al triste destino di chi ha tentato con tutti i mezzi di entrarne in possesso. Il mito soggiacente a tale tesoro vuole che fu il Principe Clarenza in persona a fare seppellire e poi incantare la truvatura, mediante sacrificio di un bambino di quattro anni. Per disincantarla, si sarebbe dovuto «prima uccidervi sopra sette fanciulli, tutti e sette figli d’un medesimo padre, e sette cavalli verdi naturali» (Pitrè 1913: 137). Gli ultimi che provarono a smagare il tesoro nascosto, una ventina d’anni prima che Pitrè ne riportasse l’episodio, pare siano stati un tale Lucio Campanazza, zappatore, e un tale Zuddu lu Sciancatu, ‘ripizzaturi’, i quali tentarono di far saltare per aria l’altarino sotto il quale si presupponeva fossero state sepolte le carrube d’oro. Tuttavia, al momento della prima esplosione, comparve loro un gigantesco fantasma del bambino sacrificato, brandente un bastone di legno di quercia e intimante: «Ma voi non sapete che per prendere questa truvatura vi si devono uccidere sopra sette figli d’un padre e sette cavalli verdi non dipinti?» (Ivi, 138). Al che, i due se la diedero a gambe… andando incontro a un infausto destino: «Lucio Campanazza morì idropico e Zuddu lo sciancato venne assalito da una specie di verme tenia così grosso che egli ne rimase giallo, secco ed allibito per tutta la vita» (idem) [6].
Al di fuori dell’area iblea, apprendiamo da Pitrè di due leggende di truvature riferibili al territorio di S. Pietro Clarenza, provincia di Catania: in entrambe il tesoro è rappresentato da una grande quantità di carrube trasformate in oro. In particolare, risulta di un certo interesse quella ribattezzata “truvatura di S. Leonardo”, perché rispetta tutti i canoni tipici delle leggende plutoniche [5], dall’atrocità con cui il tesoro è stato incantato al triste destino di chi ha tentato con tutti i mezzi di entrarne in possesso. Il mito soggiacente a tale tesoro vuole che fu il Principe Clarenza in persona a fare seppellire e poi incantare la truvatura, mediante sacrificio di un bambino di quattro anni. Per disincantarla, si sarebbe dovuto «prima uccidervi sopra sette fanciulli, tutti e sette figli d’un medesimo padre, e sette cavalli verdi naturali» (Pitrè 1913: 137). Gli ultimi che provarono a smagare il tesoro nascosto, una ventina d’anni prima che Pitrè ne riportasse l’episodio, pare siano stati un tale Lucio Campanazza, zappatore, e un tale Zuddu lu Sciancatu, ‘ripizzaturi’, i quali tentarono di far saltare per aria l’altarino sotto il quale si presupponeva fossero state sepolte le carrube d’oro. Tuttavia, al momento della prima esplosione, comparve loro un gigantesco fantasma del bambino sacrificato, brandente un bastone di legno di quercia e intimante: «Ma voi non sapete che per prendere questa truvatura vi si devono uccidere sopra sette figli d’un padre e sette cavalli verdi non dipinti?» (Ivi, 138). Al che, i due se la diedero a gambe… andando incontro a un infausto destino: «Lucio Campanazza morì idropico e Zuddu lo sciancato venne assalito da una specie di verme tenia così grosso che egli ne rimase giallo, secco ed allibito per tutta la vita» (idem) [6].
Ad ogni modo, l’importanza dell’albero di carrubo, perlomeno in quelle zone dell’Isola in cui la specie è stata o è tuttora sfruttata, è testimoniata dalla presenza di racconti, indovinelli, proverbi e modi di dire di origine popolare. Tra i racconti, va senz’altro citato quello raccolto da Pitrè dalla viva voce della sua più fedele informatrice, quell’Agatuzza Messia alla quale si deve una mole considerevole delle informazioni contenute nei sempre preziosi volumi pitreani. Il racconto, ben presente anche in area iblea, ci narra le vicende di un contadino che, a bordo del proprio carretto carico di carrube, venne assaltato da un malintenzionato. Probabilmente eccedendo, diremmo oggi, nella propria legittima difesa, il contadino lasciò il ladro privo di sensi. Intervenuti gli sbirri (per usare il gergo tipico del vocabolario popolare ottocentesco), questi decisero di sequestrare all’uomo il carretto, compresi il relativo contenuto e l’asino che lo trainava. A distanza di mesi, quando al termine del processo il contadino fu dichiarato innocente, egli tuttavia, tra varie vicissitudini, «ci appizzò lu sceccu e li carrubbi», frase che ancora ai nostri giorni viene ripetuta quando oltre al danno subentra anche la beffa (Pitrè 1875: 149).
 Altro modo di dire tipico dell’area iblea è A lu tempu ca lu Cassaru era abbalatatu d’ossa di carrubi, modo scherzoso di far riferimento a qualcosa di talmente lontano nel tempo, da fare riferimento a un’epoca in cui «gli uomini erano tanto semplici, da poter concepire che si lastricasse il Cassaro con noccioli di carrube» (Pitrè 1910: 255-256). Un proverbio popolare, Quannu viri ca lu pani è picca mancia carrubbeddi e vivi acqua (Guastella, lettera a Pitrè: 52) [7], ci introduce a un’altra leggenda, che è quella legata al nome popolare del frutto, pane di san Giovanni, con il quale esso è diffusamente conosciuto in tutta Europa, in base a una tradizione evangelica riportata sia da Marco che da Matteo. Essa narra di Giovanni Battista il quale, nel deserto, si cibò soltanto di locuste e miele selvatico, laddove pare che per locuste si debba intendere non gli insetti ma proprio il nostro frutto (tant’è che in alcuni Paesi dell’Europa settentrionale, l’albero di carrubo è chiamato proprio locust tree) e che tale erronea interpretazione sia dovuta, secondo il celebre filosofo Rudolf Steiner, a un refuso nella traduzione del brano evangelico.
Altro modo di dire tipico dell’area iblea è A lu tempu ca lu Cassaru era abbalatatu d’ossa di carrubi, modo scherzoso di far riferimento a qualcosa di talmente lontano nel tempo, da fare riferimento a un’epoca in cui «gli uomini erano tanto semplici, da poter concepire che si lastricasse il Cassaro con noccioli di carrube» (Pitrè 1910: 255-256). Un proverbio popolare, Quannu viri ca lu pani è picca mancia carrubbeddi e vivi acqua (Guastella, lettera a Pitrè: 52) [7], ci introduce a un’altra leggenda, che è quella legata al nome popolare del frutto, pane di san Giovanni, con il quale esso è diffusamente conosciuto in tutta Europa, in base a una tradizione evangelica riportata sia da Marco che da Matteo. Essa narra di Giovanni Battista il quale, nel deserto, si cibò soltanto di locuste e miele selvatico, laddove pare che per locuste si debba intendere non gli insetti ma proprio il nostro frutto (tant’è che in alcuni Paesi dell’Europa settentrionale, l’albero di carrubo è chiamato proprio locust tree) e che tale erronea interpretazione sia dovuta, secondo il celebre filosofo Rudolf Steiner, a un refuso nella traduzione del brano evangelico.
L’episodio appena citato ci consente di comprendere l’esistenza di un forte legame tra, da una parte, il frutto e la pianta del carrubo e, dall’altra, la tradizione culturale del Cristianesimo. Un legame che è sancito e riconfermato anche da altre vicende. È il caso, ad esempio, della parabola del figliol prodigo descritta nel Vangelo di Luca (XV, 16), laddove il protagonista, lontano da casa e parecchio affamato, invidia la condizione del maiale, perché almeno questi può cibarsi delle “dolci siliquie” (cit. in Coria 1982: 6).
 Il nostro albero, però, consente l’apertura di interconnessioni anche con altre vicende culturali alle quali siamo inscindibilmente legati (oltre alle già citate radici linguistiche con il mondo greco e quello romano, nonché la stratificazione cristiana dell’apparato mitico appena descritto e la stretta interrelazione con il periodo normanno). In questo senso, non mancano gli intrecci con la fase araba. Il nome comune, con il quale noi oggi conosciamo la pianta e il suo frutto, non è altro che espressione semantica della presenza araba nella nostra Isola, poiché il termine deriva dal lemma arabo kharrub.
Il nostro albero, però, consente l’apertura di interconnessioni anche con altre vicende culturali alle quali siamo inscindibilmente legati (oltre alle già citate radici linguistiche con il mondo greco e quello romano, nonché la stratificazione cristiana dell’apparato mitico appena descritto e la stretta interrelazione con il periodo normanno). In questo senso, non mancano gli intrecci con la fase araba. Il nome comune, con il quale noi oggi conosciamo la pianta e il suo frutto, non è altro che espressione semantica della presenza araba nella nostra Isola, poiché il termine deriva dal lemma arabo kharrub.
Addirittura, c’è stato anche chi, e tra questi lo scienziato tedesco Ferdinand Hoefer, ha paventato l’ipotesi secondo cui la popolazione dei Lotofagi, così ben descritta da Omero nel libro IX dell’Odissea, si nutrisse in realtà proprio di carrube. Quel loto dolce e inebriante di cui parla il grande poeta greco altro non sarebbe se non la carruba, presente in tutta l’area dell’Africa settentrionale e della Sicilia in cui i Lotofagi sono stati storicamente collocati. D’altronde, riprendendo tale ipotesi, Giuseppe Bianca fece notare che effettivamente il baccello è caratterizzato da un’elevata componente zuccherina e da esso se ne può ricavare un ottimo distillato, rendendo tale frutto “inebriante”. Per alcuni anni, a metà Ottocento, fu attivo a Catania uno stabilimento per la distillazione del fico d’India. Allo scopo di incrementare la propria produzione, per un certo periodo vi si estrasse alcool anche dalle carrube, incrementando notevolmente il proprio fatturato. Tuttavia, dopo poco tempo, l’importazione della barbabietola, il rincaro della materia prima e l’elevata tassazione imposta sul prodotto, fecero desistere dell’estrazione dell’alcool di carrube (Bianca 1881: 11).
La stessa medicina popolare, in Sicilia, ha da sempre riconosciuto le proprietà possedute dal frutto. Non a caso, nel 1875, il dialettologo e studioso di tradizioni popolari Corrado Avolio, già ne riconosceva l’importanza per l’alimentazione umana, sottolineando come le condizioni di salute della popolazione dei territori della Contea di Modica fosse di gran lunga migliore rispetto a quelle degli abitanti di altre zone, attribuendo il merito al vistoso consumo di carrube:
«la carruba è un cibo sanissimo; e ce lo provano tutti i ragazzi del nostro territorio e della vasta Contea di Modica, i quali ne mangian sempre, e sono pingui e vivacissimi; i quali crescono su robusti, di rado scrofolosi e rachitichi, come se ne osservano moltissimi ove non vegeta il Carrubo» (Avolio 1875: 492).
Del baccello del carrubo se ne è anche fatto ampiamente utilizzo, sottoforma di decotto, come lenitivo per attenuare le coliche uterine sofferte dalle donne nel post-partum (Pitrè 1896: 448). Altro utilizzo riguardò il catarro, uno dei tre spauracchi degli anziani, convinti, così come riportato da Giuseppe Pitrè nella sua Medicina popolare siciliana, che catàrru, carùti e cacarieddu portassero l’uomo alla tomba (Ivi, 410). Quindi, già in passato si conoscevano perfettamente le doti curative e terapeutiche possedute dalla carruba: tra queste, anche il ruolo esercitato nella cura dei disturbi enterici e come astringente; proprietà sintetizzata, ancora una volta, da un proverbio popolare: Cu mancia carrubbi caca ligna cu mancia vavaluci caca corna [8].
 L’utilità del carrubo e dei suoi frutti è testimoniato anche da altri utilizzi, diffusi soprattutto in ambito ibleo, dove in passato il territorio di Comiso era tra quelli con la maggior presenza di tale specie, tant’è che un modo di dire di Chiaramonte recita: Cummisaru caca-vicci (Pitrè 1880, III: 143), laddove per vicci debbano intendersi i semi contenuti all’interno del baccello [9]. Quegli stessi semi che ingenuamente si credeva che, ingeriti accidentalmente, avessero potuto germogliare all’interno del corpo umano: «i noccioli di carrube possono germogliare» (Pitrè 1896: 294). Fortunatamente, accanto ai falsi miti, i nostri avi riuscirono a sviluppare un’elevata capacità di sfruttamento di questa straordinaria materia prima, se solo si pensi che, soprattutto nell’area siracusana degli Iblei, la linfa delle carrube verdi era utilizzata come adesivo per riparare i vecchi piatti di ceramica, al posto di quel fil di ferro che, invece, ancor oggi chiunque ha modo di notare far da collante tra i cocci di vecchi piatti presenti sulle bancarelle dei mercatini antiquari della nostra Isola.
L’utilità del carrubo e dei suoi frutti è testimoniato anche da altri utilizzi, diffusi soprattutto in ambito ibleo, dove in passato il territorio di Comiso era tra quelli con la maggior presenza di tale specie, tant’è che un modo di dire di Chiaramonte recita: Cummisaru caca-vicci (Pitrè 1880, III: 143), laddove per vicci debbano intendersi i semi contenuti all’interno del baccello [9]. Quegli stessi semi che ingenuamente si credeva che, ingeriti accidentalmente, avessero potuto germogliare all’interno del corpo umano: «i noccioli di carrube possono germogliare» (Pitrè 1896: 294). Fortunatamente, accanto ai falsi miti, i nostri avi riuscirono a sviluppare un’elevata capacità di sfruttamento di questa straordinaria materia prima, se solo si pensi che, soprattutto nell’area siracusana degli Iblei, la linfa delle carrube verdi era utilizzata come adesivo per riparare i vecchi piatti di ceramica, al posto di quel fil di ferro che, invece, ancor oggi chiunque ha modo di notare far da collante tra i cocci di vecchi piatti presenti sulle bancarelle dei mercatini antiquari della nostra Isola.
In conclusione, possiamo dire che, in tutta l’area iblea, il rapporto tra il carrubo e l’uomo sia un rapporto simbiotico, fortemente contraddistinto da una sorta di reciproca commistione di caratteri e, perfino, umori. L’immagine del carrubo, che cresce su suoli aridi, rocciosi e spesso poverissimi di terra, in grado di vegetare anche isolatamente, costituisce una metafora perfetta della condizione di vita del popolo siciliano, abituato a far fronte a mille avversità, instancabilmente avvezzo a vivere in una terra piena di sole, ma spesso arida di occasioni e opportunità, traendo linfa da vicende storiche non sempre favorevoli, caratterizzate da mille dominazioni e altrettanti assoggettamenti.
Dialoghi Mediterranei, n.33, settembre 2018
Note
[1] Intervista a Piero Guccione riportata all’interno del documentario Iblei. Storie e luoghi di un parco, a cura di Vincenzo Cascone (Argo software – Extempora, 2010).
[2] «In particolar modo la provincia di Ragusa ospita numerosi esemplari plurisecolari, si tratta soprattutto di carrubi ed olivi ma non mancano altre specie come la maestosa quercia di contrada Muti nel territorio di Chiaramonte Gulfi» (Amato 2010: 26-27).
[3] Secondo Giuseppe Bianca, che scrisse le sue pagine nel lontano 1881, il nome scientifico della specie non significa altro «se non baccello cornicolato o cornuto» (Bianca 1881: 4).
[4] Una leggenda popolare raccolta a Montevago, provincia di Agrigento, così recita: «una volta G.C. [Gesù Cristo] andò a nascondersi sotto l’albero di Giuda, perché i Giudei lo cercavano a morte. Quando essi domandavano: Dunn’è? l’albero rispondeva: Talìa talìa dunn’è; e così rivelò il nascondiglio. G.C. n’ebbe dispetto, e maledisse quell’albero. Quando se ne bruciano i rami, essi dicono sempre: Tà’ tà’ tà’! cioè talìa (guarda), voce uscita da quest’albero quando volle parlare per la prima volta» (Pitrè 1889, III: 295)
[5] L’aggettivazione “plutoniche” costituisce una derivazione dalla mitologia greca, poiché Plutone, fratello di Giove, fu divinità posta a custodia dei tesori del sottosuolo.
[6] Anche nell’altra leggenda di truvature di San Pietro Clarenza riportata da Pitrè e ambientata presso la vecchia fabbrica dismessa meglio conosciuta come “palazzazzo”, il tesoro incantato è costituito da carrube, fichi secchi e altri frutti trasformati in oro (Pitrè 1913: 141-142).
[7] S.A. Guastella, Lettere di Serafino A. Guastella a Giuseppe Pitrè (a cura di G. Brafa Misicoro), lettera del 10 marzo 1879), p. 52. Proverbio poi riportato in Pitrè 1880, IV: 128.
[8] Lettera di S.A. Guastella a G. Pitrè (10 marzo 1879), p. 68. Poi in Pitrè 1896: 163. Altra versione recita: Cui mancia sosizza caca spagu, / Cui mancia carrubbi caca lignu (Pitrè 1880, IV: 87).
[9] La folta presenza del carrubo nel territorio di Comiso è testimoniata da un breve saggio, privo di data, ma collocabile nella seconda metà del XIX secolo, di Francesco Castro. Qui l’autore studia l’evoluzione del carrubeto dei baroni Pace di contrada Piombo, che poco a poco andò a sostituire il precedente impianto olivicolo: «da buon osservatore il Pace vide come il raccolto degli ulivi fosse piuttosto saltuario, per l’insidia delle nebbie marine; mentre quei pochi carrubi producevano regolarmente e abbondantemente» (Castro s.d.: 3).
Riferimenti bibliografici
Amato Giovanni,
2010, La memoria dei giganti, in «Senzatempo. Pagine di memoria degli Iblei», I, 3, dicembre: 25-27.
Amodio Emanuele (a cura di),
1987, ‘A Truvatura. Mappe del tesoro nascosto nella Contea di Modica e dintorni, Sicilia Punto L Edizioni, Ragusa.
Avolio Corrado,
1875, Coltivazone del carrubo nel territorio di Noto, in «L’Agricoltura italiana. Periodico mensile», I, I: 491-493.
Balsamo Paolo (Abate),
1969 (1809), Giornale del viaggio fatto in Sicilia e particolarmente nella Contea di Modica dall’Abate Paolo Balsamo, ristampa a cura del Rotary Club di Ragusa, Edigraf, Catania.
Bianca Giuseppe,
1881, Il carrubo. Monografia storico-botanico-agraria da servire di appendice alla monografia agraria del territorio d’Avola in Sicilia, Tip. M. Ricci, Firenze.
Castro Francesco,
s.d., Un carrubeto modello nel Comisano, Tip. Ed. Moderna, Comiso.
Coria Giuseppe (a cura di),
1982, Il carrubo… salviamolo!, Edizioni Coria, Vittoria.
Mangano Antonello,
2014, Violentate nel silenzio dei campi a Ragusa. Il nuovo orrore delle schiave rumene, «L’Espresso», 15 settembre.
Occhipinti Maria,
1993, Il carrubo e altri racconti, Sellerio, Palermo.
Pitrè Giuseppe,
1875, Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, vol. IV, Pedone Lauriel, Palermo.
1880, Proverbi popolari siciliani, voll. I-IV, Laurel, Palermo.
1889, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, voll. I-IV, Pedone Lauriel, Palermo.
1896, Medicina popolare siciliana, Clausen, Torino-Palermo.
1910, Proverbi, motti e scongiuri del popolo siciliano, Clausen, Torino.
1913, Cartelli, pasquinate, canti, leggende, usi del popolo siciliano, A. Reber, Palermo.
Testa Mons. Francesco,
1769, De vita et rebus gestis Guilelmi II Sicilae Regis, Monreale.
___________________________________________________________________________
Alessandro D’Amato, dottore di ricerca in Scienze Antropologiche e Analisi dei Mutamenti Culturali, vanta collaborazioni con le Università di Roma e Catania. Oggi è un antropologo freelance. Esperto di storia degli studi demoetnoantropologici italiani, ha al suo attivo numerose pubblicazioni sia monografiche che di saggistica. Insieme al biologo Giovanni Amato ha recentemente pubblicato il volume Bestiario ibleo. Miti, credenze popolari e verità scientifiche sugli animali del sud-est della Sicilia (Editore Le Fate 2015). Insieme a Marcella Burderi ha dato recentemente alle stampe Il sacrificio di Clementuzzu. Storie e leggende di tesori nascosti in Sicilia (Le Fate 2018).
______________________________________________________________








