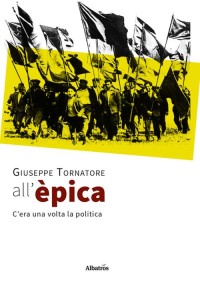Sono tante le vie che si possono seguire per arrivare alla stesura di un libro bello, coinvolgente e che aggiunge un significativo coefficiente di conoscenza su vicende che, per il loro profondo incrostarsi nell’immaginario collettivo – tra cronaca politica, cinema, letteratura, canzone popolare – sono più o meno avvertite come conoscenze condivise, collocate su di uno sfondo facilmente accessibile a tutti. Poi capita di leggere un volume come All’èpica, c’era una volta la politica di Giuseppe Tornatore (Albatros editore, 2022) e di comprendere appieno come quello sfondo sia ancora bisognoso di integrazioni, approfondimenti e, se è il caso, ribaltamenti.
In linea con quelli che sono i paradigmi dell’history telling o storia orale che dir si voglia, Tornatore, con un repertorio minimo di domande uguali per tutti i diciotto militanti e dirigenti del Partito comunista intervistati, riesce a creare un meraviglioso ircocervo che, per sua stessa ammissione: «Non sono interviste e non è nemmeno una sceneggiatura, non è un libro storico e non è nemmeno un romanzo, non è un soggetto cinematografico e nemmeno un saggio e forse è un po’ di tutte queste cose messe insieme». Di fatto, dall’impossibilità di definizione formale esce fuori una polifonia in cui le singole voci non si configurano soltanto come documenti inediti sugli eventi del passato, ma come riformulazioni di esperienze convertite in testi costruiti attraverso un dialogo – sempre sul filo del racconto e anche dell’immaginazione: non è cronaca alternativa di fatti del passato, ma nuova narrazione che sgorga dal rapporto emotivo fra i suoi co-autori, ovvero intervistatore e intervistato.
All’èpica è, da questo punto di vista, un piccolo tesoro, una truvatura che – come nella migliore tradizione romantica dei manoscritti ritrovati – è saltato fuori dal baule del regista sotto forma di repertorio di materiali preparatori per un film mai realizzato. Negli anni tra il ’90 e il ’93, quando fare politica, tra crollo dei vecchi partiti e Tangentopoli, era diventato un marchio di ignominia, Tornatore si innamora dell’idea di realizzare un film sul mito buono della politica: la politica come l’avevano vissuto milioni di persone in questo Paese, soltanto trenta, quaranta anni prima. La politica come «magnifico strumento per mezzo del quale tutti avevano sognato di cambiare il mondo e di cambiarlo in meglio… personaggi che proprio nella politica credevano profondamente come unica possibilità di riscatto, di edificazione di un futuro migliore, per sé stessi e per i propri figli».
Insomma, la politica come in seguito l’ha raccontata nel suo Baarìa (2009). Per mettere a punto il soggetto e la sceneggiatura del film, Tornatore, oltre alla documentazione rituale, decise di intervistare quante più persone possibile tra coloro che avevano vissuto quell’epoca – e che ancora potevano restituirla sotto forma di aneddotica, di esperienza personale, di situata visione della storia “dal basso”, ma anche “a latere”. Gli era indispensabile ascoltare la voce altrui per inseguire la trama di un film-racconto poi dimostratosi irrealizzabile (e di fatto irrealizzato proprio come alcuni dei grandi film della storia del cinema, puntualizzerà in altra sede il regista). Adesso quei nastri, a trenta anni di distanza sono i capitoli di un libro corale che fin dalle prime pagine si mostra crepuscolare, pervaso come è dal rimpianto per una forma di sapere, e di fare memoria, che adesso, come tanto altro, sembra svanita nell’aria. Quella che sembrava l’ecografia di un parto che non c’è stato, ha dato però vita a un magnifico racconto popolare.
Insomma, con un buon coefficiente di (dissimulata) consapevolezza teorica, l’autore bagherese si muove sulla falsa riga, come sopra accennato, della storia orale di autori come Alessandro Portelli o Carlo Ginzburg, che proprio all’inizio degli anni stavano dando mostra di uno straordinario talento divulgativo, oltre che storiografico. L’operazione di Tornatore è di geniale semplicità: la storia che gli interessa tirare fuori dal racconto di chi ne è stato, in qualche modo, co-protagonista è un sedimento che si svela solo nella narrazione diretta – ma co-gestita nella forma di dialogo, emotivamente coinvolta, esistenzialmente marcata – che se ne può ancora fare. È la versione delle cose di una generazione che ha imparato soprattutto ascoltando gli altri, sapendo ascoltare: e adesso ci fa dono del tesoro depositato nelle sue orecchie. Di chi, in altri termini, era ancora partecipe di una configurazione della civiltà che faceva dell’ascolto la strategia principale di conoscenza del mondo.
Nel lobo dell’orecchio è insita la memoria, scriveva Plinio il vecchio: la conoscenza del mondo dei protagonisti di questi dialoghi, tra gli anni quaranta e gli anni sessanta del secolo scorso, è ancora di tipo aurale. La storia di cui loro rendono testimonianza non è paradigma astratto o occorrenza documentale, ma racconto dell’esperienza direttamente vissuta o da altri narrata: ed è soprattutto la forma in cui da tali racconti affiorano le tensioni e le contraddizioni tra passato e presente, le questioni identitarie, l’ideologia, il mito.
L’elenco degli intervistati è lungo, diversi i loro profili biografici ed esistenziali. Si va da Francesco Renda (sindacalista CGIL, dirigente PCI, docente universitario e insigne storico) a Lucia Mezzasalma (militante, dirigente UDI, PCI, CGIL, poetessa), da Mimì Carapezza (bracciante agricolo, dirigente movimento contadino, sindaco di Castellana sicula) a Emanuele Macaluso (giornalista, parlamentare regionale e nazionale). La memoria dei fatti – talvolta dei medesimi fatti – è franta, nebulosa, diseguale, ma ciò non toglie spessore né credibilità alla loro testimonianza: perché quello che delle loro memorie, del loro raccontare importa davvero, non è l’accuratezza documentaria ma il fatto di costituirsi come una pratica ormai desueta.
La memoria come intreccio di dialogo, immaginazione, narrazione. Mettere in moto la memoria, restituire agli altri l’aura di un’epoca scomparsa, ridarle vita nel racconto è però lavoro faticoso, spesso contraddittorio, soggetto alla contingenza: ed è anche impegno culturalmente, ideologicamente orientato. Ricordare è un atto politico, oltre che culturale. Tutti gli intervistati ne sono ben consapevoli e per questo raccontano il loro approccio alla militanza politica come una presa di coscienza individuale in seno a un più generale, oggettivo movimento di consapevolezza da parte di categorie di persone, di classi sociali, di reti di individui che intuivano l’irripetibilità di una congiuntura storica in cui l’azione politica di massa, strutturata dentro gli schemi rigidi di un Partito dall’organizzazione interna affatto democratica, fosse il solo modo per ottenere diritti e avanzamenti, fino ad allora qualcosa a metà strada fra il miraggio e l’utopia.
E per questo tutti loro, all’insaputa uno dell’altro, sottolineano la dimensione simbolica del loro engagement, raccontando ad esempio – ognuno con accenti e trasporto degni di un bildungroman popolare – la seduzione, estetica prima che ideologica, della bandiera rossa. Una seduzione che li ha trasformati, tutti, in gente che ha dedicato l’intera vita al “Partito”. Ne viene fuori un fondamentale tratto comune in qualche modo riconducibile all’ethos del trascendimento demartiniano: sentono, tutti insieme, con un coinvolgimento emotivo e intellettuale totalizzante, il bisogno di distaccarsi da ciò che la cultura di appartenenza ha cucito loro addosso come “condizione naturale”. Sanno che possono affermare la loro presenza e il loro bisogno di cambiamento progettando opere e azioni in forma comunitaria. Nessuno si salva se non saranno tutti a salvarsi.
Il loro approccio all’esperienza politica è pre-dottrinario, messianico: se il marxismo ha provato ad occultare il bisogno di trascendimento affermando la supremazia dell’orientamento economico sul comportamento umano, questi militanti, più o meno ingenui, che diventano comunisti senza aver mai letto un rigo di Marx (per fortuna, forse) riescono a salvaguardare intatta la loro capacità di rappresentazione simbolica della realtà, trasfondendola in segni mondani, storici, civili. La bandiera rossa, la sua fascinazione violenta si dimostra aurorale per ciascuno, al punto che quasi tutti sentono il bisogno di raccontare il momento in cui per la prima volta hanno visto ciò che simbolicamente avrebbe sintetizzato il resto, nel bene e nel male, della loro esistenza.
Racconta Francesco Renda, a proposito dell’occupazione di un feudo a Cattolica Eraclea e ai disordini quasi ingovernabili, per lui giovanissimo dirigente politico, che ne seguirono. Non riuscendo in nessun modo a far desistere i contadini dai loro intenti: «Che faccio? Istintivamente dico: va bene, visto che voi non volete più ascoltare nulla io me ne vado. Se non mi riconoscete come vostro capo…Quindi prendo la bandiera, monto a cavallo e me ne vado. Ciò che non era riuscito in un’ora di fatica enorme, non appena videro il loro dirigente che andava via, come tante pecorelle se ne vennero appresso. Cioè: e questo è un fatto di plasticità… In cui proprio quella disponibilità alla disciplina, il ruolo della bandiera… Lì c’era il dirigente e la bandiera».
E Mimì Carapezza, quando racconta la prima volta che ha visto la bandiera rossa e ne ha subìto, destinalmente, la fascinazione: «A Banniera russa cumparìu cu ‘stu esercito di contadini che partirono dalla stazione di Villalba, ìeru acchianannu acchianannu di unni passavano tutti i contadini del feudo. Si fece una manifestazione a Petralia dove c’era la tenènza. Picchì tutti quei terreni erano territorio di Petralia. Quannu mi scriviv’o partito nel ’46 ivu a càmmar’o lavoro e un certo Mimiddu mi disse: cucì, stamu fannu un partitu nuovo, un partitu contr’e ricchi. Allura chistu è ‘u me’ partitu, e mi scrivivu».
E Napoleone Colajanni: «Allora io ti dico una cosa che è proprio cinematografica, la prima impressione che ho avuto io il 1 maggio 1944. Le bandiere, le prime bandiere rosse in via Libertà. Questa è proprio un pezzo di cinema. Perché, guarda, se chiudo gli occhi lo rivedo. A via Libertà, in mezzo al verde. A quei tempi c’erano le case basse, non c’erano tutte queste cose che ci stanno ora. Venivano da piazza Croci verso il Politeama: le prime bandiere rosse. Era il 1 maggio. Era la prima sfilata del 1 maggio che vedevo in vita mia. Eh, le bandiere».
Da un lato emerge, nei racconti di tutti, il riferimento a una serie di eventi che, come un tempo hanno segnato il rapporto con la militanza politica di quella generazione, adesso ne strutturano il discorso memoriale: i fatti di Villalba del settembre ’44; Portella della Ginestra; il Governo Milazzo; i fatti dell’8 luglio 1960 a Palermo. Dall’altro, ognuno degli intervistati, per percorsi interiori e esperienze di vita differenti (i militanti che vengono dall’entroterra hanno avuto nella questione agraria e nell’occupazione dei feudi l’esperienza politica fondamentale; quelli che operano nella città o nell’immediato entroterra, trovano negli infiniti problemi del sottoproletariato urbano il loro banco di prova), ammette di avere sentito come un limite, se non un peso, morale, la rigidità organizzativa del Partito; l’asperità delle sue scuole di formazione dove si sfiorava la mistificazione dei fatti e della storia; la doppiezza morale.
 Nessuno di loro però è in difficoltà con l’approccio autobiografico al racconto, tanto meno con il suggerimento implicito da parte del regista di fondere, in quel racconto, macrocosmo e microcosmo. Forse perché molti – e lo raccontano con un misto di cameratismo e disincanto – hanno fatto la scuola di Partito. E nelle scuole di Partito, come ci spiega Mauro Boarelli in La fabbrica del passato [Quodilibet 2021], i militanti erano obbligati a narrare pubblicamente, e a scriverla, una autobiografia che raccontasse il percorso verso la militanza politica come un episodio di evangelizzazione socialista. Secondo Boarelli, questa potrebbe sembrare solo una pratica importata dall’Unione Sovietica, cioè un modo di tradurre in procedura di affiliazione partitica il rituale della confessione pubblica della Chiesa ortodossa.
Nessuno di loro però è in difficoltà con l’approccio autobiografico al racconto, tanto meno con il suggerimento implicito da parte del regista di fondere, in quel racconto, macrocosmo e microcosmo. Forse perché molti – e lo raccontano con un misto di cameratismo e disincanto – hanno fatto la scuola di Partito. E nelle scuole di Partito, come ci spiega Mauro Boarelli in La fabbrica del passato [Quodilibet 2021], i militanti erano obbligati a narrare pubblicamente, e a scriverla, una autobiografia che raccontasse il percorso verso la militanza politica come un episodio di evangelizzazione socialista. Secondo Boarelli, questa potrebbe sembrare solo una pratica importata dall’Unione Sovietica, cioè un modo di tradurre in procedura di affiliazione partitica il rituale della confessione pubblica della Chiesa ortodossa.
In realtà i racconti autobiografici “controllati” che il Partito comunista italiano impose ai suoi militanti hanno forse a che fare più con l’ecclesia militans gesuitica: è lì che troviamo una pedagogia rigorosamente normativa, l’annullamento di ogni forma di individualità, l’Esame generale che prevedeva l’indagine minuziosa del candidato e di ogni aspetto della sua vita, storia familiare compresa. Dice Boarelli: «Le analogie tra l’Esame generale dei gesuiti e le autobiografie scritte e orali dei militanti comunisti hanno una radice comune: la volontà di affermare un controllo totale sulle biografie individuali attraverso criteri speculari di interpretazione dei racconti, il sospetto degli esaminatori, il senso di colpa dei narratori». Il senso di colpa.
Insomma, un lavoro capillare ma di matrice orwelliana, reazionaria, che attraverso la auto-narrazione biografica doveva generare – dopo la svolta di Salerno di Palmiro Togliatti – il Partito nuovo nelle sue caratteristiche essenziali: rielaborazione del modello sovietico; centralismo democratico; trasmissione di schemi ideologici attraverso l’educazione alla Scrittura; la formazione dei militanti e il controllo sulla loro vita passata, presente e futura. Le cose – è evidente – sono andate in maniera molto diversa.
Tra le voci che raccontano dell’esperienza, semi-concetrazionaria, della scuola di Partito, particolarmente esilarante è quella di Giuseppe Tornatore padre (segretario di sezione, consigliere comunale e capogruppo PCI a Bagheria, segretario Federbraccianti, Presidente Lega Cooperative provinciale), il quale restituisce la giornata-tipo del militante-scolaro in bozzetti degni di un grande umorista, mostrando ancora una volta che l’ironia è il solo modo per resistere all’assurdità e alle angustie anche del conformismo ideologico. Ma conclude, amaramente, che dopo quell’esperienza – complici il pedagogismo beota, l’arroganza ideologica che si trasforma in negazionismo dell’evidenza – «non si migliorava di niente, anzi si poteva pure peggiorare dal punto di vista diciamo così dell’entusiasmo più che della convinzione».
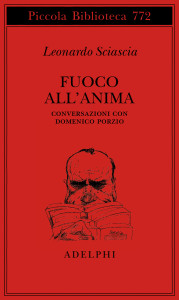 Non a caso l’archetipo degli indottrinatori comunisti è quel Paolo Robotti, cognato di Togliatti, più volte evocato dai narratori di All’èpica e di cui Leonardo Sciascia ebbe a dire: «La persona più stupida che ho incontrato in vita mia è stata, posso dire, Robotti. Perché quando un uomo che non ha tradito viene preso dalla Polizia di Stato, torturato, gli rompono la spina dorsale e continua a credere nel comunismo, è uno stupido. È assolutamente uno stupido. Sa dentro di sé di essere nel giusto, di non avere tradito, eppure viene accusato di tradimento, di eresia e subisce le torture più spaventose, ma continua a essere comunista. E continua a parlare di comunismo nel modo più stupido. Nelle Parrocchie di Regalpetra non faccio un nome, ma è lui l’uomo che viene a Racalmuto, tiene un comizio e spiega ai contadini che cos’è il kolchoz, ossia una specie di paradiso. I contadini erano vessati dall’ammasso obbligatorio; in quel momento capiscono che il kolchoz è la continuazione dell’ammasso. Ed è allora che il Partito comunista tocca il punto più basso dei voti. Nel 1948. Questo è uno stupido integrale» [Fuoco all’anima, Adelphi 2021].
Non a caso l’archetipo degli indottrinatori comunisti è quel Paolo Robotti, cognato di Togliatti, più volte evocato dai narratori di All’èpica e di cui Leonardo Sciascia ebbe a dire: «La persona più stupida che ho incontrato in vita mia è stata, posso dire, Robotti. Perché quando un uomo che non ha tradito viene preso dalla Polizia di Stato, torturato, gli rompono la spina dorsale e continua a credere nel comunismo, è uno stupido. È assolutamente uno stupido. Sa dentro di sé di essere nel giusto, di non avere tradito, eppure viene accusato di tradimento, di eresia e subisce le torture più spaventose, ma continua a essere comunista. E continua a parlare di comunismo nel modo più stupido. Nelle Parrocchie di Regalpetra non faccio un nome, ma è lui l’uomo che viene a Racalmuto, tiene un comizio e spiega ai contadini che cos’è il kolchoz, ossia una specie di paradiso. I contadini erano vessati dall’ammasso obbligatorio; in quel momento capiscono che il kolchoz è la continuazione dell’ammasso. Ed è allora che il Partito comunista tocca il punto più basso dei voti. Nel 1948. Questo è uno stupido integrale» [Fuoco all’anima, Adelphi 2021].
In una narrazione che vale anzitutto come polifonia, va segnalata, comunque, quella che secondo me è la voce più tragica del coro: cioè la voce di Mimmo Drago (Segretario della Camera del lavoro e consigliere comunale a Bagheria e a Palermo; Segretario regionale Federbraccianti e CNA) che vive prima, e racconta poi, la sua esperienza politica come un fallimento ideologico ed esistenziale insieme. Che riesce a vedere la deriva in atto rispetto a ciò che la politica era stata per la sua generazione distinguendo nettamente le cause specifiche del fallimento di un sogno ideologico e le cause generali di una trasformazione epocale del sistema delle relazioni sociali. Il centralismo democratico, ad esempio, sarà forse stata una necessità operativa per chi si trovava a reggere le fila di un Partito di massa di quel tipo, ma, fondamentalmente, ha avvelenato la vita democratica del Partito stesso.
Racconta Mimmo: «Quando il centralismo democratico diventava una stortura? Quando di fronte alle posizioni, spesso giuste e originali, entrava in atto la ragion di partito… e quindi ci si arrendeva. Il partito ha deciso…’u Pajtìtu. Difatti, io alcune volte m’incazzava. Io passàvu per essere uno spudorato di destra, socialdemocratico: m’u facevanu nèsciri ri tutt’i banni. Quando una volta ebbi a dire che il giorno più bello della mia vita era chiddu quannu nnall’Unione Sovietica ci avissiru statu grandi scioperi, Colajanni mi manciò». E chiarisce meglio il concetto quando racconta, nell’ambito delle scelte politiche regionali, del conflitto con Nicola Cipolla: «Io per loro ero un socialdemocratico picchì iddi, con le lotte per la terra, facìevanu i rivoluzionari, come se volevano la rivoluzione del mondo; io, con le lotte salariali… erano lotte, diciamo così, riduttive rispetto a quest’obiettivo. Non so se rendo l’idea. Io facìeva ‘a pàjti ru socialdemocratico, iddi èranu leninisti».
E nonostante questo Mimmo, come fosse un personaggio di Manuel Scorza, non rinnega il suo aver speso la vita per il sogno di un cambiamento radicale e generale dei rapporti sociali e politici, ma ammette che i rivoluzionari tradiscono sempre. La rivoluzione, intesa come desiderio profondo di appropriarsi del mondo, forse no. Ma i rivoluzionari sì, finiscono per diventare i primi agenti della controrivoluzione o incalliti demistificatori. «Il cosiddetto rivoluzionario di professione è sostanzialmente un mostro, un fanatico, non è un uomo, non vive col ritmo e con la vita del mondo. E io di mostri ne ho conosciuto tanti. Di mostri di fronte all’evidenza dei fatti, di problemi, di cose umane. Solo a contatto con la vita, con le passioni del mondo, con gli errori del mondo…Io lo dico: s’avissi vint’anni, tra sintìrimi l’intervento di un burocrate e un appuntamento con una bella ragazza, cu ccu mi nni issi? Mi nni issi c’a ragazza!». E pure, nonostante tutto, quello di Mimmo non è il racconto di una sconfitta: è il racconto di una lotta impari che comunque andava fatta, ad onta dello scissionismo e della litigiosità che sono vere tare genetiche della sinistra.
Chi sono i rivoluzionari di oggi? Ovvero, chi sono oggi i traditori del sogno di un mondo nuovo e più giusto? I traditori del sogno più antico? Ognuno può puntare il dito verso qualsiasi direzione e un capro espiatorio lo si trova comunque. Come osserva il direttore di questo coro, cioè Giuseppe Tornatore, «La dimensione ideologica oggi non ha più senso. Assistiamo a uno scenario paradossale del nostro vivere la politica. I sondaggi settimanali ti danno in diretta l’umore della popolazione. Li leggiamo, li valutiamo, li ascoltiamo, per seguire una sorta di pulsazione della coscienza politica collettiva. Ma non è così. Questa aritmia continua non è dovuta a una passione politica ma a delle necessità immediate che rimanifestano come possibile, in modo anonimo, in risposta alla momentanea dichiarazione più comprensibile dell’esponente più abile a prospettare fatidiche soluzioni. La politica allora era in crisi, oggi è come se non ci fosse».
C’era un volta… forse così avrebbe dovuto iniziare il canto di queste voci che furono.
Dialoghi Mediterranei, n. 56, luglio 2022
____________________________________________________________________
Maurizio Padovano, vive e lavora a Bagheria, laureato in Lettere moderne, ha conseguito un dottorato di ricerca in Filosofia del linguaggio e della mente presso l’Università di Palermo. Collabora da tempo con la rivista Segno di Palermo (sulla quale scrive di letteratura e di altro) e ha pubblicato raccolte di racconti e un paio di romanzi per le Edizioni della Battaglia (Palermo), Di Girolamo (Trapani), Drago Artecontemporanea (Bagheria), Plumelia (Bagheria). Attualmente lavora come insegnante nei licei della sua città.
_____________________________________________________________