di Stefano Montes
Da quando ho incominciato a pensare di tornare a New York, ho al contempo iniziato a ricordare nuovamente i sogni che faccio, a fare caso ai segni che mi manda il mondo a proposito di viaggio e tempo trascorso a Palermo e altrove. Improvvisamente, senza calcolo, sogno e faccio caso al tempo. Non molto bene, ovviamente, all’inizio. Non molto, non tanto, per incominciare. E non è strano che sia così; non è affatto strano che mi soffermi su questo effetto di discontinuità temporale con piacere e meditato intento. Come scrive Said, in un testo straordinario purtroppo trascurato dagli studiosi, un inizio «non è soltanto un tipo d’azione, ma è anche un ordine mentale, un tipo di lavoro, un’attitudine, una coscienza»(Said 1975, xv). Resta il fatto che io non so spiegarmi bene il senso di questo ordine mentale, di cui parla Said, che la mia coscienza si pone, mi pone: altrimenti non ci scriverei, altrimenti non ricorrerei alle virtù sintomatiche dell’inizio per capirlo. È certo che la scrittura, oltre che mezzo di trasposizione di un’esperienza già avvenuta, è ugualmente strumento di lavoro su se stessi e il mondo, potenziale esplicitazione dei sensi noti e ignoti attraverso cui soggetti e oggetti si associano o dissociano gli uni dagli altri, formano gruppi e comunità simili e diverse.
Perché torno a New York dopo così tanto tempo, dunque? È difficile dirlo. La scrittura prende sovente campo e diviene strumento di interrogazione e rivelazione. Io me ne servo, mi lascio altresì guidare. Ci scrivo per afferrarne il senso in chiave riflessiva, ma – i due movimenti vanno in parallelo – per scandagliare allo stesso tempo, più sotterraneamente e transitivamente, alcune logiche interconnesse del senso in relazione al non-senso (sempre in agguato e pur tuttavia rivelatore). Il mio passato a New York? Devo confessare senza pudore che i miei ricordi personali sono alquanto confusi, impigliati nell’apparente livellamento del tempo trascorso, nell’affiorar di tracce comunque persistenti della memoria sbiadita. I ricordi stentano a venire a galla. Non si accordano tra loro. Sono trascorsi trent’anni. Ne avevo allora venti. Non ero ancora un antropologo. Ero un’altra persona. Vedevo gli Stati Uniti come un paese in cui potevo realizzarmi liberamente, seguendo gli stimoli del momento, sminuendo la pianificazione rigida del futuro che mi veniva suggerita dalla famiglia e dalla società dell’epoca, in Italia, a Palermo. Naturalmente, dalla prospettiva odierna, mi rendo conto adesso che gli Stati Uniti rappresentavano un luogo macroscopicamente amplificato dell’immaginario in cui tutto sembrava possibile, fin troppo possibile, appena pensato e già realizzato. Non era del tutto vero e non lo era in ogni singolo caso: era questa un’immagine diffusa che, molti di noi giovani, pieni di speranze e di desiderio di alterità, avevamo allora. È vero, però, che gli Stati Uniti erano effettivamente un luogo in cui le opportunità si offrivano a chi sapeva coglierle infischiandosene di stereotipi e piste già noiosamente, frustamente battute, come lo erano, almeno per me, quelle siciliane.
Questo luogo ‘altro’ rappresentato dagli Stati Uniti, per quanto in parte immaginario e immaginato, utopico e sognato, era quindi anche un luogo concreto e tangibile dove mio zio, per esempio, si era realizzato molti anni prima di me e aveva potuto dare una svolta alla sua vita di bravo sarto malpagato a Palermo. Personalmente, non mi interessava guadagnare tanto – mio zio diceva comunque che gli aspetti economici non erano affatto trascurabili – ma potere cambiare lavoro, quello sì, seguendo l’istinto del momento, quello pure, imparando dalle ‘pratiche’ che ogni possibile lavoro mi consentiva al momento: ed erano tante a New York. Più che studiare sistematicamente, iscrivendomi a un corso universitario pluriennale, in quel periodo mi interessava vivere intensamente, coniugando letture sparse e immersione spensierata in un tempo non addomesticato dalle condizioni di lavoro dettate da altri o da forme di pianificazione di studio troppo rigide quali potevano essere quelle universitarie.
Per quanto riguarda i mezzi di sostentamento, d’altronde, mi chiedo ora – me lo chiedevo allora – perché si dovrebbe pensare a un’omologazione tra un solo lavoro (‘vita natural durante’) e la vita (nella sua interezza) a esso ricondotta linearmente? Più diversità lavorativa, corrispondevano a maggiori scelte trasversali e migliore consapevolezza del vivere, pensavo allora (e lo penso ancora). Poter cambiare lavoro era, in fondo, per me, il piacere della conoscenza dal basso, con il corpo e con la mente, con la possibilità sempre aperta del rifiuto qualora divenisse necessario passare ad altro, divenire altro, altro da me. Questa possibilità di passare da un lavoro all’altro, che mi affascinava molto, era però impensabile da realizzare nella mia città natale, Palermo, dove bisognava – e bisogna tuttora – fare una lunga gavetta, naturalmente non retribuita, con lunghe ed estenuanti ore di lavoro volte ad assicurarsi, negli anni, la sicurezza dell’agognato posto fisso. Al sogno del posto fisso ottenuto dopo tanti anni di sfruttamenti, io preferivo il sogno di un’America considerata terra delle opportunità, una terra forse difficile, sicuramente più ricca però di stimoli, aperta all’iniziativa del singolo con il senso della pratica, con la pratica del sogno. Come racconta Pasolini, nell’intervista concessa a Oriana Fallaci, cercando di spiegare, in fondo a se stesso, sul momento, il perché del suo amore per l’America:
«Tutta la mia gioventù è stata affascinata dai film americani, cioè da un’America violenta, brutale. Ma non è questa America che ho ritrovato: è un’America giovane, disperata, idealista. V’è in loro un gran pragmatismo e allo stesso tempo un tale idealismo. Non sono mai cinici, scettici, come lo siamo noi. Non sono mai qualunquisti, realisti: vivono sempre nel sogno e devono idealizzare ogni cosa» (Fallaci 2015: 235).
La forza degli americani sta nella loro capacità di accordare i contrari: il pragmatismo e l’idealismo, l’oggettività e il sogno. Senz’altro, non mi entusiasmava, da giovane, il conformismo che veniva, a torto o a ragione, loro affibbiato; mi incuriosiva, indubbiamente, il loro individualismo che non sapevo però bene come coniugare con la mia propensione personale al collettivismo sociale. Non erano certo gli Stati Uniti il luogo per pensare a forme di collettivismo socialista, e questo lo sapevo. Ma il conformismo degli americani oscurava veramente il loro desiderio di individualismo? Sono celebri le considerazioni di Sartre a questo riguardo. Più che di opposizione tra conformismo e individualismo, egli parlava di un individualismo che si staglia sulla base di un conformismo generalizzato e basilare: l’uno fa da base di lancio dell’altro. La metafora, al contempo materia concreta, che usava Sartre era quella dello spazio di Manhattan a New York: se vista nella sua lunghezza e larghezza, a piatto, New York è una città estremamente conformista in quanto le sue strade si somigliano tutte, senza svolte circolari o oblique; ma se si alza «il naso al cielo tutto cambia: in altezza, New York è il trionfo dell’individualismo. I palazzi sfuggono, verso l’alto, a qualsiasi regolamentazione urbanistica, hanno ventisette, cinquanta, cento piani, sono grigi, marrone, bianchi, moreschi, medievali, rinascimentali o moderni» (Sartre 1949: 85).
In definitiva, l’individualismo degli americani era, agli occhi di Sartre, una dimensione che presupponeva il conformismo sulla cui base era però possibile costruire una nuova direzione, una via di fuga verso l’alto e l’innalzamento individuale. Era proprio ciò di cui abbisognavo io: una via di fuga verticale, inaspettata ma fondata in basso su qualcosa di solido. All’epoca, non avevo letto queste belle pagine di Sartre, ma sarebbero sicuramente state uno sprone ulteriore per mettere me stesso alla prova, magari convinto dall’ipotesi, formulata da Sartre, secondo cui il desiderio di successo degli americani andava oltre il denaro, l’avidità o il gusto del lusso, perché voleva essere sinonimo di virtù morale e intelligenza. Insomma, un americano, se riusciva nella vita, oltre il successo economico mostrava di possedere intelligenza e morale. Soltanto se aveva successo, un americano poteva «porsi, di fronte alla folla, come una persona» (Sartre 1949: 86).
Non so se avrei accettato ideologicamente la contrapposizione folla-persona tale e quale la propone Sartre per gli americani, ma avrei certamente ceduto al fascino estremamente seduttivo del successo in quanto elemento di equivalenza a virtù morale e intelligenza. Volevo dunque mostrare di essere intelligente, più degli altri avere una possibilità di essere me stesso e al contempo una persona meglio apprezzata? Soprattutto volevo scegliere da me le strade da percorrere: leggere di tutto senza dovermi necessariamente iscrivere a un corso universitario con tante cose per me inutili da studiare; suonare la chitarra e ascoltare liberamente il tipo di musica che volevo io; trovarmi dei lavori che mi consentissero di vivere senza per questo doverli considerare, a tutti i costi, come il destino ultimo della mia vita da dover pensare a senso unico, incanalata per sempre in quell’unica direzione. Tutto qui, niente di più. Ma non è poco e forse stonava rispetto ai canoni di realizzazione individuale più diffusi dell’epoca tra le generazioni più anziane, tra i genitori e i nonni.
Fatto sta che, a Palermo, io mi davo comunque da fare, ero convincente durante i colloqui di lavoro, mi proponevo bene, trovavo dei lavoretti che, alla lunga, si rivelavano però delle vere e proprie trappole temporali e identitarie. Per esempio, ricordo bene che, una volta, sono stato assunto – naturalmente ‘in nero’ – per un lavoro che consisteva nel fare quadrare i conti alle varie fatture dei clienti di un’azienda. In sostanza, non facevo altro che calcoli dalle otto di mattina alle otto di sera con un intervallo di mezz’ora, a pranzo, in cui non mi era nemmeno concesso uscire per svagarmi un po’: dovevo stare in ufficio a ingollare il solito panino, apparso miracolosamente dall’esterno, un esterno lontano mille miglia dal vivere che avrei voluto, libero e senza costrizioni. La mia vita corrispondeva, più o meno, all’orario di lavoro. Che bella vita! Che bel destino! Mi divertivo certamente la sera, uscivo a più non posso appena finito il turno di lavoro, ma non poteva naturalmente andare avanti così. Mi sentivo in prigione durante il giorno, segregato in ufficio a fare conti, senza nemmeno potere scambiare quattro chiacchiere con qualcuno perché le fatture incombevano e il datore di lavoro vigilava lesto.
Sentivo di sprecare la mia vita mentre Time is on my side (Il tempo è dalla mia parte) dei Rolling Stones ronzava nelle mie orecchie come un inno al cambiamento e mi pressava a rivolgere le mie energie altrove, da tutt’altra parte, un altro mondo, verso l’inaugurazione di un’altra vita. Certo, come ho detto, vivevo la sera, uscivo con gli amici, facevo bisboccia come tutti i giovani, se non di più, ma pensavo la mia vita diurna come un inutile spreco di tempo reso in finalità vane, a me estranee: al servizio, cioè, del datore di lavoro di turno che, richiedendo persino gratitudine, mi prospettava invece, come al solito, un posto fisso soltanto dopo mesi, o addirittura anni, di frustrazione e paghe inesistenti. Lavoravo e lavoravo e mentre lavoravo mi chiedevo: e il senso del vivere? In ufficio, durante la giornata, dovevo imbottirmi di tazze di caffè, tanto caffè – nonostante allora non mi piacesse – tali da consentirmi di stare sveglio, di ‘tenere il colpo’, come dicono i francesi con efficace senso di realtà. No, non potevo andare avanti così, con questi lavori interminabili e mangiavita! Per non parlare poi della paga che se dico ‘inconsistente’ risulta essere un eufemismo malcelato di cui si doveva pure essere grati. Grati di che? A chi? Per cosa?
New York si profilava, quindi, come un’alternativa non indifferente, non casuale, non lineare. Ad ogni modo, all’orizzonte prossimo e al presente anteriore, la mia decisione era già presa. Con qualche titubanza fluttuante. Nonostante l’entusiasmo, ero allora consapevole che l’immagine di abbondanza e ricchezza prodotta dagli Stati Uniti andava di pari passo con un’impostazione riduttivamente capitalistica, così come con un industrialismo esasperato e deleterio umanamente, che niente avrebbe dovuto avere a che vedere con ciò che cercavo io da ‘giovane di sinistra’, qualcosa che fosse fondato più sul bene collettivo che sulla sola utilità individuale: insomma, la socialità degli esseri umani e la condivisione del vivere e dei mezzi di sostentamento. Eppure, nonostante queste gravi, non indifferenti, ‘pecche’ ai miei occhi, gli Stati Uniti rappresentavano un’alternativa sostanziale rispetto alla mia singola vita economica sintetizzata, in Sicilia, da un ‘lavorare per niente’, senza finalità altre, senza presente veramente vissuto, oltre che senza futuro autoderminato. La durata indistinta e nefasta di cui parla Augé (2014), più che effetto della tecnologia o della globalizzazione schiacciante, nel mio caso, almeno all’epoca, riguardava gli effetti di un sistema economico perverso che schiacciava passato, presente e futuro in un amalgama sfocato e indefinibile di vita quotidiana dedicata all’arricchimento altrui, votata al borghesuccio ‘padrone’ di turno.
Non imperversava ancora la globalizzazione, almeno non nei termini in cui se ne parla adesso; c’era ancora un clima di guerra fredda che ci spingeva, al liceo, a schierarci da una parte o dall’altra a favore delle grandi potenze. Più che di ‘quotidianità del sistema globale’ – titolo di un volume di un importante antropologo della globalizzazione (Friedman 2005) – si trattava di quotidianità del tirannico vivere giornaliero in cui ci si doveva accontentare di quello che si trovava in giro come lavoro. Bisognava dunque adattarsi alle regole o, come pensavo di fare io, rivoltarsi e darsi alla fuga verso altro, lasciandosi alle spalle una prospettiva di vita inquadrata, ammansita, istupidita. Gli Stati Uniti erano una buona via di fuga, pensavo. Erano una sorta di ossimoro elettrizzante: un mito concreto, utopico e realizzabile al contempo, il sogno e la realtà manifestatasi in un sol colpo. Era un mondo per giovani con l’animo volto al cambiamento. Nell’intervista a Oriana Fallaci, Pasolini materializza questa spinta al cambiamento attraverso una bella opposizione tra due vaste regioni del mondo come l’Africa e l’America: «L’Africa è come una droga che prendi per non ammazzarti, una evasione. New York non è un’evasione: è un impegno, una guerra. Ti mette addosso la voglia di fare, affrontare, cambiare: ti piace come le cose che piacciono, ecco, a vent’anni» (Fallaci 2015: 233).
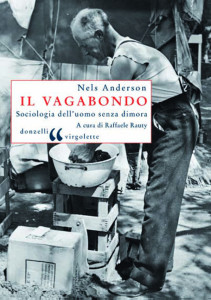 Io avevo vent’anni e avevo voglia di fare. Amavo i viaggi e i vagabondaggi, ed ecco cosa volevo fare: cambiare aria, andare a New York. Divoravo i testi di letteratura e, così, per molti aspetti, avevo la conferma di quello che mi raccontava mio zio: si poteva vivere bene in America, ma c’era anche tanta povertà, dislivelli paurosi di classi, frenetici consumismi di massa, tanta solitudine metropolitana. C’era pure, però, a New York, la possibilità, con un po’ di fortuna, di realizzare il sogno individuale di cui parlavo prima; comunque andassero le cose, c’era almeno la possibilità di trasgredire alle regole sociali imposte dall’alto e affermarsi in quanto individuo libero da convenzioni, non costretto a mettere radici. Questo era per me un elemento di sicuro fascino: fregarsene delle regole, rimanere impigliato e tirarsene fuori, stravolgendole, vagabondando. Jack London era un esempio, nel bene e nel male, di quello che andavo cercando negli Stati Uniti. Nella Strada, lo scrittore americano descriveva un mondo strano, totalmente diverso da quello in cui vivevo io, nel mio piccolo, in Italia: un mondo di libertà e di rivolta contro le regole. Si tratta, più specificamente, nella Strada, di una serie di storie a sfondo autobiografico in cui London raccontava le sue peripezie come vagabondo per le strade d’America. Il fatto davvero sconcertante, per chi non lo sapesse, è che London amava questa vita da straccione e mendicante e, come spiega lui stesso, era attratto proprio dal senso di libertà che gli dava la vita per strada, senza regole, sfuggendo alla polizia, viaggiando da un posto all’altro degli Stati Uniti su treni abbordati al volo per non pagare.
Io avevo vent’anni e avevo voglia di fare. Amavo i viaggi e i vagabondaggi, ed ecco cosa volevo fare: cambiare aria, andare a New York. Divoravo i testi di letteratura e, così, per molti aspetti, avevo la conferma di quello che mi raccontava mio zio: si poteva vivere bene in America, ma c’era anche tanta povertà, dislivelli paurosi di classi, frenetici consumismi di massa, tanta solitudine metropolitana. C’era pure, però, a New York, la possibilità, con un po’ di fortuna, di realizzare il sogno individuale di cui parlavo prima; comunque andassero le cose, c’era almeno la possibilità di trasgredire alle regole sociali imposte dall’alto e affermarsi in quanto individuo libero da convenzioni, non costretto a mettere radici. Questo era per me un elemento di sicuro fascino: fregarsene delle regole, rimanere impigliato e tirarsene fuori, stravolgendole, vagabondando. Jack London era un esempio, nel bene e nel male, di quello che andavo cercando negli Stati Uniti. Nella Strada, lo scrittore americano descriveva un mondo strano, totalmente diverso da quello in cui vivevo io, nel mio piccolo, in Italia: un mondo di libertà e di rivolta contro le regole. Si tratta, più specificamente, nella Strada, di una serie di storie a sfondo autobiografico in cui London raccontava le sue peripezie come vagabondo per le strade d’America. Il fatto davvero sconcertante, per chi non lo sapesse, è che London amava questa vita da straccione e mendicante e, come spiega lui stesso, era attratto proprio dal senso di libertà che gli dava la vita per strada, senza regole, sfuggendo alla polizia, viaggiando da un posto all’altro degli Stati Uniti su treni abbordati al volo per non pagare.
Racconti inventati o memorie che siano, l’effetto di realtà di queste storie è notevole: soprattutto, riesce a rendere un periodo movimentato della storia degli Stati Uniti in cui queste masse di vagabondi si spostavano, insieme, da una città all’altra creando subbuglio e problemi logistici di non poco conto. London racconta che, in alcuni casi, per fronteggiare le situazioni difficili e negoziare con gli ‘eserciti’ di vagabondi, veniva eletto un comitato di salute pubblico locale il cui compito era proprio quello di provvedere a sfamare i vagabondi alla meglio o cercare di affittare dei treni per dare loro la possibilità di spostarsi altrove e, così, sbarazzarsene. Per vivere, quando si spostava da solo, London era costretto a mendicare e aveva imparato a raccontare delle storie allo scopo di impietosire gli altri e raggranellare qualche soldo. Questa rivelazione, al pari dell’altra, sembra stupefacente a chi è abituato a vedere l’arte letteraria come una dote innata. L’ipotesi di London è invece che la sua arte di scrittore trova fondamento nelle infinite e varie storie che era costretto a inventare tutti i giorni, sistematicamente, per giustificare il suo stato di vagabondo con la polizia o per elemosinare qualcosa. Detto altrimenti, la gavetta di vagabondo andava di pari passo con la formazione di scrittore. Ma non è finita qui. Un altro elemento di sorpresa, in London, riguarda l’adesione politica che lui giustifica apertamente con la sua vita passata di vagabondo: fu proprio lo spirito di condivisione che vigeva tra i vagabondi a spingerlo, in seguito, a divenire socialista. A conti fatti, l’interrogativo che ci si pone di più è il seguente: perché lo faceva London? Perché, in fondo, viveva di stenti e d’espedienti quando avrebbe, in effetti, potuto fare altro? Così scrive, sorprendentemente:
«Forse l’aspetto più affascinante nella vita del vagabondo è la mancanza di monotonia. Nella Hobo Land la vita offre un volto proteiforme – è una fantasmagoria sempre mutevole, dove avviene l’impossibile e ad ogni svolta della strada l’imprevedibile balza fuori dai cespugli. Il vagabondo non sa mai cosa capiterà l’istante dopo; vive quindi solo nel momento presente. Ha capito la futilità dello sforzarsi per qualche scopo, e conosce il piacere del lasciarsi portare alla deriva dai capricci del Caso» (London 1976: 45).
Mettere in secondo piano una vita basata sul raggiungimento di scopi fissi o predeterminati e indugiare invece nel presente erano un indubbio richiamo per me, italiano di nascita, americano per vocazione. Chissà, a ripensarci, se avessi vissuto ai tempi di London, quella avrebbe potuto essere la mia vita, una vita senza monotonia! E non deve stupire che questo stile di vita fosse, per London, una scelta e non un obbligo dettato da condizioni economiche o dall’incertezza del lavoro. Le descrizioni ‘sociologiche’ di London vanno prese per buone e sono dunque degli spaccati di vita di una situazione che imperava all’epoca negli Stati Uniti, oggetto di ‘studio scientifico’, tra l’altro, da parte degli studiosi locali della Scuola di Chicago. Un sociologo che ha sicuramente avuto un destino particolare, al pari di Jack London, è Nels Anderson, di genitori svedesi, americano di nascita, vagabondo per scelta. La sua vita di vagabondo, o hobo, lo condusse, anche lui per caso, a divenire un vero e proprio sociologo specializzatosi in quella che era la sua vita, di hobo, prima di divenire uno studioso noto.
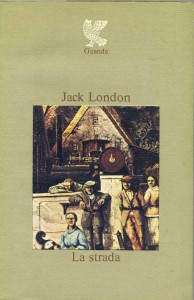 Il suo testo più famoso, in questa chiave, è infatti Hobo. Il vagabondo in cui prende come oggetto di studio i senzatetto di Chicago – lui era stato uno di loro a Chicago e, prima ancora di iniziare gli studi, in giro per gli Stati Uniti – raggruppati in alcune zone specifiche della città chiamate per l’appunto Hobohemia (Anderson 1996). Oltre ad analizzare più oggettivamente la vita dei senzatetto di Chicago, Anderson racconta senza vergogna pure la sua, mettendo l’accento sul rapporto stretto esistente tra il processo di americanizzazione e la vita itinerante e sregolata degli hobo: questi, essendo lavoratori migranti, senza scopi precisi, non attaccati a un luogo in particolare, risultavano gli operai più adatti per l’avventura (quasi) senza fine della storia della frontiera americana rappresentata, tra gli altri eventi, dalle concessioni minerarie e dal progetto americano di costruzione ferroviaria:
Il suo testo più famoso, in questa chiave, è infatti Hobo. Il vagabondo in cui prende come oggetto di studio i senzatetto di Chicago – lui era stato uno di loro a Chicago e, prima ancora di iniziare gli studi, in giro per gli Stati Uniti – raggruppati in alcune zone specifiche della città chiamate per l’appunto Hobohemia (Anderson 1996). Oltre ad analizzare più oggettivamente la vita dei senzatetto di Chicago, Anderson racconta senza vergogna pure la sua, mettendo l’accento sul rapporto stretto esistente tra il processo di americanizzazione e la vita itinerante e sregolata degli hobo: questi, essendo lavoratori migranti, senza scopi precisi, non attaccati a un luogo in particolare, risultavano gli operai più adatti per l’avventura (quasi) senza fine della storia della frontiera americana rappresentata, tra gli altri eventi, dalle concessioni minerarie e dal progetto americano di costruzione ferroviaria:
«La prima di queste frontiere fu quella della scoperta sorprendente, dell’avventura romantica, della sfida allo spirito d’iniziativa. Ci si impadronì di foreste e terreni e si recintarono concessioni minerarie. […] I più lavoravano alle dipendenze di altri. Lavoravano e si spostavano, portandosi dietro il materasso sulle spalle. Erano i primi hobos. Il loro numero si moltiplicò quando incominciò la costruzione delle ferrovie e quando furono necessari altri tipi di imprese. Lavoravano in luoghi in cui non esisteva disponibilità di manodopera» (Anderson 1996: 13).
A una prima lettura del brano, si ha l’impressione che Anderson intrecci un rapporto stretto e univoco, di tipo più economico, tra il bisogno di manodopera per la mobile frontiera americana e la creazione di questa strana figura di lavoratore migrante, senza dimora, definito hobo. La figura dell’hobo è stata creata per le necessità del processo di americanizzazione dello spazio? L’hobo è un puro effetto di cause economiche contingenti? Le ragioni economiche hanno prevalso sul resto? In realtà, nonostante questo rapporto di tipo economico sia realisticamente appurato, Anderson, al pari di London, considera quello dell’hobo uno stile di vita vero e proprio, tutto sommato sganciato dalla stretta contingenza economica e dalle sole necessità di lavoro in relazione alla frontiera mobile del Paese. Questo vale ugualmente per Anderson in quanto hobo lui stesso e per la sua famiglia di migranti con un padre in perpetuo spostamento da un posto all’altro dell’America. Uno degli elementi caratterizzanti lo stile di vita hobo è legato al caso e all’assenza di una vera pianificazione di vita a lungo termine: un hobo si lascia trasportare dal caso, dagli eventi contingenti, si adatta in qualche modo alla situazione che gli si presenta, se la ritiene di suo gusto e gradimento.
Fu per caso che Anderson si decise a tornare a scuola: in una delle famiglie in cui lavorava, fu spinto a iscriversi a scuola e lui lo fece per assecondarli e fare loro piacere, visto che lo avevano accolto in casa come uno di loro. Come dice lui stesso, egli non si poneva alcun traguardo per quanto riguardava l’istruzione: era un interesse, tutto qui. In seguito, nella continuazione degli studi universitari questo principio restò valido e lo applicò alla stesura del volume che lo avrebbe reso famoso in seguito: «Per usare un’espressione hobo, la preparazione del libro era un modo per ‘tirare avanti’, per guadagnarmi da vivere finché questo processo era in corso» (Anderson 1996: 9). Insomma, un hobo non fa progetti di lunga gittata e, se li fa, è soltanto perché, essendovi trascinato per una ragione o l’altra, li trasforma in processi di vita vissuta al presente, sottoposti al vaglio del caso sempre bene accetto. Un hobo è, in definitiva, qualcuno che è mosso dal desiderio di lavoro saltuario e dalla mobilità, non sopporta l’oppressione delle convenzioni, preferisce viaggiare piuttosto che sistemarsi, predilige la strada più che le radici. A ben vedere, oltre che esplorazione di un fenomeno sociale quale è la diffusione della figura dell’hobo, il libro di Anderson è un elogio della frontiera che si travalica in continuazione, dello stile di vita libero e degli americani in quanto individui mobili nei diversi aspetti della vita:
«Gli americani sono con ogni evidenza il popolo occidentale più mobile. Lo sono dal punto di vista della residenza, perché si spostano da una casa all’altra. Lo sono perché si spostano da un posto all’altro, dalla città alla campagna, dal centro cittadino alle periferie, da una città ad un’altra, da una regione ad un’altra. Lo sono dal punto di vista della professione, perché passano da un lavoro all’altro o da un genere di lavoro all’altro. Lo sono infine da un punto di vista sociale, nei loro movimenti verso l’alto o verso il basso da una classe all’altra. Lo hobo si spostava anche in armonia con questa tradizione di mobilità e può avervi contribuito» (Anderson 1996: 14).
In definitiva, le ragioni economiche, da sole, non sembrano spiegare il fenomeno dell’hobo che, se si segue Anderson alla lettera, deve essere visto come un vero e proprio stile di vita, forse la più profonda incarnazione dello spirito americano in tutti i suoi aspetti, se non altro quelli relativi alla mobilità, allo slancio verso la frontiera, alla capacità di adattamento. Una espressione esemplare che meglio definisce la vita degli hobo è ‘tirare avanti’; in sé, soprattutto ai giorni nostri, questa espressione può avere forti valenze negative; in realtà, nel mondo degli hobo, questa espressione soleva mettere l’accento sull’intenzionale assenza di un piano d’azione di lunga portata e sulla capacità, ogni giorno messa nuovamente alla prova, di mettersi in gioco per cavarsela. Ai miei occhi, di più, gli hobo incarnano soprattutto la figura di chi forza i limiti della dimensione temporale più tipica del vivere, andando oltre la scansione comune articolata tra presente, passato e futuro: gli hobo vivono – vivevano – il più possibile nel presente, dando meno spazio al passato, sicuramente uno ridottissimo al futuro come forma di pianificazione da realizzare nel tempo.
Vivere nel presente? Se accettata, questa affermazione porta con sé alcune osservazioni importanti, d’ordine ampiamente antropologico, comunque delicate da affrontare brevemente: il primo punto è che la marginalità, più in generale, non sempre è una forma di degradazione, di solo impoverimento economico, ma può inoltre rappresentare un modo di affrontare la vita diversamente dalla massa, un modo di essere se stessi, rifiutando le convenzioni imposte da altri individui; il secondo punto è che la strutturazione del tempo della vita, persino all’interno di una cultura occidentale, quale è quella americana, è soggetta alla diversità più ampia, a tal punto, come nel caso degli hobo, da apparire in netta dissonanza con la temporalità pur prevalente di altri americani e del loro stile di vita. Vivere nel presente, rifiutando altre forme di temporalità, può dunque essere una forma di protesta, nonché l’affermazione della propria alterità; per quanto riguarda la temporalità in sé, in definitiva, è importante ribadire il principio che essa può fornire un bell’ambito di studio non necessariamente da realizzare in versione esotizzante, in luoghi lontani, poco conosciuti.
La vita quotidiana è, ormai da tempo, un campo di osservazione esemplare per gli antropologi, da approfondire – secondo me – per comparazioni più audaci con testi di filosofia e letteratura; è utile infatti, in chiave antropologica, incrociare gli sguardi su testi di filosofia, letteratura e al contempo sui resoconti di vita vissuta al fine di svelarne gli stretti intrecci d’ordine temporale, spaziale e attoriale. Per quanto riguarda il tempo, per esempio, Kermode ricorda efficacemente quanto diversa possa essere la concezione del tempo in ambito filosofico in contrasto con quella religiosa: «Nella Bibbia il mondo nasce dal nulla. Per gli aristotelici, il mondo è eterno, senza principio e senza fine» (Kermode 2004: 62). Le due concezioni, in cui si mescolano però principi di riferimento filosofico più astratto (i filosofi aristotelici) e modi di vita più sentita (si pensi ai cristiani), sono in opposizione, una opposizione che si sgretolerà nel tempo e darà vita ad altre concezioni ugualmente interessanti. Più in là, nel suo volume, Kermode fa riferimento a tante opere letterarie per mettere in risalto i diversi modi secondo cui il tempo viene discretizzato al loro interno, focalizzando talvolta più sulla dimensione del presente o talaltra più su quella del futuro o del passato. In alcuni casi, è sorprendente quanto forte sia la proiezione in una direzione o l’altra. Per esempio, in «Macbeth c’è il desiderio di sentire in ogni istante il futuro, di essere trasportati al di là dell’ignoranza presente […] Macbeth è un uomo che vive in un diverso ordine temporale. Il mondo nutre le finzioni che si costruisce per il futuro» (Kermode 2004: 75).
Insomma, la filosofia e la letteratura sono ottimi serbatoi di cristallizzazione della dimensione temporale e della sua diversità, da scandagliare in chiave comparativa, antropologica, tenendo il riflettore puntato sulla vita quotidiana, sebbene essa sia di primo acchito più sfuggente, meno straniante. A un esame più approfondito, è persino più stupefacente scoprire – nella realtà di tutti i giorni, nel lavoro, negli studi o negli affetti – quanto frastagliato sia il ritaglio specifico della dimensione temporale e quanto grande sia la sua importanza nella costituzione dell’alterità-identità, persino della presupposta marginalità interna a una cultura, come è il caso degli hobo e della frontiera americana. L’hobo, in ultima analisi, si può dire che sia stato il risultato di un’esigenza dell’avanzamento della frontiera – trovare prontamente la manovalanza – ma è stato pure una delle figure chiave per ripensarla nel suo insieme e, allo stesso tempo, per ripensare la fissità insita nelle tiranniche convenzioni di una certa società americana.
Per quanto mi riguarda, alla maniera degli hobos, più che come baluardo invalicabile, amo pensare le «frontiere come qualcosa da superare, spingere indietro, varcare» (Deleuze 1998: 42). Lo stesso penso delle convenzioni, frutto di una tensione unilaterale – e non multi-prospettica, come dovrebbe invece essere secondo me – della cultura. Non so ancora bene, quindi, perché torno a New York dopo tanti anni di apparente indifferenza. I sensi del ritorno sono molteplici e, in questo saggio, io ho incominciato a lasciare traccia sparsa della loro valenza, in attesa di una loro maggiore sedimentazione, magari per un altro saggio, in cui la mia ‘coscienza di adesso’ – spero – resisterà un po’ meno alla mia ‘coscienza di allora’. Come sottolinea Derrida a proposito di coscienza, siamo «lontani da averla fatta finita con essa» (Derrida 1997: 363). E la mia coscienza ha lavorato qui, almeno, in due direzioni diverse: da una parte, raccontando me stesso direttamente senza ricorrere ossessivamente alle citazioni e convenzioni scientifiche; dall’altra, resistendo e cercando vie di fuga, da me stesso, negli allacci forniti dalle esperienze di scrittori, sociologi e antropologi.
Il quesito si pone più in generale ed è molto controverso nelle scienze sociali: in che misura il vissuto personale abbisogna delle convenzioni scientifiche per potere essere considerato – una volta trasposto in forma narrata e descrittiva – testo appartenente a una disciplina quale, per esempio, l’antropologia o la sociologia? Non ho lo spazio per affrontare la questione, mi interessava qui soltanto mettere in risalto alcuni elementi di interessante frizione personalmente vissuti attraverso il mio passato di migrante in fuga e il mio presente di antropologo in viaggio. Questa di cui parlo non è infatti la sola frizione messa in opera in questo saggio-narrazione. La presente riflessione mi è stata inoltre utile per ‘iniziare’ un affondo – in chiave autoetnografica (Reed-Danahay 1997; Okely, Callaway 1992) – nelle frizioni che può dare l’avvicendarsi tra il ‘passare’ e il ‘sedimentarsi’ del passato e alcuni sensi che possiamo attribuirgli. Il passato, invece di passare, spesso si sedimenta in quanto senso nostalgico dell’essere situato. Più che passare dolcemente, ‘comincio’ a supporre, il (mio) passato scivola vorticosamente sotto i significanti, finché, a un certo punto, per qualche evento non meglio identificato, si mostra significato restio al dinamismo del divenire e chiede attenzione partecipata, sedimentandosi. Le frizioni tra ‘io narrante’/‘convenzioni scientifiche adottate’ e le frizioni ‘tempo che passa’/‘tempo sedimentato’ sono state da me associate a un terzo elemento di frizione prendendo per l’appunto come spunto gli hobos: la vita come scorrere per segmenti pianificati rispetto alla vita concepita per discontinuità non terminative (direbbero i linguisti) e teleologiche (direbbero i filosofi).
Questo breve saggio è stato infatti pensato all’insegna del cominciare anche per tenere a mente due interrogativi: come vivere oggi? Come pensare il nostro tempo? Si può vivere in maniera più lineare o per incastri di inizi. L’inizio può sfociare in un segmento che rappresenta una parte intermedia di un’azione-narrazione e prevede una parte conclusiva che risolve la tensione narrativa accumulatasi precedentemente. Il prototipo dello schema precedente è questo: inizio, durata intermedia, epilogo. A questo modello, se ne può virtualmente opporre un altro in cui l’inizio, più che confluire nella sua continuazione evenemenziale e prevedere un epilogo, trasporta verso un altro inizio, e così via di seguito, d’inizio in inizio, marcando più fortemente le discontinuità che le continuità, più il senso di trazione irrisolta che lo scioglimento conclusivo del terminare. Si può, alla maniera degli hobos, avanzare per pluralità di inizi, per salti e assemblaggi non lineari. Il mio passato si fa allora presente – sospetto – per ricordarmi l’importanza di questo modo non lineare di esistere e vedere il mondo.
Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016
Riferimenti bibliografici
Anderson N., Hobo. Il vagabondo. Sociologia dell’uomo senza dimora, a cura di R. Rauty, Donzelli, Roma, 1996 (1923)
Augé M., L’antropologo e il mondo globale, Raffaello Cortina, Milano, 2014 (2013)
Deleuze G., Parnet C., Conversazioni, Ombre Corte, Verona, 1998 (1977)
Derrida J., Margini della filosofia, Einaudi, Torino, 1997 (1972)
Fallaci O., “Un marxista a New York”, in New York Stories, a cura di P. Cognetti, Einaudi, Torino, 2015: 232-241
Friedman J., La quotidianità del sistema globale, a cura di F. La Cecla e P. Zanini, Bruno Mondadori, Milano, 2005
Kermode F., Il senso della fine, Sansoni, Milano, 2004 (1966)
London J., La strada, a cura di A. Roffeni, Guanda, Parma, 1976 (1907)
Okely J., Callaway H., a cura di, Anthropology and Autobiography, Routledge, Londra, 1992
Reed-Danahay D., a cura di, Auto/Ethnography. Rewriting the Self and the Social, Berg, Oxford, 1997
Said E. W., Beginnings. Intention and Method, Columbia University Press, New York, 1975
Sartre J. P., “Individualisme e conformisme aux Etats-Unis”, in Situations III. Lendemains de guerre, Gallimard, Parigi, 1949: 75-91.
________________________________________________________________________________
Stefano Montes, ha insegnato Letteratura francese, Antropologia Culturale e Semiotica nelle Università di Parigi, Catania, Tartu, Tallinn, Palermo e Agrigento. Al di là delle etichette disciplinari, s’interessa ai modi molteplici secondo cui dinamiche culturali organizzano forme testuali (letterarie ed etnografiche). Nelle sue ricerche, ha privilegiato le analisi delle narrazioni di vita, lo studio delle modalità di produzione della cultura in alcuni testi esemplari, l’enunciazione della soggettività nelle teorie e pratiche antropologiche. Da alcuni anni i suoi campi di interesse scientifico vertono sulle strategie di conversione religiosa e sull’esperienza turistica.
________________________________________________________________













