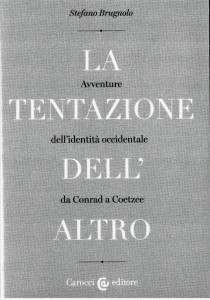La genesi dell’antropologia − o dei suoi prodromi – coincide, come è noto, con la scoperta di nuove terre, di spazi geografici inviolati, di paesaggi fisici e umani inediti. Il dispiegarsi di un orizzonte da attraversare e di un confine da varcare ha prodotto l’iniziazione a un mondo nuovo, la stupefatta epifania di una realtà sconosciuta, di un’umanità differente. L’altro è sempre esistito, era lo straniero, l’ilota, il meteco, il barbaro. O semplicemente il diverso da noi, dal momento che noi esistiamo e ci diciamo essere ciò che gli altri non sono. Il sapere empirico, però, si prepara a diventare disciplina e scienza quando la storia dell’Europa irrompe nelle vite delle popolazioni extraeuropee, quando lo sguardo sull’altro si accompagna alla conquista militare, all’occupazione territoriale, alla espropriazione coloniale. La conoscenza dell’altro si coniuga, pertanto, e si intreccia con la violenza sull’altro, con il potere sull’altro, nell’asimmetrica relazione tra egemonia e subalternità. Così è per l’esperienza di Cristoforo Colombo che – come ha dimostrato Todorov – «ha scoperto l’America, non gli americani» essendo «l’alterità umana, al tempo stesso, rivelata e rifiutata». Un’ambiguità di fondo che sarà dato strutturale e consustanziale dell’incontro con l’altro, perennemente sospeso tra il prendere e il comprendere, tra l’assimilazione e la rimozione, tra il mito del buon selvaggio e l’oltraggio dispregiativo del rifiuto assoluto.
Sull’etnocentrismo dello sguardo occidentale ha scritto vent’anni prima de La conquệte de l’Amérique di Todorov e un anno prima di La pensée sauvage di Lévi-Strauss, Giuseppe Cocchiara, autore di L’eterno selvaggio (1961), uno studio pioneristico che ripercorre le diverse tappe dell’incivilimento dei barbari ad opera dei colonizzatori, una storia ricostruita in parallelo con le diverse vicende scientifiche dell’antropologia, da Vico a Rosseau, dall’evoluzionismo positivista al funzionalismo britannico, fino ad arrivare al “rimorso dell’Occidente” che ha prodotto nel periodo della decolonizzazione luoghi non meno immaginari e ideologie del primitivo non meno prive di malintesi e manipolazioni. Nell’acuta sintesi compiuta da Cocchiara il selvaggio – realtà storica, invenzione letteraria o paradigma antropologico – è assunto a strumento di analisi e di autoanalisi culturale dell’Occidente, una sorta di alter ego attraverso il quale è possibile leggere, in filigrana o in contrappunto, la nostra identità, la civiltà e la tradizione europea. Così da constatare lungo questo percorso – come scrive lo stesso studioso – «fino a qual punto il nostro mondo si sia specchiato e riconosciuto nel mondo primitivo».
Che la storia dell’antropologia altro non sia che un’autobiografia dell’Occidente, si risolva cioè in un rispecchiamento critico e autocritico dei nostri diversi modi di guardare e considerare l’alterità in corrispondenza dell’evoluzione dei nostri diversi modi di pensare e considerare noi stessi, è in fondo la lezione di filosofia morale che risale a Montaigne che affermava: «Io dico degli altri soltanto per dire di più di me stesso». Cocchiara ne era perfettamente consapevole quando scriveva nella prima pagina del suo libro: «La barbarie, ove volessimo considerarla soltanto tale, altro non è se non un momento essenziale e imprescindibile della civiltà». Come dire che non solo il soggetto ma lo stesso oggetto della ricerca siamo stati sempre noi, noi che parliamo di loro e nel descrivere gli altri raccontiamo di noi, così che potremmo ripetere quanto Flaubert diceva di Madame Bovary: «Madame Bovary, c’est moi». In questo senso le culture extraeuropee sono state laboratorio di costruzione e plasmazione delle forme e dei valori culturali che gli europei – colonizzatori o esploratori, conquistadores o viaggiatori, evangelizzatori o etnografi – hanno attribuito e attribuiscono al concetto di uomo, all’idea di umanità.
Possiamo trasformare gli altri in noi stessi incorporandoli nelle nostre categorie e negando la loro stessa identità di individui, di collettività, di uomini. Oppure, attratti dalla diversità, da ciò che non siamo e vorremmo essere, possiamo tentare di diventare come gli altri, di abdicare alla nostra identità per assumere una qualche alterità, tra le selve di un’esotica contrada o nell’isola dell’utopica felicità. Tra il ridurre l’altro a se stessi o il diventare l’altro negando se stessi si dispiega una vasta gamma di sfumature nei punti di incrocio di questi orizzonti culturali, nel gioco multiforme delle corrispondenze, delle sovrapposizioni e delle ibridazioni. Se è vero che l’altro esalta la sua irriducibile alterità se vive e abita nell’altrove, è anche vero tuttavia quanto ha scritto l’antropologa Silvana Miceli: «Lo sguardo da lontano è uno sguardo sempre da lontano: egli conoscerà il proprio solo per la restituzione che gliene darà lo sguardo altrui, e cercherà ancora altrove come conoscere quell’altro sguardo». In questo scambio di prospettive l’osservato e l’osservatore sono implicati e impigliati nella ineludibile relazione del guardare e dell’essere guardati, nel groviglio di quelle dinamiche che costitutivamente definiscono il conoscere e il riconoscersi.
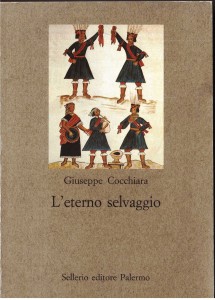 Giuseppe Cocchiara è stato tra i primi a studiare “la questione dell’altro”, passando in rassegna i fenomeni di appropriazione e riabilitazione del primitivo e del selvaggio nell’orizzonte della cultura occidentale, a partire dalla scoperta dell’America fino alla loro influenza e penetrazione nella letteratura, nella musica e nelle arti figurative del Novecento. Un viaggio in larga parte inedito che ha attraversato tre secoli e tre continenti e ha contribuito a reinterpretare i fondamenti dei saperi antropologici, a ripensare i tornanti ideologici che dal razionalismo illuministico allo storicismo romantico hanno inventato e alimentato il mito dell’eterno selvaggio. Sotto questa luce Cocchiara ha riletto Chateaubriand e Melville, i classici dell’etnologia europea, da Frazer a Malinowski, ma anche quelli della letteratura anglosassone dell’800 e del 900, il tenebroso Conrad e il vate del colonialismo inglese, Kipling, nonché i maestri del surrealismo artistico e dello sperimentalismo musicale, da Gauguin a Matisse, da Stravisnskij a Gershwin.
Giuseppe Cocchiara è stato tra i primi a studiare “la questione dell’altro”, passando in rassegna i fenomeni di appropriazione e riabilitazione del primitivo e del selvaggio nell’orizzonte della cultura occidentale, a partire dalla scoperta dell’America fino alla loro influenza e penetrazione nella letteratura, nella musica e nelle arti figurative del Novecento. Un viaggio in larga parte inedito che ha attraversato tre secoli e tre continenti e ha contribuito a reinterpretare i fondamenti dei saperi antropologici, a ripensare i tornanti ideologici che dal razionalismo illuministico allo storicismo romantico hanno inventato e alimentato il mito dell’eterno selvaggio. Sotto questa luce Cocchiara ha riletto Chateaubriand e Melville, i classici dell’etnologia europea, da Frazer a Malinowski, ma anche quelli della letteratura anglosassone dell’800 e del 900, il tenebroso Conrad e il vate del colonialismo inglese, Kipling, nonché i maestri del surrealismo artistico e dello sperimentalismo musicale, da Gauguin a Matisse, da Stravisnskij a Gershwin.
La grande lezione che ci ha lasciato lo studioso siciliano sta probabilmente nell’aver colto la centralità dello scambio come fatto storico e paradigmatico delle culture nonché fattore costitutivo delle identità degli uomini. Il suo richiamo alla coscienza europea, perché non si rinchiuda «entro le maglie di un umanesimo cui si guarda non con lo spirito innovatore proprio delle grandi tradizioni culturali, ma come una specie di idolo ormai senza templi e senza altari», è monito quanto mai esemplare ed attuale. Già mezzo secolo fa Cocchiara intuiva che la ricerca e la ridefinizione dell’identità europea passano attraverso l’incontro e il confronto con le culture extraeuropee, ovvero la convivenza e l’integrazione con i popoli che un tempo chiamavamo primitivi o selvaggi per giustificare la nostra ansia “civilizzatrice”. A quanti, «nutriti del midollo di leone della cultura europea», sembrano voler esorcizzare «a suon di piffero umanistico» la complessità e la ineludibilità della contaminazione storica e culturale nel destino dell’Europa potremmo ripetere il grido di quel Pigmeo dell’Africa equatoriale che rivolgendosi al missionario Padre Trilles esclamò: «Oh! Quanto sono bestie gli Europei che ritengono noi bestie!».
Con queste parole si concludeva la preziosa e lungimirante opera di Cocchiara, pubblicata nel 1961 e opportunamente ristampata da Sellerio nel 2000 a cura di Gabriella D’Agostino. Da allora moltissime ricerche sono state condotte nell’ambito degli studi postcoloniali sui temi dell’incontro con l’altro e, più in generale, sulle questioni teorico-metodologiche che la globalizzazione e le grandi migrazioni contemporanee sollecitano in ordine alle dicotomie identità/alterità e alle rappresentazioni prodotte nel campo delle scienze sociali e in letteratura. Come aveva intuito Cocchiara, «il primitivo che i bianchi adescavano con le perline di vetro è completamente scomparso. Oggi non esistono più popoli che sono soltanto delle appendici coloniali. Esistono popoli che rivendicano la loro qualità umana e il loro diritto di fare parte di una umanità priva di pregiudizi». Eppure il selvaggio è ancora lì, eternamente altro da noi, nella sua incomprensibile differenza che lo fa straniero senza nome, migrante senza storia, clandestino senza diritti. Nella convinzione ancora oggi persistente e diffuso senso comune che il mondo è uno e si identifica con quello dei bianchi, degli europei, degli occidentali.
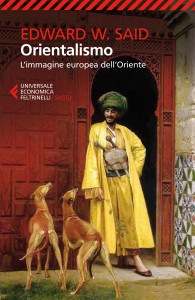 Nel frastagliato dibattito che si è sviluppato sui conflitti identitari e sulle immagini letterarie dell’alterità elaborate in Occidente, un ruolo di primo piano ha avuto, come è noto, l’opera di Edward Said, Orientalismo, che, pubblicata nel 1978, ha inaugurato un vero e proprio genere di studi critici sugli stili di pensiero e sulla colonizzazione intellettuale del mondo arabo e islamico. Nell’individuazione dei topoi più significativi dell’immaginario europeo, Said ha dimostrato che l’Oriente altro non è che un’invenzione dell’Occidente e l’orientalismo «un modo occidentale per esercitare la propria influenza e il proprio predominio sull’Oriente». Richiamando Gramsci e il concetto di egemonia, lo studioso palestinese ha passato in rassegna una grande mole di testi, di autori e di teorie della tradizione orientalista inglese, francese e americana per confutare soprattutto i processi di reificazione delle culture e delle identità intrappolate dentro retoriche e stereotipi definiti per contrapposizione. Da qui l’ampio repertorio di esotismi, di primitivismi, di erotismi, di mitologie e di romantiche fantasie associate al mondo orientale tout court, un armamentario ideologico e un apparato simbolico così egemonico e potente da orientalizzare lo stesso Oriente. «L’Oriente – scrive Said – è stato orientalizzato non solo perché lo si è trovato “orientale”, soprattutto nel senso che a tale aggettivo è stato attribuito dagli europei del secolo scorso, ma anche perché è stato possibile renderlo orientale».
Nel frastagliato dibattito che si è sviluppato sui conflitti identitari e sulle immagini letterarie dell’alterità elaborate in Occidente, un ruolo di primo piano ha avuto, come è noto, l’opera di Edward Said, Orientalismo, che, pubblicata nel 1978, ha inaugurato un vero e proprio genere di studi critici sugli stili di pensiero e sulla colonizzazione intellettuale del mondo arabo e islamico. Nell’individuazione dei topoi più significativi dell’immaginario europeo, Said ha dimostrato che l’Oriente altro non è che un’invenzione dell’Occidente e l’orientalismo «un modo occidentale per esercitare la propria influenza e il proprio predominio sull’Oriente». Richiamando Gramsci e il concetto di egemonia, lo studioso palestinese ha passato in rassegna una grande mole di testi, di autori e di teorie della tradizione orientalista inglese, francese e americana per confutare soprattutto i processi di reificazione delle culture e delle identità intrappolate dentro retoriche e stereotipi definiti per contrapposizione. Da qui l’ampio repertorio di esotismi, di primitivismi, di erotismi, di mitologie e di romantiche fantasie associate al mondo orientale tout court, un armamentario ideologico e un apparato simbolico così egemonico e potente da orientalizzare lo stesso Oriente. «L’Oriente – scrive Said – è stato orientalizzato non solo perché lo si è trovato “orientale”, soprattutto nel senso che a tale aggettivo è stato attribuito dagli europei del secolo scorso, ma anche perché è stato possibile renderlo orientale».
Nel solco della densa letteratura degli studi postcoloniali e, per certi aspetti, sulla scia del dibattito aperto dalle pagine di Said si pone il volume da poco edito di Stefano Brugnolo, La tentazione dell’Altro. Avventure dell’identità occidentale da Conrad a Coetzee (Carocci, 2017). Se i libri – come ha insegnato Umberto Eco – dialogano tra di loro, incrociando e intrecciando idee, immagini e storie, così non è sempre tra gli uomini e le diverse visioni del mondo. Aspro, difficile e, a volte, impossibile è il dialogo cercato, intrapreso o negato con l’altro diverso da noi, con l’altro che abita in un lontano e misterioso altrove. Soprattutto quando l’incontro è uno scontro e l’altro è il vinto, l’umiliato, l’offeso. Pur nell’asimmetria dei rapporti, resta tuttavia dell’altro una irresistibile fascinazione che, per quanto ambigua e contraddittoria, dà origine a scarti, faglie, resilienze, illuminazioni, suggestioni, involontarie rivelazioni. Impegnato nella ricerca di ciò che ha prodotto la tentazione dell’altro, il desiderio di essere altro da sé, di diventare uno di loro (going native), Brugnolo dipana i fili del lungo e ininterrotto colloquio che la letteratura europea tra Ottocento e Novecento ha intrattenuto con il mondo extraeuropeo, con le culture dei popoli colonizzati. Scorre quindi nelle pagine di quest’opera una ricca e straordinaria antologia di altre pagine stralciate da romanzi e racconti che hanno contribuito alla conoscenza di quella umanità “altra”, estranea alla “cultura” e vicina alla “natura”. E nel libro dialogano autori lontani nel tempo e nello spazio, con i personaggi e le loro vite declinate entro canovacci e moduli narrativi che sembrano replicare le principali funzioni proppiane: l’allontanamento, il divieto e l’infrazione, la prova e il suo superamento, la sfida con l’antagonista e l’esito finale.
Da Cuore di tenebre di Conrad a Aspettando i barbari di Coetzee, in più di un secolo di narrazioni, la letteratura ha rappresentato l’avventura di chi si sporge oltre i confini per sradicarsi dalle proprie origini, di chi volendo uscire dal proprio mondo “civile” prova ad abbandonarsi nelle profondità della “selva”, nell’oscure regioni e nelle imperscrutabili ragioni dell’alterità. Abiti quest’ultima nell’Africa nera o nelle isole della Polinesia oppure più recentemente nei Paesi dell’Islam, la struttura che sottende la morfologia delle storie riproduce un eguale schema, riconducibile al processo di mutamento e di inveramento del soggetto protagonista a fronte di una realtà sconosciuta e per ciò stesso perturbante. Le citazioni rimbalzano come in una rifrazione di specchi in un’attenta ed efficace analisi intertestuale di tipo comparativo e restituiscono un quadro complessivo unitario che, pur nelle varianti, conferma e ripropone una unica riconoscibile tesi: nel contatto con le altre culture, nel descrivere, rappresentare e raccontare gli altri, gli scrittori europei hanno di fatto – indirettamente, involontariamente, inconsapevolmente – descritto, rappresentato e raccontato se stessi, hanno cioè tradotto l’alterità, magnificata o bandita, seducente o destabilizzante, nelle forme e nelle categorie della identità occidentale.
 «Lo straniero ci abita: – ha scritto Julia Kristeva nel suo studio Etrangers a nous-mêmes del 1988 – è la faccia nascosta della nostra identità, lo spazio che rovina la nostra dimora, il tempo in cui sprofondano l’intesa e l’empatia». E nella sua lettura psicanalitica precisava: «Il volto dello straniero ci costringe a manifestare il modo segreto che noi abbiamo di porci davanti al mondo, di guardarci tutti in faccia». Non diversamente Brugnolo fa ricorso a Freud per dimostrare che «quanto in Europa viene nascosto, negato, represso emerge prepotentemente [nelle rappresentazioni di questi scrittori], come se gli occidentali si strappassero di dosso le maschere dell’educazione e facessero finalmente vedere la loro vera natura». Così il Kurtz di Cuore di tenebra, che si inoltra nella foresta africana nella qualità di campione e interprete più convinto delle magnifiche sorti e progressive dell’Occidente, in una metamorfosi che esita in «un inquietante e rivelatore ritorno del rimosso», finisce col confrontarsi con la sua nuda umanità, «quella che vede rispecchiata in quei selvaggi, un’umanità più istintiva, più franca, spogliata di ogni orpello».
«Lo straniero ci abita: – ha scritto Julia Kristeva nel suo studio Etrangers a nous-mêmes del 1988 – è la faccia nascosta della nostra identità, lo spazio che rovina la nostra dimora, il tempo in cui sprofondano l’intesa e l’empatia». E nella sua lettura psicanalitica precisava: «Il volto dello straniero ci costringe a manifestare il modo segreto che noi abbiamo di porci davanti al mondo, di guardarci tutti in faccia». Non diversamente Brugnolo fa ricorso a Freud per dimostrare che «quanto in Europa viene nascosto, negato, represso emerge prepotentemente [nelle rappresentazioni di questi scrittori], come se gli occidentali si strappassero di dosso le maschere dell’educazione e facessero finalmente vedere la loro vera natura». Così il Kurtz di Cuore di tenebra, che si inoltra nella foresta africana nella qualità di campione e interprete più convinto delle magnifiche sorti e progressive dell’Occidente, in una metamorfosi che esita in «un inquietante e rivelatore ritorno del rimosso», finisce col confrontarsi con la sua nuda umanità, «quella che vede rispecchiata in quei selvaggi, un’umanità più istintiva, più franca, spogliata di ogni orpello».
Il personaggio di Conrad è archetipo di una moltitudine di altre figure letterarie che nella sfida con l’altro sono dibattute tra l’onnipotenza occidentale e la fragilità morale, tra la supremazia intellettuale e lo smarrimento esistenziale. Molti scrittori dell’età coloniale e soprattutto postcoloniale, nelle storie che inventano sembrano voler introdurre elementi di una utopia inconfessata, quella di un ricominciamento, dell’iniziazione ad una nuova vita, ad un altro modo di vivere, di pensare, di immaginare, di abitare la terra. Il protagonista di Taipi di Melville si lascia andare al piacere della nudità, che è tratto fisico e simbolico dei selvaggi indigeni, aspira a diventare nativo, a farsi abitante di quell’isola che sognata come un paradiso scoprirà poi essere un inferno da cui fuggire. «La scoperta più vera – commenta Brugnolo – non è che non si può vivere da selvaggio tra i selvaggi, ma che non si può scappare dalla propria cultura e dai suoi condizionamenti».
Lo stesso paradiso dipinto da Gauguin a Tahiti è immaginario, artefatto, «perduto proprio perchè gli occidentali lo hanno ritrovato». Lo stesso pittore, nel suo diario di viaggio Noa Noa, ha confessato: «Avevo fatto tanta strada per ritrovare proprio quello da cui io fuggivo». Analogamente l’India trasfigurata da Kipling è assai diversa dall’Inghilterra vittoriana e imperiale ma è anche lontana dalla vera India, e il Medio Oriente descritto da Lawrence è spazio dell’orientalismo nostalgico e dell’inevitabile scacco, dal momento che, come ha scritto l’autore, «non seppi entrare nella pelle degli arabi; la mia era soltanto un’affettazione. È facile per un uomo diventare un infedele ma difficile convertirsi a una fede nuova. Mi ero spogliato di una forma senza assumerne un’altra».
Nelle parole di Lawrence si compendiano le esperienze umane e intellettuali di quanti avendo cercato l’Oriente hanno ritrovato l’Occidente, restando impigliati in una tensione cognitiva e morale che consente di sporgersi sul crinale della propria identità senza tuttavia uscire mai del tutto dall’appartenenza al proprio mondo. L’unico modo per tentare di entrare nella pelle di un altro popolo – suggerisce Vargas Llosa nel suo romanzo Il narratore ambulante – è quello di ascoltare le loro storie, di farsene coinvolgere e provare a rinarrarle. In questo circuito di migrazioni delle parole dell’immaginario sembra consistere la effettiva conversione delle identità nella reciprocità dell’immedesimazione nell’altro da sé. Che il racconto sia il luogo possibile dell’incontro paritario tra le culture, «dove esperienze, credenze, memorie possono essere scambiate, condivise e salvate», è come dire che la letteratura è metafora del dialogo tra gli uomini, lo spazio in cui le ambivalenze denunciate valgono a disvelare la realtà nascosta, le verità negate. I grandi scrittori sono proprio quelli che rappresentano nelle loro opere le inadeguatezze, le contraddizioni e le aporie del nostro stare nel mondo e, nello specifico, del nostro entrare in rapporto con l’altro, un incontro che con le sue problematicità è fatto di slanci e di cadute, di generose illusioni e di lancinanti sconfitte.
La letteratura europea, a lungo ritenuta complice e fiancheggiatrice delle violenze razziali e dei soprusi etnici consumati dall’imperialismo e dal colonialismo, è invece nelle sue espressioni più alte una mappa preziosa per leggere le avventure dell’identità occidentale nell’Oriente reale e immaginato, vero e inventato: «una sorta di contro-canto a più voci della grande e terribile impresa che fu (ed è) il tentativo di imporre un unico modo di vivere e pensare nel mondo intero», scrive Brugnolo. Le storie dei classici hanno il potere di squarciare il velo di Maya delle ideologie, di oltrepassare le stesse volontà dichiarate degli autori, di significare, a livello di strutture profonde, distanziamenti e resistenze, diserzioni e trasgressioni rispetto a ciò che, a livello di strutture apparenti, sembra coerente a princìpi, norme e concezioni politicamente coerenti alla vulgata coloniale occidentale. «Se ci parlano ancora è perché esplorano con onestà e radicalità i conflitti tra idee e schemi di pensiero occidentali (da loro, almeno in parte, condivisi) e la potenza destabilizzante degli incontri e delle esperienze reali, e delle emozioni da questi provocate».
 Il viaggio che Brugnolo ci invita a compiere attraverso le opere degli scrittori di questa letteratura ci fa sfogliare le pagine di Stevenson e di Malraux, di Gide e di Céline, di Maugham e di Faulkner, di Borges e di Flaiano, di London e di tanti altri fino a condurci a quelle più recenti di Naipaul, di Carpentier e Forster. Sia nell’Africa nera o nell’Arabia felix, sia nell’America latina oppure nell’India, l’altro che gli europei incontrano resta loro inattingibile e incomprensibile, avvolto nell’indecifrabilità di un mondo che destinato ad essere cancellato dal Progresso mostra di esistere, di resistere e di sfidare con la sua stessa esistenza la prepotente omologazione del potere occidentale. Da qui la doppia lettura che è possibile sperimentare attraverso quell’esperienza raccontata dagli autori che nel cercare di conoscere l’alterità finiscono col ritrovare l’identità perduta. Le svestizioni o le conversioni che i protagonisti compiono per tentare di avvicinarsi o di abbandonarsi all’altro, nel fare da contrappunto all’opera di dominio esercitato dai colonizzatori, segnalano quale fascino attrattivo sia implicito nella relazione problematica con l’altro e quanto «l’incontro con la diversità umana sia una sfida cognitiva e morale per tutti».
Il viaggio che Brugnolo ci invita a compiere attraverso le opere degli scrittori di questa letteratura ci fa sfogliare le pagine di Stevenson e di Malraux, di Gide e di Céline, di Maugham e di Faulkner, di Borges e di Flaiano, di London e di tanti altri fino a condurci a quelle più recenti di Naipaul, di Carpentier e Forster. Sia nell’Africa nera o nell’Arabia felix, sia nell’America latina oppure nell’India, l’altro che gli europei incontrano resta loro inattingibile e incomprensibile, avvolto nell’indecifrabilità di un mondo che destinato ad essere cancellato dal Progresso mostra di esistere, di resistere e di sfidare con la sua stessa esistenza la prepotente omologazione del potere occidentale. Da qui la doppia lettura che è possibile sperimentare attraverso quell’esperienza raccontata dagli autori che nel cercare di conoscere l’alterità finiscono col ritrovare l’identità perduta. Le svestizioni o le conversioni che i protagonisti compiono per tentare di avvicinarsi o di abbandonarsi all’altro, nel fare da contrappunto all’opera di dominio esercitato dai colonizzatori, segnalano quale fascino attrattivo sia implicito nella relazione problematica con l’altro e quanto «l’incontro con la diversità umana sia una sfida cognitiva e morale per tutti».
Se è vero che l’altro offre a noi uno specchio di ciò che non siamo ma avremmo potuto diventare, lo straniero in quanto altro da noi vale a denunciare l’arbitrarietà e la parzialità di quell’etnocentrismo che ci fa ritenere la nostra cultura universale e unica, facendoci così scoprire che la nostra forma di umanità è soltanto una delle tante possibili e che l’alterità vagheggiata e cercata fuori di noi è in realtà dentro di noi. A guardar bene, infatti, «civiltà e barbarie sono due possibilità dell’umano, due facce della stessa medaglia eternamente compresenti», scrive Brugnolo, non diversamente da quanto aveva già intuito Cocchiara e da quanto ebbe a scrivere Lévi-Strauss nel suo impareggiabile Tristi Tropici, che è diario esemplare di un viaggio e di una ricerca antropologica sulle culture altre del Brasile per ritrovare ovunque l’uomo e l’elementarmente umano, al di là dei confini e oltre le latitudini:
«… ero andato fino in capo al mondo in cerca di quel che Rosseau chiama “il progresso quasi insensibile degli inizi”. Sotto il velo delle leggi troppo sapienti dei Caduvei e dei Bororo, avevo perseguito la mia ricerca di uno stato di cose che – dice ancora Rosseau – “non esiste più, forse non è mai esistito, e probabilmente non esisterà mai e di cui ciononostante è necessario avere delle nozioni giuste per ben giudicare il nostro stato presente”. Più fortunato di lui, credevo di averlo scoperto in una società agonizzante, ma della quale era inutile chiedersi se rappresentava o no un vestigio: tradizionale o degenerata, essa mi metteva comunque davanti a una delle forme sociali e politiche più povere che si possano concepire. Non avevo bisogno di rivolgermi alla storia particolare che l’aveva mantenuta in quella condizione elementare o che, più verosimilmente, ve l’aveva ricondotta. Bastava considerare l’esperienza sociologica che si svolgeva sotto i miei occhi. Ma proprio questo mi sfuggiva. Avevo cercato una società ridotta alla sua espressione più semplice. Quella dei Nambikwara lo era a un punto tale che vi trovai solo degli uomini».
Lévi-Strauss non ha conosciuto gli ultimi sviluppi della globalizzazione e l’insorgere dei tumultuosi flussi migratori che oggi massicciamente investono il continente europeo. Aveva tuttavia percepito che i figli delle ex colonie, gli abitanti delle isole esotiche e remote o dei piccoli villaggi lontani e sperduti, inconsapevoli vittime o soggetti attivi dell’omologazione planetaria, avrebbero abbandonato terre desertificate e comunità lacerate da guerre e pestilenze, sarebbero diventati ospiti delle nostre città, profughi o clandestini, stranieri tra gli stranieri destinati a convivere in società multietniche e multiculturali. L’altro, infatti, strappato alla nostalgia e alle seduzioni dell’altrove è adesso davanti a noi, è lo straniero che ci guarda e si offre al nostro sguardo, il migrante che ci interroga e ci spaventa. E ancora ci tenta. Vivere con l’altro ci mette di fronte alla possibilità di «essere al posto suo, cosa che equivale a pensarsi e a farsi altro da se stesso». Così scriveva Julia Kristeva nello studio del 1988. E con acuta lungimiranza aggiungeva:
«Il problema, ancora e sempre utopico, si pone di nuovo oggi, di fronte a un’integrazione economica e politica su scala planetaria: riuscire intimamente, soggettivamente, a vivere con gli altri, a vivere da altri, senza ostracismi ma anche senza integrazioni livellanti? Il modificarsi della condizione degli stranieri che va imponendosi ai giorni nostri invita a riflettere sulle nostre capacità di accettare nuovi modi di alterità».
Vivere con gli altri, vivere da altri, senza ostracismi ma anche senza integrazioni livellanti: questa è la strada stretta che dobbiamo percorrere perché l’incontro con gli altri non sia un incontro mancato. Questa la lezione che la letteratura può ancora insegnarci: noi non siamo come loro ma potremmo o vorremmo essere come loro. Riconoscere ed ospitare l’altro, divenire altro da sè fino a tentare di farsi altro in sè è in fondo l’utopica metafora letteraria che ci rende consapevoli della nostra più intima e rimossa angustia, della nostra inconfessata e inconfessabile incompiutezza.
Dialoghi Mediterranei, n.28, novembre 2017
_______________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. La sua ultima pubblicazione è la cura di un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (2015)
________________________________________________________________