di Stefano Montes
Leggo un testo di antropologia, inerme davanti la televisione, inerme sotto i colpi delle brutte notizie, inerme contro il dilagare, in apparente contrappeso, del chiacchiericcio inutile: mescolanza strana, mescolanza curiosa da cui prendere le distanze. Inerme? Per ora ascolto, poi si vedrà. Ascolto diffidente e lascio che le perplessità prendano corpo, non cedo al lavaggio del cervello e non consento ai cicalecci indistinti di prendere piega impunita. Letteratura ed etnografia mi danno una mano solerte; come sempre, come so, infatti, altri tipi di mescolanza mi interessano. Nel frattempo, con le orecchie sempre ancorate al flusso televisivo, disimpegno gli occhi dal quadrato della manipolazione mediatica per sfogliare, leggere attentamente, sottolineare a matita e tornare indietro di qualche pagina. Sottolineo. Chiudo il libro che ho nella mano aperta e mi scollo dal divano per sgranchirla un po’. Riprendo a leggere, con il mento sul palmo stanco della mano distratta, come la mia mente cullata dal tamburellare dell’altra mano, quella ribelle, meno obbediente al mio dispotico volere. Leggo. A Palermo. In piena estate. Di tanto in tanto, mi appiccico sul divano in finta pelle. Fa un caldo torrido e non me ne importa molto. Mi appiccico. Più che altro, sento correre leggeri rigagnoli sul mio corpo leggermente indispettito. Piccole, quasi impercettibili gocce di sudore ingioiellano – ovviamente, si fa per dire! – la mia pelle infastidita e si tuffano sul divano, non senza aver prima percorso strade accidentate, impreviste, rese talvolta praticabili dai miei movimenti inconsulti. Il corpo, nel suo insieme, si adegua e si rende docilmente oggetto spazializzato delle gocce di sudore che imperversano qui e lì; la mano, in quanto elemento singolo, si improvvisa agente operoso dalle molteplici sembianze: solerte, aperta, distratta, pesante, ribelle. È ovviamente in corso uno dei tanti processi di quotidiana oggettivazione e soggettivazione in cui parti del corpo si improvvisano individualmente attori del fare.
Così è, bisogna farsene una ragione: persino una stessa parte del corpo, in momenti ravvicinati della giornata, tende a soggettivarsi od oggettivarsi, indipendentemente dalle intenzioni esplicite di un ego generalizzato o di una mente direttrice. Intanto, il processo corporeo è in corso, mentre ‘io’ faccio altro: sfoglio, leggo, sottolineo. Mi appiccico. Sì, mi appiccico sul divano e non me ne rendo nemmeno conto, tanta è la voglia di correre sulle pagine e inghiottire nozioni e confrontare posizioni, riassumere a caldo alcuni frammenti e valutarne, freddo e distaccato, altri. Freddo? Piuttosto, dovrei dire caldo, il caldo diffuso nell’aria afosa della stanza. Il mio corpo, per mia buona sorte, fa tutto da solo: si stacca e si sposta più in là, si riposiziona e si adagia come un paese intero «nel suo camice di neve» (Ungaretti 1969: 66). Lo lascio fare, senza intervenire. Il caldo non è mai stato per me un vero problema: l’ho sempre associato alla spiaggia, ai tuffi in acqua, alla pesca nei fondali marini. Tutte attività che ho praticato per anni con piacere. Il caldo, subìto o avversato, è però un tema trascurato nelle etnografie, nonostante si presti bene a dare un ruolo di primo piano al corpo in quanto operatore materiale e simbolico di commistione di attività cognitive, emotive e sensoriali. Negli Argonauti di Malinowski, un testo considerato un vero e proprio classico dell’etnografia, «sul caldo e su come convivere con esso non c’è nulla; al contrario, la realtà in quel lavoro è rappresentata. È visiva e distanziata, sia nelle fotografie sia quando viene espressa a parole. È presentata come un’esperienza esterna al corpo» (Taussig 2004: 46).
Per imporre una prospettiva antropologica più incentrata sull’esperienza del corpo – non più inteso come entità già data a priori, ma nemmeno puramente rappresentata – si dovrebbero ripensare i modi secondo cui si richiamano e si traducono vicendevolmente i flussi sensoriali, cognitivi e patemici: un ruolo centrale in questo senso lo gioca la figura della sinestesia proprio perché consente di riaffermare il valore di miscela – ogni volta nuovamente rimescolata dalla torsione culturale e individuale – di pensieri, emozioni e sensazioni (Montes 2014a). È per l’appunto questa miscela che mi appassiona. Che voglio scombinare e ricombinare a modo mio. Per gioco e per dispetto. Qualche tempo fa ormai, Lakoff e Johnson riaffermavano il valore culturale della metafora e il ruolo, profondo ma piuttosto trascurato fino al loro studio, che essa gioca nel vissuto quotidiano. La metafora rimaneva però la figura regina attraverso cui interpretare la realtà e un dispositivo, tutto sommato concettuale, che concedeva poco spazio alla commistione di attività cognitive, emotive e sensoriali (Lakoff, Johnson 1998). E se invece, mi chiedo, fosse la sinestesia la figura regina del pensare-provare-sentire? Nel frattempo, al pensiero di Malinowski sul campo, il mio corpo per rispetto verso il maestro dell’antropologia funzionalista si ricompone: mi disincrosto cioè dal divino divano come se fossi una impudica patella tutta attaccata suo malgrado alla ruvida roccia, in parte eretta, modellata dal divenire del tempo. Il rumore è simile allo scorrere delle dita su un foglio di carta riluttante a cedere sotto il peso delle mano e allo scartare nervoso e ritmico delle pagine da parte del pollice indifferente. Non sono da solo, in casa, malamente alle prese con i miei pensieri, la televisione e il divano in finta pelle. Mio figlio scorazza per casa. Fortunatamente.
Ha solo cinque anni. Mattia ogni tanto mi chiede di partecipare ai giochi che improvvisa, con una creatività tutta sua, che alimenta il mio orgoglio di papà impettito. Nonostante il divano. Ha preso in mano una specie di anello di carta e mi dice che da questo momento, grazie all’anello, è diventato invisibile: anzi, per meglio dire, si rinviene un’ombra. Un’ombra, mi dice, che si aggira sorpresa per la stanza. «Perché mai un’ombra?» mi chiedo, mentre lo assecondo e seguo il suono della sua voce immaginando di incontrare il vuoto nel percorso che separa il mio sguardo dalla sua persona. Sto al gioco. Come non potrei? È mio figlio. Il credere, tra l’altro, non è un tipo di adesione limitato alle sole forme religiose: il credere è un fenomeno pervasivo del quotidiano che ci porta comunemente a fare le cose in apparenza più strane, strane solo se passate invece al setaccio di una ‘ragione altra’, non pensata come culturalizzata. Persino la ragione fa infatti parte integrata dei modi della cultura e instaura relazioni con altre ‘forme di razionalità’ quali il credere e il sapere. Altrimenti, se così non fosse, non sarebbe soltanto strano farsi il segno della croce al cospetto di due pezzi di legno incrociato, lo sarebbe pure parlare e inveire contro la sedia sulla quale si è inciampati per caso e alla quale si concede uno spazio animato di interazione e ricezione di messaggi. Le ‘stranezze’ fanno parte del(le ‘religioni’ del) quotidiano. E, poi, per tornare a mio figlio, so che il gioco avrà comunque una funzione importante nella sua vita futura: gli consentirà di acquisire la flessibilità necessaria ad assumere i vari ruoli che gli capiterà di interpretare nell’evoluzione del suo percorso esistenziale (Bateson 1996); gli consentirà, ancora, di potere contare sulla forza dell’immaginazione e di essere in grado di diventare altro da sé (Benjamin 1962). Il gioco è infatti fondato su tipi di comportamento soprattutto mimetico-immaginativo: «Il bambino non gioca solo a ‘fare’ il commerciante o il maestro, ma anche il mulino a vento e il treno» (Benjamin 1962: 71). Come si può essere un treno? Appunto, giocando.
Imitiamo qualcuno o qualcosa e ci trasformiamo in quel qualcuno e quella cosa imparando ad abbandonare un unico e solo ruolo e ad assumerne un altro: attraverso il gioco, in questo modo, il concetto di alterità diventa una pratica assimilata, meno contraddistinta da quella di identità statica. Con questa idea, mi calo tutto contento nella finzione con Mattia e, d’improvviso, la distrazione incurante si blocca, piano franta dal suono delle mie parole, scambiate nel gioco sotto forma di sussurri, pronunciate talvolta a voce alta. Mia moglie, dall’altra parte della stanza, intenta a tradurre dal francese un passo difficile, mi chiede come suona una frase in italiano. Le rispondo appena, assalito dal caldo, investito dal sapore di ruggine dell’aria immobile. Non capisco bene. Il testo che traduce è di un antropologo francese che cerca di ripercorrere le rotte di Ulisse nel Mediterraneo. Rifarne una ipotetica esperienza basta per avvalorare ipotesi? Questione difficile, tutta da vedere. Cerco invece di concentrarmi sul valore del corpo in etnografia e nelle relative teorie che lo concepiscono come nesso centrale dell’uomo nel mondo. In Anima e corpo, diversamente da Malinowski, Wacquant ha mostrato tutto il valore del corpo e del potenziale sociale, per l’individuo comune, di incorporazione delle varie attività, consapevoli e inconsapevoli, condotte quotidianamente, per diletto o per dovere: il corpo impara e insegna da sé, ci conduce per mano e reagisce con una certa autonomia. Il buon pugile non colpisce l’avversario soltanto pianificando l’azione fin dall’inizio, ma lasciando inoltre che i suoi colpi partano da sé, processualmente, in virtù di un apprendistato lungo e accurato. Proprio come qualcuno che guida un’auto lasciandosi condurre dagli automatismi. Niente da obiettare fin qui. Il corpo vive una vita in parte propria, culturalmente orientata, non totalmente asservita alla programmazione di un ego centrale, massimizzatore e pianificatore del fare.
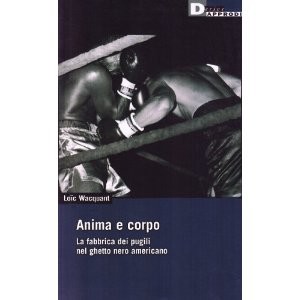 Ciò che mostra pure Wacquant è il principio, sovente dimenticato, che, oltre ad avere un ruolo centrale in quanto attore sociale, il corpo è testualizzato: leggendo l’etnografia di Wacquant si vede bene che essa afferma addirittura il carattere polifonico e pluri-genere della traduzione dell’esperienza in testo. Avanzando nella lettura di Anima e corpo, ci si rende conto che l’antropologo francese fa uso di dialoghi, appunti, riflessioni, flussi di pensiero, monologhi, ritagli di testi, foto. E quel che è ancora più interessante, in chiave semioantropologica, è che non solo Wacquant lo sottolinea, ma ribadisce inoltre una esplicita intenzionalità e progettualità nella costruzione della sua etnografia in quanto ricezione premodellizzata e inscritta nel testo stesso: «il mescolarsi dei generi e dei modi di scrivere, ma anche l’uso strategico delle immagini e delle annotazioni personali, risponde alla preoccupazione di far entrare il lettore nel quotidiano morale e sensuale del pugile ordinario, di farlo palpitare pagina dopo pagina con l’autore» (Wacquant 2002: 11). Viene quindi il bel sospetto che il meccanismo di ricezione sia tale da includere persino l’autore nelle diverse prefazioni del suo libro: man mano che il testo circolava e veniva tradotto, Wacquant stesso lo rileggeva e ne aveva una maggiore consapevolezza in quanto a ricezione, e la prefazione italiana è il risultato di questo processo. In definitiva, per sintetizzare a modo mio, il corpo è un elemento del vissuto, culturalmente recepito e prodotto, un attore pieno del fare, ma, pure, un’entità tradotta (e ritradotta) in testo. Mi chiedo se Wacquant, allievo di Bourdieu che diffidava non poco delle scienze del linguaggio, possa essere d’accordo.
Ciò che mostra pure Wacquant è il principio, sovente dimenticato, che, oltre ad avere un ruolo centrale in quanto attore sociale, il corpo è testualizzato: leggendo l’etnografia di Wacquant si vede bene che essa afferma addirittura il carattere polifonico e pluri-genere della traduzione dell’esperienza in testo. Avanzando nella lettura di Anima e corpo, ci si rende conto che l’antropologo francese fa uso di dialoghi, appunti, riflessioni, flussi di pensiero, monologhi, ritagli di testi, foto. E quel che è ancora più interessante, in chiave semioantropologica, è che non solo Wacquant lo sottolinea, ma ribadisce inoltre una esplicita intenzionalità e progettualità nella costruzione della sua etnografia in quanto ricezione premodellizzata e inscritta nel testo stesso: «il mescolarsi dei generi e dei modi di scrivere, ma anche l’uso strategico delle immagini e delle annotazioni personali, risponde alla preoccupazione di far entrare il lettore nel quotidiano morale e sensuale del pugile ordinario, di farlo palpitare pagina dopo pagina con l’autore» (Wacquant 2002: 11). Viene quindi il bel sospetto che il meccanismo di ricezione sia tale da includere persino l’autore nelle diverse prefazioni del suo libro: man mano che il testo circolava e veniva tradotto, Wacquant stesso lo rileggeva e ne aveva una maggiore consapevolezza in quanto a ricezione, e la prefazione italiana è il risultato di questo processo. In definitiva, per sintetizzare a modo mio, il corpo è un elemento del vissuto, culturalmente recepito e prodotto, un attore pieno del fare, ma, pure, un’entità tradotta (e ritradotta) in testo. Mi chiedo se Wacquant, allievo di Bourdieu che diffidava non poco delle scienze del linguaggio, possa essere d’accordo.
I pensieri corrono e lo sguardo accelera come un treno sul libro alla ricerca di conferme. Leggo. Mattia non mi dà comunque tregua, con la spada in mano, assicura gran fendenti a destra e a sinistra della mia figura sorpresa dal sudore che si guadagna terreno spavaldo sulla mia pelle di viso pallido. Mi suggerisce di rimanere immobile, mi assicura che non sarò raggiunto dai colpi. Devo crederci, devo stare al gioco. Ho appena detto che la credenza è diffusa, una forma di efficacia simbolica che consente di andare al di là di limiti ricevuti dalla pura razionalità pratica. Non posso ritrattare proprio ora che potrei essere colpito con un gran fendente. Rimango immobile. Oltretutto mio figlio si dice invisibile: come farei, pur volendolo, a prevedere i movimenti del piccolo Mattia? È alto, nel frattempo, sulle pagine, il limpido stupore del fluire del mio pensiero: tra forme di efficacia simbolica di lévi-straussiana memoria (Lévi-Strauss 1990) e colpi di spada di forte impatto fenomenologico. Che faccio? Propendo, sotto l’urto dell’attacco, per un orientamento più fenomenologico che mi consente di ‘credere’ in un «movimento totalizzatore che raccoglie il mio prossimo, me stesso e l’ambiente nell’unità sintetica di una oggettivazione in corso» (Sartre 1960: 140). Ritradotto in situazione: Mattia, io e la stanza in cui ci troviamo nel processo di oggettivazione (e di soggettivazione) che si sta svolgendo sotto i nostri occhi (pardon, i nostri sensi). Ciò mi consente, se non altro, di prevedere i colpi e pararli. Riesco miracolosamente, tra una cosa e l’altra, nel trambusto fitto dei colpi, a leggere – dall’altro libro che tengo adesso, aperto sul divano – un passo in cui si dice che l’esperienza è fondamentale nella ricerca antropologica. I modelli totalizzanti sarebbero impotenti di fronte al relativismo delle culture e all’esperienza in prima persona della cultura.
Rifletto. Sarebbe opportuno seppellire, una volta per tutte, le grandi opposizioni del tipo universalismo/relativismo ed esperienza/modello e dalle macerie fare nascere una più efficace antropologia, una antropologia che non rinuncia alle analisi formali, in cerca di modelli, ma pur sempre attenta alle immersioni esperienziali del singolo individuo tra gli altri esseri umani e non-umani. Rifletto che sarebbe meglio andare a fare un tuffo in mare. Fa caldo. Da casa mia non dista più di un quarto d’ora. Non è poi così tardi. Il traffico, in questo torrido, lento pomeriggio d’agosto, è quasi inesistente. Sono tutti nelle ville al mare e nei paesini dei dintorni a villeggiare beati. Rifletto ancora: e se l’esperienza fosse un balenare dell’immensità del reale in fondo già considerato un’organizzazione di senso? Lotman ribadisce, a riguardo, che «la realtà extralinguistica è anch’essa concepita come una certa lingua». (Lotman 1993: 16). Se l’esperienza fosse la costrizione temporale di un guizzo, di un lampo che contiene in sé uno spazio illimitato di possibilità interne alla cultura? L’idea di immensità mi riporta alla mente un verso di Ungaretti: «E l’uomo curvato sull’acqua sorpresa dal sole si rinviene un’ombra». Mi stupisce e mi affascina l’invenzione dell’opposizione di acqua e sole che si annulla nell’ombra del soldato cullata come un neonato in tempo di pace. Ma non era in trincea, Ungaretti, quando scrisse questa poesia pacificatrice dell’animo e del corpo? Chissà poi perché volteggia nella mia mente proprio questa poesia! In contraltare, forse, per soffocare i richiami continui alla guerra in Medio Oriente. Il titolo è “Vanità”. Il telegiornale, in sottofondo, in effetti, spara raffiche di notizie sulla guerra in Medio Oriente. Sto dalla parte dei più deboli: i palestinesi. Gli israeliani lo erano com’è noto tempo addietro: gli erranti senza Stato. Ancora deboli, fino a qualche tempo fa, malgrado l’esercito poderoso. Che vanità la guerra! Sarebbe tutto più semplice se gli uni e gli altri potessero parlarsi a cuore aperto. Il miracolo del dialogo è purtroppo sfibrato dalle morti antiche che oggi, forse, si frappongono al raggiungimento della pace.
Il ritorno di “Vanità” di Ungaretti nella mia mente non è un caso, dunque. Sì, lo ricordo chiaramente: Ungaretti era in trincea quando ha scritto questa poesia e le altre della raccolta L’allegria. La vanità della guerra e di tutte le cose effimere. La vanità della ricerca antropologica fine a se stessa. La vanità e basta. Della guerra, della violenza. Il libro che ho tra le mani parla inoltre di emozioni, di una antropologia delle emozioni. È scritto da un antropologo che si pregia, a ogni piè sospinto, di avere fatto eroica ricerca sul campo. Ma si intende per campo, al solito, un luogo lontano, quasi irraggiungibile, pure pericoloso, dove si è persino rischiato di perdere la vita. E lo si dice nel testo, segnando inoltre, accuratamente, la data di partenza per il campo e la data di ritorno a casa. Sembra una informazione inutile ai più, ma, a quanto pare, secondo alcuni antropologi conferisce legittimità non solo a chi si produce in questa impresa ma all’antropologia stessa. Il mio punto di vista è invece che l’osservazione-partecipante, di cui si parla sovente in antropologia, non è altro che un situarsi, un essere nella pratica, nel ‘campo’ o altrove, in continuo divenire. E, in questo senso, bisognerebbe chiedersi cosa definisce una ‘pratica’ e come la si definisce nel tempo. Un concetto non trova quasi mai finalità in sé, ma rimanda ad altro. L’evoluzione della disciplina ha chiaramente mostrato che le diverse scuole antropologiche hanno declinato la pratica dell’osservazione-partecipante in un modo o in un altro. Il risultato di tutto questo è che si dovrebbe essere guardinghi rispetto a una definizione rigida di campo (e alle sue annotazioni testuali), tesa invece, nella prospettiva di alcuni antropologi, a essere considerata il tratto di esclusiva pertinenza dell’antropologia. Non condivido questa impostazione. L’antropologia non si definisce per le sue pratiche, anche se al plurale, di campo. Ciò che avviene, purtroppo, almeno nella mia idea, inesorabilmente diviene, quindi, sfugge nella sua totalità, e si è, insomma, sempre un passo indietro rispetto all’esperienza che abbisogna di testi e di ‘fuori campo’ per essere veicolata e ricomposta (Montes 2014b).
Continuo comunque a leggere imperterrito, nonostante tutto. Mi accorgo che la bibliografia ignora del tutto i testi di semiotica e di filosofia del linguaggio, un filone non indifferente, negli ultimi vent’anni, sullo studio delle emozioni e delle passioni. Meraviglie dell’esperienza antropologica – fortunatamente solo di alcuni studiosi – volta a cogliere la differenza delle culture altre, ad affermare una certa concezione del campo e a ignorare invece le altre discipline: un tipo di antropologia tutta tesa a cogliere l’alterità lontana e a trascurare il vissuto quotidiano in opera a casa propria. Già nel 1973, Perec si lamentava del fatto che sembravano sovente l’‘insolito’ e lo ‘straordinario’ a volerci parlare, a essere significativi, portandoci così a trascurare altri fatti meno spettacolari. «Si tratta, finalmente, di fondare la nostra antropologia: quella che ci parlerà di noi, che andrà a cercare in noi ciò che noi abbiamo così a lungo predato presso gli altri, a cercare non più l’esotico, ma l’endotico» (Perec 1989: 11-12). Mi chiedo se, da parte di alcuni antropologi ostinati a voler mantenere un ancoraggio obsoleto, non si tratti di ignoranza dei percorsi di lavoro delle altre discipline o di sola diffidenza volta a difendere uno steccato concettuale ben compartimentato che darebbe sicurezza. Come se le discipline, tutte, non fossero il risultato di un processo di disciplinarizzazione che le configura in un modo o nell’altro, nel tempo, in rapporto ai conflitti e alle negoziazioni dell’agire e pensare umano. Le discipline sono inevitabilmente il risultato di una politica della disciplinarizzazione.
Lo sguardo si posa nel frattempo sull’altro libro, ai miei piedi: Cocaina di Michael Taussig. Proprio quello che ho appena citato, più in alto, più a destra. Un testo formidabile che coniuga descrizione e storia con l’analisi dei fenomeni connessi al colonialismo, all’immaginazione e alle pratiche locali di resistenza. Il tutto in un montaggio da quasi pellicola cinematografica calcolata al millimetro. Un esempio da imitare per i contenuti e la forma. Mi torna in mente, in ambito nostrano, la coraggiosa autoetnografia di Francesca Cappelletto sul suo stato di salute e sulle interazioni con i medici (Cappelletto 2009). No, non è l’antropologia a essere antiquata: sono solo alcuni antropologi di vecchia annata, tanto vecchia che dovrebbero ormai farsi da parte o, comunque, aprirsi a prospettive di ricerca meno stantie. Mentre mi passano per la testa questi pensieri, Licia torna alla carica. Mi soffia per scherzo, a portata d’orecchio, la frase che sta traducendo. La soppeso, la pronuncio a voce alta, la ritraduco in francese a mo’ di prova. Non ne vengo a capo. Rinuncio. Improvvisamente una pubblicità chiede spazio alla mia mente vagante. In televisione dicono che il telefonino costa solo sessantanove euro. Mattia mi chiede se è poco o molto. Improvviso delle spiegazioni. Perché lui possa comprendere, mi sforzo di dire le cose come stanno, semplicemente. Sessantanove euro non è una somma da poco. Se gli dessi questa somma, potrebbe comprarsi diverse piccole cose, qualche giocattolo. Gli ricordo che quando andiamo in edicola compriamo una busta regalo con soli cinque euro. La cifra è relativa all’oggetto che si vuole acquistare e al resto delle altre somme di denaro che si prendono in considerazione. Comprare un telefonino con sessantanove euro è un affare. Ma, in sé, sessantanove euro, soprattutto in relazione alla busta regalo, è una grossa somma. Mi rendo conto di parlare da relativista. Ma anche di passare da una posizione da relativista a una condizione da universalista per potergli spiegare il ruolo del denaro e l’importanza della somma di cui mi parla. Non ha tutti i torti Barnard quando afferma che l’antropologia tutta, per partito preso, è relativista (Barnard 2002). Poi, Barnard aggiunge che sono possibili delle posizioni miste che tengono conto degli aspetti più generali che accomunano le culture, delle categorie più astratte che si possono fare valere più universalmente per società e gruppi diversi. (Mi piacerebbe dire meticciate proprio per pensare non solo gli Altri più liberamente, ma, anche, lo stesso pensiero antropologico come mescolanza.)
 Non hanno tutti i torti, il caro Barnard e il mio piccolo Mattia: sessantanove euro possono essere una grossa cifra o una cifra miserabile. Lo stipendio da ricercatore mi sembra una cifra da miserabile se lo confronto a quello che vorrei e che faccio, i miei compiti, la ricerca, la didattica e tutto il resto. È effettivamente relativo al mio stile di vita personale. Mi basta poco per stare bene: tante buone letture, qualche passeggiata al centro, una nuotatina quando sono a Palermo, in estate. Tutte cose che non costano poi tanto. Mi rincuora il pensiero che, nonostante tutta la relatività (si noti che non ho detto ‘relativismo’), esistono ancora le cifre, gli euro e le operazioni per poterli calcolare. Nonostante le diverse e buone sostanze esistono anche le forme. Le tante monete ma anche le poche operazioni per calcolarle. Vanità o forza della presunzione che i modelli sono comunque necessari a dispetto della mia tranquilla e beata, caotica e illuminante, distratta e accorta esperienza relativa a un piccolo e quotidiano pomeriggio d’estate? Sono necessari i modelli astratti e i tuffi nel vissuto: entrambi. Non capisco perché si debba produrre questo inutile iato. Sarebbe opportuno parlarne con testi alla mano, ma, questa volta, ho deciso: non devo superare di troppo i limiti concessi dalla rivista. Me ne faccio un punto d’onore. E mi risolvo a fare altro.
Non hanno tutti i torti, il caro Barnard e il mio piccolo Mattia: sessantanove euro possono essere una grossa cifra o una cifra miserabile. Lo stipendio da ricercatore mi sembra una cifra da miserabile se lo confronto a quello che vorrei e che faccio, i miei compiti, la ricerca, la didattica e tutto il resto. È effettivamente relativo al mio stile di vita personale. Mi basta poco per stare bene: tante buone letture, qualche passeggiata al centro, una nuotatina quando sono a Palermo, in estate. Tutte cose che non costano poi tanto. Mi rincuora il pensiero che, nonostante tutta la relatività (si noti che non ho detto ‘relativismo’), esistono ancora le cifre, gli euro e le operazioni per poterli calcolare. Nonostante le diverse e buone sostanze esistono anche le forme. Le tante monete ma anche le poche operazioni per calcolarle. Vanità o forza della presunzione che i modelli sono comunque necessari a dispetto della mia tranquilla e beata, caotica e illuminante, distratta e accorta esperienza relativa a un piccolo e quotidiano pomeriggio d’estate? Sono necessari i modelli astratti e i tuffi nel vissuto: entrambi. Non capisco perché si debba produrre questo inutile iato. Sarebbe opportuno parlarne con testi alla mano, ma, questa volta, ho deciso: non devo superare di troppo i limiti concessi dalla rivista. Me ne faccio un punto d’onore. E mi risolvo a fare altro.
Vado, vado a mare. Un bel tuffo in acque limpide mi schiarirà di certo le idee. Crollerà pure questo imperversante, inutile capitalismo globalizzato, prima o dopo; ne sono certo mentre con il pensiero sono già in acqua, pronto a lasciarmi trasportare passivamente dai flutti, a fare il vuoto dentro la mia coscienza, ma con l’intenzione, allo stesso tempo, di resistere alle possibili onde imbizzarrite e di nuotare controcorrente. Mentre mi dirigo fuori, qualche sprazzo di pensiero fa ancora tenace capolino. Penso che si debba smettere una volta per tutte di porre una discontinuità tra il vivere a casa propria e la ricerca sul campo in luoghi lontani: come se non si vivesse anche quando si va nell’altrove più esotizzante o si rimane invece a casa propria a lavorare con i migranti o altri. Ma non è tutto. Oltre ad essere vissuta, la vita è testualizzata e tradotta. Per quanto strano possa sembrare di primo acchito ad alcuni antropologi innamorati degli steccati disciplinari, una vita non potrebbe essere concepita – né al presente, né al passato o al futuro – senza le relative forme di testualizzazione che la rendono in ultima analisi significativa e comunicabile a se stessi e agli altri. Chi vuol intendere, intenda! La vita assume il tratto di memoria culturale che si conserva e si trasmette grazie ai diari personali, i giornali, i libri, i film, i video, senza contare i luoghi appositamente adibiti a tale scopo fin dall’inizio, quali i monumenti o i musei. Ed è proprio per questo che mi piace il testo di Wacquant: è abbastanza eterogeneo, dal punto di vista dei generi, da rappresentare egregiamente il disordine stesso della vita. Per quanto riguarda il presente ordinario, più sfuggente, si deve ribadire che noi viviamo costantemente in mezzo ai segnali e ai segni più disparati e meno visibili, in casa, per strada, quando passeggiamo o guidiamo, lavoriamo o ci riposiamo. Persino quando sogniamo, nel nostro letto, siamo ininterrottamente immersi nell’esperienza della semiosi. Il fatto sorprendente è che non soltanto siamo immersi in questo continuo fiume in piena, ma, pure, mettiamo a confronto, nel quotidiano e in una stessa lingua, i testi che ne risultano, operando traduzioni intralinguistiche (da un significato all’altro) e intersemiotiche (da un tipo di codificazione segnica all’altra, come, ad esempio, da un romanzo a un film). La mia ipotesi, per finire, è dunque che le diverse forme di traduzione della cultura non concernono unicamente segni e testi più materialmente concepiti, ma, ugualmente, se non di più, gli stessi flussi di sensi e pensieri: insomma, in una parola, il vissuto.
Dialoghi Mediterranei, n.11, gennaio 2015
* Questo testo è stato scritto a Palermo in una torrida estate di otto anni fa, dopo una lunga permanenza in un freddo, ma bel paese del Nord Europa. Il testo non è mai stato pubblicato, adesso solo in parte rimaneggiato per l’occasione. Ringrazio Tonino Cusumano per i pungoli alla scrittura, in Dialoghi Mediterranei, che sta ormai diventando una splendida abitudine agli esperimenti etnografici sul pensare. Il testo vuole inoltre essere, per mia intenzionale disseminazione, un omaggio a Ungaretti.
Riferimenti bibliografici
Barnard Alan, Storia del pensiero antropologico, Il Mulino, Bologna, 2002 (2000)
Bateson Gregory, “Questo è un gioco”. Perché non si può mai dire a qualcuno “gioca!”, a cura di Davide Zoletto, Raffaello Cortina, Milano, 1996 (1956)
Benjamin Walter, “Sulla facoltà mimetica” in Angelus Novus, a cura di Renato Solmi, Einaudi, Torino, 1962 (1955): 71-74
Cappelletto Francesca, “Vivere l’etnografia. Osservazioni sul rapporto medico-paziente”, in Vivere l’etnografia, a cura di Francesca Cappelletto, Seid, Firenze, 2009: 199-225
Lakoff George, Johnson Mark, Metafora e vita quotidiana, a cura di Patrizia Violi, Bompiani, Milano, 1998 (1980)
Lévi-Strauss Claude, “L’efficacia simbolica”, in Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano, 1990 (1964)
Lotman Jurij M., La cultura e l’esplosione. Prevedibilità e imprevedibilità, Feltrinelli, Milano, 1993 (1993)
Malinowski Bronislaw, Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva, vol. I, Bollati Boringhieri, Torino, 2004 (1922)
Montes Stefano, “E se fosse un gioco? Un antropologo in spiaggia e i sensi dell’altrove”, Dialoghi Mediterranei, n. 10, novembre 2014a
Montes Stefano, “Una incursione fotografica ‘sul campo’ e l’antropologia ‘fuori campo’”, Dialoghi Mediterranei, n. 9, settembre 2014b
Perec Georges, “Approches de quoi?”, in L’infra-ordinaire, Seuil, Parigi, 1989 (1973): 9-13
Sartre Jean-Paul, Questions de méthode, Gallimard, Parigi, 1960
Taussig Michael, Cocaina. Per un’antropologia della polvere bianca, Bruno Mondadori, Milano, 2005 (2004)
Ungaretti Giuseppe, “Dormire” e “Vanità” in Vita d’un uomo, a cura di Leone Piccioni, Arnoldo Mondadori, Milano, 1969
Wacquant Loïc, Anima e corpo. La fabbrica dei pugili nel ghetto nero americano, DeriveApprodi, Roma, 2002 (2000)
_____________________________________________________________________________
Stefano Montes, ha insegnato Letteratura francese, Antropologia Culturale e Semiotica nelle Università di Parigi, Catania, Tartu, Tallinn, Palermo e Agrigento. Al di là delle etichette disciplinari, s’interessa ai modi molteplici secondo cui dinamiche culturali organizzano forme testuali (letterarie ed etnografiche). Nelle sue ricerche, ha privilegiato le analisi delle narrazioni di vita, lo studio delle modalità di produzione della cultura in alcuni testi esemplari, l’enunciazione della soggettività nelle teorie e pratiche antropologiche. Da alcuni anni i suoi campi di interesse scientifico vertono sulle strategie di conversione religiosa e sull’esperienza turistica.
________________________________________________________________












