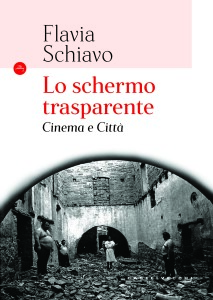Il volume, Lo schermo trasparente. Cinema e Città, edito da Castelvecchi, in uscita, potrebbe essere definito un punto di snodo del mio percorso di ricerca sulle “fonti non convenzionali”, inaugurato nel 2004 con un libro, Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto, edito da Sellerio, con il quale ho avviato lo studio che approfondisce il ruolo della narrazione quale strumento per restituire, in termini dichiaratamente soggettivi e inclusivi, il dinamismo e il magma sociale.
Tale ricerca, che affronta la “narrazione” letteraria, cinematografica e, in alcuni momenti, fotografica, nasce da un posizionamento disciplinare “slittato” e da alcune passioni, e si riconnette all’esplorazione dei linguaggi dell’urbanistica, da me intesi ed indagati come dispositivi tecnici e non, di espressione, di sedimento e di sperimentazione delle discipline territoriali. Nodo qui solo accennato, sempre presente nel mio lavoro, che fa riferimento a un mio ulteriore studio del 2005: Tutti i Nomi di Barcellona. Il linguaggio urbanistico: parole, immagini. Dal Plan Cerdà all’Area metropolitana, edito da FrancoAngeli.
I termini “slittato” e “passione” meritano una precisazione di dettaglio. Il posizionamento disciplinare “fuori asse” rispetto all’impostazione canonica della mia disciplina e allo sguardo “tecnico” dell’urbanistica e della pianificazione, entrambe intese come “scienze di sintesi” (Schiavo, 2005), origina dall’idea che, per fare ricerca, occorre essere eretici, anarchici, indisciplinati, oltre che riguardosi della tradizione e rigorosi nel “fare”, forzando il limite e mettendo in discussione il dominio degli specialismi che, a mio parere, rischiano di uccidere l’interpretazione e l’immaginazione teorica e progettuale. Queste, di contro, possono essere fecondate da una impostazione metadisciplinare, utile a porre in interscambio reciproco competenze diverse, lanciando reti, fili, connessioni, tra ambiti e campi non contigui o che non appartengono alle discipline urbane e territoriali, con un metodo non solo strettamente scientifico, ma tendenzialmente euristico che si avvale non unicamente dell’intuito, ma del ruolo dei linguaggi e delle forme espressive “non scientifiche”.
Se lo slittamento riguarda la costruzione contaminata e “impura” della mia formazione e del mio procedere nella ricerca, le passioni parlano di un’amorevole vicinanza con la letteratura, il cinema e la fotografia, da sempre mia personale ‘musica del profondo’, vissuta all’intersezione tra un campo intimo ed emozionale e la riflessione intellettuale. L’“orecchio” per le parole e l’“occhio” per le immagini sono stati, nel mio percorso culturale e scientifico, quegli organi guida impegnati a vedere e ad ascoltare per interpretare, con consapevolezza sempre crescente, romanzi, novelle, film, immagini fotografiche, le sinfonie e il “canto” verbale e visivo interiore e la trama su cui costruire un lungo itinerario di indagine.
La ricerca sulle “fonti non convenzionali”, che integra la passione per i mezzi visivi e verbali o verbo-visivi-sonori (come il cinema) con gli strumenti più ortodossi della mia formazione di architetto, urbanista e paesaggista, non ambisce a una aderenza o a una mimesi con quegli approcci che trattano analisi critiche dei testi letterari o del linguaggio cinematografico, ma intende lavorare sul “contesto” (Schiavo, 2004) e sulle narrazioni che lo rappresentano alla ricerca dei rapporti tra le persone, i luoghi, il tempo, le emozioni, tra micro e macro eventi, tra archetipi e pratiche, tra locale e sovralocale.
Se nel corso dell’ultimo ventennio, in cui ho lavorato tanto su tali temi, ho sperato che i miei libri sapessero esprimere tale percorso, mi auguro che questo volume, edito da Castelvecchi, parli per me. Il libro, che non ha un carattere sistematico, dichiara sin dal titolo Lo schermo trasparente. Cinema e Città, i suoi contenuti. È composto da otto capitoli. Il primo, chiaramente introduttivo, è seguito dagli altri che ragionano del ruolo del cinema, muovendo da numerosi film, da alcuni autori, da specifici documentari o serie televisive, e da alcuni corpus fotografici, ponendo sempre al centro la città, la società, gli spazi abitati, il potere, le relazioni delle persone con il sistema complesso delle emozioni, delle passioni, dei diritti, delle conflittualità che agitano e compongono la città stessa, intrisa di materia e di simboli.
La narrazione dei corpi e dei sentimenti, la luce, il racconto, gli individui o i gruppi in azione, le pratiche sono al centro delle immagini e delle storie che, in termini soggettivi e qualitativi, disegnano eventi e dinamiche, spesso presentate dalle discipline territoriali secondo modalità quantitative o attraverso insiemi di dati. Le “fonti non convenzionali” non intendono ovviamente sostituire gli approcci ortodossi delle discipline territoriali, ma ambiscono a dialogare con questi, aprendo al “forse”, al dubbio, al superamento del limite e accogliendo il caos del quotidiano.
Costellazioni di autori e autrici compongono la via lattea centrale in questo mio lavoro che, peraltro, soprattutto negli ultimi anni ha avuto significative ricadute didattiche, sia nell’ambito dei Corsi da me tenuti presso il Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze della Città, sia presso il Dottorato di Ricerca in Arti, Architettura e Pianificazione, del cui Collegio faccio parte.
 È possibile leggere il libro a partire da uno qualunque degli otto saggi che lo compongono, all’interno dei quali si trovano costanti rimandi reciproci per congegnare una rete che tiene insieme autori e opere molto diverse. Nel volume si affronta in termini teorici il ruolo delle “fonti non convenzionali”, riflettendo sugli strumenti per rappresentare e capire cosa sia o sia stata la città (o il territorio abitato), identificando nel cinema il dispositivo in grado di eludere la sola quantità, integrando le conquiste delle discipline territoriali con le pratiche dello sguardo più soggettivo, intrecciando diversi linguaggi espressivi e differenti livelli narrativi. In tal senso si è ragionato sul possibile ruolo dell’immagine e nello specifico dell’“immagine cinematografica”[1] (“immagine” articolata e complessa verbale, visiva, sonora), convinti che la “verità storica” si costruisca anche con l’uso delle “fonti non convenzionali” [2] testuali e/o visive, oltre che attraverso le fonti accreditate. Verità che, a partire da Tucidide, testimone e storico, si fondano sulla restituzione di eventi, fatti, relazioni, accadimenti che, selezionati e trascritti, permangono in sostituzione di un’immanenza destinata a scomparire.
È possibile leggere il libro a partire da uno qualunque degli otto saggi che lo compongono, all’interno dei quali si trovano costanti rimandi reciproci per congegnare una rete che tiene insieme autori e opere molto diverse. Nel volume si affronta in termini teorici il ruolo delle “fonti non convenzionali”, riflettendo sugli strumenti per rappresentare e capire cosa sia o sia stata la città (o il territorio abitato), identificando nel cinema il dispositivo in grado di eludere la sola quantità, integrando le conquiste delle discipline territoriali con le pratiche dello sguardo più soggettivo, intrecciando diversi linguaggi espressivi e differenti livelli narrativi. In tal senso si è ragionato sul possibile ruolo dell’immagine e nello specifico dell’“immagine cinematografica”[1] (“immagine” articolata e complessa verbale, visiva, sonora), convinti che la “verità storica” si costruisca anche con l’uso delle “fonti non convenzionali” [2] testuali e/o visive, oltre che attraverso le fonti accreditate. Verità che, a partire da Tucidide, testimone e storico, si fondano sulla restituzione di eventi, fatti, relazioni, accadimenti che, selezionati e trascritti, permangono in sostituzione di un’immanenza destinata a scomparire.
L’immagine stessa, in pittura (si pensi al lavoro di Emilio Sereni, sul paesaggio agrario), in fotografia (si pensi alle teorizzazioni di Susan Sontag e Roland Barthes), nel cinema (sia “romanzesco”, sia documentaristico), assume valore di fonte. Si tratta, anche in questo caso, di una fonte densa (carica di senso) e “non convenzionale”, appunto, in bilico tra verità non arroganti e finzioni dichiarate, che restituisce “verità” attestabili, restituzioni plausibili e non (anch’esse importanti, in quanto relative e in grado di aprire nuove visioni). Tali rappresentazioni non convenzionali, nel loro complesso e con le debite differenze, a volte integrano, a volte completano o confutano le informazioni provenienti dagli archivi tradizionali, costruendo versioni difformi o in controtendenza, versioni coerenti con altre restituzioni e, sicuramente, entrano a far parte della memoria e dell’immaginario collettivi.
Queste “verità”, che spesso riconsegnano un ulteriore punto di vista, possono essere considerate sia per il loro ruolo paradigmatico (rispetto alle “immagine dei luoghi” nelle discipline territoriali e sociali), sia per il valore strumentale e concreto, nonché per sottrarsi alla mise en abyme di una “restituzione” complessa e sfuggente, com’è quella territoriale. Cercando una “verità” relativa fatta di storie personali, soggetti, luoghi, luce, tempo.
Tale prospettiva interpretativa, che considera parziale e soggettiva ogni verità rappresentata, comunque ritiene che nemmeno in ambito storico stricto sensu, sussistono fonti autentiche e oggettivamente stabili: anche la ricostruzione storica più accurata è frutto di selezione e interpretazione, essendo compiuta con la modificazione sia dei paradigmi, sia dei metodi, sia per l’accesso progressivo alle fonti e alle “testimonianze”, si pensi per esempio alla “nuova storia” e agli Annales di Le Goff.
Nella costruzione dell’“immagine restituita”, attribuendo a questo termine un valore ampio e non solo ottico, la rappresentazione visiva ha un ruolo di fondamentale importanza, sia quando fissi un momento, come accade in pittura o in fotografia, sia quando rappresenti un processo o un fenomeno di breve, medio o lungo corso.
Il libro dedica a Ciprì e Maresco, definiti “antropologi per caso”, uno spazio che vale a rendere omaggio alla mia città, Palermo e a due tra gli interpreti più sottili della realtà sommersa, in parte invisibile agli occhi, ma fortemente intrisa di storia e di catastrofi locali. Nel cinema di Ciprì e Maresco, infatti, si negano le categorie consuete che spiegano e definiscono, si traccia in un modo diverso la mappa degli errori (sociali, politici, esistenziali), delle dispersioni, delle “distrazioni”, dei mondi smarriti e delle occasioni perdute, si elaborano pensieri sui luoghi, sulle politiche, sulle “pratiche sociali”, ricostruendo una micro-storia paradossale, ma altamente rappresentativa di una porzione significativa del reale.
L’importanza attribuita al lavoro dei due cineasti, mi ha spinto a mettere in copertina un frammento tratto da uno dei loro film più impietosi e duri, Totò che visse due volte, costituito da tre episodi, e caratterizzato da un bianco nero raffinato ed estremo. Quel film ha una specifica cifra narrativa, proponendo una modificazione rispetto al consueto rapporto tra la “comicità” e la tragedia, tra il disfacimento e la speranza. Costruito come una narrazione biblica rovesciata, tra miracoli mancati, disastri, martirio, sacrificio, verità traslitterate, rottura del patto fideistico tra Dio e umanità, dice del fallimento della redenzione e della salvezza. I luoghi rappresentati – spazio dell’esperienza individuale e collettiva – lo Spasimo, parti del centro storico (come il Capo), la foce dell’Oreto, mostrano la necrosi della terra, la perdita del confine urbano e sono teatro di eventi che generano disgusto.
In Totò che visse due volte, uno dei numerosi film e corti analizzati della coppia di registi, il rapporto tra luoghi, eventi e soggetti, è costitutivo e più esplicito e gli interpreti sono uomini senza diritti sociali, per assenteismo politico e per analfabetismo, per ignavia e inerzia, dove vige un loop, mancano l’azione partecipativa, la democrazia diretta e la spinta per la richiesta e la costruzione dei valori civici.
Lo schermo trasparente, intenzionalmente, sfugge a una sistematizzazione, edificando una impalcatura eterogenea, dove si susseguono protagonisti come Rosi, con il suo Le mani sulla città, opera esplorata considerando il complesso periodo italiano, contraddistinto dal periodo post bellico dalla Ricostruzione nazionale; dalle politiche di recupero e rilancio economico e dell’occupazione (che puntarono molto sull’edilizia); nonché dal desiderio di superare l’esperienza della guerra e il profondo senso di sconfitta e di “perdita” insito in quella fase.
Pasolini, in altre pagine, è letto nell’intreccio tra letteratura, documentari, interviste e cinema, alla ricerca dello “spirito del luogo” presente nelle sue sensibilissime opere, riflettendo sulla “sua” periferia, sugli “spazi di transizione”, sulla “molteplicità dello sguardo” che incrementa il senso urbano, così attivando – consci di quanto sia impossibile una restituzione onnicomprensiva – un metodo di ricerca destinato ad amplificare e rendere meno assertiva la comprensione, ed evidenziando, da un lato come alcune fratture e forti trasformazioni (per esempio la comparsa della periferia) agiscano da elementi scardinanti, possedendo un valore di rifondazione urbana e, dall’altro, come ogni “linguaggio” di rappresentazione, “radicato” in uno specifico campo espressivo-disciplinare, sia soggetto a regole precise, enfatizzando alcuni aspetti, obliterandone altri: è la configurazione espressiva che fornisce agli oggetti descritti, in questo caso le periferie, un preciso regime di esistenza.
Si dimostra alla fine come i linguaggi non sono mai neutrali, non si riferiscono a contenuti o rappresentazioni date, ma agiscono come “pratiche” che materializzano gli stessi oggetti di cui parlano. I sistemi di rappresentazione, le narrazioni, le immagini sono, dunque, atti culturalmente creativi e possiedono un valore performativo. In tal senso non sono solo strumento minuzioso, ma possono esser considerati come pratiche di fondazione di contesti, di spazio e di luogo.
C’è spazio nel libro per un’interpretazione compiuta, a partire dalle prime 4 Stagioni di Gomorra la serie televisiva, del trash e delle case di abitazione della camorra napoletana, in relazione ai luoghi della serie, ai soggetti e agli eventi narrati. La casa, trattata come un fenomeno culturale “intertestuale”, è posta in connessione con altri fenomeni. Si esprime sia tramite un linguaggio di superficie, visibile, fatto di forme, di scelte estetiche e tattiche, di oggetti, di colori, sia attraverso strutture astratte, idee, riferimenti. In tal senso le case dei protagonisti di Gomorra, così come gli esterni offrono un’apertura per comprendere parte di una complessità culturale, propria di un ambiente locale, quello della camorra partenopea che, compatta e ramificata, riguarda un contesto globale. Ed è in tal senso che Gomorra può essere intesa come documento: il paesaggio non è composto dalle semplici inquadrature degli edifici, ma va letto come una rappresentazione di un sociale deformato. È l’intero spazio ad essere protagonista della storia, ripreso da lontano, ripreso dall’interno, nell’estremo dettaglio di un muro sbrecciato o di una parete rivestita di una carta da parati lussuosa e sfoggiata, lo spazio stesso comunica la sua natura trascendente: non è geometrico, non è quantitativo; è concreto, ed è simbolico, porta in sé la drammatica consistenza qualitativa degli eventi che riguardano le persone, e comunica il peso dell’appropriazione da parte della camorra da un lato, e dall’altro le azioni di governo e le occasioni mancate.
Lo spazio di Gomorra ci dice quale sia la storia dei luoghi, suggerendo cosa fare e come. Le scelte estetiche sono, allora, solo una parte di un quadro assai più complesso, sono il frutto dell’aderenza ad alcuni modelli seducenti che esprimono potere e arroganza in termini espliciti, ma sono soprattutto espressione visibile dell’illegalità e del danaro impiegato per manifestare potere e dominio.
Le case, collocate all’interno dell’urbano, ci dicono – con la loro storia, con il loro aspetto, con la loro posizione e condizione – della città e delle persone che la abitano. Tra le scene significative a questo proposito, una in cui uno dei giovani appena assoldati della camorra, da una terrazza del complesso insediativo delle Vele, prova l’eccitazione del potere e punta la pistola verso un altro edificio, mostrando come chi tenga in mano un’arma sia rinunciatario di ogni dialogo, sia esterno a ogni forma di gestione democratica, abbia paura e senta la necessità di una protezione anomala e fondata sulla prevaricazione. La scena, però, mostra come le terrazze sui tetti siano territorio per organizzare riunioni dei soldati della camorra e, nel contempo, luogo in cui i bambini giocano in uno spazio tendenzialmente squallido, in cui non esiste una pianta, o un vaso di fiori, ricordandoci che i ragazzini in quel quartiere giocano per strada con difficoltà, anche per l’assenza di quei luoghi pubblici previsti nel progetto e mai costruiti.
Parigi e New York sono al centro di una ricognizione del repertorio cinematografico e fotografico (E. Atget e B. Abbott) che le ha rappresentate ai primi del Novecento: si esplora come l’identità urbana influisca su fenomeni più contemporanei, come la Street Art. Particolare attenzione è stata data all’imponente filmografia delle “origini” che ha raccontato la “capitale culturale” nordamericana, anche a partire da un brevissimo e significativo film del 1921, Manhatta, opera di due statunitensi, Paul Strand (fotografo) e Charles Sheeler (pittore e fotografo).
Il film, minuziosamente scandagliato, è occasione per riflettere sulla natura “impermanente e anti-monumentale” di New York, in quanto può essere considerato un primo esempio di cinema sperimentale in America e sicuramente il primo documentario urbano della città che stava affrontando l’impegnativa trasformazione sociale ed economica, iniziata a metà Ottocento, per diventare la prima metropoli americana, quale luogo produttivo e metamorfico alla ricerca di un’immagine trionfante, ma non magniloquente. Immagine che, testimoniando un ruolo egemone non solo in America, fu ed è una delle sue componenti retoriche più forti.
Il film, Manhatta, in bianco e nero, muto e breve (poco meno di 10 minuti), con rimandi all’espressionismo tedesco, ma rivendicando un proprio statuto formale, è il più rappresentativo tra quelli che in quella fase raccontarono NYC ed è un singolare prodotto di quel modernismo che inaugura la decostruzione della prospettiva rinascimentale in favore di punti di vista molteplici, costitutivi della veduta “mobile” di paesaggio urbano del Novecento. Veduta esplorata da numerosi film che, non solo New York City (ma a Berlino come a Vienna, come in seguito a Parigi) restituivano un urbano trasformato.
New York, infatti, fu ritratta da numerose pellicole, durante la fase d’esordio e iniziale del cinema: tra essi The Crowd di K. Vidor (1928) che rappresenta un punto di svolta nella rappresentazione dell’American dream, rivisto criticamente. Vi si esplora la parabola discendente del protagonista (John Sims, nato il 4 luglio del 1900), e della sua famiglia. John rappresenta l’uomo medio vessato dalle grandi illusioni, come mostrato da una delle didascalie del film che recita: “When John was twenty-one he became one of the seven million that believe New York depends on them”[3]. The Crowd, dunque, scandaglia analiticamente la vita di John, sin dalla morte del padre vissuta in tenerissima età, intrappolata in un’immagine massificante, quella della folla indifferenziata: uomini e donne come robot omologati prigionieri di scrivanie identiche e di una società orientata al consumo, di oggetti e persino di emozioni, rigidamente programmate. John e la moglie, però, lunghi dall’essere i perfetti esponenti di coloro che cercavano e raggiungevano la “felicità”, colpiti da un gravissimo lutto, affrontano non solo la perdita della figlia, ma la tragedia complessiva di una débâcle totale del modello. John Sims, per Vidor, rappresenta tutti gli uomini traditi dal mito fallace della civiltà delle macchine e servi del “sogno americano”.
Nelle ultime pagine del volume ci si intrattiene sul complesso rapporto tra Jane Jacobs e Robert Moses, attraverso un film, alcuni documentari e due serie TV. Tale relazione, tra le più significative del Novecento, appare emblematica per approfondire la diatriba tra approcci urbanistici antinomici: pur esplorando tale battaglia combattuta a New York (cercando di approfondire le ragioni e soprattutto gli esiti del conflitto, che eccedono il tempo e i luoghi, influenzando fortemente il dibattito disciplinare immediatamente successivo ed attuale), si è voluto esplorare la “collaborazione”, l’alleanza che i due urbanisti instituirono non riguardo all’idea di città (ovviamente dicotomica), o alla progettualità da proporre e realizzare, ma rispetto alla formazione del “paradigma New York”[4] e al dibattito su una questione centrale sulla pianificazione: il rapporto tra Ordine e Caos, tra azioni top-down e pratiche bottom-up.
Il conflitto così inteso diventa funzionale a identificare la città, a comprendere parte dell’evoluzione disciplinare e dell’immagine urbana nel suo farsi. Essa, intimamente indagata – come sostiene Nadar a proposito del ritratto fotografico – appare costituita non unicamente dalla forma visibile, o dai processi attuati, ma da quelle modalità che, oltre gli eventi, hanno guidato la sua trasformazione. Il paradigma New York, infatti, si forma anche attraverso lo “stile” delle pratiche e l’azione di figure tanto diverse, come si plasma grazie alla cultura urbana instauratasi ab origine, ad alcuni elementi contingenti e a numerose coincidenze. Ed è in tal senso che si propone il termine “collaborazione” intesa come pratica inconsapevole del “riequilibrio” reciproco, come confluenza di due modelli antitetici che, in un dato tempo e in un dato luogo, hanno vissuto in integrazione (intendendo così lo scontro e l’esternazione di un conflitto dialettico tradotto in azioni e pratiche). Tali modelli, guardati nella loro intensa e vicendevole relazione e nel rapporto con la storia delle trasformazioni, sono espressione di quel paradigma newyorchese, sono forme delle culture urbane specifiche che entrano a far parte dell’immaginario collettivo e civico, agendo sui comportamenti, sugli stili di governo e sull’idea di futuro.
Al Mediterraneo sono dedicate le conclusioni del volume, a quella ampia area fatta di terra e soprattutto di mare, storicamente definita, ma soggetta a una feconda, vitale, a volte tragica revisione: il Mediterraneo, un’idea, uno spazio del quotidiano e un progetto, un sistema poroso che integra Mare e Terra, città e linee di transizione. Si passano in rassegna, allora, tre film che “trattengono” in sé e narrano il Mare nostrum, il suo essere placenta e ambito di contraddizioni.
Nel riprendere le premesse e l’intento più autentico del libro, si ragiona infine su quanto resta sospeso tra il non detto e l’implicito del cinema e la luminosità delle narrazioni, ipotizzando e progettando nuove strade per la prosecuzione della ricerca.
 Il cinema viene descritto come “un’opera aperta”, illustrando come le neuro scienze si siano recentemente rivolte al cinema stesso (approfondendo la “simulazione incarnata” di cui parlano Vittorio Gallese e Michele Guerra [5], ed esplicitando come tra concretezza e immaginazione nel rapporto con la realtà esaminata, i film mostrino la relazione tra natura e azioni antropiche, riflettendo sul senso dell’azione. Lo spettatore in “ascolto” troverà lo scorrere della vita quotidiana con le sue “singolarità”, e sperimenterà l’empatia, situandosi all’interno del contesto, esplorandolo con un metodo prevalentemente induttivo che, da casi specifici, muove verso una consapevolezza e eventualmente verso considerazioni più generali.
Il cinema viene descritto come “un’opera aperta”, illustrando come le neuro scienze si siano recentemente rivolte al cinema stesso (approfondendo la “simulazione incarnata” di cui parlano Vittorio Gallese e Michele Guerra [5], ed esplicitando come tra concretezza e immaginazione nel rapporto con la realtà esaminata, i film mostrino la relazione tra natura e azioni antropiche, riflettendo sul senso dell’azione. Lo spettatore in “ascolto” troverà lo scorrere della vita quotidiana con le sue “singolarità”, e sperimenterà l’empatia, situandosi all’interno del contesto, esplorandolo con un metodo prevalentemente induttivo che, da casi specifici, muove verso una consapevolezza e eventualmente verso considerazioni più generali.
Lo spazio disfatto-eterogeneo-discontinuo della città contemporanea, e dei suoi abitanti, viene restituito con il flusso del racconto che, proprio in quanto dicotomico, può essere considerato complementare a quello scientifico. Tra luoghi e film esiste, dunque, una reciproca permeazione e influenza, mentre viene registrata, narrata, la casualità che pone i protagonisti in diversa collisione [6], utile a comprendere l’eterogeneità delle relazioni tra spazio e persone. I luoghi attraversati, cardine della percezione [7], sono così al centro della “mappatura degli ambienti vissuti” in cui risultano evidenti le diversità di sguardo e di posizionamento dell’osservatore rispetto alla rete di nessi, ai fatti, ai luoghi e alle persone che sono, come i luoghi, “punti di inferenza”.
Dialoghi Mediterranei, n. 56, luglio 2022
Note
[1] Si utilizza il termine “immagine cinematografica” richiamando alcune tra le suggestioni contenute nel documentario in otto capitoli di Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma (1988-98). Come nota Jacques Rancière ne Le destin des images, La fabrique éditions, Paris 2003, Godard, anche se non in modo inequivoco, sostiene che le immagini (nel cinema), presenze visive, «abbiano valore unicamente all’interno delle combinazioni che autorizzano: combinazioni con altri elementi visivi e sonori, ma anche con frasi e parole pronunciate da una voce o scritte sullo schermo»; così, prosegue Rancière, anche gli «Estratti di romanzi o poemi, titoli di libri o di film spesso effettuano gli accostamenti che danno senso alle immagini, o piuttosto, che fanno dei frammenti visivi assemblati delle “immagini”, ovvero dei rapporti tra una visibilità e una significazione».
[2] Flavia Schiavo, Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto, Sellerio, Palermo 2004.
[3] Quando John ebbe ventuno anni, diventò uno tra quei sette milioni che pensavano che New York dipendesse da loro.
[4] Flavia Schiavo, New York: entre la tierra y el cielo, Ediciones Asimétricas, Iniciativa Digital Politècnica, Barcelona, Madrid 2021.
[5] Vittorio Gallese, Michele Guerra, Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze, Raffaello Cortina, Milano 2015.
[6] Steven Johnson, Complessità urbana e intreccio romanzesco, in Franco Moretti (a cura di), Il romanzo, Vol. 1, Einaudi, Torino 2001.
[7] Marshall Berman, L’esperienza della modernità, il Mulino, Bologna 1985.
______________________________________________________________
Flavia Schiavo, architetto, architetto del paesaggio e PhD in Architettura, Arti e Pianificazione, è prof.ssa Associata presso la Università degli Studi di Palermo, dove insegna Fondamenti dell’Urbanistica e della Pianificazione territoriale (Laurea in Urbanistica e Scienze della Città). Ha al proprio attivo numerose pubblicazioni (saggi e monografie), in italiano e in inglese, che sviluppano articolati temi di ricerca: fonti non convenzionali (letteratura e cinema per interpretare città e territorio); linguaggio urbanistico; partecipazione, conflitti, azioni e pratiche bottom-up in ambito urbano; parchi e giardini; sviluppo e questioni sociali, economiche e antropologiche nel contesto della Rivoluzione Industriale; arte, culture urbane e contaminazioni. Tra i titoli delle monografie: Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto, 2004, Sellerio, Palermo; Tutti i Nomi di Barcellona, 2005, FrancoAngeli, Milano; Piccoli giardini. Percorsi civici a New York City, 2017, Castelvecchi, Roma; Lettere dall’America, 2019, Torri del Vento, Palermo; New York: entre la tierra y el cielo, Ediciones Asimétricas, Iniciativa Digital Politècnica, Barcelona, Madrid, 2021. Fa parte di Comitati scientifici di prestigiose collane editoriali (FrancoAngeli) e di Riviste del settore. È co-direttore della collana Cinema e Città, della Palermo University Press. Ha organizzato seminari, simposi, meeting, convegni nazionali e internazionali e ha condotto lunghi periodi di ricerca in Italia e all’estero, in Europa (UAB, Barcellona) e recentemente negli Stati Uniti (Columbia University, New York City).
______________________________________________________________