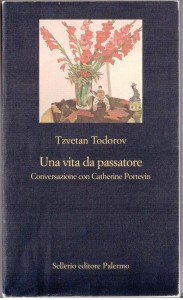Il 7 febbraio del 2017 moriva Tzvetan Todorov. A poco più di un anno dalla sua scomparsa, mi piace ricordarlo in occasione della sua visita a Palermo, allo Steri, il 15 dicembre del 2010, per la presentazione del suo libro Una vita da passatore. Conversazione con Catherine Portevin, appena uscito per Sellerio. Il testo che segue riprende l’intervento che allora lessi, con emozione, alla presenza dell’Autore.
Considero un privilegio aver avuto l’opportunità di curare l’edizione italiana di questo libro che oggi presentiamo, per molte ragioni: per la statura intellettuale dell’Autore, si tratta di uno dei protagonisti più significativi della vita intellettuale del Novecento in Occidente; per la forma in cui il libro si presenta, una lunga narrazione di una storia di vita, e per il valore paradigmatico che questa storia personale assume; per le diverse narrazioni in cui si articola, che possono, al tempo stesso, rappresentare una introduzione ai temi che hanno caratterizzato la lunga e articolata produzione scientifica di Todorov (dalla critica letteraria alla linguistica, all’antropologia, alla storia), per coloro che quella produzione non conoscono o conoscono poco ma anche per quanti su quei testi (almeno su alcuni) si sono formati (e sono molti qui dentro) e possono ripensarli attraverso la ricostruzione e la presentazione che ne fa il loro Autore, mostrando l’occasione della scelta di un tema, il processo della ricerca, svelandone connessioni, trame sottese, più o meno evidenti e percettibili.
 Certo, si tratta di una ricostruzione a posteriori, sul filo della memoria, dunque non una mera registrazione di fatti come sono realmente accaduti, ma una loro ripresentificazione alla luce di una mutata sensibilità, di un accumulo di esperienze, in relazione a un presente, al qui e ora della narrazione. D’altro canto, lo stesso Todorov riconosce la forza di certa produzione intellettuale quando (sono parole sue) «l’individuo vi è implicato personalmente» (p.133). Lo dice, per esempio, a proposito della critica allo strutturalismo, segnalando che le scienze umane e sociali sono anche «scienze morali e politiche» e devono ricordarselo. Lo dice anche a proposito di Hannah Arendt che, con La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, scrive Todorov, «ha sconvolto il nostro modo di vedere il mondo». In che senso? Perché il libro è scritto come un reportage ma Hannah Arendt «vi è implicata completamente», mettendo «in questione – e quanto dolorosamente – le sue identità: è così che è riuscita a trasformare il nostro modo di vedere il Male» (p.132).
Certo, si tratta di una ricostruzione a posteriori, sul filo della memoria, dunque non una mera registrazione di fatti come sono realmente accaduti, ma una loro ripresentificazione alla luce di una mutata sensibilità, di un accumulo di esperienze, in relazione a un presente, al qui e ora della narrazione. D’altro canto, lo stesso Todorov riconosce la forza di certa produzione intellettuale quando (sono parole sue) «l’individuo vi è implicato personalmente» (p.133). Lo dice, per esempio, a proposito della critica allo strutturalismo, segnalando che le scienze umane e sociali sono anche «scienze morali e politiche» e devono ricordarselo. Lo dice anche a proposito di Hannah Arendt che, con La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, scrive Todorov, «ha sconvolto il nostro modo di vedere il mondo». In che senso? Perché il libro è scritto come un reportage ma Hannah Arendt «vi è implicata completamente», mettendo «in questione – e quanto dolorosamente – le sue identità: è così che è riuscita a trasformare il nostro modo di vedere il Male» (p.132).
Questa «implicazione del soggetto nell’oggetto, dell’uomo nelle sue opere» (sono sempre parole sue) è ciò che fa sì che la buona letteratura può insegnare di più di un saggio critico, può portare a un «maggiore progresso nella conoscenza della condizione umana» (p. 133). Questo non è un libro di letteratura e non è neanche un saggio critico, ma la sua forza risiede proprio nel fatto che l’intellettuale e l’uomo vi sono implicati e i contenuti passano attraverso la sua corporeità e il suo intelletto. Così, con questo racconto Todorov ci trasporta attraverso un cinquantennio della sua storia (umana e intellettuale), che è anche la nostra storia.
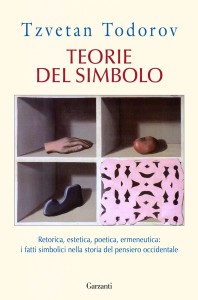 La presentazione di un libro è, canonicamente, una illustrazione dei suoi contenuti anche per indurre i lettori o gli ascoltatori a leggerlo. Proverò allora a illustrarne la struttura (Todorov mi perdonerà se utilizzo questo termine!). Come è costruito il libro? Si compone di dieci capitoli ognuno dei quali racconta una fase della vita dell’Autore, dalla giovinezza trascorsa nella Bulgaria comunista, nel capitolo primo; all’arrivo a Parigi nel 1963 e il suo incontro con la critica letteraria, la linguistica, lo strutturalismo (da Barthes a Benveniste a Jakobson, per citare i più noti), insieme a Gérard Genette (nel secondo capitolo); alla critica a questo approccio a partire dal 1972 (dopo la pubblicazione del Dizionario enciclopedico delle Scienze del Linguaggio e soprattutto con Teorie del simbolo nel 1977).
La presentazione di un libro è, canonicamente, una illustrazione dei suoi contenuti anche per indurre i lettori o gli ascoltatori a leggerlo. Proverò allora a illustrarne la struttura (Todorov mi perdonerà se utilizzo questo termine!). Come è costruito il libro? Si compone di dieci capitoli ognuno dei quali racconta una fase della vita dell’Autore, dalla giovinezza trascorsa nella Bulgaria comunista, nel capitolo primo; all’arrivo a Parigi nel 1963 e il suo incontro con la critica letteraria, la linguistica, lo strutturalismo (da Barthes a Benveniste a Jakobson, per citare i più noti), insieme a Gérard Genette (nel secondo capitolo); alla critica a questo approccio a partire dal 1972 (dopo la pubblicazione del Dizionario enciclopedico delle Scienze del Linguaggio e soprattutto con Teorie del simbolo nel 1977).
In mezzo c’è il maggio francese, il Sessantotto, che vede Todorov in America ma, dopo l’estate, egli è partecipe attivo nella creazione di un nuovo modo di concepire l’insegnamento universitario attraverso l’esperimento dell’università di Vincennes. Sul versante dell’agitazione politica il giudizio di Todorov è tranciante, ma non voglio togliervi il gusto di leggerlo nel capitolo quarto.
Alla fine degli anni Settanta Todorov si è aperto a nuovi temi e nuovi approcci; esemplare, in questo senso, è il libro La conquista dell’America, dove si tratta della questione dello straniero e dell’alterità, del rapporto noi/gli altri, della pluralità delle culture, attraverso la rappresentazione di Colombo, di Cortés, della Malinche (e siamo al capitolo quinto). Lasciatemi leggere un breve passo da questo capitolo, a proposito del suo modo di intendere la scrittura della storia. La sua intervistatrice gli chiede:
Lei presenta certe sue opere come dei «racconti esemplari»; significa che si tratta di racconti edificanti?
«Si tratta di una maniera di scrivere la storia. Prima di tutto, gli avvenimenti devono essere ricostruiti il più precisamente possibile (è l’esigenza di verità fattuale, di verità di adeguatezza). Dopo, li si interroga secondo il loro “senso morale”, […], dunque senza perdere di vista l’uso che il lettore di questo testo ne potrà fare nella sua vita.
Questa forma mi è congeniale per più motivi. In effetti, il racconto, a differenza dell’analisi astratta, è accessibile a un pubblico di non-specialisti; in più, propone invece di imporre, lasciando così una maggiore libertà al lettore. La storia raccontata resta nella mente del lettore che può, in seguito, ritornarvi a suo modo; essa non è diretta solo alla sua coscienza attiva, ma agisce anche per l’intermediazione della memoria. Il solo mezzo di farci vivere un’esperienza non nostra è, forse, il racconto: questo è il suo grande potere. Ci si può proiettare nei personaggi, reali o immaginari, e uscirne trasfigurati. Hannah Arendt (Vies politiques, Paris, Gallimard 1974) diceva «nessuna filosofia, nessuna analisi, nessun aforisma, per profondi che siano, possono essere comparati in intensità e pienezza, con una storia ben raccontata». Mi sembra che da questo punto di vista, il racconto storico possieda lo stesso potere del romanzo. Aggiungo esemplare per dire che non mi attengo alla sola ricostruzione degli eventi: rammento al lettore che il passato gli può insegnare qualcosa sul presente. Rammentare, ma senza dare una lezione, sollevare delle questioni ma non fissare le risposte: un confine che a volte è difficile tracciare con precisione» (pp.218-19).
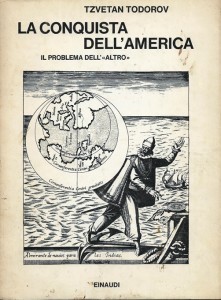 A partire da qui si apre una fase nuova. Nei capitoli sesto e settimo, le questioni poste in La conquista dell’America trovano in Noi e gli altri, e più tardi in Le Jardin imperfait, un respiro più ampio. Todorov avvia infatti una stagione “umanistica”, caratterizzata da una riflessione, da una parte, sull’universalismo e sulla possibilità di pensare e comprendere al suo interno le differenze, dall’altra sulla “modernità”. I suoi referenti sono, tra gli altri, Montaigne, Montesquieu, Tocqueville (attraverso Louis Dumont), Rousseau cui dedica il libro Fragile felicità, Benjamin Constant, per cui prova «una vera e propria simpatia, quasi un attaccamento personale», e alla cui opera De la religion dedica una prefazione. Qui Todorov si interroga pure sul ruolo dell’intellettuale “umanista”, sul significato di “impegno” e “responsabilità”, sul rapporto tra “sapere”, “pensiero”, e “azione”, attraverso figure come Albert Camus, Raymond Aron, le loro posizioni rispetto ai totalitarismi, alla Guerra d’Algeria, ecc.
A partire da qui si apre una fase nuova. Nei capitoli sesto e settimo, le questioni poste in La conquista dell’America trovano in Noi e gli altri, e più tardi in Le Jardin imperfait, un respiro più ampio. Todorov avvia infatti una stagione “umanistica”, caratterizzata da una riflessione, da una parte, sull’universalismo e sulla possibilità di pensare e comprendere al suo interno le differenze, dall’altra sulla “modernità”. I suoi referenti sono, tra gli altri, Montaigne, Montesquieu, Tocqueville (attraverso Louis Dumont), Rousseau cui dedica il libro Fragile felicità, Benjamin Constant, per cui prova «una vera e propria simpatia, quasi un attaccamento personale», e alla cui opera De la religion dedica una prefazione. Qui Todorov si interroga pure sul ruolo dell’intellettuale “umanista”, sul significato di “impegno” e “responsabilità”, sul rapporto tra “sapere”, “pensiero”, e “azione”, attraverso figure come Albert Camus, Raymond Aron, le loro posizioni rispetto ai totalitarismi, alla Guerra d’Algeria, ecc.
Ancora i totalitarismi e i campi di concentramento, comunisti e nazisti, costituiscono l’osservatorio a partire da cui Todorov guarda alla condizione umana e alla vita morale in condizioni estreme. Di fronte all’estremo è appunto il titolo del suo libro in cui affronta queste questioni, oggetto della narrazione del capitolo ottavo, il cui filo conduttore è il senso morale della storia. Non si tratta tuttavia di una condanna senza appello ma della ricerca, insistita, di un senso, di una umanità colta attraverso quelle che Todorov chiama “virtù quotidiane”.
Nel capitolo nono, il filo della narrazione è la memoria, le sue sacralizzazioni e le sue banalizzazioni, i suoi “abusi” come Todorov li chiama, e la relazione con la giustizia. Nel decimo capitolo, infine, l’elogio della moderazione – tessuto lungo tutta la narrazione – si rivela chiave d’accesso al pensiero del nostro autore e lente attraverso cui ripensarne il percorso umano e intellettuale.
Va da sé che ciascuno dei capitoli torna su temi già messi a fuoco, altri ne anticipa. Gli eventi evocati, le questioni che quegli eventi hanno suscitato costituiscono la materia di una storia personale e di storie collettive strettamente intrecciate. Todorov dà forma e sostanza a quella materia presentandola secondo un intreccio coerente e intelligibile, come accade per ogni narrazione biografica o autobiografica, sguardo ordinato a posteriori su una serie di eventi che diventano appena una storia di vita.
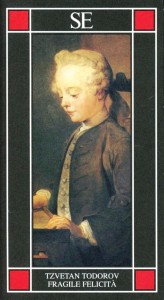 I temi affrontati, come abbiamo visto, sono tanti e tutti di interesse certo anche per i non specialisti. Anzi, come ho già detto, uno dei pregi del libro consiste proprio nel fatto di introdurre il lettore ai temi che hanno caratterizzato la produzione intellettuale di Todorov a partire dai suoi esordi, dall’inizio degli anni Sessanta del Novecento, temi che hanno segnato e scandito il dibattito scientifico e accademico più avanzato nell’ambito delle scienze umane. Proposti in modo innovativo e stimolante, non di rado essi sono stati veri e propri esempi di ricerca interdisciplinare. Le riflessioni sulla morale, la storia, i diritti, la giustizia immettono inoltre nel vivo del dibattito contemporaneo non solo nell’ambito delle scienze umane, e sono articolate non in modo astratto e accademico ma incarnandole, presentandole cioè a partire da esperienze dirette e vissute, con un saldo ancoraggio alla realtà concretamente esperita. Temi incarnati dunque, non solo nella vita del Narratore ma anche in tanti uomini e tante donne (anzi a queste guarda, mi sembra, con particolare rispetto e ammirazione), grandi e meno grandi, da lui incontrati, direttamente o indirettamente. La forza della riflessione di Todorov risiede proprio in questo: nel riferirsi a una realtà immediata, personale e collettiva, e nel cercare le risposte in quel serbatoio di “virtù quotidiane” di individui in carne e ossa, individui di uno spazio e di un tempo determinati, virtù che si connotano per la forza della loro paradigmaticità.
I temi affrontati, come abbiamo visto, sono tanti e tutti di interesse certo anche per i non specialisti. Anzi, come ho già detto, uno dei pregi del libro consiste proprio nel fatto di introdurre il lettore ai temi che hanno caratterizzato la produzione intellettuale di Todorov a partire dai suoi esordi, dall’inizio degli anni Sessanta del Novecento, temi che hanno segnato e scandito il dibattito scientifico e accademico più avanzato nell’ambito delle scienze umane. Proposti in modo innovativo e stimolante, non di rado essi sono stati veri e propri esempi di ricerca interdisciplinare. Le riflessioni sulla morale, la storia, i diritti, la giustizia immettono inoltre nel vivo del dibattito contemporaneo non solo nell’ambito delle scienze umane, e sono articolate non in modo astratto e accademico ma incarnandole, presentandole cioè a partire da esperienze dirette e vissute, con un saldo ancoraggio alla realtà concretamente esperita. Temi incarnati dunque, non solo nella vita del Narratore ma anche in tanti uomini e tante donne (anzi a queste guarda, mi sembra, con particolare rispetto e ammirazione), grandi e meno grandi, da lui incontrati, direttamente o indirettamente. La forza della riflessione di Todorov risiede proprio in questo: nel riferirsi a una realtà immediata, personale e collettiva, e nel cercare le risposte in quel serbatoio di “virtù quotidiane” di individui in carne e ossa, individui di uno spazio e di un tempo determinati, virtù che si connotano per la forza della loro paradigmaticità.
È vero, come osserva Todorov nell’Epilogo, che il libro non è né «una storia degli ultimi sessant’anni del XX secolo», né «una vera e propria biografia o autobiografia», né «un riassunto preciso» dei libri da lui pubblicati. Eppure, anche se nessuno di questi aspetti è prevalente, essi ci sono tutti. Essi rimandano a una sensibilità, a una scelta etico-politica oggi più che mai urgente e necessaria. È degna di interesse, in questa direzione, anche la chiave proposta per leggere questa storia personale che potrebbe essere assunta a metafora di un auspicabile destino collettivo: l’essere tra, la condizione di passatore. Come scrive Todorov: «sembra una delle mie ossessioni, forse per il fatto di esser passato da un paese all’altro: voglio sempre far oltrepassare le barriere, attraversare le frontiere, scoprire i passaggi in ambiti apparentemente autonomi» (cfr. capitolo terzo). O ancora con le sue parole: «L’interprete dei testi è a suo modo un passatore, egli cerca di far comunicare meglio lo scrittore e il lettore».
Todorov si riferisce qui al fatto che quando era adolescente si rimproverava di essere estremamente malleabile, di farsi influenzare troppo dai suoi interlocutori, di non avere idee che fossero veramente sue, di essere eccessivamente camaleontico. Dubitava insomma della sua capacità di piacere. Anche a questo lega le sue scelte professionali, e in particolare il fatto di essersi dedicato alla critica letteraria e al commento degli autori.
E, riprendendo la citazione, continua:
«Votandomi all’interpretazione degli altri, convertivo la mia infermità in vantaggio: li capivo, mi calavo in loro, poi parlavo con la loro voce. Io li dicevo ma, al tempo stesso, essi dicevano me, essi esprimevano le mie convinzioni meglio di quanto io sapessi fare» (p. 407).
 Il passatore tuttavia non è un mediatore perché egli non opera una sintesi ma si muove dall’una all’altra sponda del fiume del mondo, lo attraversa, vi passa in mezzo e non si ferma né sull’una né sull’altra, dando esito a una condizione che nega la logica bipolare. Il passatore è contro la logica essenzialista dell’identità e della cultura (Todorov dice di se stesso: «né bulgaro, né francese»), è contro gli steccati disciplinari, contro ogni visione manichea, e tende verso un «umanesimo ben temperato» alla ricerca di un po’ più di «saggezza» per vivere meglio
Il passatore tuttavia non è un mediatore perché egli non opera una sintesi ma si muove dall’una all’altra sponda del fiume del mondo, lo attraversa, vi passa in mezzo e non si ferma né sull’una né sull’altra, dando esito a una condizione che nega la logica bipolare. Il passatore è contro la logica essenzialista dell’identità e della cultura (Todorov dice di se stesso: «né bulgaro, né francese»), è contro gli steccati disciplinari, contro ogni visione manichea, e tende verso un «umanesimo ben temperato» alla ricerca di un po’ più di «saggezza» per vivere meglio
Scrive Todorov, e concludo:
«I miei libri si rivolgono a tutti, anche se non mi aspetto che l’intero globo se ne accorga… Cercando di aiutare gli altri, i miei lettori, mi preoccupo anche di aiutare me stesso a condurre una vita migliore, più ricca di senso e di bellezza, più aperta verso l’assoluto, e pure più felice. È un contributo, seppur minuscolo, alla felicità dell’umanità, dal momento che ne facciamo tutti parte. La preoccupazione di sé non è egoista se si sa che il sé non esiste senza gli altri, separato dagli altri. È bello amare l’umanità, ma, per iniziare, preoccupiamoci di essere umani presi ad uno ad uno» (p. 427).
Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018
________________________________________________________________________________
Gabriella D’Agostino, antropologa, insegna Antropologia culturale nell’Università di Palermo. È direttore responsabile del semestrale di scienze umane, Archivio Antropologico Mediterraneo, e direttore scientifico del festival internazionale di documentari, Sole Luna Doc Film Festival. Tra i suoi lavori più recenti: Altre storie. Memoria dell’Italia in Eritrea (Archetipolibri 2012); Sottotraccia. Percorsi tra antropologia e contemporaneità (Bonanno 2016).
________________________________________________________________________________