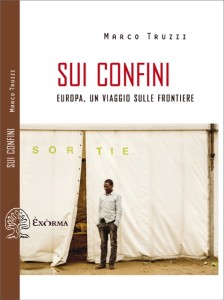La mappa del mondo che abbiamo in testa assomiglia al disegno di un bambino. Sono i contorni a definire le figure. Linee spesse e grossolane separano persone, piante, animali e cose dal resto del foglio dando vita alla scena; allo stesso modo noi generalmente concepiamo i paesi, compreso quello in cui viviamo, come ritagli di pianeta che agiscono sulla cartografia globale come figure di un disegno. In alcuni casi la similitudine si mostra in modo evidente: l’Italia è ‘lo Stivale’, la Francia l’Hexagone. Sono i contorni a determinare gran parte del senso del disegno; il resto è affidato a passate di colore quanto più omogeneo possibile, a conferma che quel tondo giallo è il sole e quell’altro tondo rosa è la faccia di una bambina. È uno schema naturale, frutto dei nostri processi cognitivi e culturali, che – come ci ripeteva sempre il maestro Antonino Buttitta – non sono altro che una costante discretizzazione del continuum spaziotemporale dell’universo. È il nostro modo di dare senso alla realtà. Un senso; uno solo, e basta.
La similitudine tra disegno infantile e confini tra Stati si ferma qui. Le arti figurative, a tutti i livelli della loro produzione, hanno esplorato la realtà sin dalla nascita della specie, intervenendo su di essa, raccontandocela in modi più complessi, suggerendoci movimenti e connessioni tra le forme, evidenziando i flussi che interlacciano il reale: gli animali sulle pareti della grotta Chauvet, la luce e il buio di Caravaggio, la quarta dimensione dei cubisti. Non è un caso se la pittura ha sempre ispirato l’animo della gente molto più degli accordi internazionali e dei trattati di pace: l’idea di Stato dall’epoca moderna ad oggi mantiene la rozzezza e la banalità delle opposizioni semplici. Contorni spessi, figure bidimensionali, fondo omogeneo; confini ipertrofici – sia sul territorio che nell’idea che ne abbiamo – e luoghi comuni sugli abitanti di un paese. Difficilmente evitiamo le generalizzazioni quando pensiamo a una nazione o a una regione dai confini definiti. Di fronte a una mappa, la nostra capacità di discernimento critico viene intrappolata; le divisioni tra buoni e cattivi, facce tristi e facce sorridenti, amici e nemici, corrono lungo le linee di confine.
Sui Confini. Europa, un viaggio sulle frontiere di Marco Truzzi e Ivano Di Maria (Exòrma Editore, 2017) esplora proprio questa dimensione del pensare lungo i confini, dell’agire umano sugli spazi a partire dalla costruzione dei limiti, percorrendo l’Europa (intesa in primis come Unione Europea) in lungo e in largo, dalle sue appendici meridionali in cui diventa Africa, al fronte orientale in espansione, fino alle sue estreme propaggini subartiche. La narrazione di Truzzi e le foto di Di Maria camminano lungo le linee di confine, esaminano le frontiere delle identità europee, facendo emergere dove possibile la polifonia dei soggetti in campo. Luoghi di confine, ma anche confini pensati, abitati, vissuti, incarnati nelle parole delle persone, nelle loro traiettorie esistenziali, nel loro modo di intervenire sul territorio. Confini geografici e mentali, narrati attraverso la disperata ma inarrestabile pressione di chi vuole sfondarle queste barriere, e la rabbiosa determinazione di chi vuole alzare muri sempre più invalicabili.
Il libro viene fuori dall’esperienza di Europe, around the borders (http://www.aroundtheborders.eu.), un progetto di ricerca e documentazione fotografica iniziato da Truzzi e Di Maria nel 2013, che ha già dato vita a una mostra fotografica itinerante e a numerose narrazioni pubbliche e presentazioni. Around the borders: l’Europa è quello che c’è intorno ai suoi confini, che diventano il centro del discorso e dell’osservazione. Il focus sui margini non è solo la classica inversione centro-periferia alla ricerca di una retorica altra da quella ufficiale; l’immagine di Europa che emerge dal testo, aldilà della nostalgia per gli ideali alla base dell’Unione, è quella di un gigantesco corpo parastatale senza organi basato sui confini. Sulla produzione di confini e sulla loro difesa.
Truzzi in apertura definisce l’Europa come una “promessa non mantenuta”. Il punto non è l’emergere delle spinte xenofobe, reazionarie e neofasciste, accomunate da una forte retorica antieuropeista, in tutti i Paesi membri. Non è la Brexit, o i vari Le Pen, Grillo e Salvini a sancire la fine del sogno della comunità europea come inclusiva, solidale, baluardo dei diritti umani. È l’Europa stessa a smentire le sue promesse, l’Europa che rafforza le frontiere piuttosto che aprirle, che ha armato le sponde del mar Mediterraneo e ha alzato chilometri di muri e di filo spinato, investendo miliardi in apparati militari e in tecnologia del controllo. «Il filo spinato, in fondo, è la vera voce narrante delle frontiere», senza soluzione di continuità dalle guerre mondiali ai campi di concentramento, alla cortina di ferro, ai limiti invalicabili della fortezza di Schengen.
Truzzi si riferisce a quel sogno europeo e a quella retorica comunitaria che ha visto intensificarsi subito dopo la caduta del muro di Berlino, momento che l’autore ha vissuto da adolescente con l’entusiasmo della fine della guerra fredda, come una promessa di un futuro di pace e di unità. È interessante notare come il simbolo che viene in mente per primo pensando alla fine del comunismo sia proprio la caduta di un muro: la definitiva vittoria del sistema delle democrazie capitaliste sul blocco socialista fu salutato come il trionfo della civiltà attraverso la lente del progetto europeo. Finalmente, le famiglie berlinesi poterono riabbracciarsi dopo decenni di assurda separazione; allo stesso modo l’UE attendeva di accogliere tra le sue braccia i Paesi orientali dell’Europa, una volta naturalmente che questi avessero accettato il modello dell’economia di mercato e aderito alle nostre regole.
La fede nella via dell’unione sovranazionale degli Stati europei ha accompagnato anche la generazione dei millennials, sin dai primissimi anni novanta, coi jingles pubblicitari in televisione, le schede sui sussidiari scolastici, gli ECU e poi gli euro a monete di cioccolato, i biglietti interrail, i progetti universitari di intercambio Erasmus e Leonardo. La fiducia nell’espansione del progetto europeista e l’esperienza di un continente senza frontiere hanno segnato un’epoca nell’immaginario civico di almeno due generazioni; un’epoca che per Truzzi è ormai giunta alla fine: «questi anni sembrano segnare un’epoca. Il ‘dopo’, in ogni caso, non sarà mai più come prima».
Secondo l’idea originale, il libro doveva essere un reportage fotografico delle frontiere abbandonate, lungo le linee delle trincee della prima guerra mondiale, al confine tra i due blocchi, come quelle di Gorizia e Tarvisio. Frontiere perdute, limiti valicati dalla contemporaneità inclusiva. Ben presto però i due autori hanno sentito l’urgenza di avere a che fare con le frontiere attuali, vive, con i focolai di tensione liminale. I migranti, malgrado le previsioni degli autori, diventano da subito un argomento molto importante nel testo. Migranti è il participio presente più azzeccato qui, in quanto si riferisce a movimenti umani non conclusi, al continuo spostarsi delle persone costrette a passare da una baraccopoli all’altra, dagli scogli di Ventimiglia alla jungle di Calais, dannandosi la vita per infilarsi su un altro treno, nascondersi in un altro bagagliaio, passare attraverso le maglie di un’altra rete.
I capitoli del libro corrispondono ad altrettanti confini, caldi e freddi, centrali e periferici. L’itinerario parte dal mappamondo illuminato nella stanzetta di Lorenzo, il figlio di Marco, e finisce nel Ground Zero d’Europa, il luogo della sua tragica origine, il peccato capitale che contiene ‘In Utero’ (Nirvana, non latino) il germe dell’unione. Truzzi conclude ad Aushwitz il suo esperimento di letteratura di frontiera europea, come se rievocare il mostro della guerra tribale nazifascista possa servire a esorcizzare la paura delle minacce antieuropeiste: «Proprio [ad Auschwitz] prende vita un sogno che nasce da un incubo e dal rifiuto, dalla negazione che un’altra Auschwitz possa accadere di nuovo».
L’idea da cui parte il volume è visuale, e tale rimane. Non c’è alcun approccio etnografico; la storia procede per immagini, sia attraverso gli scatti di Di Maria che nella prosa di Truzzi, giornalista e romanziere. Le loro voci imperniano la narrazione, leggono luoghi e vicende umane attraverso filtri che conosciamo. La scelta dei luoghi sembra quasi casuale, procede per giri tortuosi attraverso il continente, attraversando alcuni confini iconici dell’Europa che viviamo e tralasciandone altri, soffermandosi su punti poco noti della storia e della geografia della separazione, scegliendo personaggi a volte prevedibili, a volte sorprendenti. Partendo da Melilla, enclave spagnola incastonata nel Rif marocchino, il viaggio risale fino a Gorizia, svolta verso Basilea e la neutralità svizzera, procede sino al ponte di Öresund tra Danimarca e Svezia, e più oltre tra i boschi e le alci al confine tra Svezia e Norvegia. Da lì si torna giù, sugli scogli di Ventimiglia, poi nella jungle di Calais; da lì in Bosnia attraverso Gradiška, rivivendo gli stermini etnici delle guerre balcaniche nel lutto infinito delle madri di fronte alle stele commemorative. Gli autori risalgono poi in Ungheria, il cuore nero d’Europa, passano la dogana abbandonata con la Slovacchia, fino al ghetto di Cracovia e poi Passau, la città dei tre fiumi. Da lì si salta in Grecia: una sbirciatina ai militanti di Alba Dorata e poi dritti nell’inferno di Idomeli, il climax patetico del viaggio. Nell’ultimo capitolo ci ritroviamo in una visita guidata ad Aushwitz, dove si conclude il tutto: «Buonanotte, Europa. Buongiorno, Europa».
Le storie sono legate tra loro dall’incedere emotivo con cui il testo è stato editato, e dalla capacità narrativa di Truzzi che trasforma sapientemente gli incontri lungo il tragitto in personaggi che animano gli episodi del viaggio per poi scomparire prima della tappa successiva. Le pagine giocano e dialogano con i luoghi dell’immaginario comune europeo, sfrut- tandone la forza diegetica. Prevale un conflitto – più visuale che agito nelle storie narrate – tra la vitalità dei margini e la noia del benessere del cuore settentrionale dell’Europa, tra la gioventù dei migranti e la vecchiaia degli europei, tra la commozione di chi nasce alla stazione di Ventimiglia e l’antipatia per il business svizzero dell’eutanasia. Quasi mai il racconto dei luoghi e delle persone nel testo mette in crisi le idee preconcette che abbiamo, il bagaglio di immagini che filtrano il nostro sguardo sugli eventi dell’attualità e sul recente passato del continente.
Non è questo il senso di Sui Confini. La forza del testo sta nella sincerità dello sguardo degli autori, che ci restituiscono la loro antipatia per l’anziana svedese ai bagni di Malmö, il fastidio per Moustafà, cinico tassista abusivo di Melilla – uno dei personaggi più riusciti del libro –, la commozione disperata per la bambina che gioca tra i lacrimogeni e le pallottole di gomma al confine con la Macedonia. Emozioni scontate, sterili, che riproducono l’ambiguità del nostro agire e patire da privilegiati del Primo mondo; eppure emozioni vere, che attraversano l’animo di chiunque faccia ricerca o semplicemente passi da quei luoghi, e che gli strumenti dell’analisi antropologica ci permettono di controllare e di scomporre in parti di senso solo dopo un lungo e severo processo di addomesticamento. Queste emozioni esistono dentro di noi, narrano le nostre lacrime davanti alle immagini di un bambino siriano morto su una spiaggia turca e la nostra indifferenza di fronte ai sanguinosi conflitti scaturiti per mantenere bassi i prezzi dei nostri beni di prima necessità: batteria del cellulare, microprocessore del computer, benzina. Truzzi patisce queste emozioni in prima persona, cerca un senso nei drammi a cui assiste attraverso di esse; non lo trova, torna a casa con le stesse immagini con cui era partito. Eppure non si inventa una conclusione, non nasconde l’astio di chi soffre nei confronti di chi indaga la sofferenza senza viverla, non risponde a nessuna domanda, non esprime giudizi. Ci mostra un album di istantanee.
Resta la domanda su che diritto abbiamo di parlare dei mali del mondo se stiamo bene, di raccontare la tragedia epocale della migrazione clandestina stando al di qua del muro, di mostrare le ferite degli sconfitti della terra quando gli spari della polizia di frontiera non sono per noi, noi che viaggiamo con i documenti in tasca. Questa domanda non c’è nel libro; c’è nella mia testa di aspirante antropologo delle migrazioni, oggi che il movimento umano e lo scontro tra culture sono più che mai terreno privilegiato dell’agire biopolitico, e le scienze sociali non assolvono nessun ruolo di critica strutturale, nessun’altra funzione pubblica se non fornire informazioni su chi è oggetto di ricerca, permettendo all’opinione pubblica europea di sentirsi in contatto con la realtà dalla propria poltrona leggendo libri e giornali, informandosi attraverso lo schermo di un computer.
Truzzi vive questa inquietudine nelle pagine del libro, non ne fa una questione disciplinare, non si appella al falso mito di dare voce a chi non ne ha. Risolve questo conflitto sul campo, spiegando alla gente che incontra le sue ragioni per essere lì, accettando di essere mandato a fanculo da chi ha ben altro a cui pensare, strappando con pazienza un sorriso da chi si vede finalmente ritratto in una bella foto d’autore e non nella scheda segnaletica di un centro di detenzione. Il senso del viaggio si espleta nei contatti umani diretti; Truzzi ce li restituisce grondanti di esperienza, ci fa sentire l’odore acre del sudore sotto le tende, ci infanga i piedi nei sentieri tra le baracche, ci secca la gola con la polvere e il gas dei luoghi in cui l’Europa celebra col filo spinato il suo mito di terra promessa di seconda scelta, lontano dagli occhi benpensanti della sua opinione pubblica. La vivida narrazione di Sui Confini ha il merito di sporcare chi legge con la materia di cui è fatto il libro. E non è poco.
È questo il senso di ‘discesa verticale’ su cui insistono tanto Orfeo Pagnani e Maura Sassara, che hanno dato vita al progetto editoriale Exòrma, e che mi viene illustrato con chiarezza affabile da Silvia Bellucci, responsabile dell’ufficio stampa. Il nome stesso della casa editrice significa mollare gli ormeggi; da questa idea di immersione nel viaggio nasce la collana Scritti Traversi: un esperimento contem- poraneo di letteratura di viaggio, nato al confluire di linguaggi meticci con incursioni di antropologia, fotografia e scrittura narrativa. Nel catalogo, di cui Sui Confini è l’ultima uscita, figurano preziosi titoli come Artico Nero di Matteo Meschiari e Capo Verde un luogo a parte di Marco Boccitto.
L’umorismo di Truzzi, il tono colloquiale della sua prosa e i continui rimandi al calcio, alla letteratura e al cinema rendono la lettura leggera anche nei passi più drammatici. Ciononostante, il segno comune delle descrizioni è il dolore, e il degrado. Per primo, il degrado di un’Europa vecchia e gelosa dei suoi privilegi basati sullo sfruttamento su scala mondiale. Il libro insiste su immagini del decadimento culturale, l’indebolimento identitario, la crisi dei valori di progresso e accoglienza del mondo di cui facciamo parte. Si mostra il cinismo dei nuovi Paesi membri, gelosi e affamati degli striminziti privilegi ottenuti con l’allargamento dell’UE, che accettano il lavoro sporco di difendere violentemente i cancelli d’Europa pur di ritagliarsi un posticino al sole. I migranti non vengono esclusi dalla rappresentazione del dolore: lo squallore esistenziale dei campi di Calais e la disperazione della gente ammassata lungo cancelli che non verranno loro aperti risuona nelle parole e nelle immagini senza essere mitigata dagli episodi positivi che punteggiano il racconto. Eppure, un senso di energia inarrestabile pervade le descrizioni delle masse di diseredati che premono alle porte dell’impero, e alla disperazione delle tragedie personali si accompagna la consapevolezza collettiva di costituire una forza storica che nessun accordo politico-militare sarà in grado di arrestare.
Quelle scritte “Wedon’tgoing back” e “Open the borders” immortalate dall’obiettivo di Di Maria hanno una forza comunicativa che va molto oltre i piccoli pannelli di cartone su cui sono state graffitate con mano incerta. Sono un dito medio piantato in faccia all’elettorato xenofobo europeo: quelle scritte dicono il vero. Per quanti miliardi possano essere spesi in trattati internazionali, controlli e piani di rimpatrio, per ogni migrante espulso o respinto ne arrivano altri; e sebbene sembri impossibile, tanti giovani, donne e uomini, riescono nell’impresa di scavalcare muri, attraversare tratti di mare aperto a nuoto, varcare check-points stipati per ore dentro il cruscotto di un’auto. Truzzi è bravo a tratteggiare la forza storica della speranza, un sentimento che muove miliardi di traiettorie esistenziali stravolgendo le dinamiche geopolitiche e piegando il corso della storia. La speranza, che insieme all’utopia viene indicata da Meschiari come prodigioso motore politico e culturale nella storia degli Stati Uniti d’America, sapientemente veicolata dalla campagna comunicativa di Trump.
L’amarezza è data dal fatto che anche il sogno Europeo era nato con l’energia della speranza. L’Europa suggerisce – o suggeriva – un ideale nuovo, che sembrava dover mettere definitivamente in pensione i vecchi nazionalismi che avevano insanguinato il continente. Proprio dalle ceneri della seconda guerra mondiale sorgeva l’idea di mettere insieme vincitori e vinti nel sogno di pace e unità nel continente che aveva prodotto tutti i più gravi conflitti su scala mondiale. Invece, per ogni muro abbattuto, l’Europa ne ha eretto cento, espandendo le sue frontiere e demandando il loro controllo a Paesi asiatici e africani. I passeurs e gli scafisti, i campi di prigionia in Libia, il razzismo di regime nei paesi del Nordafrica, la violenza sistematica su uomini e donne, sono frutto delle politiche dell’Unione Europea tanto quanto i diritti civili, il progetto Erasmus, il wi-fi libero. Solo che non li vediamo. Sono oltre il limitato orizzonte visivo della nostra opinione pubblica, dentro l’orizzonte visivo di diverse forme di opinione pubblica, che se ne infischiano. Come a Melilla.
Non c’è di che stupirsi; in fondo la storia è sempre la stessa. Le nazioni sono artefatti inventati, le basi culturali delle unità nazionali si creano sempre a posteriori. Nulla di culturale accomunava veneti e calabresi intorno alla metà del XIX secolo, nulla al di fuori di un’idea di nazione condivisa da una manciata di intellettuali romantici, di politici, di finanzieri, di industriali e di proprietari terrieri. Nulla al di fuori di una nobile lingua di scrittori e poeti che non parlava neanche il re. Nulla al di fuori del sogno di terra e libertà di migliaia di giovani siciliani che si unirono entusiasti alle camicie rosse sgominando l’esercito borbonico; un sogno concepito e subito infranto dalla spietata repressione garibaldina, fedele agli interessi diplomatici sabaudi molto più che al patriottismo rivoluzionario. I contadini fucilati a Bronte dalle truppe di Nino Bixio, così come le migliaia di rumeni espulsi dal governo Sarkozy nel 2010, ci ricordano come tra i discorsi sulla cittadinanza inclusiva e il suo concreto funzionamento ci sia uno iato incolmabile, che deriva dalle forze strutturali che producono gli Stati, molto più concrete dell’amor di patria.
Quello che ci è stato venduto come internazionalismo, libertà di movimento e coesistenza tra i popoli sembra essere in realtà solo il conglobarsi di stati e staterelli – alcuni talmente piccoli che nella mappa sono indicati soltanto con l’iniziale – in un organismo le cui regole di inclusione ed esclusione non seguono nessun parametro identitario o nazionalistico: rumeni e bulgari insieme a danesi, croati e austriaci, ciprioti e britannici, magari tra un po’ anche turchi e bosniaci. Non c’è una categoria del ‘noi’ tanto grande da farci stare dentro tutti. I criteri sono altri: convenienza politica, opportunità strategica, e soprattutto criteri economici di mercato e finanziari.
Tutto ciò non basta a Truzzi per sancire la fine del sogno europeo. Per lui, l’energia per reinventare l’Europa può venire dal rischio concreto della guerra e della distruzione, da campanilismi mai sopiti, dall’uso della xenofobia come valvola di sfogo sociale, dall’emergere sempre più minaccioso e violento di confini che, più che tener fuori i profughi siriani, sono confini interni. Gli stessi confini che ci vengono proposti dai giovani europei che massacrano e che si fanno uccidere in nome di un ideale che può essere compiuto solo con l’annientamento del mondo occidentale, lo stesso in cui sono nati e cresciuti.
Dialoghi Mediterranei, n.26, luglio 2017
_______________________________________________________________________________
Eugenio Giorgianni, laureato in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha recentemente completato il Master of Arts in Visual Anthropology presso The University of Manchester. Tra il 2011 e il 2012 ha condotto, con il supporto della Universidad de Granada, una ricerca etnografica presso la comunità dei migranti in transito a Melilla (Spagna africana). Tra i suoi interessi di studio temi e questioni relativi all’antropologia dello spazio. In questa direzione ha condotto una ricerca sul quartiere palermitano di Ballarò
________________________________________________________________