L’idea che la traduzione costituisca un tradimento del testo originario è antica e ribadita più volte nel corso del tempo nelle più diverse situazioni: la coppia di termini si rifà a un etimo comune presente nelle lingue neolatine anche se poi si realizza in binomi diversi per ogni lingua (it. Tradurre / tradire, fr. Traduction / trahison, sp. traducir / traicionar, rum. Traduce / trăa). A prescindere in ogni caso dal gioco di etimologie e binomi conseguenti, è opinione comune che il tradimento non appaia insito nell’atto stesso del tradurre: nei fatti quest’ultimo consiste nel passaggio da una lingua all’altra, ma è anche e più di tutto trasposizione da una cultura all’altra (Eco 2003). Ne deriva una conseguenza operativa di rilievo:
«La domanda fondamentale che si pone chi sceglie la professione del traspositore di culture e d’idiomi e si definisce traduttore, fin dal primo sollevare di penna e aprir di dizionario, è come tradurre un testo in maniera neutra ma comprensibile alla propria cultura senza cadere nella tentazione … di metterci del proprio, sottraendo a volte o donando altra ricchezza e profondità all’opera altrui. In entrambi i casi lo si fa “lavorando” in proprio, dando vita a qualcosa di diverso dall’originale e quindi in qualche modo “tradendo” nel bene o nel male la propria missione e la propria professione … Ogni traduzione crea un ponte che collega anche per strade tortuose mondi lontani. È come l’opera di un artigiano, piena d’amore e fedeltà ma al contempo un piccolo esercizio di libertà … Per quanto faticoso e arduo sia trovare nella propria lingua concetti surrogabili ad altri che non appartengono al traduttore o vocaboli che nella sua cultura sono insignificanti, quanto a volte persino insensati, aprire la mente e cercare l’uguaglianza e la misura è esercizio estremamente stimolante» (Tamagnini 2012: 9).
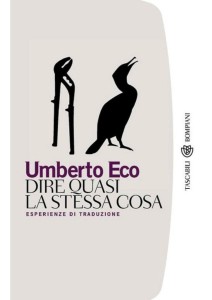 La validità del binomio, in ogni caso, con la coppia di termini che si sostengono l’un l’altro, risale a tempi remoti. È da dire però che in anni recenti l’idea del tradire tende a smarrirsi e ne lascia subentrare una nuova, più potente e articolata: tradurre, lungi dall’essere un atto di tradimento, involontario e inconsapevole che sia, è un’opera di ricostruzione del testo sino al punto di potersi ritenere un atto di ricostruzione volontaria, esplicita e consapevole, dovuta alla molteplicità dei codici in gioco, linguistici in primo luogo, e poi iconici e sonori, oltre che a ragioni politico-ideologiche, per non dire di altre ancora riconducibili alle nuove tecnologie.
La validità del binomio, in ogni caso, con la coppia di termini che si sostengono l’un l’altro, risale a tempi remoti. È da dire però che in anni recenti l’idea del tradire tende a smarrirsi e ne lascia subentrare una nuova, più potente e articolata: tradurre, lungi dall’essere un atto di tradimento, involontario e inconsapevole che sia, è un’opera di ricostruzione del testo sino al punto di potersi ritenere un atto di ricostruzione volontaria, esplicita e consapevole, dovuta alla molteplicità dei codici in gioco, linguistici in primo luogo, e poi iconici e sonori, oltre che a ragioni politico-ideologiche, per non dire di altre ancora riconducibili alle nuove tecnologie.
Tradurre manipolando
Un passaggio dal tradire al ricostruire richiama quello che qui intendiamo con l’espressione manipolare per comunicare, la quale sottende un orientamento innovativo che nella pratica del tradurre vede un’opera non di semplice trasposizione, né tantomeno di sostituzione di parole da una lingua all’altra, ma di reale e concreta ricostruzione del testo di partenza: di qui il passaggio al concetto di manipolazione che è dato ritrovare in prima istanza nella manipulation thesis sostenuta da Theo Hermans (1985). L’autore intravede infatti nella traduzione un genere letterario di primaria importanza che, come avviene per la gran parte delle azioni sociali e politiche, dipende da istituzioni impegnate a coltivare solo i generi culturali su cui convergono le volontà delle classi al potere.
Nel “manipolare” pensieri e modi d’essere delle diverse società un ruolo centrale finisce con l’essere riservato alla traduzione la quale appare un «genere letterario primario di cui le istituzioni sociali dispongono sì ma in primo luogo per manipolare una società al fine di costruire il tipo di cultura voluta». Il quadro che Hermans delinea e denuncia risulta politico e ideologico insieme: vi rientrano varie «considerazioni sull’esigenza di prender coscienza del potenziale manipolatorio che il lavoro dei traduttori può avere per l’universo dei lettori» (Barrale 2011: 12).
La manipulation thesis registra negli anni una veloce crescita di interesse e di attenzione: sono molti gli studiosi di traduttologia che cominciano a coltivare i nuovi approcci, tutti facenti parte della Manipulation School, ripresi tra i primi da Susan Bassnett e André Lefevere che avviano progetti di ricerca in settori diversificati e «prendono in esame i condizionamenti ideologici e politici cui le traduzioni vanno soggette».
Sulla stessa linea si muove Lawrence Venuti per il quale il testo tradotto è una creazione «al servizio della cultura che traduce». È infatti nella cultura d’arrivo che prende il via la maggior parte dei progetti traduttivi, ed è lì che un testo straniero viene scelto per soddisfare gusti diversi da quelli che ne hanno motivato la creazione e la ricezione nella cultura di partenza. Esito di decisioni e imposizioni assunte nella cultura d’arrivo, per il fatto stesso di costruire rappresentazioni sia pur parziali di identità culturali, «la traduzione può scatenare nel contesto che la accoglie un inevitabile effetto destabilizzante, rivelando la precarietà su cui si fonda l’autorità sociale delle istituzioni culturali e politiche». Poiché costituisce la rappresentazione di un testo e di una cultura straniera in qualche modo determinata,
«il testo tradotto definisce all’interno della cultura d’arrivo un modo di comprendere che è anche una posizione ideologica, permeata di codici e di canoni, di interessi e di obiettivi propri di determinati gruppi sociali [e] può esercitare una certa influenza sia nel mantenere che nel modificare la gerarchia di valori propri della lingua d’arrivo» (Venuti 1995: 40).
André Lefevere, da parte sua, non manca di rilevare come il potenziale sovversivo di una traduzione risieda nel rischio del confronto della cultura d’arrivo con un diverso modo di guardare alla vita e alla società:
«Il percorso di un testo letterario tradotto, che alla fine sfocia nel suo accoglimento o nel rifiuto, nella sua canonizzazione o nella non canonizzazione, è regolato dall’insieme di “centri di potere (persone e istituzioni) in grado di favorire o ostacolare la produzione, la diffusione e la riscrittura di opere letterarie”: ogni riscrittura può costruire immagini distorte e rappresentare pertanto manipolazioni testuali che si pongono al servizio del potere» (Lefevere 1998: 56).
La tendenza di coloro che traducono ad adattare i testi all’ideologia dominante o alle concezioni politiche del tempo si riscontra con maggiore frequenza nei testi tradotti in Paesi dove vigono regimi totalitari pur essendo «tutt’altro che assente nelle società democratiche, dove la produzione di riscritture viene condizionata, in modo del tutto analogo, da altre correnti esegetiche».
Nel quadro che si delinea in seno agli studi sulla traduzione è ora il momento di inserire la prima di diverse tematiche che vi sono sottese. La prima riguarda il comunicare per manipolare, tema di una vasta letteratura che nasce nei primi decenni del Novecento: il timore di una possibile “manipolazione delle coscienze” si amplia a partire dagli anni Trenta quando, con l’avanzare dei regimi totalitari in Europa e con l’imporsi del modo di produzione capitalista in USA, le società occidentali si ritrovano esposte a massicce ondate di campagne di pubblicità e di propaganda condotte da comunicatori di professione sui mass media appena nati. L’allarme suscitato nei più sensibili pensatori del tempo è grande perché quel genere di messaggi sembra sortire effetti “manipolatori” su destinatari inermi e non avvertiti e tutto avviene in maniera decisa, secondo una linea di pensiero detta Bullett Theory, o teoria bersaglio, a indicare la certezza con cui i messaggi colpiscono i destinatari.
Il “comunicare per manipolare” costituisce da allora in poi una sentenza fatta propria da tutto l’orientamento degli “apocalittici”, i quali temono una conseguente omologazione di culture, e diventano patrimonio collettivo di un’intera generazione di intellettuali le riflessioni condotte da Max Horkheimer, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, i fondatori della Scuola di Francoforte le cui riflessioni si incentrano sugli effetti prodotti dall’industria culturale. Adorno nota al riguardo che «il messaggio nascosto può essere più importante di quello evidente, poiché quello nascosto sfuggirà ai controlli della coscienza, non sarà evitato dalle resistenze psicologiche nei diversi consumatori, ma di certo penetrerà nel cervello degli spettatori» (1969: 384).
Nei fatti, tra gli anni Venti e i Quaranta si delinea quella che oggi è detta strategia della manipolazione per come viene operata dall’industria culturale, mezzo di dominio esercitato attraverso messaggi latenti che «fingono di dire una cosa e invece ne dicono un’altra … [per cui] lo spettatore, attraverso il materiale che osserva, viene messo continuamente, a sua insaputa, nella condizione di assorbire ordini, prescrizioni, proscrizioni» (Wolf 1985: 90).
Lo stesso orientamento, di forte critica a quello visto come esito di un vasto «progetto di colonialismo capitalista», non stenta a diffondersi anni dopo in un settore coltivato da linguisti e politologi interessati all’uso politico della lingua: tra di loro si segnala Louis Jean Calvet che in Linguistique et colonialisme (1977) denuncia con forza una «manipolazione linguistica» nel diffondersi e nell’imporsi di lingue d’uso internazionale come l’inglese che più che ampliare il raggio della comunicazione finisce con l’imporre ideologie e visioni del mondo delle società egemoniche sulle subalterne. L’imposizione di lingue ufficiali a parlanti autoctoni, come accade nei Paesi coloniali, genera processi di manipolazione culturale: ponendosi accanto ai mass media le lingue europee procedono nella stessa opera.
Non passa molto tempo che, entro prospettive legate allo strutturalismo e al determinismo linguistico, tende a rovesciarsi il binomio di partenza e si richiama la dovuta attenzione su un nuovo binomio, manipolare per comunicare, mostrando come sia il primo a condizionare l’altro, e non viceversa. In questo senso è chiaro che il termine manipolare non significa influenzare o condizionare l’opinione pubblica, ma “lavorare con le mani”, “dar forma a qualcosa”, un po’ come si manipola l’argilla per farne manufatti di terracotta. In questa prospettiva, inoltre, l’argomento della manipolazione non viene accantonato ma riproposto in nuovi termini, che se non sono apocalittici rimangono in ogni caso problematici: a dare un’idea di come la questione della manipolazione si ripresenti ad un livello molto più profondo sono le ricerche etnografiche condotte da antropologi e linguisti, i rilievi della semiotica sul ruolo svolto dalla lingua nel definire i tratti di una cultura, gli studi di sociologia della conoscenza incentrati sulla costruzione di realtà operata dalla lingua (Giacomarra 1997).
In quest’ottica i codici utilizzati per comunicare risultano a loro volta esiti di manipolazioni previe, che se ne sia consapevoli o meno: non comunicare per manipolare, dunque, ma prima ancora “manipolare per comunicare”, essendo quest’atto la condizione di quello; è impossibile comunicare se ciò che si vuol dire non è stato prima manipolato, ovvero plasmato e “formato” dalla lingua proprio come si dà forma all’argilla per conferire forma e funzione al manufatto.
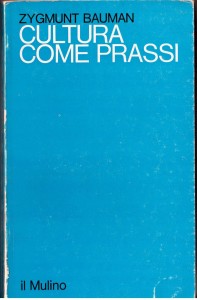 Comunicare per costruire realtà
Comunicare per costruire realtà
La tappa che segue al manipolare per comunicare è il comunicare per costruire realtà su cui concentra l’attenzione il primo Zygmunt Bauman, antropologo prima che sociologo della società liquida e autore di quella Cultura come prassi oggi quasi del tutto ignorata. Egli fa proprio un orientamento innovativo mantenendosi lungo una prospettiva che diciamo funzionalista e aderendo ad un principio di liberazione che supera pur con qualche difficoltà l’ideologia determinista: ciò perché non si può metter da parte la funzione di “adattamento” svolta dalla cultura senza prima aver colto le implicazioni d’ordine socio-politico che la prassi in quanto tale contempla. Nelle “società fredde” le strutture di base non possono essere messe continuamente in discussione col rischio che vengano meno le possibilità stesse di sopravvivenza dei gruppi umani, il che contribuisce a spiegarne peraltro il sostanziale conservatorismo e il puntuale rispetto delle soluzioni convalidate dalla tradizione. Altre società sono libere invece di mettersi di continuo in discussione: le esigenze di sopravvivenza non vi vengono compromesse in quanto si collocano molto in basso, soddisfatte come sono su piani ben più di base di quelli in cui si conduce la contestazione e si genera il mutamento (Bauman 1976).
«Il lessico – ha modo di osservare sulla stessa scia Giorgio R. Cardona in una prospettiva etnolinguistica – presenta distinzioni più sottili nei settori che hanno maggiore importanza culturale per cui, in culture che hanno come principale alimento il riso, possiamo aspettarci che la lavorazione e i diversi tipi di riso siano indicati con un lessico molto articolato». È noto del resto come la lingua rientri nello stesso campo semantico della prassi dal momento che viene assunta come strumento primo nel «ritagliare realtà preumane». Le aree di particolare densità culturale sfidano la trasmissione nel tempo e la diffusione nello spazio solo perché sono formate sul piano linguistico, pena il rischio di rientrare nella non-cultura: «Settori dell’esperienza legati alla cultura materiale non è un caso che si costituiscano come modelli di riferimento conoscitivo rispetto ad altri campi dell’esperienza umana» (1976: 100-01).
Non mancano conferme di vario genere, a partire dai già noti modi di “nominare” la neve e le foche tra gli Eschimesi, nei quali si impone con tutta evidenza la funzione della lingua che, mantenendo distinte le unità individuate, ne consente la classificazione in termini funzionali e la comunicazione: la simbiosi con gli animali si traduce in diverse visioni del mondo le quali si estendono ai diversi aspetti del quotidiano.
La lingua, infine, opera vere e proprie “costruzioni di realtà” rispondendo alle esigenze dettate dai diversi generi di prassi legati ai bisogni di sopravvivenza. Ogni lingua è un mezzo di costruzione di realtà, secondo quanto suggerito da antropologi, linguisti e semiologi anche se in questa direzione i maggiori insegnamenti vengono dai sociologi della conoscenza se il concetto stesso di «realtà come costruzione sociale» appartiene alle loro elaborazioni e ne costituisce ancora il fondamento, a cinquant’anni anni ormai da The Social Construction of Reality (1969) di Peter Berger e Thomas Luckmann.
Con la pubblicazione di quel libro negli USA si può dire che i due sociologi abbiano lanciato una vera e propria sfida:
«Essi, assai ambiziosamente, intendevano impegnarsi in un “ragionamento teorico sistematico” i cui presupposti erano decisamente critici rispetto alle spiegazioni funzionalistiche prevalenti – osserva Loredana Sciolla nella prefazione all’edizione italiana – (…) Al centro dell’indagine non sono più le idee e le dottrine, ossia la conoscenza teorica prodotta dalle élites intellettuali, ma tutto ciò che passa per conoscenza in una società, più di tutto quindi le conoscenze preteoretiche che costituiscono il patrimonio comune e indiscusso dell’individuo nella realtà della vita quotidiana» (Berger Luckmann 1989: 17).
L’ipotesi interpretativa qui elaborata segue linee di pensiero che, partendo da Max Weber, passano per la fenomenologia di Alfred Schutz per cui vi si ritrovano aree di studio e riflessione quali si incontrano nel rapporto fra relazioni sociali e comunicazione.
Nell’idea di “costruzione sociale della realtà” convergono linee di pensiero già note: la realtà nella quale gli uomini interagiscono quotidianamente appare costruita socialmente e si delinea nel tempo tramite processi di “istituzionalizzazione” e “concrezione” (o “riduzione”) di significati. Ciò che importa rilevare è che la lingua, in un modo o nell’altro, vi svolge il ruolo centrale più volte richiamato: ciò che crediamo di percepire come reale non ha alcuna consistenza oggettiva, ma varia da una società all’altra, prodotto, trasmesso e conservato attraverso processi culturali, ovvero lingue variabili da una società all’altra e che solo attraverso pratiche di traduzioni possono far condividere tratti di una comune cultura. La conseguenza finale è una: «Quella che noi chiamiamo realtà non può essere che una costruzione sociale, la quale è oggetto di codificazioni, mediazioni, trasmissioni che finiscono col dare una consistenza simbolica a qualcosa che, in linea di principio, può non averne» (ivi: 136).
 Riscrivere per creare nuove realtà
Riscrivere per creare nuove realtà
Quali altre conseguenze sono rilevabili sulla traduzione? La prima è l’idea di riscrittura (rewriting) In effetti, l’idea stessa di manipolazione, e poi di costruzione di realtà, evolve in breve tempo verso nuove tesi, non meno suggestive di altre proprie di quella che vien detta costruzione culturale. La traduzione torna ad apparire ancora come il genere letterario per eccellenza di cui dispongono le istituzioni per manipolare le società e costruire la cultura voluta, ed è questa la riflessione che emerge dal mondo dei Cultural Studies verso il quale si orientano sia Bassnett che Lefevere.
La tesi della cultural construction si accompagna in realtà a tutta una complessa problematica incentrata sull’idea di rewriting alla quale si rivolge una crescente attenzione da parte dagli studiosi richiamati: lungo questa linea si muove André Lefevere che nel rewriting fa rientrare tutti i processi nei quali «il testo originale viene reinterpretato, alterato o manipolato» e accanto alla traduzione, vi fa rientrare la creazione del canone, l’antologizzazione e la scrittura critica. Egli non manca inoltre di mettere in rilievo il fatto che i criteri di riscrittura sono dettati, in maniera talora inconsapevole, dall’ideologia del traduttore e dalle poetiche dominanti dell’epoca; e non si preoccupa infine di evidenziare come «la traduzione rappresenti la modalità più riconoscibile di riscrittura, e sia potenzialmente la più influente in quanto capace di proiettare l’immagine di un autore, e/o delle sue opere, oltre i confini della loro cultura d’origine» (in Mazzara 2004).
Di seguito al lungo percorso interpretativo che dalla sostituzione di parole giunge alla manipolazione di testi e alla vera e propria riscrittura, l’idea di costruzione di realtà trova fondamento in Constructing Culture (1998), testo curato ancora da Bassnett e Lefevere. La prima sostiene, in partenza, che fra Translation Studies e Cultural Studies esiste uno stretto collegamento essendo caratterizzati dalla comune natura ibrida poiché entrambi stanno a metà tra gli studi di letteratura e di linguistica, da una parte, e studi letterari e socioculturali, dall’altra: qui vengono evidenziati i parallelismi nella comune tendenza ad ampliare lo studio della letteratura con quello del testo in un determinato contesto.
Al di là dei singoli autori che rientrano nel manipulation group, non c’è chi non ponga l’accento sulle implicazioni ideologiche della traduzione e al contempo non manca di porsi domande su che genere di testi si traducono in un determinato sistema letterario, sul come e sul perché, né di contrastare la tendenza secolare a riconoscere al testo tradotto una posizione inferiore all’originale. Da un orizzonte culturale in cui appariva netta la linea di demarcazione tra l’opera di traduzione e i comuni settori di ricerca si passa infine a delinearne uno in cui è l’attenzione verso l’altro ad accomunare gli studi sulla traduzione a nuovi ambiti come gli studi post-coloniali e più in generale la ricerca etnografica.
Dialoghi Mediterranei, n. 29, gennaio 2018
Riferimenti bibliografici
Adorno Theodor W. (1969), Televisione e modelli di cultura di massa, in Livolsi (1969).
Barrale Natascia (2011), Una verifica della manipulation thesis: come si tradusse dal tedesco sotto il Fascismo, La Fabbrica del Libro, n. 1.
Bassnett Susan (1993), La traduzione. Teoria e pratica, trad. it., Bompiani, Milano.
Bassnett Susan Lefevere André (1998), Constructing cultures. Essays in literary translation, Multilingual Matters, Bristol.
Bauman Zygmunt (1976), Cultura come prassi, Il Mulino, Bologna.
Berger P. Luckmann T. (1989), La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna.
Calvet Louis J. (1977), Linguistica e colonialismo, Mazzotta, Milano.
Cardona Giorgio R. (1976), Introduzione all’etnolinguistica, Il Mulino, Bologna.
Eco Umberto (2003), Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione, Bompiani, Milano.
Giacomarra Mario G. (1997), Manipolare per comunicare. Comunicazione e costruzione di realtà, Palumbo, Palermo.
Giacomarra Mario G. (2016), Sharing Sociology. Il ruolo della comunicazione nella sociologia della condivisione, Palumbo, Palermo.
Hermans Theo (1985), The Manipulation of Literature, Bekkenham, Croom Helm.
Lefevere André (1998), Traduzione e riscrittura. La manipolazione della fama letteraria, Utet, Torino.
Livolsi M. (1969), Comunicazione e cultura di massa, F. Angeli, Milano.
Mazzara Federica (2004), La traduzione come studio culturale, Culturalstudies.it
Tamagnini Isa (2012), L’annosa questione del ‘tradurre è tradire’, Cartaecalamaio. com
Venuti Lawrence (1995), The Translator’s Invisibility: A History of Translation, Routledge, London.
Wolf Mauro (1985), Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani, Milano.
_______________________________________________________________________________
Mario G. Giacomarra, di formazione antropologica e docente di Sociologia della Comunicazione all’Università di Palermo, è stato l’ultimo Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia prima della sua confluenza nella Scuola delle Scienze umane e del Patrimonio culturale. Si è occupato a lungo di migrazioni e dei processi di integrazione, mettendo a confronto i fenomeni della contemporaneità con quelli che hanno determinato le minoranze storiche galloitaliche nel XII secolo e albanesi nel XV. Tra le pubblicazioni su questi temi si segnalano: Immigrati e minoranze. Percorsi di integrazione (1994); Migrazioni e identità. Il ruolo delle comunicazioni (2000); Condizioni di minoranza oggi. Gli albanesi di Sicilia fra etnicismi e globalizzazione (2003). Ha curato nel 2006 gli Atti del Congresso Isole. Minoranze migranti globalizzazione, promosso dalla Fondazione Buttitta. Ha pubblicato anche: Una sociologia della cultura materiale (2004); Fare cultura in Sicilia (2007); Comunicare per condividere (2008); Il piacere di far libri. Percorsi di editoria in Sicilia (2010); Sharing Sociology. Il ruolo della comunicazione nella sociologia della condivisione (2016).
________________________________________________________________









