di Aldo Aledda
Due giovani romani, cui diamo i nomi immaginari di Massimo e Carlo, ma protagonisti di una vicenda vera, decidono di trascorrere una gradevole notte romana di un anno fa ad arricchire il proprio bagaglio culturale recandosi alle Terme di Caracalla ad assistere a una rappresentazione dell’Aida. Al termine del primo atto, nella buvette del teatro Massimo è colto esternare all’amico un auspicio: «Speriamo che adesso “diano” Va pensiero?».
Chi è un po’ informato sull’andamento di certe vicende musicali sa che il celebre coro degli ebrei in esilio è stato scritto da Giuseppe Verdi nel Nabucco trent’anni prima dell’altra opera cui assistevano i due giovanotti, rappresentata al Cairo nel 1871 per l’inaugurazione del canale di Suez. Certo, non tutti si recano a vedere un’opera lirica senza alcune informazioni di base, autore, trama, notizie su chi l’ha composta e chi la interpreta, ma ciò che spiega certi approcci è anche un modo per certi versi colpevole di rapportarsi alle opere d’arte tipico del turismo “mordi e fuggi” e le esigenza di una cultura cosiddetta di massa che oggi invero infesta tutto il comparto artistico e che richiede che tutto appaia quanto più possibile “attuale”, in modo che tutto sia moderno, godibile e accessibile a chiunque paghi un biglietto. Vale a dire all’altezza di un consumatore che poco sa e nulla vuole che sappia di vecchiume e ancora meno dei tormenti e dei significati che stanno dietro le realizzazioni artistiche.
Così vediamo nei musei in particolare sciamare orde di visitatori talmente assorti nel loro trekking da limitarsi a gettare uno sguardo affrettato, se per caso si trovano, i lavori di Leonardo, Michelangelo, Picasso, Raffaello o Caravaggio saltando tutti ciò che sta sotto, da Piero Della Francesca a Guido Reni. La verità è che oggigiorno la monetizzazione delle opere d’arte, nonostante l’opinione attribuita tempo fa all’ex ministro dell’economia Giulio Tremonti – ma anche da lui prontamente smentita – che “con la cultura non si mangia” (una ricerca universitaria internazionale dimostrò proprio l’effetto moltiplicatore di un dollaro investito in cultura), ha fatto definitivamente presa ed è perseguita, anche giustamente e con convinzione, in Paesi come l’Italia che hanno deciso di far fruttare al massimo il vantaggio rappresentato dal detenere quasi l’ottanta per cento dei beni culturali del bacino del Mediterraneo. Il turismo culturale che su questi presupposti si è quindi sviluppato divenendo, dopo quello ambientale dove preferisce recarsi la gran parte dei visitatori in cerca di svago e di relax, la seconda meta anche perché oltretutto non conosce limiti stagionali. Donde l’esigenza di sostenerlo costi quel che costi anche a discapito della qualità.
Il turismo culturale come toccasana della nostra economia
In realtà un tipo di turismo culturale è sempre esistito più che altro rivolto alle forme della cosiddetta cultura antropologica nei Paesi più lontani dove sopravvivono popolazioni che mantengono o conservano tradizioni e costumi che trasmettono o vendono agli occasionali visitatori non solo attraverso oggettistica, acconciature e realizzazioni tipiche ma anche offrendo rievocazioni della loro cultura come càpita, per esempio, nel Cultural Center della Polinesia o presso gli aborigeni australiani o i Maori in Nuova Zelanda o ancora i Navajo in Arizona. Nondimeno nelle diverse aree dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina le popolazioni musulmane e quelle indigene si adoperano nei Suk e nei mercatini alla vendita di stoffe e indumenti oltre che cercare di elevare il livello allestendo musei antropologici di tutto rispetto in cui i costumi tradizionali sono portati all’attenzione dei visitatori con ricostruzioni fedeli e riprese cinematografiche o video di discreta qualità e interesse.
Personalmente ho sempre curato questo tipo di viaggio, divenendo nel tempo un appassionato collezionista di maschere allegoriche dei Paesi extraeuropei e, soprattutto, di piccoli strumenti musicali etnici, che al momento dell’acquisto controllo essere ben funzionanti per poterli esibire convenientemente ai miei ospiti. Tuttavia, non disdegno neanche le espressioni della cosiddetta Alta Cultura nostrana, rispetto alle quali comunque sento il dovere di esprimere alcune perplessità dovute soprattutto al fatto che l’ossessione del coinvolgimento delle masse determina non pochi corto circuiti.
Come non rimanere perplessi, per esempio, al “rilancio” del Colosseo attraverso la rievocazione del suo “funzionamento”, mostrato per la prima volta proprio ai grandi della terra nell’ultimo G7? Tutti sappiamo quale fosse la vera destinazione di questo monumento: sterminare le fiere che venivano portate a migliaia a Roma dai confini dell’Impero per celebrare i “trionfi”, dare in pasto alle belve i primi cristiani che si rifiutavano di onorare gli dèi pagani e, infine, offrire a una plebe e a una classe di ottimati parassiti e nullafacenti la vita degli stranieri, schiavi e uomini liberi che per soldi in veste di gladiatori si prestavano a combattere tra di loro o con le fiere. Come se, mi si lasci passare il paragone forse un po’ toppo dissacrante, tra qualche secolo degli ipotetici governanti tedeschi pensassero di valorizzare turisticamente i campi di sterminio, che oggi hanno la funzione didattica e rievocativa di non fare dimenticare un momento così drammatico della nostra storia, approfittando che il tempo ha lenito lo sdegno e l’orrore per ciò che accadeva, e rappresentassero puntualmente le modalità in cui avveniva il sacrificio di ebrei, zingari, omosessuali, ecc.
Su tutte le nuove mode incombe oggi l’esigenza dell’accessibilità generalizzata e senza limiti a qualsiasi performance artistica che si realizza attraverso un processo di attualizzazione di eventi e opere d’arte lontane nel tempo con l’obiettivo ulteriore di aggiornarli, se è necessario, anche all’etica del “politicamente corretto”. In questa logica il messaggio culturale, equivocando col suo carattere di universalità, deve essere sempre “attuale”, mai apparire “passatista” e mai trascurare ambiti in linea con quanto gradito ai circoli culturali e politici e spaccati di società più alla moda. Non a caso siamo appena passati attraverso le celebrazioni dantesche del Sommo Poeta, considerato sempre più attuale quanto più nelle piazze lo declamava Roberto Benigni, anche se era giustificato il sospetto che l’attualità fosse data più da chi recitava i versi rispetto a chi li aveva scritti. A questo punto la domanda è: interessa ai governanti e ai promotori di questo rinascimento culturale che il popolo diventi veramente più “colto” oppure la ragione è quella solita di spillare qualche moneta in cambio di un generico accesso?
Non posso passare in rassegna tutte le occasioni in cui il combinato disposto di turismo culturale e la necessità di adeguare il messaggio artistico ai giorni nostri per attrarre quanto più possibile curiosi passa come un tritasassi sul nostro patrimonio culturale, anche perché mi mancano le necessarie competenze, ma non riesco a nascondere un moto di fastidio quando, per esempio, sento giornalisti televisivi o uomini politici annunciare che il tale scrittore o musicista o pittore che in quel momento si sta celebrando, fosse esso nato mille anni fa o solo novanta, è sempre “attuale”. Tuttavia, proprio a causa dei miei limiti, mi soffermerò su un’espressione artistica che sono più aduso a seguire e che apparentemente è oggetto di minori attenzioni ma anche, a mio avviso, di maggiori manipolazioni proprio per l’impatto mediatico, economico e turistico che le si vuole riservare: l’Opera lirica.
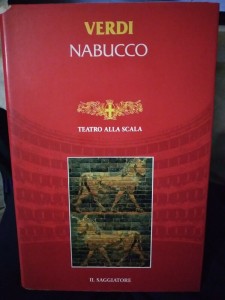 Un caso di scuola: l’Opera lirica
Un caso di scuola: l’Opera lirica
L’Opera lirica è un prodotto culturale tipicamente italiano. Tutte le altre forme d’arte che hanno raggiunto il culmine dell’espressività nel nostro Paese, come quelle figurative e architettoniche, affondano le radici nella notte dei tempi. L’Opera, come insieme di musica e di recitazione, ha parenti troppo lontani nella storia della cultura, forse la tragedia greca, per prestarsi ad analoghi accostamenti. Nata probabilmente a Firenze all’interno della Camerata dei Bardi, ebbe la sua prima e canonica realizzazione, quasi un manifesto, con l’Orfeo di Monteverdi nel 1607 in pieno clima arcadico e post rinascimentale. Da lì l’Opera italiana, grazie soprattutto alle avanguardie della scuola napoletana e veneziana, è esplosa in tutta Europa raggiungendo il culmine nel romanticismo ottocentesco con Giuseppe Verdi, oggi il musicista più eseguito al mondo, e prima di lui Rossini, Spontini, Bellini e Donizetti, i cui primi due non a caso campeggiano ancora nel frontone dell’Opera Garnier di Parigi. Fu proprio con il fiorentino Lulli, musicista ufficiale di Luigi XIV, poi Cavalli e Pierluigi da Palestrina, quest’ultimo direttore del Conservatorio parigino, che partì la conquista italiana della Capitale francese e, poi, di tutta Europa, sollecitando ovunque la nascita di compositori che si rifacevano a questo genere musicale così tipico ma soprattutto segnando una sorta di imperialismo culturale del nostro Paese, anche grazie all’impegno dei cantanti più celebrati, da Giuditta Pasta a Giovanni Battista Rubini.
L’italiano divenne così alla moda che lo stesso Mozart, tranne nel Flauto magico, Il ratto del serraglio e in altre composizioni giovanili, riteneva la nostra la lingua più idonea a mettere in musica l’opera e così fece con Idomeneo, Così fan tutte, Le nozze di Figaro e Don Giovanni. Gradualmente in tutti gli altri Paesi, a partire dal Settecento, ma particolarmente nell’Otto e Novecento, ci fu la corsa dei musicisti più affermati a comporre opere liriche (anche perché, rappresentate in teatro con pubblico pagante e relativi impresari, il successo per il musicista era più appagante sotto il profilo economico della composizione di una semplice sinfonia o sonata da presentare in qualche salotto o davanti a u modesto pubblico dando fama ma non denaro).
Dall’Italia l’opera dilagò in tutta Europa dove vi fu chi, in terra tedesca, ne fece solo una come Beethoven con il Fidelio, comunque un autentico capolavoro, cui seguirono Gluck, ritenuto il riformatore dell’opera lirica moderna, Handel, Haydin, Weber o chi come Wagner dedicandosi totalmente a questo genere ne impresse un taglio modernista, seguito in Austria da Richard Strauss (leggasi il Cavaliere della rosa). In Francia il genere conobbe egualmente alte realizzazioni con Bizet (la cui Carmen ancora oggi è una delle opere più rappresentate al mondo), Gounod, con l’altra opera di grande successo, il Faust, quindi Meyerbeer, Offenbach, Delibes, Debussy, Saint Sans e tanti altri. Poi dilagò nell’Est Europa con Smetana, Janaceck, Bartok e in Russia soprattutto con Mussorgsky, Tchaikovsky, Borodin e Stravinsky. Ma in testa rimane sempre l’Opera italiana, che nel Novecento verista conobbe un ulteriore impulso internazionale grazie a Puccini, Mascagni, Leoncavallo e Giordano, a tacere di Boito, Cilea e Ponchielli che la diffusero anche negli altri continenti in qualche modo a rimorchio dell’emigrazione italiana. Dopodiché il ciclo si chiude e, come una volta disse Placido Domingo, gli autori dodecafonici come Berg e Stockhausen hanno prodotto sì lavori musicalmente eccellenti, e con loro sicuramente anche Gershwin e Bernstein, ma nessuno si ricorda delle loro melodie, come quelle di Verdi, Rossini o Puccini. Perciò, già nei primi decenni del Novecento alla produzione e alla composizione segue la fase della rielaborazione in cui si sono inserite anche le variabili turistiche e le nuove esigenze della cultura di massa.
Incominciamo dalla prima novità che talvolta si spinge fino allo stravolgimento della volontà degli autori, ossia ciò che potremmo definire come il moderno revisionismo. Viste dalla parte del pubblico, certe operazioni si concretizzano con la sottrazione ai suoi principali fruitori di un bene artistico gradito soprattutto nell’Ottocento al mondo popolare, che oggi rimane attestato per fortuna nel “loggione” mantenendo ancora da qualche parte il potere tollerato di affossare come un tempo interpreti e realizzatori. Lo strappo è avvenuto paradossalmente all’insegna di una maggiore valenza culturale da attribuire all’opera, per effetto soprattutto della spinta concentrica dei grandi direttori d’orchestra volta a garantire anche alla partitura operistica un livello di approccio analogo alla musica strumentale, e di musicologi e critici, mentre il pubblico rimane in genere indifferente. In questo modo gradualmente si è sottratto al gusto popolare un genere che fino allora ne aveva costituita la più genuina espressione a favore di un’esecuzione “critica”, musicalmente più accurata e sofisticata. I cantanti, i veri protagonisti delle opere e beniamini degli appassionati (i compositori quando scrivevano le opere giustamente si preoccupavano prima di tutto di chi gliele avrebbe eseguite, da cui dipendeva il successo, come capitò a Verdi il cui lancio nel mondo musicale fu legato alla scelta del più grande baritono del tempo, Giorgio Ronconi, di cantare il Nabucco alla Scala in luogo di un’altra opera che avrebbe preferito la direzione del teatro del pur affermato e valido Pacini); i cantanti, dunque, sono passati dal livello ottocentesco in cui spesso provenivano dalla strada (o dalla parrocchia) senza troppa preparazione musicale a quello attuale in cui il rigoroso studio al Conservatorio e le altre tappe della formazione richiedono quasi una decina d’anni; per essi affidarsi al solo virtuosismo o all’atletismo vocale – forse anche giustamente – non vale quanto la fedeltà allo spartito, al punto dall’essere concepiti, soprattutto da Herbert Von Karajan in poi, come meri strumenti dell’orchestra e marionette in mano ai registi.
Analoga evoluzione hanno subìto i complessi orchestrali, non più composti da semplici “musicanti” diretti da un batteur de mesure, bensì da professori di musica del relativo strumento, in numero almeno di settanta-ottanta in luogo dei tradizionali quaranta-cinquanta, diretti da un “Maestro”, anch’esso, un autentico intellettuale non solo in questo campo che, tra le varie lauree, è diplomato in composizione in direzione d’orchestra oltre che, il più delle volte, in uno specifico strumento (in genere il pianoforte, ma sapendone suonare anche altri). Il fenomeno è stato soprattutto conseguenza della creazione dei direttori stabili che per un tempo relativamente lungo lavorano in una sede forgiando l’orchestra, per primo Arturo Toscanini con la BBC di New York, poi vi fu Claudio Abbado che lavorò numerosi anni con i Berliner, facendone probabilmente il primo complesso orchestrale al mondo. Contendono questo primato i Wiener che, secondo una sua direttrice italiana, costituiscono la Ferrari delle orchestre giacché quando si rappresenta un’opera lirica vanno direttamente all’esecuzione finale dopo una sola prova di pianoforte, tale è la loro preparazione musicale. Anche le nostre orchestre hanno fatto passi in avanti nella preparazione e nella serietà, perché dopo Riccardo Muti nessun direttore ospite si lamenta che gli orchestrali della Scala durante le prove ascoltino addirittura le partite con le radioline come si dice accadesse un tempo. L’orchestra sinfonica della mia città si ristrutturò dopo che una volta Mario Del Monaco, giunto per cantare la Fedora di Giordano, si lamentò di essere accompagnato non da un’orchestra ma da una banda, da lì la corsa dell’istituzione a equilibrare con archi e legni la sonorità prevalente degli ottoni.
 Se ciò ha migliorato l’esecuzione e la fedeltà agli spartiti ha contenuto certe espressioni del divismo dei cantanti, sia pure codificate nei manuali ufficiali delle variazioni dei testi originali, come quando Riccardo Muti a una prima della Scala vietò al tenore del Trovatore di fare il do di petto in Di quella pira perché non scritto da Giuseppe Verdi, anche se ormai era divenuto una tradizione. Tuttavia, cancellando il divismo dei cantanti dall’Opera, si è finito per buttare con l’acqua sporca anche il bambino. Infatti, oggi si vede che, a meno non canti Jonathan Kauffman o Andrea Bocelli o Anna Netrebko, i cartelloni non riportano i nomi dei cantanti, se non in piccolo e in fondo, mentre abbondano di figure secondarie pur utili allo spettacolo, dagli scenografi ai truccatori quasi fino agli elettricisti e ai vigili del fuoco, si potrebbe dire, ma non i cantanti che poi sono quelli per cui si va a sentire un’opera.
Se ciò ha migliorato l’esecuzione e la fedeltà agli spartiti ha contenuto certe espressioni del divismo dei cantanti, sia pure codificate nei manuali ufficiali delle variazioni dei testi originali, come quando Riccardo Muti a una prima della Scala vietò al tenore del Trovatore di fare il do di petto in Di quella pira perché non scritto da Giuseppe Verdi, anche se ormai era divenuto una tradizione. Tuttavia, cancellando il divismo dei cantanti dall’Opera, si è finito per buttare con l’acqua sporca anche il bambino. Infatti, oggi si vede che, a meno non canti Jonathan Kauffman o Andrea Bocelli o Anna Netrebko, i cartelloni non riportano i nomi dei cantanti, se non in piccolo e in fondo, mentre abbondano di figure secondarie pur utili allo spettacolo, dagli scenografi ai truccatori quasi fino agli elettricisti e ai vigili del fuoco, si potrebbe dire, ma non i cantanti che poi sono quelli per cui si va a sentire un’opera.
Lo stravolgimento delle regole eterne dello spettacolo è evidente. E, come se in una partita sportiva, si menzionasse solo l’allenatore e il direttore tecnico e non i giocatori. Il pubblico va a vedere a teatro Leo Nucci o Barbara Frittoli, come allo stadio Messi o Ronaldo e non Mourinho o Allegri, con tutto rispetto, o al cinema Al Pacino o Julia Roberts e non Ford Coppola. L’esigenza di impatto mediatico, dovuta al fatto che i teatri dell’opera puntano a validare lo spettacolo maggiormente in chiave cinematografica e televisiva, hanno dato un maggiore risalto alla figura del “regista”, un tempo defilata anche perché le prove disponibili sono due o tre più quella generale, fatto questo che non consente di preparare veramente un complesso, a meno che non si tratti di compagnie stabili, poche ma esistenti (limite che avvertì per esempio qualche anno fa John Turturro incaricato di curare la regia del Rigoletto per il “Massimo” di Palermo). Di certo oggigiorno in omaggio al cosiddetto “spirito di squadra” si tende a riconoscere maggiormente il lavoro di chi organizza il gruppo pur senza apparire in scena, al punto che a raccogliere le ovazioni alla fine dell’opera si vedono avanzare nel proscenio non solo i cantanti come da tradizione, ma anche il direttore d’orchestra, il regista, il direttore del coro e, con l’andare del tempo, mi permetto di dire saliranno anche il sovrintendente che organizza tutto, l’assessore competente in cerca di voti che mette i soldi e magari anche il sindacalista che ha consentito che orchestrali e coristi non facessero sciopero per via delle retribuzioni troppo basse dei lavoratori dello spettacolo.
I registi, in particolare, oggi, incarnano questa tendenza che potremmo definire mediatica e populista nella misura in cui sono incaricati di fare da trait d’union tra il prodotto artistico e il pubblico garantendone appunto l’“attualità” e la modernità e, se occorre, si incaricano pure di sorvegliare il lato del politicamente corretto. Inutile dire che quasi nessuno ha raggiunto i livelli di Franco Zeffirelli o Giorgio Strehler, fedeli al testo e che quando si trovavano davanti a compositori come Verdi sapevano che la cosa migliore era seguire le indicazioni del Maestro così ricche di dettagli e di sapienza teatrale (per inciso l’autore del Rigoletto e dell’Aida una volta disse che avrebbe preferito essere ricordato come uomo di teatro più che come musicista). Non a caso le critiche musicali, coerenti con questa nuova impostazione, dopo avere analizzato il lavoro del direttore d’orchestra (uno studio di qualche anno fa di un’università americana ha consacrato scientificamente quello che pensavamo un po’ tutti e cioè che, salvo si tratti dei più grandi direttori, quasi nessuno degli spettatori si accorge della differenza tra l’uno o l’altro), passano subito a parlare di quello del regista e dello scenografo e solo da ultimo citano i cantanti.
Con questo taglio l’opera lirica dovrebbe avere assunto un formato sempre più turistico e massivo, da collocare all’interno di un pacchetto tanto più comprensibile quanto più si identifica con lo spettacolo cinematografico o televisivo, in altri termini con la superficialità con cui ci accostiamo in genere alle fiction televisive in cui ci piace la sorpresa, ma che è incompatibile quando ci si trova davanti a un Dante o a un Verdi. In buona sostanza ciò accade non perché ci sia una precisa preferenza del pubblico ma perché il regista e lo sceneggiatore oggigiorno, ripeto, sono diventati i custodi dell’“attualità” e devono garantire che il prodotto artistico sia “attuale”, sia pure col rischio di relegare la produzione operistica a livelli che il pubblico “suo” (e che comunque ne costituisce la base del successo), e il più delle volte anche la critica più attenta, si sente di accettare sempre meno. Ma ne vale la pena?
L’opera deve diventare attuale e corretta
È noto che i compositori hanno prodotto dei lavori musicali e teatrali in conformità con gli autori i cui testi rielaboravano e da cui traevano ispirazione, da Shakespeare a Victor Hugo, Scribe, Voltaire o Schiller, qualche volta adattandoli alle concezioni correnti e non senza problemi, come capitò a Verdi in alcune sue opere, con il Rigoletto e il Ballo in Maschera che le censure del tempo non accettarono e soprattutto con la Traviata, il cui testo fu reputato troppo moderno dal pubblico della Fenice per dargli quel successo che gli venne attribuito solo nelle successive rappresentazioni. E già qui si assiste a un primo strappo, costituito dalla forzatura in chiave modernista di testi che spesso poco avevano a che fare con l’attualità già all’epoca in cui furono musicati e mostrati oggi con legami che risultano ancora più tenui e perfino grotteschi, soprattutto quando si sconfina nel politicamente corretto. A esserne affetta più di recente è stata la produzione dell’Otello verdiano al “San Carlo” di Napoli, dove si sarebbe vista una Desdemona “femminista” reagire alla gelosia del marito puntandogli una pistola e, poco prima, al “Maggio fiorentino” di un anno fa, una Carmen che il regista non fa morire, come vuole il libretto di Prospere Merimée, ma al suo posto sacrifica don Josè che dovrebbe ucciderla e a cui invece la focosa cigaraja è riuscita a sottrarre la pistola. “Basta con i femminicidi”, proclama il regista moderno, incominciamo dall’opera. Bah! Avevamo dimenticato che Verdi tempo fa avesse provocato qualche mugugno nel pubblico musulmano, quando nell’Otello il Moro di Venezia entra in scena invitando i ciprioti a esultare perché “l’orgoglio musulmano sepolto è già”. Certo queste variazioni sul tema, per dirla musicalmente, hanno portato i registi alla ribalta della cronaca nazionale, ma c’è veramente da chiedersi se l’opera presentata in queste condizioni sia veramente un’operazione culturale o non solo un make up per rendere commercialmente più appetibile il prodotto. Infatti, lo sforzo per stravolgere, cambiare e stupire di molte regie è al limite del paradosso.
In realtà, pare che la moda sia iniziata proprio in Germania, dove si rappresenta ben un terzo di tutta la produzione operistica al mondo. Una volta assistetti in un teatro tedesco a un Elisir d’amore ambientato in un laboratorio di ricerca in cui avveniva tutto il contrario di ciò che prevede la trama. L’imbonitore delle folle, Dottor Dulcamara che, per Donizetti, diffonde i suoi prodotti naturali a base di alcol, radici, vino e acqua potabile a un pubblico di contadini ignoranti convincendoli che farà ringiovanire le vedove, rendere prolifici i vecchi, eliminare le rughe, combattere la gotta e tutte le malattie, ecc., convince Nemorino, un giovane analfabeta che non riesce a fare breccia nel cuore di Adina, una figlia di proprietari terrieri capace di leggere. La vicenda si risolve positivamente perché il povero innamorato (e disoccupato) riceve una ricca eredità da uno zio lontano che gli fa correre dietro tutte le ragazze del villaggio, compresa Adina, fenomeno che lui attribuisce all’efficacia del “mirabile liquore” del Dottor Dulcamara. Tutta la vicenda, rappresentata come volle l’autore, oltre che allietata da una bellissima musica (per tutti la celebre aria “Una furtiva lacrima”), risulta godibile e divertente per i paradossi e i colpi di scena che si susseguono. Tuttavia, il regista tedesco riesce a renderla paradossale e del tutto improbabile, rappresentandola in un laboratorio di analisi dove in luogo dei contadini ignoranti ad abboccare alle menzogne del “Dottore” vi sono dei ricercatori scientifici – di cui Adina era la direttrice e Nemorino solo l’addetto delle pulizie –. Che venisse messo alla berlina l’amore corrente dei tedeschi per l’omeopatia? Chissà!
E, sempre per concludere con la terra da cui questa svolta proviene (in realtà pare per iniziativa di un celebre regista britannico), proprio mentre stendevo questo pezzo, ho visto in un canale tedesco la ripresa del Crepuscolo degli dei in diretta dal tempio wagneriano di Bayreuth. Per il suo regista la tetralogia non si consumava nel Wahalla ma in un moderno appartamento di una zona residenziale tra donne stressate, aperitivi, rinfacciamenti e crisi di nervi degli dèi. Un’altra volta assistetti sempre nel Paese tedesco a una edizione del Lohengrin ambientata nella biblioteca di un’università, tutti in abiti moderni, in cui il duello tra il Duca di Brabante e Lohengrin, previsto da Wagner con la spada, avvenne a colpi di libroni in testa col pubblico tedesco che sghignazzava tanto la cosa appariva ridicola (alla fine, ciliegina sulla torta, Lohengrin prende la nave che lo porta via con la valigia di cartone del classico migrante).
Confusione in platea
Carmen che sopravvive, dunque, Desdemona che impugna la pistola non solo contribuiscono a decontestualizzare le vicende di cui sono protagoniste, nel momento in cui si assumono comportamenti e valori fuori dal periodo storico in cui si collocano (e che spesso sono state decontestualizzate a loro volta dagli autori, come capita spesso nell’opera barocca), ma cambiano anche lo svolgimento previsto nel libretto, nel senso che in scena si canta una cosa e nel contempo se ne fa un’altra, se non addirittura il contrario. Così una volta vidi in tivù un’edizione del Rigoletto nelle Terme di Caracalla in cui l’ultimo atto si svolgeva in una roulotte in periferia dove si era recato il buffone di corte per assistere e controllare l’uccisione del suo signore, il Duca di Mantova, che aveva disonorato la figlia, Gilda. Orbene, quando il sicario, Sparafucile, chiede alla sorella Maddalena di porgergli la spada per portare a termine la commissione, questa più “attualmente” gli allunga una pistola. Queste evasioni dal testo nelle moderne rappresentazioni stanno diventando sempre più frequenti, e veramente inducono a domandarci se vale la pena tradire un’opera d’arte per rispondere a una mai provata richiesta del pubblico di assistere a cose più moderne perché più comprensibili, ossia più attuali. E ciò, mentre al contrario nella filmografia assistiamo alla ricerca di una fedeltà storica più puntuale, con usi e costumi rigorosamente delle epoche storiche.
Il culmine di queste operazioni “culturali” e la loro relativa attualizzazione è stato raggiunto quest’anno dalla rappresentazione del Nabucco all’Arena di Verona. Sulla scena, sicuramente sfruttando il legame tra il Verdi “giovanile” e il Risorgimento italiano, memori magari che la scritta “Viva Verdi” apposta dai patrioti nei muri di Milano significava “Viva Vittorio Emanuele Re D’Italia”, il regista e lo scenografo hanno ritenuto portare sulla scena in cui faceva da sfondo una riproduzione della Scala di Milano reparti di coristi e di comparse vestiti da soldati sardo piemontesi con relativi cavalli e affusti di cannone cacciati poi (o rivestitisi) da soldati austriaci, in cui il re Nabucodonosor vestiva i panni del maresciallo Radetzky e il suo antagonista, il grande sacerdote ebreo Zaccaria, forse quello del sindaco rinascimentale di Milano in redingote e tanto di cravattina tricolore. Naturalmente il pubblico dell’Arena, formato in gran parte dai tour operator e guidato dalla claque del teatro, ha mostrato un grande entusiasmo per uno spettacolo, movimentato fino al parossismo da una confusa e indecifrabile vicenda risorgimentale mentre i cantanti-attori recitavano il testo scritto da Temistocle Solera dagli evidenti riferimenti biblici e alle vicende assiro-babilonesi. Guardavo questo spettacolo, inspiegabile per le figure della Sovrintendente dell’Arena, il grande soprano Cecilia Gasdìa, e il non meno importante direttore d’orchestra Daniel Oren, e mi chiedevo se non si poteva rappresentare a questo punto direttamente la guerra in Ucraina, con Putin come Nabucco, Zaccaria come Zelenskyi o addirittura Joe Biden, mentre Fenena, figlia di Nabucco, poteva essere una delle numerose discendenti di Putin esiliata in Svizzera, presa in ostaggio dagli americani, innamorata del condottiero ebreo (magari Zelensky in veste di Ismaele), mentre Abigalle, la tessitrice di trame contro Nabucco poteva essere benissimo la Zacharova che a un certo punto lo rovescia con grande soddisfazione del Grande Sacerdote/Joe Biden che a quello aveva mirato fin dall’inizio della guerra. Perché il regista non ci aveva pensato, forse avrebbe ottenuto anche una diretta del presidente ucraino? Tutto da vedere, da applicare e…da ridere, insomma.
Qui dobbiamo parlare dell’operazione culturale che rischia di essere confusa con istanze moderniste ed economiche. Davvero si pensa che lo spettatore, senza preparazione culturale musicale adatta e a prezzo di enormi acrobazie mentali, possa gustare un simile genere di spettacolo? Si spera forse sia preso dalla sindrome di Stendhal e per effetto di questa ne rimanga abbagliato? A parte il mio caso che, dopo avere assistito a 15 anni al Barbiere di Siviglia condotto da mia madre, divenni un appassionato di questo genere, ho conosciuto solo il caso di un’amica giornalista che, essendo inviata una volta dal direttore del suo giornale a fare un servizio sul Trovatore di Verdi che davano nel teatro della sua città, pur essendo totalmente a digiuno di musica lirica, ne fu talmente attratta da divenirne una grande appassionata. Tutte le altre persone che conosco e occasionalmente si recano all’opera, prima si informano su Internet e seguono il testo nello stesso teatro. Ma anche loro cosa possono capire dello spettacolo quando, come nell’Arena di Verona, sul palco si rappresenta un evento e i cantanti ne cantano un altro con il direttore d’orchestra che finge di non vedere e non sentire e il regista che fa acrobazie per far coincidere quanto possibile le due cose.
All’uscita delle Terme di Caracalla, mia figlia che con un’amica avevano carpito la conversazione di Massimo e Carlo, per caso li incontrarono mentre si accingevano a entrare nella loro auto sentendo che si rammaricavano: “Peccato che non hanno cantato “Va pensiero””. Vale la pena vendere dei biglietti per avere simili risultati? Certo “pecunia non olet”, diceva Vespasiano. Sicuramente questa è anche la conseguenza delle tanto conclamate imprese compiute dai tre tenori, Pavarotti, Domingo e Carreras o Andrea Bocelli, cui è stato sempre ascritto il merito di avere avvicinato le folle all’Opera. E allora non c’è da stupirsi se molti vedono questa come un collage di pezzi celebri e sorprende che i nostri Massimo e Carlo non si siano lamentati che alla fine dell’Aida il tenore non abbia intonato Nessun dorma (per inciso una volta lasciai stupite delle persone che ignoravano che fosse una romanza di un’Opera che si chiama Turandot e non di una composizione di rock melodico).
Cosa fare allora? Riportare tutto ai significati culturali non rappresenta una perdita, a incominciare dalla precisione delle informazioni sulla struttura e sulla dinamica che fanno cultura, lungi dalle semplificazioni che allontanano proprio la cultura da questo genere musicale. Così nella grande e ultima rappresentazione scaligera del Macbeth, il grande e molto preparato giornalista anche in questo campo, Bruno Vespa, ci lasciò sopresi perché non smetteva di riferirsi al protagonista dell’Opera, il baritono Luca Salsi, definendolo il “tenore”. Dettagli? No. Tutti sanno che ciò che rende grande musicalmente l’opera lirica è la polifonia, il contrappunto e la diversità del colore vocale assicurati dal fatto che non esiste solo una voce maschile, il tenore, e una femminile, il soprano, ma per ciascun sesso almeno tre voci base che si estendono in una quantità ulteriore di sfumature, dal belcanto belliniano e donizettiano fino al verismo novecentesco di Puccini e Leoncavallo in cui si va dal tenore di grazia a quello lirico spinto, al soprano di coloratura, dal baritono rossiniano a quello verdiano fino al basso cantante e quello profondo. Essere al corrente di tutti questi dettagli significa dotarsi di ulteriori elementi di comprensione di ciò che si va vedere, come pure conoscere gli strumenti che diverse volte in assolo commentano le varie scene o accompagnano le voci.
Certo a molti spettatori i cantanti appaiono come le vacche che di notte sono tutte nere, giacché tutti sono “tenori” e i soprani “prime donne”. D’altronde la cultura popolare corrente ha favorito questa visione, anche perché il tenore si colloca in quella zona grigia tra la musica impegnata e quella popolare nella misura in cui i compositori hanno affidato a loro le arie più trascinanti che, concludendosi con l’acuto finale, strappano automaticamente l’applauso; la tradizione, poi, ha voluto che i grandi tenori, da Caruso a Schipa a Gigli a Di Stefano e, oggi, a Pavarotti e Bocelli abbiano cantato le canzoni più popolari (e indirettamente, per esempio, abbiano avuto il merito di fare entrare nel repertorio classico la grande canzone napoletana).
Per concludere il problema di come rapportarsi esiste quando si affronta l’alta cultura. Crearne una di formato tascabile da viaggio equivale a tradire la funzione principale della cultura che deve suonare come invito all’impegno e allo sforzo intellettuale. Quando sentivo le Lecturae Dantis in piazza di Roberto Benigni col pubblico che incantato applaudiva, mi chiedevo se tutto ciò era giusto a fronte della fatica immensa che avevamo fatto al liceo a digerire la Divina Commedia immagazzinando, come si faceva allora, interi brani a memoria mentre il professore si faceva in quattro per dissezionare versi e parole del testo dantesco. A saperlo che c’era un modo più veloce di entrare in contatto col Sommo Poeta…! Viceversa, crepo di invidia ogni volta che vedo le scolaresche dei Paesi stranieri che stanno stravaccate a terra prendendo appunti davanti alle grandi opere delle National Gallery con i docenti che ne spiegano le caratteristiche, mentre noi dovevamo studiarne le prospettive, i colori, le caratteristiche e le differenze sulle fotografie dei libri. Due modi differenti in cui si può fare o no cultura in epoca moderna sfruttando le grandi risorse esistenti sul territorio, ma che confluiscono in un’unica conclusione.
Si apra l’alta cultura a tutti, ma non nasconda che dietro le grandi realizzazioni c’è ingegno, fatica, lavoro e, spesso, sofferenza e l’accesso comporta non minore impegno. E anche riguardo alla cosiddetta attualità e al politicamente corretto ci separa un mare di cultura che non ci autorizza a imbarcarci nel grottesco. Certamente Giuseppe Verdi, che divenne Senatore del Regno, era un compositore che nelle sue opere, rispetto a quasi tutti i colleghi che si soffermavano esclusivamente sul tema, più attraente per il pubblico, dell’amore giovanile – donde la fissazione popolare su tenori e soprani –, analizzava tutta la gamma dei sentimenti umani (un musicologo disse che se avesse deciso di comporre una Giulietta e Romeo sicuramente più che dell’amore dei due giovani si sarebbe interessato alla lotta tra i Capuleti e i Montecchi), per cui in qualche modo si comprende il tentativo dei responsabili dell’Arena di Verona di collocarlo in quell’ambito risorgimentale.
Verdi aveva nel cuore il Risorgimento italiano e tutte le sue opere giovanili nel loro accentuato carattere corale e marziale vibrano di questa passione. Il tema del potere nel Maestro di Bussetto non ha bisogno di interpretazioni moderne essendo cruciale in tutte le sue opere, dal Rigoletto, in cui il buffone di corte si rammarica che l’essere difforme lo esclude dal potere (“il retaggio di ogn’uom m’è tolto”, canta), ai grandi duetti del Don Carlos tra Filippo II e il Grande Inquisitore e poi col Marchese di Posa che sono elevati trattati di psicologia politica sul tema del contrasto tra il potere civile e quello ecclesiastico che stavano tanto a cuore a un anticlericale come Verdi, tema che farà poi da sfondo all’Aida nel contrasto tra il Faraone e il Grande Sacerdote, per poi finire nell’esultanza di Jago che, ottenuto il risultato di vedere cadere ai suoi piedi stremato il governatore di Cipro che ha distrutto facendo leva sul sentimento della gelosia, esclama: “Ecco il leon di Venezia!”. Finale che in qualche modo rispecchia quello di Puccini che, assai meno interessato di Verdi a questo tema, fa concludere a Tosca dopo avere ucciso Scarpia: “Ai suoi piedi tremava tutta Roma”.
Orbene tutte questi collegamenti, riflessioni, raffronti, ecc. vanno lasciati al pubblico che così fa e si fa cultura e non alle acrobazie troppe volte goffe di un regista che le vuole fare per conto suo. L’approccio culturale significa, in primo luogo, comprensione della temperie intellettuale del tempo in cui veniva concepito e rappresentato il lavoro artistico, compito da riservare, oltre che alla critica, allo spettatore. Come dire, inutile prendersela col solito Giorgio Germont, il padre di Alfredo che invita Violetta, la “traviata”, a lasciare in pace il figlio per il buon nome della famiglia perché cinico e insensibile, giacché questi non faceva altro che esprimere convinzioni culturali più radicate nel Midì rispetto alla trasgressività parigina, tutte cose che, se vogliamo, possiamo cogliere nella grande epopea dei Rougon Macquart di Emile Zola, ossia della famiglia che dal Sud della Francia si stabilisce a Parigi, senza andare a scomodare i trattati di storia sociale di Georges Duby.
A che serve accostarsi all’opera d’arte senza che questa provochi nello spettatore o nel visitatore riflessioni profonde e allargate sulla vicenda umana, non crei collegamenti storici e consenta di discernere tra le universalizzazioni più o meno possibili tra ciò cui si assiste? Cosa vorrebbero i propugnatori di una certa cultura mordi e fuggi, che i fruitori dell’opera d’arte si accontentassero di leggere i depliant turistici e rinunciassero a prepararsi o a leggere trattati prendendo per buono tutto ciò viene loro offerto?
Che fare?
Passando alla parte propositiva possiamo chiederci che cosa si può fare? A parere di chi scrive si può sviluppare meglio almeno la parte informativa e preparatoria, in cui oggi eccellono i musei di tutto il mondo con video e, soprattutto, cartelloni con spiegazioni di ciò che si trova esposto. Come nei musei gli studenti studiano davanti ai dipinti e nelle scuole le comitive di ragazzi che hanno in programma di recarsi in teatro o all’opera sono preparati dai rispettivi docenti, presso il pubblico del teatro musicale potrebbe svilupparsi meglio la parte informativa a disposizione di chi vuole sapere di più di ciò che va a vedere, sia attraverso le conferenze preparatorie che qualche giorno prima curano molti enti lirici e meglio ancora con quelle realizzate poco prima dell’inizio dello spettacolo in Germania e in Nord Europa in cui un esperto si incarica di spiegare lo spettacolo al pubblico nello spazio antistante l’ingresso interno o addirittura nella caffetteria, come ho visto fare a Stoccolma, mentre si mette qualcosa nello stomaco prima dell’inizio dell’opera.
Dopodiché c’è il competente che non ha bisogno di tutto questo, ma vi è anche chi è già dotato di buona volontà per essersi recato a fare qualcosa di impegnativo che sarà ancora più contento di non avere mancato quell’appuntamento. Esemplare, secondo me, ciò che ho visto fare sia a Vienna sia a Madrid, annettere al teatro la vendita di dischi, libretti e libri su argomenti attinenti all’opera. Come dire, a quel punto il pubblico non avrà più alibi e non si arriverà a fare, come ho visto accadere in un grande teatro romano, in cui si rappresentava Molto rumore per nulla di Shakespeare, con diversi attori dialettali di un noto programma televisivo, in cui alcuni spettatori vicino a me sdegnati prima non applaudire e, poi, all’intervallo uscirsene. Beh!, almeno nell’opera volenti o nolenti rimane da ascoltare la grande musica che ancora nessuno si è azzardato a cambiare.
Dialoghi Mediterranei, n. 57, settembre 2022
_________________________________________________________
Aldo Aledda, studioso dell’emigrazione italiana con un’ampia esperienza istituzionale (coordinamento regioni italiane e cabina di regia della prima conferenza Stato-regioni e Province Autonome -CGIE), attualmente è Coordinatore del Comitato 11 ottobre d’Iniziativa per gli italiani nel mondo. Il suo ultimo libro sull’argomento è Gli italiani nel mondo e le istituzioni pubbliche (Angeli, 2016). Da attento analista del fenomeno sportivo ha pubblicato numerosi saggi e una decina di libri (tra cui Sport. Storia politica e sociale e Sport in Usa. Dal big Game al big Business, finalisti premio Bancarella e vincitori Premio letterario CONI); ha insegnato Storia all’Isef di Cagliari e nelle facoltà di Scienze motorie a Cagliari, Roma e Mar del Plata in Argentina.
_______________________________________________________________















