Clifford Geertz (1988) esagerava (sapendo benissimo di esagerare) quando diceva che “fare antropologia” equivale essenzialmente a “scrivere”. Tuttavia, con la sua celeberrima provocazione, coglieva alla perfezione un dato difficile da confutare: l’antropologia è essenzialmente un sapere discorsivo in cui il momento della restituzione dei risultati della ricerca non è affatto una fase residuale del lavoro ed è anzi carico di molteplici implicazioni.
Gli antropologi notoriamente studiano per riportare a casa qualcosa e comunicarlo, non certo per diventare nativi o appiattire il loro punto di vista su quello dei loro informatori. Essi utilizzano le categorie della scienza per dire qualcosa di sensato sulla cultura facendo dialogare, ancora con Geertz, «concetti vicini all’esperienza» (i loro) e «concetti lontani dall’esperienza» (quelli oggetto d’indagine). Ovviamente gli antropologi non ricorrono al solo canale verbale per accedere alla conoscenza ma, come sostengono Roberto Malighetti e Angela Molinari (2016), essi vanno lì e spendono tanto tempo sul campo (o, aggiungerei io, in archivio e in biblioteca) per un fine ben preciso: riferire ciò che hanno capito (di ciò che i loro informatori hanno capito) a qualcun altro. Inevitabilmente scrivendo [1].
Che cosa si intende con l’espressione qualcun altro? L’insieme di terze persone cui l’antropologo si rivolge, ovvero i destinatari diretti e indiretti delle sue riflessioni. Innanzitutto, quindi, la comunità scientifica da cui il ricercatore parte e a cui ritorna: il consesso di scienziati, cioè, che autorizza il discorso antropologico e legittima il ventaglio di strategie metodologiche, epistemologiche e retoriche grazie alle quali il singolo studioso cerca di interpretare la realtà indagata e descriverla. Poi, il pubblico generico composto da cultori non professionisti e/o semplici curiosi desiderosi di conoscere il punto di vista antropologico su determinate questioni socioculturali. Infine, e questa è una delle più dirompenti novità prodotte dal processo di decolonizzazione, gli stessi gruppi presso cui si è condotta la ricerca: non è raro, infatti, che le monografie (o i saggi, gli articoli, etc.), al termine dell’etnografia, ritornino alle comunità oggetto di indagine, finendo così con l’alimentare una relazione circolare sempre più complessa tra studioso e informatori.
 Che la scrittura rivesta un’importanza decisiva nel progetto antropologico è evidente. Scegliere come e cosa scrivere non solleva problemi esclusivamente stilistici, come si potrebbe pensare a prima vista, bensì epistemologici, politici ed etici. Johannes Fabian, ad esempio, l’aveva capito benissimo quando evidenziava il “rischio allocronico” insito in ogni impresa etnografica. L’allocronia, sostiene Fabian (2021), consiste nel collocare le società studiate in un tempo altro rispetto al presente di chi produce il discorso antropologico. Essa è il risultato della scissione esperienziale tra l’attività di campo e quella retorica (con i suoi artifici da tavolino, ad esempio l’uso del “presente etnografico”) e rende manifesto uno dei tanti paradossi della ricerca antropologica: nel tentativo di rendere comprensibile l’alterità pur mantenendone l’estraneità, il ricercatore (il più delle volte inconsapevolmente) può finire col cristallizzare in un eterno presente scritto soggetti che sul terreno ha ovviamente incontrato in un regime di contemporaneità. Riportare all’interno di un testo le parole degli altri, inserirvi l’io antropologico e fornire una determinata rappresentazione (piuttosto che un’altra) della cultura sono allora operazioni altamente delicate che investono l’autore di una responsabilità enorme.
Che la scrittura rivesta un’importanza decisiva nel progetto antropologico è evidente. Scegliere come e cosa scrivere non solleva problemi esclusivamente stilistici, come si potrebbe pensare a prima vista, bensì epistemologici, politici ed etici. Johannes Fabian, ad esempio, l’aveva capito benissimo quando evidenziava il “rischio allocronico” insito in ogni impresa etnografica. L’allocronia, sostiene Fabian (2021), consiste nel collocare le società studiate in un tempo altro rispetto al presente di chi produce il discorso antropologico. Essa è il risultato della scissione esperienziale tra l’attività di campo e quella retorica (con i suoi artifici da tavolino, ad esempio l’uso del “presente etnografico”) e rende manifesto uno dei tanti paradossi della ricerca antropologica: nel tentativo di rendere comprensibile l’alterità pur mantenendone l’estraneità, il ricercatore (il più delle volte inconsapevolmente) può finire col cristallizzare in un eterno presente scritto soggetti che sul terreno ha ovviamente incontrato in un regime di contemporaneità. Riportare all’interno di un testo le parole degli altri, inserirvi l’io antropologico e fornire una determinata rappresentazione (piuttosto che un’altra) della cultura sono allora operazioni altamente delicate che investono l’autore di una responsabilità enorme.
Scrivere, da questo punto di vista, racchiude in sé molte delle irresolubili antinomie del progetto antropologico: su tutte quella che Talal Asad (1973), uno scienziato sociale che non a caso ha tanto ragionato sulle ricadute politiche delle monografie nei contesti studiati dagli etnografi, definiva «asimmetria strutturale» tra chi ha il potere di conoscere (e scrivere) e chi, invece, è ridotto a (muto) oggetto di conoscenza; quella che Ursula K. Le Guin [2] (2022), straordinaria narratrice e creatrice di mondi, metteva in evidenza definendo l’antropologia con una fulminante e sincera antitesi: un «atto di imperialismo» e insieme di «solidarietà umana».
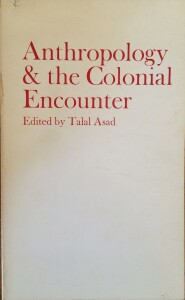 Cionondimeno, scrivere è l’unica cosa che può fare un antropologo – si spera accorto e sensibile – per far conoscere i suoi studi, prendere posizione e, nel caso, impegnarsi attivamente senza rinunciare alla propria identità scientifica. Affrontare la prova del pubblico, avviando il dialogo con una variegata comunità di soggetti (scrittori e lettori), è ciò che permette la realizzazione di un archivio di storie utili a ragionare su quello strano animale che è l’essere umano e osservarlo alle prese, nel tempo e nello spazio, con la costruzione e l’utilizzo di categorie (“identità”, “alterità”, “natura”, “cultura”, “politica”, “economia”, etc.) che a dispetto dell’immagine immutabile con cui tendono a presentarsi sono costrutti sociali e culturali sempre passibili di essere diversamente.
Cionondimeno, scrivere è l’unica cosa che può fare un antropologo – si spera accorto e sensibile – per far conoscere i suoi studi, prendere posizione e, nel caso, impegnarsi attivamente senza rinunciare alla propria identità scientifica. Affrontare la prova del pubblico, avviando il dialogo con una variegata comunità di soggetti (scrittori e lettori), è ciò che permette la realizzazione di un archivio di storie utili a ragionare su quello strano animale che è l’essere umano e osservarlo alle prese, nel tempo e nello spazio, con la costruzione e l’utilizzo di categorie (“identità”, “alterità”, “natura”, “cultura”, “politica”, “economia”, etc.) che a dispetto dell’immagine immutabile con cui tendono a presentarsi sono costrutti sociali e culturali sempre passibili di essere diversamente.
Proprio come a uno sterminato archivio di storie mi piace pensare a Dialoghi Mediterranei, il bimestrale dell’Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo che ha raggiunto quest’anno il prestigioso traguardo dei dieci anni di vita. Dieci anni spesi a scandagliare la contemporaneità dando voce a un nutrito gruppo di studiosi (maestri riconosciuti, accademici, ricercatori più o meno strutturati e più o meno giovani) che con approccio transdisciplinare si servono (anche) dell’antropologia per intervenire autorevolmente nell’arena pubblica del nostro Paese rappresentandone un controcanto critico.
La scrittura riveste un ruolo fondamentale all’interno dei Dialoghi – e non potrebbe essere altrimenti. La rivista lascia agli autori una libertà espressiva che è molto difficile da trovare in altre pubblicazioni specializzate. I suoi contributi, infatti, coprono un ampio spettro di soluzioni stilistiche e contenutistiche aprendosi tanto a forme canoniche e tradizionali quanto ad esperimenti più riflessivi e narrativi. In tal modo, il periodico persegue alti obiettivi divulgativi (lontani però da facili generalizzazioni) coniugando rigore analitico e soggettività e mettendo in risalto, una volta di più, come in antropologia (e nelle scienze umane e sociali in generale) sia molto complicato disgiungere l’analisi scientifica dal coinvolgimento personale del ricercatore. Questa libertà, non solo formale ma anche tematica, si oppone altresì in modo creativo e originale alla crescente burocratizzazione delle pratiche di restituzione che investe il mondo accademico (e non solo), sempre più vittima di un preoccupante corto circuito: nel tentativo di evadere dalla famigerata “torre d’avorio”, è indotto a pianificare ricerche che rispettino “indici di impatto” oggettivi e utilitaristici per ottenere finanziamenti esterni e sopravvivere.
Il progetto dei Dialoghi Mediterranei è, al di là della formazione degli autori che vi contribuiscono, autenticamente pluralistico e aperto: esso propone contributi impegnati e partecipi del clima politico e intellettuale del nostro tempo. La scelta del formato (bimestrale online), da questo punto di vista, appare quanto mai opportuna: da una parte consente agli studiosi di intervenire tempestivamente sulle questioni più strettamente d’attualità e di essere rilanciati nello spazio pubblico, come voci autorevoli, grazie al gioco di condivisioni favorito dalla rete; dall’altra permette loro di mantenere la giusta distanza dagli eventi, di meditare a fondo e di fare ciò che contraddistingue il discorso antropologico: «il giro più lungo». Proprio dello scienziato umano, infatti, non è arrivare per primo sulla notizia, bensì scriverne fuggendo l’ovvio e il superficiale per farne risaltare significati, detti, non detti e ricadute. Da quanto fin qui sostenuto, pertanto, emerge con chiarezza come il principale obiettivo del periodico sia quello di riflettere sulla realtà aggredendola da più punti di vista e secondo un’ottica critica che destrutturi concetti e categorie e fornisca strumenti per orientarsi e, soprattutto, andare al fondo delle cose.
Nel primo numero dei Dialoghi (marzo 2013) il mar Mediterraneo veniva indicato come il fulcro di un progetto editoriale teso a riannodare i fili della memoria che legano indissolubilmente la Sicilia al più ampio spazio nordafricano e mediorientale. E nell’editoriale del marzo 2023, che ha inaugurato i festeggiamenti per il decennale della rivista, si ricorda come la città di Mazara del Vallo fosse stata subito individuata come «limes o finis terrae ma anche limen, passaggio verso altre terre, capolinea e avamposto, faglia stretta ai margini di mondi e continenti diversi». Col tempo, evidentemente, il progetto iniziale si è ingrandito accogliendo un arco di temi e aree d’indagine sempre più ampio, in linea con le competenze e gli interessi dei collaboratori che progressivamente si sono uniti al progetto e con uno scacchiere mondiale sempre più interconnesso.
Ma c’è dell’altro. Il progetto, infatti, si è ampliato non in contraddizione, bensì in continuità con il profondo valore simbolico di Mazara del Vallo e del Mediterraneo tutto – porte verso l’altrove, crocicchi, nodi, crocevia di genti, idee, valori, sogni, speranze, illusioni, incubi. E non, si badi bene, perché Mazara del Vallo e il Mediterraneo siano banali sineddochi del villaggio globale (questa tendenza a vedere nelle piccole realtà la miniaturizzazione di quelle più grandi era stata opportunamente stigmatizzata da Clifford Geertz già in Scrivere le culture), bensì perché questi «spazi praticati», oggi come ieri, riflettono gli intricati giochi dialettici tra la sfera locale e quella globale e sono attraversati, per ricorrere al gergo di Arjun Appadurai (2001), dai flussi deterritorializzati della cultura e dell’immaginazione.
Ed eccomi allora, chino sul mio laptop, a scrivere mentre brucia ancora la ferita per le morti di Steccato di Cutro (26 febbraio 2023); a notare incredulo e impotente come il primo numero dei Dialoghi venisse pubblicato qualche mese prima di un’altra immane tragedia: il naufragio di Lampedusa (13 ottobre 2013) in cui persero la vita quasi quattrocento persone; a vedere come il continuo richiamo all’immagine del Mare Nostrum (tutto locale e anzi di proprietà certificata) alimenti retoriche securitarie (se non apertamente razziste) che vogliono rendere l’Europa una fortezza inaccessibile, mentre il discorso pubblico, almeno nelle sue declinazioni più mainstream, indulge senza vergogna in un linguaggio guerresco (“invasione”, “urto”, “danni collaterali”, “carichi residuali”); ad osservare come dinamiche identitarie violente, retoriche muscolari, negazionismi e revisionismi stiano prendendo piede in molte zone del mondo, e in ogni ambito del sociale (politica, scuola, società civile, cultura), favorendo il successo dei populismi reazionari e limitando progressivamente lo spazio riservato al confronto e al dialogo; a constatare, infine, come l’empatia – la grande chimera antropologica – lasci sempre più spazio al cinismo nell’orientare i rapporti umani, ad esempio quando importanti esponenti istituzionali consigliano agli altri (sempre agli altri…) di “non partire” o, dopo una catastrofe, chiedono se costoro fossero “consapevoli dei rischi” di una traversata in mare.
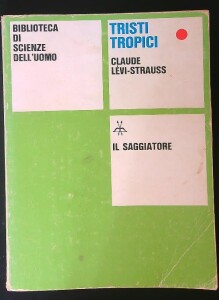 A tutto questo, e a molto altro, Dialoghi Mediterranei risponde da dieci anni privilegiando «la chiave di lettura antropologica per decostruire retoriche e luoghi comuni e scoprire le somiglianze laddove in prima approssimazione sono visibili solo le discordanze» (Editoriale, marzo 2023). Aprendo, a tal fine, uno spazio libero in cui una comunità viva di scrittori e lettori rinnova ogni sessanta giorni una public anthropology sensibile, impegnata e consapevole che ciò che è può sempre essere diversamente. Poco importa, allora, che a scrivere nel periodico dell’Istituto Euroarabo non siano solo antropologi di formazione (e professione), bensì storici, sociologi, linguisti, filosofi, giuristi, teologi. Perché in questo luogo si riflette transdisciplinarmente sulla condizione umana e lo si fa non in astratto, ma con approccio profondamente antropologico: consapevole cioè che dietro le astrazioni – “cultura”, “società”, “politica”, “economia” – ci sono le storie di esseri umani in carne e ossa.
A tutto questo, e a molto altro, Dialoghi Mediterranei risponde da dieci anni privilegiando «la chiave di lettura antropologica per decostruire retoriche e luoghi comuni e scoprire le somiglianze laddove in prima approssimazione sono visibili solo le discordanze» (Editoriale, marzo 2023). Aprendo, a tal fine, uno spazio libero in cui una comunità viva di scrittori e lettori rinnova ogni sessanta giorni una public anthropology sensibile, impegnata e consapevole che ciò che è può sempre essere diversamente. Poco importa, allora, che a scrivere nel periodico dell’Istituto Euroarabo non siano solo antropologi di formazione (e professione), bensì storici, sociologi, linguisti, filosofi, giuristi, teologi. Perché in questo luogo si riflette transdisciplinarmente sulla condizione umana e lo si fa non in astratto, ma con approccio profondamente antropologico: consapevole cioè che dietro le astrazioni – “cultura”, “società”, “politica”, “economia” – ci sono le storie di esseri umani in carne e ossa.
Nel 1955 usciva la prima edizione di quel capolavoro rapsodico che è Tristi Tropici. Qui Claude Lévi-Strauss metteva a nudo le difficoltà epistemologiche, etiche e politiche dell’incontro con l’alterità culturale e, soprattutto, le inquietudini della scienza antropologica. In un periodo storico in cui la critica cominciava a riflettere timidamente sulla genesi della disciplina denunciandone l’implicazione con il dispositivo coloniale e a intuire le imbarazzanti collaborazioni tra etnografi e apparati militari, l’etnologo francese parlava dell’antropologia come di «rimorso dell’Occidente» e abbozzava i contorni di un sapere (auto)riflessivo che, oltre a produrre conoscenza sull’alterità, consentisse ai suoi cultori di affrancarsi dalle apparenti certezze della propria cultura. In questo modo, sosteneva Lévi-Strauss, l’antropologia avrebbe raggiunto un autentico potenziale trasformativo e, memore degli errori del passato, avrebbe potuto proiettarsi verso il futuro.
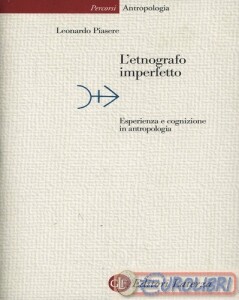 Ecco, sono convinto che il contributo di Dialoghi Mediterranei al dibattito pubblico italiano stia proprio nella fedeltà a questo nobile ideale levistraussiano: nel suo radicamento nel presente, nel recupero della lezione critica del passato e, soprattutto, nel senso della possibilità che spinge a immaginare sempre, pur nelle storture che quotidianamente viviamo, analizziamo e scriviamo, un futuro buono per tutti. Il grande archivio di storie, racconti e immagini che in questi primi due lustri di vita la rivista ha creato, allora, non ci racconta solo chi siamo o chi eravamo. Ci dice anche chi vorremo essere e quali strade decideremo di percorrere. Ci spinge ad alimentare il discorso critico e a divulgare un pensiero anti-etnocentrico (e anti-antropocentrico) che abbia valore operativo.
Ecco, sono convinto che il contributo di Dialoghi Mediterranei al dibattito pubblico italiano stia proprio nella fedeltà a questo nobile ideale levistraussiano: nel suo radicamento nel presente, nel recupero della lezione critica del passato e, soprattutto, nel senso della possibilità che spinge a immaginare sempre, pur nelle storture che quotidianamente viviamo, analizziamo e scriviamo, un futuro buono per tutti. Il grande archivio di storie, racconti e immagini che in questi primi due lustri di vita la rivista ha creato, allora, non ci racconta solo chi siamo o chi eravamo. Ci dice anche chi vorremo essere e quali strade decideremo di percorrere. Ci spinge ad alimentare il discorso critico e a divulgare un pensiero anti-etnocentrico (e anti-antropocentrico) che abbia valore operativo.
Leonardo Piasere (2002), dialogando criticamente con Clifford Geertz, una volta disse che l’antropologo è costretto a scrivere perché non capisce del tutto ciò che osserva e vive. Forse ha ragione lui. Forse l’antropologia è destinata a non comprendere mai pienamente la realtà circostante. Forse è condannata a girarci intorno illuminandone, con le sue parole, giusto qualche scorcio. Qualche angolo nascosto, eppure importantissimo, che il senso comune e altri sguardi ignorano o non riescono a vedere. Uno sforzo inesausto e mai fine a sé stesso di cui le parole scritte lasciano traccia, fiaccole che illuminano il cammino e spingono a proseguire il viaggio.
Dialoghi Mediterranei, n. 61, maggio 2023
Note
[1] Con questo, ovviamente, non intendo negare valore all’antropologia restituita tramite altri media – filmati audiovisivi, fotografie, disegni, etc. – e probabilmente, come avvertiva già Clifford Geertz (1988), sarebbe più opportuno utilizzare il verbo “inscrivere”. Nell’economia del discorso portato avanti in questo contributo, ad ogni modo, la differenza tra “scrivere” e “inscrivere” non è determinante; da qui la decisione di non soffermarmi sulla questione e di avvertire il lettore solo con qualche prudente corsivo: “scrivendo”; “scrivere è l’unica cosa che può fare un antropologo […]”.
[2] Ursula K. Le Guin, figlia di Alfred Kroeber, aveva parecchia familiarità con l’antropologia culturale: i suoi romanzi fantascientifici e fantastici, nonché i suoi saggi teorici, sono fortemente influenzati da concetti e dati antropologici.
Riferimenti bibliografici
Appadurai A. 2001, Modernità in polvere, Meltemi, Roma (ed. or. 1996).
Asad T. (a cura di) 1973, Anthropology and the Colonial Encounter, Humanity Books, New York.
Fabian J. 2021, Il tempo e gli altri, Meltemi, Milano (ed. or. 1983).
Geertz C. 1988, Interpretazione di culture, il Mulino, Bologna (ed. or. 1973).
Le Guin K. U. 2022, I sogni si spiegano da soli. Immaginazione, utopia, femminismo, SUR, Roma (ed. or. 2018).
Lévi-Strauss C. 1960, Tristi Tropici, il Saggiatore, Milano (ed. or. 1955).
Malighetti R., Molinari A. 2016, Il metodo e l’antropologia. Il contributo di una scienza inquieta, Raffaello Cortina Editore, Milano.
Piasere L. 2002, L’etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia, Laterza, Roma-Bari.
_____________________________________________________________
Dario Inglese, ha conseguito la laurea triennale in Beni Demo-etnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e la laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Si è occupato di folklore siciliano, cultura materiale e cicli festivi. A Milano, dove insegna in un istituto superiore, si è interessato di antropologia delle migrazioni e ha discusso una tesi sull’esperimento di etnografia bellica Human Terrain System.
______________________________________________________________









