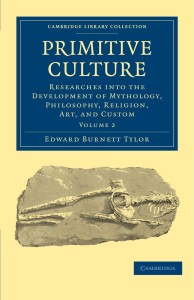di Giovanni Gugg
«A me sto fatto che bisogna annà sempre contro la minoranza non me sta bene. Non me sta bene che no» (Simone, 15 anni, abitante di Torre Maura, Roma, rivolto a vari esponenti di estrema destra, il 3 aprile 2019)
Esattamente 150 anni fa, nel 1871, sir Edward Burnett Tylor compiva una rivoluzione, formalizzando una nuova versione del concetto di cultura, molto più inclusiva rispetto al suo significato più usuale all’epoca. Con il suo libro Primitive culture, Tylor forniva uno strumento nuovo per analizzare e capire le alterità tra le comunità umane: da quel momento, il termine “cultura” non sarebbe stato più (solo) sinonimo di “sapere” o di “sapienza”, ma una nozione più ampia che includeva le conoscenze – anche le più minute e quotidiane – di ciascun essere umano, di ciascun gruppo. Le differenze tra gli umani erano sempre state evidenti, per cui in merito ad esse ci si era posti sistematicamente anche curiosità e questioni, ma le risposte e le spiegazioni erano in ogni caso riconducibili ad una visione morale, per cui sempre piuttosto insoddisfacenti e parziali. Con il concetto declinato da Tylor, invece, si trova uno strumento che aiuta a formulare argomentazioni più solide, almeno per l’epoca, come ad esempio che le diversità tra le società umane sono culturali. Il punto, pertanto, è capire cosa sia la cultura, il cui dibattito non si è mai concluso fino ad oggi.
In questo secolo e mezzo, l’antropologia ha compiuto molti passi in avanti, attraversando anche delle crisi profonde nella seconda metà del Novecento, contribuendo alla consapevolezza sull’umano e delineandosi come un particolare tipo di sguardo sul mondo, perché offre un ventaglio di possibilità osservate nel tempo e nello spazio. Ma l’antropologia “fa” cultura? O si limita a registrare e a interpretare la cultura degli altri? È comprensibile che ogni disciplina rivendichi un proprio ambito di studio, per cui la geografia ha lo spazio, la psicologia la mente, la biologia la vita, la sociologia la società e l’antropologia la cultura. Tuttavia, osserva Tim Ingold (2020), per gli antropologi quest’affermazione, «strategicamente parlando, è un suicidio». La ragione è che, in un regime capitalista dove l’economia regna sovrana e dove si presuppone che la prosperità degli esseri umani dipenda dal funzionamento del mercato, si rischia che «la cultura appaia come una semplice ciliegina sulla torta», alla stregua di un’attività elitaria o superflua. In un contesto del genere, la cultura è intesa come un lusso determinato dall’abbondanza, per cui in caso di emergenza e austerità non può che finire per essere dichiarata “non essenziale”, come è stato in effetti stabilito durante la crisi pandemica in cui ci troviamo dai primi mesi del 2020, dunque sacrificabile.
Tra le studiose e gli studiosi di questo settore è ricorrente sentir ripetere che l’antropologia è più di una scienza, perché è anche l’arte di immaginare l’esistenza, la convivenza, il futuro, per cui se ne ambisce ad una maggiore diffusione e a un suo ruolo pubblico più incisivo, sebbene sul piano istituzionale e sociale il suo apporto sia spesso ancora irrisorio. È un’esigenza che emerge regolarmente in occasione dei disastri, come all’indomani del sisma nel Centro Italia dell’agosto 2016, quando il geografo umano Giuseppe Forino ha lanciato un vero e proprio appello per le scienze sociali:
«Mentre esperti e professionisti come sismologi, geologi, ingegneri, architetti, urbanisti, economisti sono figure fondamentali nell’assistere le istituzioni nella creazione di policy e strumenti effettivi ed efficaci per la riduzione del rischio sismico, essi devono essere supportati – e devono mutualmente supportarle – da analisi rigorose dell’ampio spettro di questioni sociali che intervengono nel post-disastro. Tale analisi include ad esempio l’evoluzione storica, le traiettorie di sviluppo locale, le esigenze specifiche di persone con disabilità, bambini o anziani, l’uso di specifiche strategie di comunicazione, la creazione e la valorizzazione di reti formali e informali nel dialogo tra cittadini e istituzioni. Antropologia, sociologia, comunicazione e media, geografia e scienze del territorio sono tra quelle scienze altrettanto fondamentali nell’aggiungere un punto di vista umano e sociale sul disastro, e nel decostruire racconti parziali e superficiali, come questi brevemente considerati nel testo» (Forino 2016).
Una sensibilità simile è stata recentemente espressa da Virginia Garcia-Acosta, secondo la quale la pandemia ha rivelato la necessità delle scienze sociali, in particolare dell’antropologia culturale, intesa «come un’arena per osservare come gli esseri umani affrontano e danno senso a ciò che stanno vivendo quotidianamente attraverso una lente che si concentra sul livello locale e comunitario» (Garcia-Acosta 2021: 41).
Si tratta di un’ambizione che condivido, ma che comporta una serie di riflessioni sul ruolo e sulla postura da tenere. Riprendendo le osservazioni di Mara Benadusi (2015) per inquadrare l’impegno pubblico dell’antropologo nei disastri, ritengo che le direttrici principali da seguire siano tre: vivere, enunciare e agire la realtà, con le sue problematiche, i suoi attriti, le sue contraddizioni. Tutto questo emerge con forza e chiarezza dalle sollecitazioni lanciate da Francesco Faeta (2021) sull’impegno che gli intellettuali – in particolare dell’area antropologica – oggi devono recuperare perché non si limitino a descrivere il mondo, ma contribuiscano a immaginarne il cambiamento. Quegli “Appunti per non ricominciare” con le vecchie e stantie poetiche e politiche della cultura, sono stati poi ulteriormente arricchiti da numerose riflessioni nei mesi successivi: da Lia Giancristofaro (2021), che ha efficacemente proposto la metafora della potatura, gesto antico capace di tramandare la vita e di tutelare la longevità, a Vito Teti (2021), che invita la comunità degli antropologi a una militanza che ritrovi la sua capacità di demitizzare e demistificare, al fine di partecipare alla nascita di mondi nuovi; da Giovanni Cordova (2021), che recupera alcuni aspetti fondativi della disciplina, come il fare ricerca con l’altro, condividendone le storie, le speranze e le paure, a Davide Accardi (2021), che incita a produrre cultura dove più necessario: «in Largo Domenico delle Greche a Tor Bella Monaca o ai Quartieri Spagnoli e non nei salotti borghesi ai quali siamo abituati».
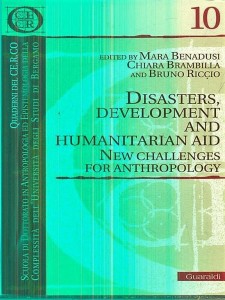 La questione del posizionamento dell’antropologo è antica e particolarmente sentita da chi si occupa di antropologia applicata: essere fuori o dentro dalle istituzioni di governo? Nel primo caso, si può lavorare in modo autonomo (Benadusi 2011; Revet 2013) o in maniera esplicitamente militante (Scheper-Hugues 1995). Nel secondo caso, invece, l’antropologo può operare all’interno dell’ente, ma a due differenti livelli di coinvolgimento: come consulente o perito che fornisce un servizio su commissione (Ciccozzi 2013), correndo tuttavia il rischio di non esercitare più alcun controllo sulla sua consulenza, perché verrà inevitabilmente utilizzata da altri, o come membro interno di un’equipe multidisciplinare tecnico-scientifica (Langumier 2013), dove invece il limite più evidente è rappresentato da eventuali pressioni politiche del momento, nello scarso peso decisionale che un antropologo isolato può avere tra esponenti di discipline più “dure”, oppure, ancora, nel rischio di routinizzazione dell’osservazione che, nel medio-lungo periodo, può rendere inefficace l’apporto dello sguardo antropologico.
La questione del posizionamento dell’antropologo è antica e particolarmente sentita da chi si occupa di antropologia applicata: essere fuori o dentro dalle istituzioni di governo? Nel primo caso, si può lavorare in modo autonomo (Benadusi 2011; Revet 2013) o in maniera esplicitamente militante (Scheper-Hugues 1995). Nel secondo caso, invece, l’antropologo può operare all’interno dell’ente, ma a due differenti livelli di coinvolgimento: come consulente o perito che fornisce un servizio su commissione (Ciccozzi 2013), correndo tuttavia il rischio di non esercitare più alcun controllo sulla sua consulenza, perché verrà inevitabilmente utilizzata da altri, o come membro interno di un’equipe multidisciplinare tecnico-scientifica (Langumier 2013), dove invece il limite più evidente è rappresentato da eventuali pressioni politiche del momento, nello scarso peso decisionale che un antropologo isolato può avere tra esponenti di discipline più “dure”, oppure, ancora, nel rischio di routinizzazione dell’osservazione che, nel medio-lungo periodo, può rendere inefficace l’apporto dello sguardo antropologico.
 Si ripropone ancora, dunque, quello che Clifford Geertz (1988: 72) definiva «dilemma umano oltre che dilemma professionale», ossia l’annosa questione se l’antropologo debba ricoprire il ruolo di attore o di ricercatore. Personalmente, ritengo che oggi gli sia richiesta un’ambivalenza che, a seconda dei tempi, del campo e delle circostanze, possa consentirgli di lavorare su fronti diversi: per alimentare rielaborazioni inedite dell’esistente in chiave partecipativa, dinamica e radicale, ma anche per analizzare gli strumenti normativi e tecnico-operativi a livello istituzionale. Gli antropologi dovrebbero pensarsi alla stregua dei «lavoratori del negativo» a cui fa riferimento René Lourau: analisti della società che tendono, «silenziosamente o non, le braccia verso quegli elementi devianti, verso quelle anomalie, quei traviamenti, quelle negazioni dell’ordine esistente» (Lourau 1975: 80), ovvero verso gli out-sider, gli out-law, i drop-out della società. Al contempo, gli antropologi dovrebbero avere la capacità di entrare nelle stanze in cui vengono elaborati scenari e in cui si stabiliscono azioni che condizionano il presente, consapevoli dei pericoli di strumentalizzazione evidenziati da Edward Said (2014), ma anche fiduciosi nella loro solidità deontologica e nella loro capacità di distanziamento professionale (Gugg 2015).
Si ripropone ancora, dunque, quello che Clifford Geertz (1988: 72) definiva «dilemma umano oltre che dilemma professionale», ossia l’annosa questione se l’antropologo debba ricoprire il ruolo di attore o di ricercatore. Personalmente, ritengo che oggi gli sia richiesta un’ambivalenza che, a seconda dei tempi, del campo e delle circostanze, possa consentirgli di lavorare su fronti diversi: per alimentare rielaborazioni inedite dell’esistente in chiave partecipativa, dinamica e radicale, ma anche per analizzare gli strumenti normativi e tecnico-operativi a livello istituzionale. Gli antropologi dovrebbero pensarsi alla stregua dei «lavoratori del negativo» a cui fa riferimento René Lourau: analisti della società che tendono, «silenziosamente o non, le braccia verso quegli elementi devianti, verso quelle anomalie, quei traviamenti, quelle negazioni dell’ordine esistente» (Lourau 1975: 80), ovvero verso gli out-sider, gli out-law, i drop-out della società. Al contempo, gli antropologi dovrebbero avere la capacità di entrare nelle stanze in cui vengono elaborati scenari e in cui si stabiliscono azioni che condizionano il presente, consapevoli dei pericoli di strumentalizzazione evidenziati da Edward Said (2014), ma anche fiduciosi nella loro solidità deontologica e nella loro capacità di distanziamento professionale (Gugg 2015).
Come ci ricorda Pierre Bourdieu (2007), nell’elaborazione di ogni visione del mondo, una variabile fondamentale è quella della localizzazione dell’individuo, quindi anche del ricercatore, nel senso di luogo da cui egli osserva e comunica, non solo come spazio fisico e geografico, ma anche come posizione sociale e politica. Durante la pandemia di Covid-19, tutti i governi europei hanno coinvolto numerosi scienziati in comitati di esperti che potessero aiutare nelle difficili decisioni da prendere per far fronte alla diffusione del patogeno, ma la loro composizione varia a seconda dei Paesi: in Italia il Comitato Tecnico-Scientifico, istituito ai primi di febbraio del 2020, è composto da esperti di alto livello in molti campi medici, tutti dirigenti della pubblica amministrazione, poi integrato o modificato in relazione a specifiche esigenze, tenuto conto della situazione di crisi; in Gran Bretagna lo Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) include esperti di varie specializzazioni mediche, ma anche di logistica, scienza del comportamento e istruzione; in Germania la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina ha diversi gruppi di lavoro che possono attingere a una lista di 1600 membri internazionali di qualsiasi disciplina, in Francia il Conseil scientifique Covid-19 è composto da 12 esperti in virologia, epidemiologia e biologia molecolare, oltre che dal sociologo Daniel Benamouzig e dall’antropologa Laëtitia Atlani-Duault.
Questa rapida occhiata alle strategie europee evidenzia due aspetti, dinanzi ad una crisi sanitaria inedita per la nostra generazione: da una parte gli scienziati sociali sono stati inclusi ed ascoltati in vari Paesi, dall’altra l’Italia si distingue per assenza, confermando ancora una volta una mentalità eminentemente emergenziale e tecnocentrica. Eppure, le problematiche pedagogiche, psicologiche e socio-culturali non sono mancate, così come è emersa l’esigenza di pensare al dopo-pandemia, al “mondo che avremo”, come hanno scritto Aime, Favole e Remotti (2020):
«Che cosa possono fare gli antropologi? Hanno da lavorare contro l’accecamento, cercando di analizzare la megacultura che ci avvolge: si tratta di studiarne le caratteristiche e il funzionamento, così come i suoi presupposti più profondi da un lato e gli effetti di devastazione sociale e naturale dall’altro. Hanno da offrirci un ampio “magazzino” di conoscenze su società che abbiamo bollato come “tradizionali”, come se fossero immerse in un eterno passato, mentre, viste da vicino, risultano spesso ben più attrezzate di noi a pensare il futuro. Occorre far tesoro della conoscenza di queste molteplici possibilità dell’umano».
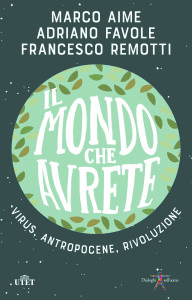 Il punto è come compiere questa “rivoluzione culturale”, ovvero questo mutamento profondo in termini di visione del mondo, di comportamenti e di effetti pratici? A mio avviso, lo sforzo – di ciascuno e della comunità degli antropologi – deve concentrarsi su tre traiettorie: il détour dello sguardo e la serendipità, l’ascolto e il dialogo, l’ubiquità e la simultaneità.
Il punto è come compiere questa “rivoluzione culturale”, ovvero questo mutamento profondo in termini di visione del mondo, di comportamenti e di effetti pratici? A mio avviso, lo sforzo – di ciascuno e della comunità degli antropologi – deve concentrarsi su tre traiettorie: il détour dello sguardo e la serendipità, l’ascolto e il dialogo, l’ubiquità e la simultaneità.
L’antropologia può rivendicare un suo tratto distintivo, tra le varie discipline scientifiche, quello del cambio del punto di vista, assumendo, nel caso della pandemia di Covid-19, la prospettiva dei pipistrelli o dei volatili (Keck 2020), oppure, nel caso di altre possibili crisi, come il rischio vesuviano, il “guardare con gli occhi del vulcano”, che significa riflettere e agire sul tipo di urbanizzazione avuto negli ultimi decenni nell’area napoletana e, più in generale, sul modello di sviluppo che lo ha ispirato, responsabile dell’attuale esposizione alla minaccia geologica (Gugg 2017). Tale postura comporta una certa apertura e duttilità da parte del ricercatore, dal momento che, stando sul terreno, intervengono sempre stimoli inaspettati, per cui è fondamentale riuscire a adattarsi alle circostanze o saper “navigare a vista”. Essere aperti al “caso” o alla “serendipità” significa superare le rigidità metodologiche ed essere disposti a scoprire qualcosa che non si era previsto, che si tratti di dati scientifici, intuizioni teoriche o soluzioni politiche.
Altra particolarità dell’antropologia, su cui ritengo si possa costruire un nuovo ruolo socio-culturale dei suoi esponenti, è la riscoperta dell’ascolto, che a sua volta significa tornare a percorrere i luoghi e a incontravi l’altro. Essere sui territori, come si ripete sempre, in antropologia è una verità alquanto banale, eppure è una pratica di cui bisogna riassaporare il gusto e le potenzialità, anche sperimentando nuovi metodi, come per esempio le walking interview, che sono al contempo interviste prolungate e fortuite, di condivisione e introiezione. Ascolto e dialogo sono pratiche evocate più volte da David Graeber, specie quando scrive che il compito dell’intellettuale è «guardare chi sta creando alternative percorribili, cercare di immaginare quali potrebbero essere le più vaste implicazioni di ciò che si sta (già) facendo, e quindi riportare queste idee, non come disposizioni, ma come contributi e possibilità, come doni» (Graeber 2006). Evidentemente, questo non vale solo con gli interlocutori sul campo etnografico, ma anche con le altre discipline e le altre branche del sapere: non una generica e retorica multidisciplinarietà, ma una collaborazione concreta, che cominci dagli aspetti più minuti e che sia orientata alla costruzione di un vocabolario comune. D’altra parte, sottolinea Stefano Montes, «il dialogo non è altro che il situarsi del ‘due’, in potenza e in atto» (Montes 2015).
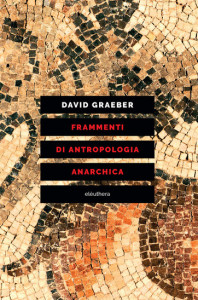 Una volta chiarito ciò, la figura dell’antropologo che “fa” cultura non può che volgere verso una dimensione utopica, ma che in futuro determinerà la sua riconoscibilità sociale e politica: l’ubiquità e la simultaneità. L’essere qui e ovunque, ora e poi, ossia il non rimanere fermi neanche dinanzi a sé stessi fa dell’antropologo «un individuo in costante transito, tra entità diverse, sulla frontiera dell’essere nel ‘qui rassicurante’ e al contempo in un ‘altrove indefinito’» (Montes 2015). Tale postura permette di andare oltre la fissità identitaria, per cui questo è il solo atteggiamento che legittima il ricercatore a interpretare l’altro, poiché comporta che lo studioso sia al contempo disponibile a farsi interpretare dall’altro (Canevacci 2014). L’antropologia è una modalità di studio con le persone, piuttosto che una ricerca sulle persone, per cui, più che una disciplina è una in-disciplina (Ingold 2020: 98), nel senso che va concepita come un dialogo sincretico, come una conversazione: innanzitutto tra gli studiosi e i loro interlocutori sul campo, ma anche tra coloro che la praticano e tra studiosi di saperi diversi, comprese istituzioni e organizzazioni, in tempi ordinari e straordinari, quindi duttile, fluida e porosa, impegnata, applicata e autoironica, come una celebre vignetta di Gary Larson del 1984, “The Far Side”.
Una volta chiarito ciò, la figura dell’antropologo che “fa” cultura non può che volgere verso una dimensione utopica, ma che in futuro determinerà la sua riconoscibilità sociale e politica: l’ubiquità e la simultaneità. L’essere qui e ovunque, ora e poi, ossia il non rimanere fermi neanche dinanzi a sé stessi fa dell’antropologo «un individuo in costante transito, tra entità diverse, sulla frontiera dell’essere nel ‘qui rassicurante’ e al contempo in un ‘altrove indefinito’» (Montes 2015). Tale postura permette di andare oltre la fissità identitaria, per cui questo è il solo atteggiamento che legittima il ricercatore a interpretare l’altro, poiché comporta che lo studioso sia al contempo disponibile a farsi interpretare dall’altro (Canevacci 2014). L’antropologia è una modalità di studio con le persone, piuttosto che una ricerca sulle persone, per cui, più che una disciplina è una in-disciplina (Ingold 2020: 98), nel senso che va concepita come un dialogo sincretico, come una conversazione: innanzitutto tra gli studiosi e i loro interlocutori sul campo, ma anche tra coloro che la praticano e tra studiosi di saperi diversi, comprese istituzioni e organizzazioni, in tempi ordinari e straordinari, quindi duttile, fluida e porosa, impegnata, applicata e autoironica, come una celebre vignetta di Gary Larson del 1984, “The Far Side”.
Poiché la crisi è un momento delicato – di eventuale biforcazione – è possibile cogliere la pandemia come un’opportunità per trasformare il rapporto tra scienza e potere, tra ricerca e politica, tra cultura registrata e cultura prodotta. In questo, l’antropologia può ricoprire un ruolo fondamentale e multiplo, a patto che cominci da sé stessa, ripensando la propria funzione sociale e politica come approccio polifonico e in transito, navigando lo spazio delle relazioni umane nel loro divenire fluido e mutevole. A distanza di un secolo e mezzo dal concetto di cultura di Tylor, oggi l’antropologia si sta progressivamente spogliando di quella nozione, per indirizzarsi verso una sua nuova declinazione, basata sull’idea di partecipare a una struttura di rete che prende la forma di un sistema esperto diffuso, capace di catturare intelligenze e saperi per concepire condizioni e possibilità di vite diverse. Ingold afferma che,
«dovremmo apprezzare questa libertà di fare congetture, di dire ciò che noi pensiamo, senza fingere che le nostre parole siano di fatto un distillato delle visioni dei popoli tra cui abbiamo studiato. Naturalmente se non fosse stato per queste ricerche, non potremmo dire nulla di ciò che invece affermiamo. Ma non spetta a noi parlare a nome dei nostri insegnanti. Parliamo con i nostri cuori e le nostre menti, non con i loro, e sarebbe senza dubbio disonesto fingere il contrario» (Ingold 2020: 93-94).
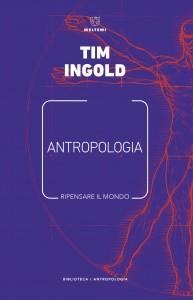 Fin dall’inizio della crisi sanitaria attuale, le antropologhe e gli antropologi hanno mostrato un’ottima capacità di interpretare il tempo, di riflettere su quanto sta avvenendo e di studiare i processi di risignificazione che stanno avvenendo. Molti, mi sembra, si sono mossi in maniera simile a quella di un quindicenne di periferia, che due anni fa, con coraggio e risolutezza, ha affrontato da solo l’arroganza dei violenti e l’ingiustizia dei disonesti, dimostrando che la cultura è più della grammatica, più dell’appartenenza, più della norma o della specializzazione. Per non ricominciare, come ci sollecita Faeta, la cultura di cui abbiamo bisogno è quella anfibia: è la capacità di esserci quando bisogna esserci; è un bosco in cui ci si muove tra codici e sistemi diversi; è un artigianato del vivere che permette di tessere connessioni inedite e sorprendenti. La cultura “che-si-fa” è il percorrere una visione, per cui l’immaginazione e la costruzione del mondo non sono opera di specialismi puri o di conoscenze igieniste, ma di saperi innestati che, dice Alessandro Baricco (2021), avranno «lo sguardo del falco e la pazienza della quercia – la precisione di un bisturi e la memoria di una montagna».
Fin dall’inizio della crisi sanitaria attuale, le antropologhe e gli antropologi hanno mostrato un’ottima capacità di interpretare il tempo, di riflettere su quanto sta avvenendo e di studiare i processi di risignificazione che stanno avvenendo. Molti, mi sembra, si sono mossi in maniera simile a quella di un quindicenne di periferia, che due anni fa, con coraggio e risolutezza, ha affrontato da solo l’arroganza dei violenti e l’ingiustizia dei disonesti, dimostrando che la cultura è più della grammatica, più dell’appartenenza, più della norma o della specializzazione. Per non ricominciare, come ci sollecita Faeta, la cultura di cui abbiamo bisogno è quella anfibia: è la capacità di esserci quando bisogna esserci; è un bosco in cui ci si muove tra codici e sistemi diversi; è un artigianato del vivere che permette di tessere connessioni inedite e sorprendenti. La cultura “che-si-fa” è il percorrere una visione, per cui l’immaginazione e la costruzione del mondo non sono opera di specialismi puri o di conoscenze igieniste, ma di saperi innestati che, dice Alessandro Baricco (2021), avranno «lo sguardo del falco e la pazienza della quercia – la precisione di un bisturi e la memoria di una montagna».
Dialoghi Mediterranei, n. 49, maggio 2021
Riferimenti bibliografici
Accardi D., 2021: Tra cultura egemonica e subalterna: le edicole sacre a Napoli, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 48, marzo: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-cultura-egemonica-e-subalterna-le-edicole-sacre-a-napoli/
Aime M., Favole A., Remotti F., 2020: Il mondo che avrete. Virus, antropocene, rivoluzione, UTET, Torino.
Baricco A., 2021: Mai più, terza puntata, in “Il Post”, 22 marzo: https://www.ilpost.it/2021/03/22/baricco-mai-piu-tre/
Benadusi M., 2011: On the Crest of the Tidal Wave: Adrift in Post-tsunami Sri Lanka, in “Disasters, Development and Humanitarian Aid. New Challenges for Anthropology”, a cura di M. Benadusi, C. Brambilla, B. Riccio, Guaraldi, Rimini.
Benadusi M., 2015: Antropologia dei disastri. Ricerca, attivismo, applicazione. Un’introduzione, in “Antropologia Applicata”, n. 1.
Bourdieu P., 2007: Il critico, o il punto di vista dell’autore [2000], in “Allegoria. Per uno studio materialistico della letteratura”, anno XIX, n. 55, gennaio/luglio, Palumbo Editore, Palermo.
Canevacci M., 2014: Il Simultaneo e l’Ubiquo, in “Rivista di Scienze Sociali”, n. 11: https://www.rivistadiscienzesociali.it/digitale-simultaneo-ubiquo/
Ciccozzi A., 2013: Parola di scienza. Il terremoto dell’Aquila e la Commissione Grandi Rischi. Un’analisi antropologica, DeriveApprodi, Roma.
Cordova G., 2021: Intellettuali ed etnografia tra impegno e sovversione, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 48, marzo: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/intellettuali-ed-etnografia-tra-impegno-e-sovversione/
Faeta F., 2021: Appunti per non ricominciare. La cultura, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 47, gennaio: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/appunti-per-non-ricominciare-la-cultura/
Forino G., 2016: Quando mancano le scienze sociali: quelle narrative distorte dal terremoto in Italia centrale, in “Lavoro Culturale”, 5 settembre: https://www.lavoroculturale.org/narrative-distorte-dal-terremoto/giuseppe/2016/
García Acosta V., 2021: Aprendizajes y nuevos derroteros en el estudio de los desastres y epidemias. Reflexiones desde la antropología, in “Desacatos. Revista de Ciencias Sociales”, vol. 65, https://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/2271/1561
Geertz C., 1988: Antropologia interpretativa [1983], il Mulino, Bologna.
Giancristofaro L., 2021: Convegni e altre kermesse intellettuali: “arte del potatore” e rinascita post-pandemica, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 48, marzo: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/convegni-e-altre-kermesse-intellettuali-arte-del-potatore-e-rinascita-post-pandemica/
Graeber D., 2006: Frammenti di antropologia anarchica [2004], Elèuthera, Milano.
Gugg G., 2015: Rischio e post-sviluppo vesuviano: un’antropologia della ‘catastrofe annunciata, in “Antropologia Pubblica”, n. 1.
Gugg G., 2017: Al di là dello sviluppo, oltre l’emergenza: il caso del rischio Vesuvio, in “Territori vulnerabili. Verso una nuova sociologia dei disastri italiana”, a cura di A. Mela, S. Mugnano, D. Olori, FrancoAngeli, Milano.
Ingold T., 2020: Antropologia. Ripensare il mondo [2018], Meltemi, Milano.
Keck F., 2020: Les sentinelles des pandémies. Chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine, Editions du Seuil, Parigi.
Langumier J., 2013: Concerter, négocier, mobiliser. Retour critique sur la “culture du risque” à partir du Plan Rhône en France, in “Le gouvernement des catastrophes”, a cura di S. Revet, J. Langumier, Karthala, Parigi.
Lourau R., 1975: Lavoratori del negativo, unitevi!,in F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro (a cura di), Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all’oppressione, Einaudi, Torino.
Montes S., 2015: Per una etnografia dialogica e improvvisata, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 13, maggio: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-etnografia-dialogica-e-improvvisata/
Revet S., 2013: Small World: Ethnography of a Natural Disaster Simulation in Lima, Peru, in “Social Anthropology / Anthropologie Sociale”, n. 21.
Said E., 2014: Dire la verità. Gli intellettuali e il potere, Feltrinelli, Milano.
Scheper-Hughes N., 1995: The Primacy of the Ethical: Propositions for a Militant Anthropology, in “Current Anthropology”, n. 36.
Teti V., 2021: Pensieri su un limite, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 48, marzo: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pensieri-su-un-limite-2/
Tylor E. B., 2010: Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom [1871], Cambridge University Press, Cambridge.
______________________________________________________________
Giovanni Gugg, dottore di ricerca in Antropologia Culturale e docente a contratto di Antropologia Urbana presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università “Federico II” di Napoli, attualmente è assegnista di ricerca presso il LESC (Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative) dell’Université Paris Nanterre. Un suo progetto di ricerca intitolato “Covid-19 and Viral Violence” è finanziato dalla University of Colorado ed è chércheur associé presso il LAPCOS (Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales) dell’Université Côte d’Azur di Nizza. I suoi studi riguardano la relazione tra le comunità umane e il loro ambiente, specie quando si tratta di territori a rischio. In particolare, ha condotto una lunga etnografia nella zona rossa del vulcano Vesuvio e ha studiato le risposte culturali dopo i terremoti nel Centro Italia (2016) e sull’isola d’Ischia (2017); inoltre ha osservato e documentato i mutamenti sociali e urbani della città di Nizza dopo l’attacco terroristico del 14 luglio 2016. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Inquietudini vesuviane. Etnografa del fatalismo (2020), Disasters in popular cultures (2019), Anthropology of the Vesuvius Emergency Plan (2019), The Missing ex-voto. Anthropology and Approach to Devotional Practices during the 1631 Eruption of Vesuvius (2018), Vies magmatiques autour du Vésuve (2017).
______________________________________________________________