Ho ben chiaro in mente il momento in cui ad un certo punto del mio percorso di studi, per riferirmi a un individuo che si è stabilito in un Paese o in una regione diversa da quella di origine, ho smesso di utilizzare il termine “immigrato”, per sostituirlo con l’espressione “migrante”. Questa ponderata scelta rientrava in un riesame del lessico utilizzato nel quotidiano, molto spesso fortemente viziato, anche quando appare neutrale (che comprendeva, per esempio, anche la sostituzione di “di colore” con “nero”, di “sesso” con “genere”, etc). La scelta di utilizzare il termine migrante era però strettamente legata alla lettura di un testo che per la sua franchezza, chiarezza e profondità, finì per diventare uno spartiacque nella mia percezione del fenomeno migratorio, come aveva peraltro ragion d’essere. La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato del sociologo algerino Abdelmaled Sayad, pubblicato in Francia nel 1999 e tradotto in Italia nel 2002 per i tipi di Cortina Editore, è considerato un caposaldo della sociologia delle migrazioni, in quanto apre la strada ad una corrente socio-antropologica che per la prima volta nella storia degli studi mette al centro della sua analisi il fenomeno migratorio.
Sebbene questa considerazione possa apparire scontata, non lo è affatto. Nella sua approfondita ricerca sui migranti algerini in Francia negli anni Cinquanta Sayad esplicita in modo estremamente chiaro quale sia la postura assunta dalle società occidentali nei confronti del fenomeno migratorio. Le politiche di accoglienza ed integrazione, così come le strutture metodologiche utilizzate nello studio delle migrazioni, apparivano infatti al sociologo concepite e costruite per rispondere unicamente alle esigenze, nel caso delle politiche, e alle domande, nel caso degli studi, delle società di arrivo. Ovvero le società di im-migrazione. Attraverso quindi una riflessione sul linguaggio utilizzato, che è sempre, come la punta di un iceberg, l’indicatore e l’espressione dei concetti a cui si fa riferimento [1], Sayad evidenziava la parzialità di un discorso, quello sulle migrazioni, che pretendeva invece di assurgere a espressione oggettiva della realtà.
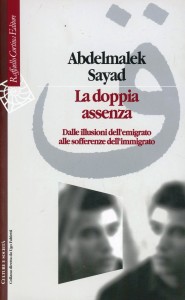 Facendo seguito a questa riflessione il sociologo introduceva dunque l’utilizzo del termine “migrazione” per richiamare il fenomeno della mobilità umana, e “migrante”, per gli individui protagonisti di questa mobilità, per far riferimento ad un processo unitario, che, senza sezionare arbitrariamente pezzi di storia e di geografia, coinvolgesse Paesi di immigrazione, di emigrazione e di transito, e progetti biografici sviluppati nell’arco di intere vite.
Facendo seguito a questa riflessione il sociologo introduceva dunque l’utilizzo del termine “migrazione” per richiamare il fenomeno della mobilità umana, e “migrante”, per gli individui protagonisti di questa mobilità, per far riferimento ad un processo unitario, che, senza sezionare arbitrariamente pezzi di storia e di geografia, coinvolgesse Paesi di immigrazione, di emigrazione e di transito, e progetti biografici sviluppati nell’arco di intere vite.
Questa considerazione, legata alle mie più recenti letture, mi ha portato a riflettere su un dato abbastanza attuale. Fino a pochi anni fa anche in Italia era diffuso l’utilizzo del termine “immigrato”, quando non “clandestino”, per riferirsi indistintamente ai migranti. Negli ultimi anni, invece, l’espressione “migrante” è entrata a far parte del linguaggio comune [2], sostituendo quasi totalmente “immigrato”, probabilmente veicolata dai media, per un atteggiamento sociale di politically correctness che spesso però, a furia di sventolare a tutti i costi la bandiera del rispetto, è finito per svuotare di significato le parole. Alla sostituzione del termine non è affatto corrisposto un ripensamento della categoria del “migrante” [3], che è rimasto lo straniero poco desiderato, ma per forza di cose tollerato, pronto ad essere chiamato in causa come capro espiatorio per le più disparate problematiche sociali.
A fronte dunque di un rinnovamento, seppur auspicabile, del linguaggio e delle “parole della migrazione”, i migranti sono tuttora ostaggio di un discorso, nel senso foucaultiano del termine. La produzione, e la riproduzione, di un sapere dominante intrappola la migrazione e i migranti dentro a una doxa (prendo qui in prestito invece un concetto di Bourdieu), che è così radicalmente introiettata da non essere messa in discussione neanche dalle forze politiche più progressiste. Anche quando viene discusso, analizzato e problematizzato, il discorso sul fenomeno migratorio rimane sempre confinato all’interno dell’idea di im-migrazione, ponendo quindi in ogni caso come punto di partenza e di riferimento le società occidentali. Questo è ciò che, nel suo ultimo libro Liberare le migrazioni. Lo sguardo eretico di Abdelmalek Sayad, edito da Ombre corte nell’ottobre 2018, Gennaro Avallone definisce un «approccio Stato-etno-centrico». L’autore, che dedica il libro a Soumaila Sacko, il bracciante agricolo sindacalista maliano, ucciso nel giugno 2018 in Calabria con un colpo di pistola, propone una rilettura del lavoro di uno «tra i più importanti, profondi e rispettosi ricercatori delle migrazioni, rimarcando alcuni dei concetti che possono essere considerati rivoluzionari nella metodologia e nell’economia delle politiche nazionali e sovranazionali, in particolare l’autonomia delle migrazioni.
Nell’introduzione si legge: «il libro propone un percorso di liberazione dal dominio dello sguardo di Stato alla messa in evidenza della possibilità, oltre che della necessità, dell’eresia, e degli eretici dell’ordine nazionale». L’intento dell’autore è dunque quello di ribadire alcuni concetti, che sono già abbastanza noti per gli addetti ai lavori e che sono le basi di una corrente di studi che ha posto l’accento sulla centralità del fenomeno migratorio nel palcoscenico globale, considerandola per l’appunto come un “fatto sociale totale”, e che ha rifiutato di guardare ai migranti come vittime inermi di processi totalmente esterni alla loro volontà, cercando invece di restituirgli la dignità di essere umani. Questa corrente, che ha mosso i suoi passi a partire dalle riflessioni di Foucault, Bourdieu, Arendt, Appadurai, Said, Fanon, Sayad e molti altri, ha tra i suoi maggiori rappresentanti in Italia Sandro Mezzadra, Salvatore Palidda, Alessandro Dal Lago, Fabio Raimondi, ma conta soprattutto molti studiosi all’estero. Ciononostante, sebbene siano molti gli studi che osservano le migrazioni da una prospettiva “non Stato-etno-centrica” [4], il discorso dominante nella società contemporanea non solo non prende in considerazione, ma non contempla affatto la possibilità di affrontare il tema delle migrazioni da un altro punto di vista. Come se, peraltro, il fenomeno migratorio ci riguardasse, oggi come nel passato, solo dal punto di vista dell’im-migrazione e non da quello dell’e-migrazione [5]. È bene dunque parlare, scrivere e pubblicare le parole degli “eretici” e dei loro partigiani, tra cui mi posiziono.
Avallone presenta brevemente un quadro delle teorie sulle migrazioni classiche, che si sono susseguite nei decenni, ma che ancora oggi vengono chiamate in causa per spiegare cause e processi delle migrazioni. Queste teorie sono: il modello idraulico, il modello push&pull e il modello circolare. Secondo il modello idraulico «l’umanità tenderebbe all’equilibrio nella sua dimensione spaziale, pertanto dove ci sono squilibri demografici o economici interverrebbero movimenti spaziali (migrazioni, appunto) a ripristinare la stabilità». Il secondo modello, quello push&pull, identifica dei fattori di spinta (push) e di attrazione (pull) come causa unica delle migrazioni in una relazione simmetrica tra i Paesi di origine e quelli di destinazione. Infine, il modello circolare «pensa la migrazione come una rotazione continua, presupponendola come provvisoria e transitoria, anche “quando essa ha una grande possibilità di diventare definitiva o di estendersi alla vita attiva”». Questi approcci sono spesso richiamati dagli studiosi e dagli esperti che vengono interpellati pubblicamente dai media per parlare di migrazione nei talk show, sui giornali o nelle trasmissioni radiofoniche. Sarà facile riconoscere nel seguente breve passo di Avallone gli orientamenti interpretativi che sottostanno alle dichiarazioni pubbliche di rappresentanti politici e giornalisti del nostro Paese.
«I tre modelli convergono, da una parte, nel riconoscimento scarso o nullo dei fattori soggettivi, […] e, dall’altra, verso un’idea della migrazione come un fatto che si impone sugli individui. […] Allo stesso tempo, questi tre modelli condividono la medesima idea normativa delle migrazioni, basata sulla loro compatibilità con gli interessi dello Stato e delle società di arrivo. Per questo motivo, le migrazioni sono subordinate all’occhio calcolatore che le valuta in base al bilancio costi-benefici, […] ricondotte, in questo modo, a un puro rapporto contabile, in cui le persone hanno senso solo se sono utili e finché sono utili».
Come Sayad e molti altri studiosi hanno già evidenziato questo atteggiamento interpretativo è un’emanazione chiara della storia coloniale, che continua ancora oggi ad influenzare non solo i rapporti tra gli ex Stati colonizzatori e gli ex Stati colonie nei loro accordi bilaterali, ma anche tra i migranti e gli autoctoni, secondo una gerarchia relazionale che riproduce del tutto la relazione coloniale e che si proietta anche sulle generazioni che non hanno migrato (i giovani di seconda generazione), innescando, evidentemente, lo stesso meccanismo di credito-debito.
La proposta epistemologica del sociologo algerino, che Avallone riprende attualizzando e suggerendo un collegamento ideale con gli scritti di Frantz Fanon [6], è quella di osservare il fenomeno migratorio, svincolando il proprio sguardo dall’imperialismo che è ormai culturalmente introiettato dalle nostre società, tanto da essere percepito come l’unico sguardo possibile, come un sguardo naturale. Ciò che più di un secolo di studi antropologici avrebbero dovuto insegnarci è che quasi sempre ciò che è percepito come naturale è invece un fatto naturalizzato, eminentemente culturale e in molti casi anche politico. La naturalizzazione di un fenomeno, un concetto, un’idea, come lo Stato, per esempio, è quanto di più pericoloso possa produrre una società. Pensare che una cosa sia naturale, che sia così com’è per sua stessa costituzione, implica l’accettazione del fatto che essa stessa non possa esistere in forme diverse, non possa essere altrimenti e, anzi, debba essere difesa da qualsiasi minaccia e attacco che la mini alla sua base [7]. Ciò che è naturale non può in alcun modo essere messo in discussione, per questo stesso motivo Sayad era, in definitiva, un eretico.
Eppure i segnali dell’artificialità di alcuni prodotti del nostro pensiero esistono. In particolar modo le migrazioni, con la loro “funzione specchio” (cfr. Sayad, 2002), mettono a nudo la società di arrivo, riflettendo il carattere totalmente politico e culturale di concetti come Stato, cittadinanza e identità, svelando dunque la loro artificialità. «Le migrazioni sono una sfida a ciò che è costruito come naturale e indiscutibile» (ivi, 92).
Un esempio lampante di questo processo sono gli status, i permessi e i visti che vengono riconosciuti o di cui gli individui hanno bisogno per migrare. A parità di condizioni, due persone provenienti da Paesi di origine diversa possono ottenere i visti necessari per affrontare un’esperienza di mobilità con un livello di facilità/difficoltà molto diverso; a causa del cambiamento di una legge o per mezzo di una sanatoria un individuo che fino a ieri era irregolare può oggi trovarsi in stato di regolarità o addirittura ottenere la cittadinanza, e ritrovarsi ad essere, arbitrariamente, un cittadino come me. Lo status di regolarità/irregolarità, così come la percezione di pericolosità e criminalità, attributi che siamo socialmente portati ad ascrivere direttamente agli individui e alle loro responsabilità individuali, sono generalmente, nella maggior parte dei casi, delle condizioni socialmente e politicamente prodotte, determinate artificialmente da leggi, che non sono emanazione diretta della “natura”, ma che sono invece ideate, scritte ed elaborate da persone, da una classe politica, appunto, legi-ferante. La supposta incontestabilità del pensiero di Stato, e dunque delle leggi, è ciò che in questi ultimi anni ha prodotto aberrazioni del senso umanitario condannando, per ragioni eminentemente “legali”, organizzazioni e individui che agiscono rispondendo ad un senso di umanità e solidarietà, che definirei in molti casi legittimo, per quanto tristemente illegale. È il caso di Mimmo Lucano, sindaco di Riace e simbolo dell’accoglienza ai migranti, condannato al divieto di dimora per truffa e concussione [8], o delle organizzazioni non governative, impegnate nel soccorso in mare ai migranti in transito nel Mediterraneo prese di mira dal governo italiano, o ancora, di Cédric Herrou, l’agricoltore condannato ad agosto 2017 dalle Corte d’appello di Aix-en-Provence a quattro mesi di carcere con la condizionale per aver “facilitato la circolazione e il soggiorno” dei migranti, oltre ad averli aiutati ad attraversare il confine italiano, e solo recentemente assolto.
Un ultimo esempio, di eccezionale valore, è quello che sta avvenendo attualmente nella chiesa di Bethel in Olanda, dove è in corso dal 26 ottobre 2018 la celebrazione delle funzioni religiose, per proteggere la famiglia Tamrazyan dall’espulsione. Una legge olandese non permette infatti alle forze di polizia di irrompere nei luoghi di culto durante una celebrazione; e così da più di un mese pastori protestanti provenienti da diverse aree del Paese si turnano per garantire che la cerimonia non si interrompa e la famiglia di origini armene, che si è vista negare il diritto all’asilo [9], possa rimanere in salvo [10].
Fuori da qualsiasi lettura “buonista”, per utilizzare un termine in voga, o di carità cristiana, l’operato di questi individui, partigiani dell’eresia, manifesta la possibilità politica di pensare e di immaginare il fenomeno migratorio e i migranti fuori dalla cornice pre-costituita del pensiero di Stato. È possibile pensare il diritto alla mobilità come un diritto basilare dell’individuo, che garantisce ai soggetti la possibilità di disegnare e perseguire un progetto di vita, decidendo del proprio futuro e riaffermando la propria dignità di essere umano, anche se non si sta scappando da una guerra o da una persecuzione. Sono proprio queste le «pratiche eretiche di liberazione» di cui Avallone parla e che egli, scrivendo questo libro, ha contribuito a mettere in atto nel campo scientifico degli studi di settore. Questo tipo di eresie sono necessarie per combattere «la negazione dell’agire politico per gli immigrati, cioè la negazione della loro facoltà di esistere in maniera piena come esseri umani, in quanto “esistere è esistere politicamente” (Sayad, 2008:13), cioè esistere significa poter esercitare il diritto di avere diritti» (ivi, 87).
Le migrazioni sono un fenomeno non recente, costitutivo della specie umana; tutte le leggi, la burocrazia e la criminalizzazione che a noi oggi sembrano naturalmente connesse al fenomeno sono solo costruzioni artificiali, occidentali. Come recita infatti in modo semplice ma, a mio avviso, illuminate, il verso di una ormai datata canzone del gruppo gipsy-punk Gogol Bordello, in the old time it was not a crime [11].
Dialoghi Mediterranei, n.35, gennaio 2019
[1] In questo senso un tema che mi stupisce sempre, ma che sembra non destare alcuna sorpresa nei miei variegati interlocutori, è che nell’apparato legislativo italiano, da anni ormai, ogni volta che si deve scrivere o formulare un decreto o una legge relative alla tematica migratoria, si parli insieme, come se fosse un binomio ovvio, di “immigrazione e sicurezza”, come se, automaticamente il fenomeno della migrazione abbia delle ripercussioni dirette sulla sicurezza e l’ordine pubblico della società. Questa semplificazione, ormai così banale da non essere nemmeno notata, che si riferisce implicitamente ai migranti come a dei criminali, basterebbe da sola ad esemplificare quanto la nostra postura mentale verso i migranti sia viziata da un razzismo latente e subdolo. Queste brevi riflessioni non entrano poi nel merito dei contenuti dei cosiddetti “decreti sicurezza e immigrazione”, uno fra tutti l’ultimo, proposto dal Ministro dell’interno Matteo Salvini e già approvato dal Parlamento, che ha richiamato nella memoria di molti un certo provvedimento legislativo emanato in Italia nel 1938 da Benito Mussolini.
[2] Dal sito http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/migranti-respingimenti, dell’Accademia della Crusca:
«La parola migrante è attestata già dall’Ottocento nella sua funzione di participio presente del verbo migrare, quindi con il significato di ‘chi si trasferisce momentaneamente o stabilmente dal suo paese d’origine’. Ha assunto invece un significato più specifico negli ultimi decenni con le nuovi grandi ondate migratorie, arrivando a indicare tutti coloro che lasciano il loro paese d’origine e si muovono alla ricerca di migliori condizioni di vita (nel nostro Paese e in molti altri Paesi europei) e ha sostituito progressivamente i più comuni emigrante e immigrato». Un’altra fonte online del 2015, poco attendibile ai fini di questo contributo, ma di grande rilevanza sociologica è l’articolo «Perché diciamo “migrante” anziché “immigrato”? Ce lo spiega la Boldrini». L’articolo appare all’interno del “Quotidiano Sovranista” online Il Primato Nazionale (al link https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/perche-diciamo-migrante-anziche-immigrato-boldrini-23608/) dove l’autore, responsabile nazionale della cultura del Casa Pound Italia, critica la grande confusione della lingua italiana sorta nel momento in cui il «termine (migrante, n.d.r.) è stato scelto come definizione ufficiale delle masse sradicate che muovono il grande business dell’immigrazione», evidenziando come l’utilizzo del participio presente cancelli l’origine e la destinazione del viaggio intrapreso dall’emigrato/immigrato, che dovrebbe invece intraprendere lo spostamento come «una parentesi limitata al fatto di raggiungere un determinato luogo».
[3] Secondo Fabietti, questo è ciò che è avvenuto, attraverso il culturalismo, anche per il termine “razza” (cfr. Fabietti, 2000). Quando ad un certo punto della storia è diventato intollerabile parlare e sentir parlare ancora di razze, poiché l’espressione era strettamente legata al razzismo e poiché la scienza aveva ampiamente dimostrato che le razze non esistevano, allora si cominciarono ad utilizzare i termini “etnia” e “cultura”, che risultavano politicamente corretti, ma che, di fatto, finivano per determinare la stessa porzione di umanità, definita (e a volte anche autodefinita) per differenza, rispetto ad un campione umano utilizzato come metro di misura, generalmente bianco ed occidentale.
[4] Una breve ed incompleta bibliografia di alcuni testi di riferimento: De Genova, N. (a cura di) The borders of Europe.Autonomy of migration, Tactics of Bordering, Duke University Press, Durham, 2017; Grosfoguel, R. e Cordero-Guzmán, H., International Migration in a Global Context: Recent Approaches to Migration Theory, in “Diaspora”, 7(3): 351-368, 1998; Mezzadra, S. e Ricciardi, M. (a cura di), Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche, Ombre corte, Verona, 2013; Mezzadra, S. (a cura di), I confini della libertà. Per un’analisi politica delle migrazioni contemporanee, DeriveApprodi, Roma, 2004; Palidda, S., Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni, Raffaele Cortina Editore, Milano, 2008; Papadopoulos, D., Niamh, S. e Tsianos, V., Escape Routes. Control and Subversion in the 21st Century, Pluto Press, Londra-AnnArbor, 2008; Raimondi, F., Migranti e Stato. Saggio su Abdelmalek Sayad, Ombre corte, Verona, 2016.
[5] Come si legge infatti in un articolo del Sole24 ore online (https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-06-20/italiani-sempre-piu-migranti-11percento-trasferimenti-estero-130541.shtml?uuid=AEvrkU9E) «La mobilità dei “nuovi italiani” inizia ad assumere l’entità di un fenomeno che non si può ignorare; pur essendo ancora di piccole dimensioni, è una dinamica emergente nel panorama migratorio internazionale». Il rapporto ISTAT 2018, ha infatti evidenziato un incremento delle migrazioni “esterne”; questo rapporto non tiene però conto, anche dell’elevato numero di migrazioni interne dal Sud verso il Nord dell’Italia; fenomeni che influenzano significativamente la vita economica e sociale del Paese.
[6] Alludendo anche alla metodologia di ricerca utilizzata e alla sua postura rispetto ai fenomeni indagati, Avallone cita una frase molto significativa dell’autori de “I dannati della terra”, psichiatra e filosofo francese nero, la cui famiglia era originaria della Martinica: «io mi sono dedicato in questo studio a toccare la miseria del negro. Tattilmente e affettivamente. Non ho voluto essere oggettivo. Per di più, questo è falso: non è possibile essere oggettivo» (Fanon 2009:95, in Avallone 2018: 51).
[7] È questo in soldoni ciò che da secoli ormai la nostra società fa con la famiglia, il sesso/genere, l’idea di cittadinanza, lo stato, i confini, la patria, la nazione (questi ultimi due termini richiamano proprio etimologicamente l’idea di qualcosa di biologico, visceralmente legato alla discendenza e alla nascita: nazione dal lat. natio -onis, der. di nasci «nascere») , e a volte anche con la legge.
[8] In un bellissimo articolo di Internazionale del 2 ottobre 2018, intitolato La campana di Riace, la giornalista Ida Dominijanni scrive: «Sapevamo perfettamente che se l’inchiesta era in cerca di illegalità le avrebbe trovate: Lucano non ha mai negato, e rivendica nelle intercettazioni incriminate, di aver inventato degli espedienti per aggirare le maglie strette di una legislazione (Bossi-Fini e non solo) fatta apposta non per agevolare ma per impedire l’accoglienza. E rivendica di averlo fatto perché – come dargli torto? – la giustizia non sempre coincide con la legalità, e in questi casi bisogna stare dalla parte della giustizia. Si chiama disobbedienza civile, ed è veramente sorprendente sentir dire, in queste ore, che essa si attaglierebbe ai privati cittadini ma giammai a un pubblico ufficiale quale è un sindaco» (https://www.internazionale.it/opinione/ida-dominijanni/2018/10/02/riace-mimmo-lucano ).
[9] Il diritto di asilo, così come il diritto di cittadinanza, è uno di quei diritti ad intermittenza, che sarebbe forse il caso di definire “concessione” in molti dei paesi occidentali, in quanto per il solo fatto di poter essere revocato non rientra più nella definizione di “diritto”.
[10] https://www.nytimes.com/2018/12/10/world/europe/migrants-dutch-church-service.html
[11] Gogol Bordello, Not a Crime, Gypsy Punks: Underdog World Strike, 2005 (https://www.youtube.com/watch?v=StZwrbKHnG4 )
Riferimenti bibliografici
Avallone, G., Liberare le migrazioni. Lo sguardo eretico di Abdelmalek Sayad, ombre corte, Verona, 2018
Fabietti, U., Mondo delocalizzato e antropologia della contemporaneità. PLURIVERSO, 82-90, 2000
Sayad, A., La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Raffaele Cortina Editore, Milano, 2002
___________________________________________________________________________
Cinzia Costa, dopo aver conseguito la laurea in Beni demoetnoantropologici all’Università degli Studi di Palermo si è specializza in Antropologia e Storia del Mondo contemporaneo presso l’Università di Modena e Reggio Emilia con una tesi sulle condizioni lavorative dei migranti stagionali a Rosarno, focalizzando l’attenzione sulla capacità di agency dei soggetti. Si occupa principalmente di fenomeni migratori e soggettività nei processi di integrazione. Collabora con l’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture.
___________________________________________________________________________











