Innā li’llāhi wa-innā ilayhi rāği‘ūna, «A Dio apparteniamo e a Lui facciamo ritorno» (Corano, 2: 156).
Nella cornice di questa affermazione si sviluppa il discorso coranico rispetto ai due grandi temi dell’esistenza: la vita e la morte. La vita, o meglio l’origine dell’essere quale creatura di Dio, e la morte, quale passaggio verso un oltre, un aldilà, che rappresenta l’oggetto della presente riflessione. Il mezzo, attraverso il quale si delineano gli spunti di meditazione qui proposti, è il linguaggio, nella consapevolezza che la Parola coranica, per quanto “analizzata”, sondata nelle sue appartenenze etimologiche o contestualizzata nello spazio della sua rivelazione, rimane fluida componente di quell’oceano che ben descrive il filosofo e sufi Abū Ḥāmid al-Ġazālī (al-Ġazālī, 1983: 8-9):
«Non sai forse che il Corano è un oceano dal quale si dirama la conoscenza di ogni tempo, proprio come dalle sponde dell’oceano si propagano fiumi e correnti? Non invidi la gioia di coloro che si sono immersi nelle sue traboccanti onde e, arrivando al rosso zolfo, hanno attraversato le sue profondità estraendone purpurei rubini, perle luminose e verdi crisoliti?»
Acqua e pietre preziose: elementi che prevalgono nell’immaginario coranico legato alle descrizioni del Paradiso, come si vedrà più avanti. Se dunque il Corano è un oceano di conoscenza, i suoi versetti, come afferma la tradizione esegetica del sufismo (Sands, 2006), sono una sorgente inesauribile di significati, contenendo un senso “esteriore” (ẓāhir) ed uno “interiore” (bāṭin), una “espressione chiara” (‘ibāra) ed una “allusione” (išāra), comprensibili rispettivamente dalla “gente comune” (‘awāmm) e dall’élite (ḫawāṣṣ). La metafora dell’oceano, che richiama insieme i concetti di “insondabilità” e di “infinitudine”, viene ribadita, in particolar modo nei commentari coranici per mano dei sufi, a sottolineare la natura multivalente del testo sacro dell’Islam, ricollegandosi, in ciò, ad un altro versetto chiave (Corano, 3:7): «Egli è Colui che ti ha rivelato il libro, il quale contiene versetti solidi (āyāt muḥkamāt), che sono la madre del libro, e altri che sono allegorici (āyāt mutašābihāt)». Solidi e allegorici, altrove tradotti con “chiari” ed “ambigui”, dal significato “stabilito” e dal significato “non stabilito”. L’esegesi si è largamente profusa su cosa debba essere inteso con i rispettivi attributi e, soprattutto, su quali versetti vadano considerati dell’una o dell’altra categoria. Ai fini del presente discorso, è inevitabile fare riferimento all’interpretazione di al-Ṭabarī (m. 923), massimo annalista e teologo musulmano, autore di uno dei più grandi commentari coranici, laddove include, tra i versetti allegorici o “ambigui”, proprio quelli relativi all’immaginario escatologico ed alla descrizione degli eventi post mortem (al-Ṭabarī, 1954-7, vol. 3: 174-5), aggiungendo che solo Dio può esserne l’autentico interprete.
Partendo dunque dal presupposto che l’oggetto stesso della presente riflessione sia di per sé variamente interpretabile, ben prestandosi a chi ne voglia fare una lettura antropomorfica quanto a chi ne suggerisca una visione allegorica, ci si propone di riflettere su alcuni termini chiave attraverso i quali si modulano simboli, visioni ed approcci al tema della vita oltre la morte. La lingua araba, dunque, rimane lo strumento privilegiato della nostra analisi: lingua le cui parole si rivelano potenti nella loro carica evocativa e lingua straordinariamente fisica nei suoni, calda, corporea, intensa, qualità tutte che caratterizzano anche, come vedremo, l’immaginario dell’escatologia coranica.
Un percorso tra desiderio e nostalgia
Il “luogo del ritorno”, al-ma‘ād: l’espressione è usata nel Corano (28:85) ad indicare l’Aldilà e, con esso, l’insieme delle speculazioni, proprie alla teologia islamica, attorno al ciclo vita, morte, resurrezione e Giorno del Giudizio. La parola deriva dalla radice del verbo ‘āda, il cui significato è “tornare”. L’Aldilà viene dunque detto ed identificato non come un oltre o un dopo, ma come un ritorno all’origine, a quell’appartenenza creaturale proclamata nei versetti citati in apertura: Innā li’llāhi wa-innā ilayhi rāği‘ūna, «A Dio apparteniamo e a Lui facciamo ritorno». Entriamo così nella dimensione del pensiero arabo-islamico: l’uomo è un essere “ritornante” e la sua vita è uno spazio di passaggio tra un prima ed un poi, che a sua volta riconduce al prima, alla nascita in Dio. Tra il desiderio e la nostalgia: “lontano dalle stelle” della sua appartenenza originaria (come suggerisce l’etimo latino de-sidera) il credente anela nostalgicamente al “ritorno” (dal greco nostos) verso quel luogo senza spazio né tempo a cui fa riferimento il noto “versetto di alastu” (Corano, 7:172). Prima ancora di ogni creazione Dio si rivolse alle sue future creature, chiedendo: A-lastu bi-rabbikum?, «Non sono forse Io il vostro Signore?», ed esse risposero: «Certamente sì, lo attestiamo!». Questo “dialogo” primitivo tra Dio e il futuro uomo rappresenta l’origine e la meta a cui anima e corpo aspirano a ritornare, intraprendendo un percorso “a ritroso”, che è il cammino dell’esistenza.
È dunque in una concezione ciclica della vita che si inseriscono le modalità di pensiero e di comportamento nelle culture arabo-islamiche. Non a caso, una delle parole arabe per significare “casa” o “territorio” è dār, che appartiene alla medesima radice della parola “cerchio, ciclo”. L’uomo abita un luogo circolare, che gli ricorda, già nel linguaggio, il motivo del suo esistere: il ritorno a Dio.
In questa cornice di circolarità, qual è dunque l’approccio nei confronti della morte e, dunque, della vita e dell’oltre-vita? Due sono le immagini che ci sembrano meglio “fotografare” una possibile risposta. La prima è quella di un luogo, nella città del Cairo, che sorprende ed interroga chiunque abbia la fortuna di conoscerlo o di visitarlo: al-Qarāfa, più comunemente noto come la “città dei morti”. Poco lontana dalla Cittadella e dalla zona turistica, sorge una necropoli, che nei suoi dodici chilometri di lunghezza attraversa da nord a sud la capitale dell’Egitto. Unico al mondo nel suo genere, questo sito sepolcrale è in realtà un cimitero inurbato, in cui circa un milione di persone vive nelle tombe costruite dai conquistatori arabi dei primi secoli, accanto a mausolei di sultani e di mistici oggetto di culto. Nella consapevolezza che «il sepolcreto rispecchia l’interezza della cultura del gruppo umano che lo ha concepito, registrando fedelmente non solo l’ideologia della morte […], bensì anche le sue strutture fondanti, sociali, economiche, politiche, religiose» (Tozzi Di Marco, 2008: 21), un luogo destinato ai defunti, ma abitato dai vivi, non può non essere l’immagine paradigmatica del legame tra vita e morte quale percepito, vissuto e praticato nelle culture arabo-musulmane. Nell’interazione dinamica tra sacro e profano, la «singolare coabitazione tra vivi e defunti denota quindi l’assenza di una netta separazione tra i due confini, sia a livello spaziale che figurato» (id.: 24). La morte, dunque, si dimostra essere un’alterità al contempo sentita dentro la vita, l’una permeante l’altra, nella consapevolezza costante di quel «a Dio apparteniamo e a Lui facciamo ritorno».
La seconda immagine è quella di una danza rituale, tanto emblematica quanto spesso impoverita dall’uso folcloristico di cui è divenuta vittima: il samā‘, pratica divenuta nota attraverso la confraternita sufi dei dervisci rotanti, discepoli del mistico persiano Ğalāl al-Dīn al-Rūmī (m. 1273). Il derviscio, darwīš, letteralmente “povero, mendicante”, termine utilizzato per riferirsi ai mistici stessi, indossa un’ampia veste di lana bianca, sudario dell’anima; sulle spalle un mantello nero, simbolo della tomba, o della morte. Al suono del nay, il flauto di canna, il sufi comincia a roteare: danza ciclica, che rappresenta il meccanismo celeste ed insieme il movimento di circolarità dell’esistenza, a cui si accennava poc’anzi. Con un gesto rimuove il mantello, segno dell’anima che, attraverso la morte del corpo, si concede alla verità. A questo punto, le braccia si aprono: il palmo della mano destra rivolto verso l’alto, ad accogliere ciò che proviene dall’altra vita, e quello della mano sinistra verso il basso, ad indicare il contatto con l’esistenza terrena. La morte, dunque, danzata e vissuta non come una separazione, ma un passaggio: un ponte tra cielo e terra.
Il morire è un confine, che insieme separa ed unisce. Di fatto, secondo il testo coranico, il modo in cui l’uomo immagina e poi incontra la morte dipende dalla sua fede o dalla sua empietà. Per chi professa l’Islam, e cioè il muslim, e più in generale per chi possiede l’īmān, o la fede nel Dio dei tre monoteismi, la morte è come il palmo della mano teso verso il cielo, e cioè il tramite per un incontro con Dio. Per coloro che non credono, invece, il morire è una porta che si apre sulla sofferenza ed il tormento. Fine inesorabile, e su questo insiste il testo coranico (23:99-100): «Finché quando a uno di loro giunga la morte dirà: “Signore, fammi tornar sulla terra / a che possa forse fare del bene, in sostituzione di quel che omisi di fare!” “Per sempre no!”: ecco la parola che Iddio allora pronunzierà. E alle loro spalle s’ergerà una Barriera fino al dì quando saranno resuscitati». “Assolutamente No!” è la risposta di Dio: kallā, in arabo, particella che indica la negazione più assoluta. E dal No divino si erge il barzaḫ, la barriera tra il qui e l’altrove.
Il sonno o “la piccola morte”: viaggio dell’anima oltre barriere e tormenti
Il termine barzaḫ, di probabile origine persiana, ricorre altrove nel Corano (cfr. 25: 53 e 55: 20), venendo ad assumere, dal suo significato originario di “spazio che separa”, accezioni differenti, quali quella di “velo”, in ciò simile al più noto termine ḥiğāb, “barriera” che divide il mondo terreno o fisico (dunyā) da quello spirituale, “ostacolo” (ḥāğiz) che impedisce il ritorno dei morti alla vita di questo mondo (Amir-Moezzi, 2007). Alcune interpretazioni sufi ne danno una rappresentazione che richiama esplicitamente l’idea cristiana del “limbo”, quale spazio di sospensione tra l’inferno ed il paradiso, con ciò evidenziando come la simbologia coranica, relativa all’escatologia, sia di fatto un’estensione delle dottrine elaborate dall’ebraismo e dal cristianesimo, a loro volta prolungamento di più antiche dottrine di origine iranica. Il versetto sopra citato si rivela interessante nel suo esplicitare la realtà di una vita (dell’anima?) tra la morte e la resurrezione («fino al dì quando saranno resuscitati»): questa realtà, a cui allude anche un noto hadith trasmesso da al-Tirmiḏī (IX sec. d.C.), supporterebbe un’altra dottrina escatologica, presente in scritti rabbinici e, prima ancora, nel mazdeismo iranico, ossia quella del “tormento della tomba” (‘aḏāb al-qabr). Secondo tale dottrina, di cui il Corano non parla esplicitamente, il defunto sarà sottoposto ad un interrogatorio da parte di due angeli, in merito alla sua fede ed alle sue buone azioni.
I riferimenti al barzaḫ ed al ‘aḏāb al-qabr si rivelano particolarmente interessanti ai fini della presente riflessione. Ciò non solo poiché sono prova evidente del sincretismo di immagini e simboli in cui si inserisce il discorso escatologico coranico, ma perché permettono di aggiungere una sfumatura di pensiero allo sconfinato spazio speculativo intorno al concetto di “anima”, in arabo nafs. Lungi dal focalizzarci sulla natura e sulla valenza della nafs, materia degna di una meditazione a sé stante, l’idea di una “barriera”, come spazio fisico tra, e di un “tormento della tomba”, come spazio temporale in, suggeriscono, come sopra accennato, la possibilità di una vita dopo la morte e prima della resurrezione. Protagonista di questa vita post mortem è l’anima, “respiro” (come suggerisce il suo etimo) di una realtà misteriosa, affine allo “spirito” (rūḥ), tesa verso un equilibrato dualismo con il corpo (Lahbabi, 2017). Il movimento dell’essere, dall’esistenza alla cessazione della stessa, dopo la morte e prima della resurrezione, è di fatto un movimento dell’anima. La stessa anima che vive ogni giorno l’esperienza della morte: «Dio chiama a Sé le anime al momento della loro morte, e anche le anime che non muoiono durante il sonno, e l’anima di cui ha decretato la morte la trattiene, mentre le altre le rinvia fino al termine decretato» (Corano, 39:42), e così in 6: 60 «Egli è Colui che vi richiama a Sé durante la notte […]». Particolarmente suggestiva è l’idea coranica della “piccola morte” che avviene durante il sonno: di notte l’anima è rubata da Dio e restituita al corpo con la luce del giorno ed il risveglio. Nel viaggio notturno l’anima torna (ancora torna…) ad una dimensione oltre la vita: che cosa esperisce nell’attimo in cui abbandona il corpo, tornando a Dio? Verso dove si muove? Forse i sogni sono un assaggio di quell’oltre che Dio concede all’anima di abitare ogni notte? Interrogativi sospesi, che riconfermano, però, il continuo legame tra vita e morte che caratterizza l’esistenza nel discorso coranico.
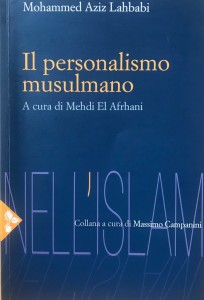 La percezione dell’Aldilà: il silenzio dei sepolcri
La percezione dell’Aldilà: il silenzio dei sepolcri
Poc’anzi si è fatto riferimento al mondo fisico o terreno, in arabo al-dunyā. Il termine, che indica appunto la “vita di questo mondo”, condivide la medesima radice di “essere basso”, “essere vicino” o “essere sotto”. Ad esso si contrappone il termine più diffuso per indicare l’Aldilà o la vita ultraterrena, ossia al-āḫira, che condivide la radice etimologica delle parole “ultimo” e “altro”. Nella lingua e nell’immaginario coranico, vita e morte sono dunque figurativamente rappresentate come un sotto ed un sopra: inoltre, la percezione della morte come oltre, che accomuna diverse culture e religioni, si associa qui alla percezione della morte come alterità. Tale percezione sembra porsi in apparente contrasto con l’immagine emblematica di convivenza tra vita e morte rappresentata dalla necropoli del Cairo sopra descritta. In realtà, è proprio il sentimento della morte come qualcosa di inesorabilmente altro dall’esistenza umana a favorire l’accettazione della stessa come un evento non interrogabile e dunque allontanabile dal circuito della parola. Di fatto, è più facile convivere con un’estraneità mai messa in discussione che con una prossimità pronta a suscitare il dubbio e la domanda.
Nell’approccio musulmano al morire si percepisce un senso di ineluttabilità che, intransigente e necessario, chiude le labbra al grido di dolore, alla domanda tutta umana di un “perché?”. L’individuo davanti alla morte è intimamente silenzioso. Non il silenzio della ragione che riconosce umilmente il proprio limite, bensì il silenzio di un ragionare sottomesso all’inesorabilità di un evento, deciso da Qualcuno, la cui volontà sia ritenuta indiscutibile. Nuovamente la lingua ispira la nostra riflessione: dalla medesima radice derivano infatti le parole arabe istiġrāb, “stupore”, e iġtirāb, “alienazione” o “estraniamento”. La morte, non quale evento ma quale “luogo della domanda”, viene alienata dalla coscienza individuale, poiché il credente teme di autorizzarsi allo stupore, di cedere al disorientamento. Il profeta dell’Islam, modello di comportamento per ogni credente, non esitò a mostrarsi in tutta la sua umana fragilità non solo quando, consapevole della sua morte imminente, si rifugiò tra le braccia della moglie ‘Aisha, spaventato e tremante, ma anche di fronte alla tragica morte del figlio Ibrahīm, come narrano le biografie di Muḥammad (Lecker, 2007: 354):
Improvvisamente, i suoi occhi si bagnarono e i suoi compagni gli chiesero: “O Inviato di Dio, stai piangendo, tu che sei un Profeta?”. “Sono soltanto un uomo con occhi che piangono e un cuore che soffre, ma non diciamo quello che può dispiacere al Signore. Per Dio, o Ibrahīm, noi siamo tristi per te” e poi aggiunse: “Di certo, avrà una balia in paradiso!”.
L’atteggiamento del Profeta è paradigmatico: lacrime, sofferenza e tristezza si svelano quasi timorose di condurre l’essere umano a dire «quello che può dispiacere al Signore», perché il credente non può permettersi il lusso del dubbio rispetto alla giustezza dell’operare divino. Il figlio avrà una balia in Paradiso: questa è una certezza. La parola del dolore, allora, spesso si zittisce davanti alla morte ed ugualmente silenziosi sono i luoghi che della morte portano il segno. Eloquente è la definizione che lo storico Vercellin attribuisce ai cimiteri, quali «non-luogo» o «terre di nessuno» (Vercellin, 2000: 100). Nonostante, fin dai tempi del Profeta, fosse raccomandato visitare i cimiteri per pregare per le anime dei defunti, e benché sussistano precisi rituali legati alle cerimonie funebri, l’ortodossia islamica non ha favorito lo sviluppo di una cultura del sepolcro o di un culto dei morti. I cimiteri egiziani, ad esempio, sono spesso luoghi anonimi ed il luogo di sepoltura è raramente contrassegnato da tombe in rilievo; raramente sono apposte lapidi o iscrizioni tombali, che, in ogni caso, al di fuori del nome, non riportano foto o immagini che ricordino il defunto. Il luogo del ricordo non è lo spazio esteriore, ma l’intimità del cuore, la memoria individuale o condivisa, l’invocazione dell’orante, tutto racchiuso in quella frase che sempre accompagna la menzione di un defunto: Allāh yarḥamu-hu, “Che Dio abbia misericordia di lui”.
“Che Dio abbia misericordia di lui”: parole che ci conducono verso un’ulteriore riflessione. Ascoltiamo l’enfasi di alcuni versetti coranici (80:18-22):
«[…] L’essere umano! Da cosa l’ha creato Iddio? / Da una goccia di sperma l’ha creato! E ha fissato il suo destino: /gli spiana il sentiero della vita / poi è causa del suo trapasso e del sepolcro / ma quando vuole lo restituisce alla vita».
Questo versetto ci conduce direttamente alla dottrina musulmana della predestinazione. Il termine (ağal) della vita di un uomo è decretato fin dalla sua nascita, fisso, stabilito presso l’Onnipotente (6:2), ineludibile verità che è contenuta già in una delle parole arabe per dire “morire”: tawaffā, al passivo tuwuffiya, dalla radice di “compimento”. La morte, dunque, come il compiersi di un percorso scelto e deciso da Dio. Indubbiamente, la rivelazione coranica introduce una prospettiva innovatrice, se confrontata con la concezione pagana preislamica: si fa spazio, infatti, una nuova dimensione di fede in una vita ultraterrena, che amplia lo sguardo oltre il presente. Morte e vita si inseriscono, nuovamente, in un processo dinamico che vede l’esistenza terrena come un passaggio verso l’Aldilà. In questo senso, è evidente il legame che la dottrina escatologica del Corano intrattiene con l’etica, laddove il testo sacro, nel continuo richiamo alla ricompensa ed al castigo, sottolinea «il ruolo che le azioni umane hanno nel processo di salvezza dell’anima, alla fine dei tempi» (Ami-Moezzi, 2007: 254). Sebbene, quindi, Dio sia l’unico fautore del destino umano, la responsabilità dell’uomo in questa vita non è in alcun modo compromessa: la vita è una ‘ibāda, cioè un costante atto di servizio e di devozione a Dio, così come la fine di questa vita è la fine di ogni possibilità, concessa all’uomo, di guadagnarsi la beatitudine del Paradiso.
Inevitabile, dunque, un certo timore. Anche perché, nella descrizione degli avvenimenti escatologici, il Corano trova le sue espressioni più fervide e incisive. Si parla di yawm al-dīn, letteralmente “il giorno della religione”, ossia il Giorno del Giudizio. Lentamente si configura l’immagine di un Dio giudice sovrano, che premia o punisce. Il linguaggio coranico è potente e condiziona sentimenti e comportamenti. Tra mysterium fascinans e mysterium tremendum, la “Bellezza” (Ğamāl) del Dio clemente e misericordioso si alterna, lungo l’intero testo coranico, alla “Maestà” (Ğalāl) del Dio giusto, che riserva agli empi punizione e tormenti. Ecco allora risuonare, inevitabile, quel Allāh yarḥamu-hu, “Che Dio abbia misericordia di lui”: si invoca la misericordia di Dio, perché si teme l’ira di Dio. E qui entriamo, d’obbligo, in uno spazio delicato, poiché il discorso coranico di un Dio della ricompensa e della punizione rimanda al discorso più complesso dell’approccio interpretativo al testo sacro. Se il Dio “Clemente e Misericordioso”, al-Raḥmān al-Raḥīm, è perpetua menzione nelle labbra del musulmano, e non solo durante le cinque preghiere quotidiane, d’altro canto, il Dio “Potente ed Eccelso” (al-Ğabbār al-‘Azīz) si configura come dominante, in particolar modo nei riferimenti coranici all’Aldilà. Dio farà “il conto” (al-ḥisāb) delle azioni umane e peserà i meriti di ognuno su una Bilancia (Corano, 7:8-9, e altrove); su di essa, come riporta una tradizione profetica (Bausani, 1987: 31), «saranno pesati i fogli su cui sono registrate le azioni umane dagli angeli incaricati di scriverle». Di fronte alla menzione di simili “realtà” escatologiche, quali la Bilancia appena citata o (Corano, 36:66; 37:23) al-ṣirāṭ, il “Ponte” sottile teso sopra l’inferno, entrambe di chiare origini iraniche, l’esegesi teologica applica il principio del bilā kayfa (lett. “senza come”), ossia l’accettazione dei dati della rivelazione senza discuterne il “modo”. Con ciò, la corposità eloquente delle rappresentazioni coraniche del paradiso e dell’inferno ben si presta ad un’interpretazione antropomorfica, spesso favorendo l’idea di un Dio-persona che premia e punisce. L’approccio perlopiù letterale dell’esegesi coranica ha favorito ed incoraggiato simili interpretazioni, facendo spesso del testo uno strumento perfetto nelle mani di un’ideologia, grazie anche alla potenza dei versetti escatologici: l’idea di un Dio che sottometta i suoi fedeli attraverso la minaccia dell’inferno e la speranza del paradiso è notoriamente alla base di strumentalizzazioni politiche così come di molti movimenti fondamentalisti di matrice islamica.
Una prospettiva diversa, in chiave allegorica e del tutto spirituale, è tuttavia avanzata dall’approccio mistico, la cui esegesi del testo non solo sublima l’immaginario escatologico, liberandolo da ogni sfumatura antropomorfica, ma supera il dualismo inferno-paradiso, punizione-ricompensa, nella figura di un Dio che è Amore, Amante ed Amato. Emblematica, al riguardo, è la testimonianza della mistica irachena Rābi‘a al-‘Adawiyya (m. 801). Si racconta che un giorno un gruppo di giovani vide Rābi‘a correre per le strade di Baghdad, portando in una mano una torcia accesa e nell’altra una brocca d’acqua. Le chiesero dove stesse andando e lei rispose (Scattolin, 1994: 58-59):
«Sto andando in cielo per gettare il fuoco in Paradiso e per versare l’acqua nell’Inferno, in modo che nessuno dei due rimanga. Allora sarà manifesto il mio scopo: che i fedeli guardino a Dio senza speranza né paura. Poiché, se non ci fosse la speranza del Paradiso o la paura dell’Inferno, forse che non adorerebbero Lui solo, il Reale, e non obbedirebbero ai suoi ordini?».
Parole provocatorie allora come ora, che invitano alla lettura del discorso coranico sull’Aldilà attraverso il linguaggio stra-ordinario della spiritualità, intesa come rivoluzione interiore più che adempimento di una prassi subordinata alla logica di un “fare per”.
 Il Paradiso in uno sguardo: sublimazione dei sensi o sensualità del sublime?
Il Paradiso in uno sguardo: sublimazione dei sensi o sensualità del sublime?
Pur se variamente interpretabili, i temi della ricompensa e della punizione rivestono un ruolo importante nell’escatologia coranica. Le rappresentazioni musulmane del paradiso e dell’inferno hanno trovato ampia eco nelle opere di teologi, esegeti e letterati musulmani che hanno dato vita ad una vasta letteratura di argomento escatologico, a partire dalle due fonti essenziali di riferimento: gli oltre 300 versetti che il Corano dedica all’argomento e le centinaia di tradizioni profetiche (hadith) sul sistema delle ricompense delle azioni umane. A questo si aggiungano, come sopra ricordato, le influenze di fonti cristiane e giudaiche, ma anche iraniane e indù.
Sfogliando le pagine di trattati ad opera di grandi teologi, quali Ğalāl al-Dīn al-Suyūṭī (m. 1445) ed il già menzionato al-Ġazālī, notiamo quanto corposo e concreto sia l’approccio della teologia islamica alle questioni escatologiche: descrizioni del paradiso e dell’inferno a tinte fervide ed esuberanti, insieme ad una dettagliata cosmologia dell’Aldilà, contribuiscono a costruire una «mitologia dinamica» (Bouhdiba, 2005: 83), in cui l’elemento terreno e quello ultraterreno si intersecano in un movimento perpetuo.
È noto che lo stesso Dante, nello scrivere la Divina Commedia, abbia attinto al famoso “Libro della Scala”, un’opera arabo-spagnola frutto della ricca tradizione della letteratura araba edificante e popolare ed ispirata al viaggio notturno di Muḥammad. Nell’incipit della sūra 17 del Corano si allude, infatti, ad un viaggio miracoloso che il profeta avrebbe compiuto dai luoghi santi della Mecca e della spianata del Tempio di Gerusalemme, attraversando il baratro infernale e ascendendo i Sette Cieli, per giungere alla “contemplazione” di Dio. Ed è la mušāhada, ossia la “contemplazione” del volto di Dio, ad ispirare la riflessione sulla prima parola chiave del lessico escatologico del Corano: lo sguardo. Leggiamo nella “Sūra della resurrezione” (75: 22-25): «In quel giorno vi saranno volti radiosi / che guarderanno il loro Signore, / e vi saranno volti corrucciati, / al pensiero della sciagura che subiranno». Ed ancora, nella “Sūra delle schiere” (39:68): «Si darà fiato alla tromba […]. Ci sarà un altro squillo, ed eccoli tutti in piedi a guardare». Lo sguardo, e con esso il volto, è un termine centrale nel lessico arabo. Nell’eloquente riflessione linguistica proposta dall’intellettuale marocchino Mohammed Aziz Lahbabi nel suo Il personalismo musulmano, si sottolinea l’evoluzione semantica che la parola wağh (“viso, faccia”) subisce nel linguaggio coranico, passando dal senso fisico di “volto” al senso figurato di “sguardo”, arrivando infine, per estensione di senso, all’identificazione con l’essere nella sua interezza, ossia con la persona (Lahbabi, 2017: 24). Volti radiosi, volti corrucciati, esseri miranti, in piedi a contemplare: lo sguardo è l’autentico protagonista del paradiso coranico.
Vedere ed essere visti, ammirare, osservare. Il piacere è tutto visivo: luce e luminosità, giacinto e oro, perle e smeraldi; il paradiso antropomorfico coranico abbonda di pietre preziose che, come la perla dell’alchimia araba, hanno la virtù di allietare, confortare, illuminare gli occhi. Le vergini promesse dal paradiso coranico sono chiamate ḥūr e devono il loro nome allo sguardo: ḥuriyya, cioè “nero intenso della pupilla degli occhi”. Parola la cui radice, non senza rinnovata sorpresa, significa anche “ritornare”. Il “luogo del ritorno”, o l’Aldilà, è lo spazio in cui l’essere ritorna o restituisce all’altro il proprio sguardo, con ciò facendolo esistere anche nella dimensione ultraterrena. L’espressione sartriana del «sorgere dell’altro nello e attraverso lo sguardo» (Sartre, 1980: 27) trova qui la sua migliore realizzazione. Il paradiso coranico è un piacere per gli occhi, perché essi sono il simbolo della pienezza dell’essere e del ben-essere. Significativo è il fatto che Satana venga spesso descritto come un malvedente o cieco: privato dello sguardo, e dunque privato dello stare bene, che è la visione di Dio.
Lo sguardo, inoltre, implica un oggetto, materiale o umano, a cui indirizzarsi: un due, almeno, ossia la non-solitudine. Non a caso la dimensione che nel Corano valorizza il paradiso è la comunione, l’unità del gruppo contro la solitudine dell’inferno. L’inferno è assenza, abbandono, sofferenza dell’isolamento: l’uomo è solo, nelle pene e nel tormento. Al contrario, il paradiso implica una moltitudine: si parla infatti di Ahl al-Ğanna e cioè “le genti del paradiso”. L’uno cerca l’altro, l’uno desidera l’altro, l’uno è insieme all’altro. Se l’Islam terreno trova la sua forza nel concetto di gruppo, di appartenenza ad un’unica e coesa comunità di fede (la “Umma” islamica), allo stesso modo l’Islam celeste è la massima celebrazione di questa comunità.
Nessun vuoto, dunque, nel paradiso islamico, dove tutto è riempito di suoni e di presenza, di contatto, di vicinanza. Accanto alla vista, gli organi dei sensi sono coinvolti quali strumenti di godimento del piacere paradisiaco, che il Corano e le tradizioni profetiche dipingono con una concretezza insieme onirica e visionaria. Dall’occhio, in arabo ‘ayn, al gusto, senso fisico o sublimato attraverso il quale il credente si disseta alla “sorgente”, termine che viene espresso con la medesima parola ‘ayn. Dio offre da bere agli eletti: acqua, latte e vino. Latte: simbolo di nutrimento; vino, metafora dell’ebbrezza, spesso usata anche dai mistici sufi per significare lo stordimento dell’estasi nell’incontro con Dio. E l’acqua, oggetto di desiderio dell’anima assetata, finalmente raggiunto, bevuto e gustato, in un appagamento fisico e allo stesso tempo spirituale.
Questa contiguità dello spirito con la materia, del sensuale col sacrale, tipica della visione coranica dell’Aldilà, attraversa di fatto l’Islam nella sua interezza, sia come ortodossia sia come ortoprassia. Infatti, se scarni ed essenziali sono i dogmi di fede del musulmano, molteplici sono, invece, le norme che regolano i gesti ed i riti del credente. Basti pensare alla preghiera canonica, per adempiere alla quale occorre osservare una serie di atti che richiedono una costante attenzione al corpo, quali la purificazione, l’abluzione rituale e, con essa, tutte le condizioni che determinano i concetti di impurità maggiore e minore. Anche rispetto alla morte, quel silenzio di parola a cui si accennava sopra è riempito dall’eloquenza di gesti rivolti al corpo del cadavere: accurate e scrupolose procedure di lavaggio, avvolgimento del corpo nel sudario (kafan), deposizione e sepoltura accompagnano il morto nel rito di passaggio alla vita ultraterrena. “Corpo spirituale e terra celeste”, titolo di un’opera famosa dell’islamista ed iranista francese Henry Corbin: sintesi perfetta di quella comunione di spirito e sensi, sessuale e sacrale che caratterizza l’escatologia coranica e l’Islam in generale. E ancora: quale concezione della sessualità nell’Islam, quale il rapporto con la dimensione carnale dell’essere umano? Nel racconto coranico della genesi, la coppia Adamo ed Eva disobbedisce a Dio, ma viene perdonata: la colpa è ampiamente scontata con l’espulsione dall’Eden. Nella prospettiva coranica è assente dunque l’idea del peccato originale, o della necessaria espiazione. Questo spiega perfettamente la carica erotica che caratterizza le descrizioni della vita ultraterrena: in un’ottica islamica, proprio perché l’opera della carne è esente da ogni idea di peccaminosità, la dimensione sessuale è parte integrante della rinascita oltre la vita, concepita come conciliazione dell’uomo con la sua stessa natura e, dunque, con la materia.
Continua l’inno ai sensi ed alle percezioni, di cui l’Aldilà si fa voce: oltre alla vista ed al gusto, l’odorato e l’udito. Insieme ai profumi inebrianti, c’è una musica propria al paradiso che è melodia delle voci degli eletti, degli angeli, dei profeti e di Dio stesso. La parola umana diviene anch’essa parte integrante del paesaggio paradisiaco, poiché la recitazione dei testi sacri fa parte delle delizie dell’Aldilà, così come la salmodia del Corano accompagna ogni momento significativo della vita terrena.
 Comunità di corpi o comunità di spiriti? Il “mercato delle immagini”
Comunità di corpi o comunità di spiriti? Il “mercato delle immagini”
Giungiamo al tema della resurrezione, ampiamente menzionato nel testo coranico. Qiyāma, in arabo, dalla radice che significa “alzarsi o rialzarsi, elevarsi, stare eretti”. Yawm al-qiyāma (2:79), il “Giorno del Risollevarsi”, altrove denominato as-sā‘a, “l’Ora” (8:186), o il “Risveglio” (ba‘ṯ, 30:56).
«La gente ti chiede dell’Ora. Rispondi: “La sua conoscenza è possesso di Dio solo, e chi ti dice che l’Ora non sia prossima?”» (33:63). La resurrezione dei corpi segue l’annichilimento di tutte le creature (fanā’ al-muṭlaq) e precede il Giorno del Giudizio (1:3). Toni apocalittici descrivono la distruzione finale: il cielo si spaccherà (84:1-2), la terra verrà scossa, i monti stritolati (56: 4-6) e gli uomini saranno come farfalle disperse (101:4). Al suono di una Tromba, «ogni anima gusterà la morte», (29:57) e al secondo “grido” di tromba i corpi saranno resuscitati. La resurrezione viene chiamata ḫalq ğadīd, una “nuova creazione” o una ripetizione della creazione (21:104) e il Corano la descrive con grande precisione, parlando di «ossa richiamate alla vita e rivestite di carne» (2:259). Preponderante nella prospettiva coranica è il tema del grande “raduno” (ḥašr, 19:85), ampiamente sviluppato anche dalle tradizioni profetiche. Interessante, al riguardo, è il seguente versetto, che fa riferimento a coloro che, non avendo creduto nella resurrezione, saranno destinati all’inferno: «Li raduneremo, il giorno della resurrezione, sordi, muti, ciechi, il volto a terra, la loro dimora sarà la Geenna (ğahannam) e ogni volta che si affievolirà la ravviveremo di fuoco ardente» (17:97). «Il volto a terra»: l’inferno coranico non è che il corrispondente terrificante del paradiso sopra descritto. Fortemente significativo è infatti il riferimento al volto: lo sguardo del peccatore sarà rivolto a terra, la vista diverrà cecità, la luce (nūr) della visione appagante diverrà ardente fuoco (nār), una medesima radice linguistica per due parole che definiscono gli opposti del meraviglioso paradisiaco e dell’incubo infernale.
Giungendo al nodo cruciale ed insieme conclusivo della presente riflessione, si deduce che l’escatologia coranica più che un discorso sull’Aldilà offra una rappresentazione dell’Aldilà. Rappresentazione che si presta, come abbiamo accennato sopra, a diversi approcci esegetici: tra questi, oltre al misticismo islamico, anche la Mu‘tazila, scuola razionalista che propugnava un’interpretazione allegorica del testo, ha valorizzato la dimensione spirituale delle rappresentazioni coraniche, sottolineando comunque e sempre il limite interpretativo della ragione umana. Esempio paradigmatico di un tale tipo di interpretazione è quello indirizzato all’espressione coranica “il volto di Dio”, in cui sia i sufi sia i razionalisti dell’Islam hanno saputo leggere la metafora del raggiungimento di una beatitudine spirituale altrimenti indescrivibile. La corrente interpretativa di carattere antropomorfico, invece, si è spesso dilungata in descrizioni di un Dio visibile, assiso sul trono. In mezzo si è posta la teologia “tradizionale” o sunnita, propugnando il già menzionato principio del “senza come”.
Quale possibile approccio dunque? Un eloquente suggerimento giunge dal profeta Muḥammad, quando afferma: «In paradiso vi è un mercato dove si vendono delle immagini» (Bouhdiba, 2005: 99). Il paradiso è il regno dell’immaginario, inteso come spazio che l’individuo stesso è in grado di percepire attraverso il suo desiderio. Così sembra suggerire il Corano (41:31): «Noi siamo i vostri amici nella vita del mondo e nell’aldilà, dove avrete quel che le vostre anime vorranno, dove avrete quel che chiederete». L’Aldilà esiste, dunque, nella misura in cui Dio ha reso l’uomo capace di desiderare e dunque di immaginare: è il luogo del desiderio e, come ogni oggetto del desiderio, include in sé il concepibile, ma anche quel che trascende la facoltà umana di concepire. Un margine di mistero, quindi, interrogabile solo in una logica di fede.
Un ultimo suggerimento interpretativo viene proprio dalla lingua. “Paradiso”: in arabo al-ğanna, letteralmente “giardino”. Giardini e fiumi d’acqua, del resto, popolano non solo l’Aldilà, ma tutta la poesia araba sin dall’epoca preislamica: simboli di benessere e prosperità nell’arido paesaggio del caldo deserto che faceva da sfondo alla vita beduina. Alla stessa radice di ğanna appartiene la parola ğunūn, “follia”: suggestivo è l’accostamento con l’etimo latino di “follia”, inizialmente “mantice, soffietto” e “pallone pieno di vento per giocare”, immagine usata poi metaforicamente per designare un uomo di testa “vuota” di senno, alludendo alla vacuità, alla mobilità ed alla leggerezza del “corpo rotondo” dell’etimo originario. Il paradiso è follia, dunque, ossia spazio che trascende la ragione, mobile e leggero, ma soprattutto “svuotato” di ogni possibile domanda che ne voglia definire i limiti, riempirne le dimensioni. Ma ğanna condivide la radice anche del termine ğanīn, che indica il feto, o l’embrione. Immagine evocativa, non solo della rinascita ultraterrena come “nuova creazione”, citando il Corano, ma come un altrove che, di fatto, è del tutto intimo all’essere umano, in quanto dell’esistenza è la massima realizzazione.
Dialoghi Mediterranei, n.39, settembre 2019
Riferimenti bibliografici
Amir-Moezzi, Mohammad A. (2007), a cura di, Dizionario del Corano, Milano: Mondadori.
Anghelescu, Nadia (1993), Linguaggio e cultura nella civiltà araba, a cura di M. Vallaro, Torino: Silvio Zamorani ed.
Bashir, Shahzad (2011), Sufi Bodies. Religion and Society in Medieval Islam, New York: Columbia University Press.
Bausani, Alessandro (2006) a cura di, Il Corano, Milano: Biblioteca Universale Rizzoli.
— (1987), L’Islam, Milano: Garzanti.
Bouhdiba, Abdelwahab (2005), La sessualità nell’Islam, Milano: Mondadori.
Cardona, Giorgio Raimondo (2009), Antropologia della scrittura, Torino: UTET.
—- (2006), I sei lati del mondo. Linguaggio ed esperienza, Roma-Bari: Laterza.
Corbin, Henry (1986), Corpo spirituale e Terra celeste. Dall’Iran mazdeo all’Iran sciita, Milano: Adelphi.
Ġazālī, Abū Ḥāmid M. al- (2010), Miškātu ’l-Anwār, in Mağmū‘at Rasā’il li’l-Imām al-Ġazālī fī ’l-fiqh wa’l-‘aqīda wa’l-uṣūl wa’l-taṣawwuf, Cairo: Dār al-Imām al-Šāṭibī.
— (1983), Ğawāhir al-Qurān wa-duraruhu, Beirut: Dār al-Afāq al-Ğadīda.
Glassé, Cyril (2008) The Concise Encyclopaedia of Islam. 3rd ed. London: Stacey International.
Ḥisān, Muḥammad (2006), Aḥkām al-ğanā’iz, Cairo: Maktabat Fayāḍ.
Ibn Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram (1988), Lisān al-‘Arab, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
Lahbabi, Mohammed Aziz (2017), Il personalismo musulmano, Milano: Jaca Book.
Lecker, Michael (2007) a cura di, Vite antiche di Maometto, Milano: Mondadori.
Nasr, Seyyed Hossein (1988), Ideals and Realities of Islam, Cairo: The American University in Cairo Press.
Owens, Jonathan (2013), The Oxford Handbook of Arabic Linguistics, New York: Oxford University Press.
Sands, Kristin Zahra (2006), Sūfī Commentaries on the Qur’ān in Classical Islam, London and New York: Routledge.
Sartre, Jean-Paul (1980), L’essere e il nulla: saggio di ontologia fenomenologica, Milano: Il Saggiatore.
Scattolin, Giuseppe (1994), Esperienze mistiche nell’Islam. I primi tre secoli, Bologna: Editrice Missionaria Italiana.
Ṭabarī, Abū Ğa‘far al- (1954-7), Ğāmi‘ al-bayān ‘an ta’wīl āy al-Qur’ān, Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
Tozzi Di Marco, Anna (2008), Il giardino di Allah. Storia della necropoli musulmana del Cairo, Torino: Ananke.
Ventura, Alberto (2010) a cura di, Il Corano, Traduzione di Ida Zilio-Grandi. Commenti di A. Ventura, M. Yahia, I. Zilio-Grandi e M. Ali Amir-Moezzi, Milano: Mondadori.
Vercellin, Giorgio (2000), Tra veli e turbanti. Rituali sociali e vita privata nei mondi dell’Islam, Venezia: Marsilio Ed.
Versteegh, Kees (1997), Landmarks in Linguistic Thought III. The Arabic Linguistic Tradition, London and New York: Routledge.
Winkler, H. Alexander (2009), Ghost Riders of Upper Egypt. A Study of Spirit Possession, tr. by N. S. Hopkins, Cairo: The American University in Cairo.
Yusuf Ali, Abdullah (1990), The Holy Qur’ān. Text, translation and commentary, Cairo: Al-Zahrā’ li’l-I‘lām al-‘Arabī.
______________________________________________________________
Elena Biagi, laureata in Lingue e Letterature Orientali presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, ha vissuto dieci anni in Egitto, dove ha conseguito il Master in Arabic Studies presso l’American University in Cairo. É docente di Lingua Araba per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e per il Corso di Laurea Magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia presso l’Università degli Studi di Pavia. Relatrice in conferenze e seminari in ambiti quali la Biblioteca Ambrosiana di Milano, the (ATSA) Turkish-Senegalese Association for Atlantic Cultural Dialogue e The Arts and Humanities Research Council (United Kingdom), conduce attività di ricerca sulla tradizione spirituale del sufismo. Tra le sue pubblicazioni: “Plunging into the wave’s ebb: Sufi words, biographies of humanity”, in Altre Modernità, Rivista di studi letterari e culturali, Università degli Studi di Milano, n. 16, novembre 2016; A Collection of Sufi Rules of Conduct. Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Sulamī, Cambridge: The Islamic Texts Society, 2010.
______________________________________________________________












