
Elena e Paride. Particolare di un cratere a campana apulo a figure rosse (IV secolo a.C.), Museo del Louvres, Parigi
di Alessandro Prato
La retorica e l’antropologia sono certamente due discipline molto eterogenee, sia per campo d’indagine, sia per le metodologie adottate, tuttavia presentano alcuni elementi comuni di grande interesse e rilevanza, al punto che è possibile disegnare un ambito di riflessione e di applicazione che appartiene ad entrambe. Il primo elemento in comune riguarda le forme e le modalità del linguaggio verbale: per la retorica in quanto arte del discorso, fin dalla sua fondazione e, successivamente, a partire dalla sistematizzazione aristotelica, il punto centrale di riferimento è stato il discorso orale, anche se in quanto scienza o arte, essa era e doveva essere un prodotto della scrittura. Al centro del suo interesse si colloca il discorso pubblico o oratoria che rimase per secoli, anche in culture chirografiche e tipografiche, il paradigma di ogni tipo di discorso, compreso quello scritto.
Del resto anche i celebri discorsi dei retori latini come Cicerone sono stati pensati per essere pronunciati oralmente, nella condivisione del medesimo spazio e del medesimo tempo con l’uditorio, solo molto tempo dopo sono stati trascritti. All’epoca infatti non era pratica comune per gli oratori avvalersi o fare riferimento a un testo scritto mentre parlavano davanti a un pubblico, dovendo dimostrare la propria abilità di tenere a mente il discorso per poterlo utilizzare senza problemi. La Rhetorica ad Herennium, la prima opera retorica scritta in latino tra l’86 e il 92 a.C., considera la memoria – la capacità di tenere presenti nel pensiero gli argomenti, le parole e la loro disposizione – una delle abilità che l’oratore deve avere (Mortara Garavelli 2011: 36). Avere bisogno di un testo scritto era insomma considerato segno di incompetenza (Ong 1970: 56-58). Lo stesso fondatore della linguistica moderna, Ferdinand de Saussure, ha richiamato l’attenzione sulla primarietà del discorso orale che è alla base di tutta la comunicazione verbale (Saussure 1967: 35).
Analogamente per l’antropologia l’espressione orale ha rappresentato un campo d’indagine privilegiato perché essa può esistere, anzi è prevalentemente esistita, a prescindere dalla scrittura, mentre la scrittura non può fare a meno dell’oralità: l’elemento verbale svolge per la scrittura una funzione analoga a quella che hanno le fondamenta per un edificio. L’habitat naturale di una lingua è l’elemento orale, di conseguenza la scrittura può essere considerata un sistema di modellizzazione secondario che dipende dal sistema primario della lingua parlata (Ong 1982: 26). Molte ricerche sul campo svolte dagli antropologi hanno riguardato le società orali e molte riflessioni sono state condotte, a partire dal fondamentale saggio di Goody (1981), sul confronto tra le dinamiche della verbalizzazione orale primaria e la verbalizzazione scritta, oltre che sui cambiamenti delle strutture mentali e sociali verificatesi a seguito dell’introduzione della scrittura. Ad esempio, nelle società a tradizione orale che non hanno modo di registrare o mettere per iscritto quanto è accaduto, gli uomini possono pensare al passato solo in modo molto semplice: alcuni per rifarsi al passato cercano di imparare a memoria i nomi dei padri, dei nonni, dei bisnonni e così via, altri per fare il computo degli inverni passati incidono dei segni su un tronco d’albero o su un bastone, così da poter contare all’indietro (Mead 1962: 10).
 È vero che gli esseri umani comunicano utilizzando tutta la loro sfera sensoriale e che la comunicazione non verbale è molto ricca e variegata, ma è altrettanto vero che il suono articolato è fondamentale per la lingua (Ong 1970: 1-9). «L’oralità fondamentale del linguaggio è un carattere stabile» (Ong 1982: 25): non sappiamo quando gli uomini hanno cominciato a parlare, sicuramente ciò avvenne decine di migliaia di anni fa e per moltissimo tempo gli uomini usarono solo la forma orale, le parole venivano solo dette e udite. Solo circa 4000 anni prima di Cristo gli uomini sentirono il bisogno di fissare le parole e nacquero così le prime scritture su pietra, legno, tavolette di argilla soprattutto per ragioni religiose ed economiche (De Mauro 1980: 9-13). Comunque delle migliaia di lingue parlate nel corso della storia umana solo una piccola minoranza ha avuto una scrittura e una letteratura, ancora oggi centinaia di lingue in uso non sono mai state scritte.
È vero che gli esseri umani comunicano utilizzando tutta la loro sfera sensoriale e che la comunicazione non verbale è molto ricca e variegata, ma è altrettanto vero che il suono articolato è fondamentale per la lingua (Ong 1970: 1-9). «L’oralità fondamentale del linguaggio è un carattere stabile» (Ong 1982: 25): non sappiamo quando gli uomini hanno cominciato a parlare, sicuramente ciò avvenne decine di migliaia di anni fa e per moltissimo tempo gli uomini usarono solo la forma orale, le parole venivano solo dette e udite. Solo circa 4000 anni prima di Cristo gli uomini sentirono il bisogno di fissare le parole e nacquero così le prime scritture su pietra, legno, tavolette di argilla soprattutto per ragioni religiose ed economiche (De Mauro 1980: 9-13). Comunque delle migliaia di lingue parlate nel corso della storia umana solo una piccola minoranza ha avuto una scrittura e una letteratura, ancora oggi centinaia di lingue in uso non sono mai state scritte.
L’analisi delle proprietà peculiari dell’oralità costituisce un ambito di ricerca particolarmente interessante e fecondo per chi intende studiare le forme e le modalità delle culture umane. Ong (1982: 65 ss) ha individuato alcune caratteristiche assunte dal pensiero e conseguentemente dall’espressione in una cultura orale. La prima consiste nel privilegiare un andamento paratattico corrispondente all’uso dello stile additivo basato sul polisindeto, in cui l’elemento ridondante e iterativo è utile per la memorizzazione dei temi da esporre nel discorso. La scrittura invece predilige una modalità ipotattica che fa uso della subordinazione analitica e ragionata e dove alla ripetizione si preferisce la variatio. L’effetto di ridondanza appartiene alle figure retoriche dell’epanalessi e della paronomasia che da sempre infatti sono state ampiamente utilizzate nei proverbi popolari, nelle forme liturgiche e rituali. L’epanalessi raddoppia l’espressione ripetendola, all’inizio, al centro o alla fine di un segmento testuale. Fra le parole ripetute possiamo ritrovare vocativi, interiezioni, congiunzioni (Mortara Garavelli 2010: 129-31). Il caso della paronomasia è diverso perché si tratta di un gioco linguistico che presenta una combinazione di parole con una minima variazione di suono (quindi non si tratta di una ripetizione) cui corrisponde però una notevole differenza di significato. Ed è proprio in virtù di questo scarto tra espressione e contenuto che la figura attira l’attenzione del destinatario. È consuetudine distinguere la paronomasia apofonica da quella isofonica: nel primo caso il gioco si basa sull’apofonia, cioè sull’alternanza vocalica nella radice delle parole, come nel proverbio “chi non risica non rosica”; nel secondo caso è presente invece l’isofonia, cioè l’uguaglianza dei suoni su cui cade l’accento di parola, ad esempio nel detto “traduttore\traditore” (ivi: 74-76).
 La seconda proprietà riguarda il fatto che in una cultura orale si preferisce utilizzare forme espressive di tipo aggregativo piuttosto che analitico, in questo modo vengono inserite nel discorso gruppi di parole come gli epiteti o le perifrasi. La perifrasi può essere considerata come «un sinonimo a più termini» (ivi: 29), il principio che la governa è l’equivalenza di senso; differisce dalla definizione perché è usata al posto di un’espressione e non in sua presenza. Una volta che queste espressioni si sono cristallizzate e sono entrate nell’uso comune si ritiene utile lasciarle inalterate senza scomporle mai. Come dice Lévi-Strauss (1962: 267), il modo di concepire il ragionamento nelle culture orali è sempre totalizzante e conservatore perché la conoscenza è preziosa e la mente è l’unico deposito in cui possa essere conservata; per questo i vecchi saggi che si specializzano nel conservarla e che raccontano le storie dei tempi passati sono tenuti in così grande considerazione.
La seconda proprietà riguarda il fatto che in una cultura orale si preferisce utilizzare forme espressive di tipo aggregativo piuttosto che analitico, in questo modo vengono inserite nel discorso gruppi di parole come gli epiteti o le perifrasi. La perifrasi può essere considerata come «un sinonimo a più termini» (ivi: 29), il principio che la governa è l’equivalenza di senso; differisce dalla definizione perché è usata al posto di un’espressione e non in sua presenza. Una volta che queste espressioni si sono cristallizzate e sono entrate nell’uso comune si ritiene utile lasciarle inalterate senza scomporle mai. Come dice Lévi-Strauss (1962: 267), il modo di concepire il ragionamento nelle culture orali è sempre totalizzante e conservatore perché la conoscenza è preziosa e la mente è l’unico deposito in cui possa essere conservata; per questo i vecchi saggi che si specializzano nel conservarla e che raccontano le storie dei tempi passati sono tenuti in così grande considerazione.
La terza proprietà si riferisce al fatto che nell’oralità si preferisce nella maggior parte dei casi utilizzare l’elemento esperienziale e situazionale, lasciando in secondo piano l’astrazione; la conoscenza in questo modo diventa parte integrante dell’esperienza concreta. Lo stesso significato delle parole, non essendo depositato nei dizionari, viene controllato da ciò che Goody e Watt chiamano “ratifica semantica diretta”, ossia facendo sempre riferimento alle situazioni e ai contesti della vita reale in cui quella parola viene utilizzata. In questo caso la funzione referenziale del discorso è centrale. Le culture orali tendono invece a usare i concetti in ambiti di riferimento situazionali ed operativi, ad esempio secondo la ricerca condotta da Lurija (1978) gli illetterati intervistati tendevano a identificare le figure geometriche non con i nomi astratti (cerchio, quadrato, triangolo ecc..), bensì con i nomi degli oggetti della vita quotidiana: così un cerchio era chiamato a seconda delle persone piatto, orologio, luna e un quadrato era di volta in volta uno specchio, una porta, un asse. Su questo terreno si misura un’ulteriore profonda differenza rispetto alle culture scritte dove sia lo sviluppo del ragionamento, sia i processi semantici delle lingue storico-naturali, sono per loro stessa costituzione dipendenti proprio dall’astrazione. Ad esempio, tutte le parole che noi usiamo sono generali, anche un termine concreto come “albero” non si riferisce semplicemente a questo albero che esiste nella realtà e che io sto ora osservando, ma a un concetto astratto e generale che si può applicare a ogni albero che esiste, una classe generale basata sui tratti in comune in cui tutti gli alberi possono rientrare proprio perché si fa astrazione dagli elementi particolari che gli enti hanno in natura (Prato 2012: 66-70): «la classificazione che sta alla base dei nomi generali non rispecchia una classificazione naturale delle cose» (Formigari 1981: 66).
La quarta e ultima proprietà coinvolge sia l’elemento agonistico, sia il modo enfatico di rappresentare gli eventi. Nel primo caso ci troviamo di fronte alla dimensione conflittuale che nelle culture orali è sempre in primo piano in quanto i proverbi e gli indovinelli vengono usati non solo per stimolare la memoria, ma anche per sfidare gli ascoltatori a rispondere con uno più appropriato o con uno che lo contraddica: la battaglia verbale è molto frequente e celebrata. L’elemento agonistico a sua volta costituisce il fattore primario di ogni discorso retorico in cui l’oratore non è mai da solo, ma si presenta sempre in competizione con un avversario che sostiene un punto di vista opposto al suo. Per questa ragione la figura dell’antitesi che «è il corrispettivo linguistico della tecnica argomentativa del contraddittorio» (Prato 2012: 20) è molto utilizzata. Nel secondo caso possiamo vedere quanto il discorso orale si basi, per raggiungere e portare dalla propria parte l’interlocutore, sull’identificazione con l’oggetto del discorso e non sull’oggettività e il distacco personale che sono invece tipici della scrittura. Per questa ragione si fa uso spesso delle figure della prosopopea e dell’iperbole. Nella prima, congeniale alla favolistica e all’aneddotica, si dà vita all’inanimato umanizzando i concetti astratti, i sentimenti o gli elementi della natura; nella seconda si tende ad amplificare ed esagerare la rappresentazione di ciò che si vuole comunicare. Per raggiungere il suo scopo l’iperbole deve mantenere un aggancio con la realtà nel momento in cui la oltrepassa: possiamo dire “annegare in un bicchiere d’acqua” perché sappiamo che secondo la nostra esperienza si può annegare nell’acqua. In ogni caso è il contesto discorsivo a determinare l’interpretazione della figura (Mortara Garavelli 2010: 31).
 Un ulteriore elemento di distinzione tra oralità e scrittura risiede nel fatto che per un alfabetizzato le parole possono essere “viste”, sono simili a cose e possono infatti essere “ricercate”, ad esempio nel vocabolario. Se a noi alfabetizzati chiedessero di pensare alla parola “nonostante” saremmo probabilmente portati a pensare al modo in cui questa parola viene scritta e ci risulterebbe difficile probabilmente pensare soltanto al suo suono. Il potere della scrittura è tale che un alfabetizzato non può recuperare totalmente il senso di ciò che quella parola significa per chi è immerso in una cultura a oralità primaria (Ong 1982: 31). La stessa espressione “Letteratura orale” andrebbe pertanto evitata in quanto suggerisce la concezione del tutto riduttiva della tradizione orale come variante della scrittura.
Un ulteriore elemento di distinzione tra oralità e scrittura risiede nel fatto che per un alfabetizzato le parole possono essere “viste”, sono simili a cose e possono infatti essere “ricercate”, ad esempio nel vocabolario. Se a noi alfabetizzati chiedessero di pensare alla parola “nonostante” saremmo probabilmente portati a pensare al modo in cui questa parola viene scritta e ci risulterebbe difficile probabilmente pensare soltanto al suo suono. Il potere della scrittura è tale che un alfabetizzato non può recuperare totalmente il senso di ciò che quella parola significa per chi è immerso in una cultura a oralità primaria (Ong 1982: 31). La stessa espressione “Letteratura orale” andrebbe pertanto evitata in quanto suggerisce la concezione del tutto riduttiva della tradizione orale come variante della scrittura.
Le parole senza la scrittura non hanno una presenza visiva, sono soltanto suoni che si possono richiamare o ricordare, ma non cercare, non sono collocati in uno spazio, sono eventi. Il termine ebraico “dabar” significa allo stesso tempo parola ed evento (ivi: 60). Malinowski osservava che per i popoli primitivi il linguaggio è un modo dell’azione più che il contrassegno del pensiero. Non sorprende quindi il fatto che quasi tutti i popoli a tradizione orale attribuiscono grande potere alla parola: non si può emettere suono senza esercitare in qualche modo una forma di potere, ogni suono è dinamico. Questo potere spesso è stato considerato magico e le parole sono associate alla magia proprio in quanto azioni, eventi. I popoli orali pensano ai nomi come entità che hanno potere sulle cose e ciò dimostra che una riflessione sul logos era già presente ancora prima che si affermasse la filosofia greca.
Chiamare per nome significa creare, con la parola si crea e si distrugge, la maledizione espressa in alcune circostanze si rivela ineluttabile, con la parola si fissa il destino, cioè la cosa detta: il termine fatum deriva dal latino fari che significa appunto “dire”, “parlare” (Seppilli 1962: 17). Anche nella teologia dei Sumeri è detto che il Dio dell’acqua crea per mezzo della parola e la potenza della parola è cantata in numerosi inni chiamati Enem, cioè “parola”. Del resto il mito della parola creatrice si ritrova nella tradizione cristiana, basti pensare a quel passo della Genesi (I, 50) in cui si dice che «Dio chiama luce la luce e notte la tenebra e così fu notte e poi mattino e fu il primo giorno». La potenza della parola si risolve inoltre nel suo possibile effetto terapeutico sottolineato da Lévi-Strauss (1966: 168) in riferimento al caso in cui per guarire un malato non si tocca il suo corpo, né viene somministrato alcun farmaco, ma si ricorre semplicemente alla suggestione operata dalla parola che narrativizza un evento (la cura) in realtà mai avvenuto.
Allo stesso tempo però viene sottolineata la fragilità delle parole che dipende dalla natura del suono e dal suo rapporto peculiare con il tempo: la parola detta esiste mentre sta morendo, non si può fermare, non si può ripercorrere, è deperibile, impalpabile, fragile, evanescente. Questo ha delle ripercussioni notevoli sulle modalità del pensiero che in questo caso deve strutturarsi, come abbiamo visto, in ripetizioni, formule, frasi fatte, proverbi; poiché non esistono testi e non si possono prendere appunti è necessario pensare in moduli mnemonici creati apposta per un pronto recupero orale, il pensiero così tende a essere ritmico, sfruttando allitterazioni e assonanze, poiché il ritmo aiuta la memoria. La legge stessa è custodita in formule che rappresentano non una mera decorazione esteriore ma l’essenza stessa della giurisprudenza.
A questo punto incontriamo un altro fattore, oltre all’interesse per l’oralità e per i suoi rapporti con la scrittura, che avvicina la retorica all’antropologia e che permette di costruire un campo di riflessione comune alle due discipline: l’interesse per lo studio dei fattori e delle condizioni che rendono la parola efficace e per il fatto che essa possa esercitare un potere persuasivo sulle persone a cui è rivolta. Questa funzione persuasiva – il fenomeno per cui, senza alcuna forma di coercizione, le persone sono indotte a sostenere un’opinione, ad assumere un comportamento che prima non avevano oppure, in altri casi, a modificare l’opinione in cui credevano o il comportamento in cui si riconoscevano – è naturalmente sempre stata al centro dell’interesse degli studiosi di retorica (da Aristotele a Perelman e anche oltre), ma è anche molto presente ad uno dei più significativi esponenti della ricerca antropologica come Lévi-Strauss.
Già Gorgia da Lentini (485-375 a.C. circa) si era occupato a più riprese del problema riguardante il potere delle parole. Egli era nato in Sicilia ed era stato allievo di Empedocle, si era poi trasferito ad Atene nel 427 a.C. Con Gorgia la retorica dall’ambito strettamente giudiziario ha iniziato a ampliare il suo oggetto di indagine per investire anche l’ambito dei discorsi letterari come l’elogio e il panegirico, ed è proprio verso questa tipologia discorsiva che Gorgia ha dimostrato un particolare talento. Tra i sofisti Gorgia è il solo autore del quale abbiamo conservato qualche opera, la più conosciuta e discussa è senz’altro l’Encomio di Elena. Tutta l’opera si risolve in una dimostrazione della forza della parola che è capace, mediante un opportuno utilizzo anche non corretto, di ribaltare il convincimento popolare a proprio piacimento sfruttando la forza dell’eloquio che agisce sull’intelletto e sulle passioni di coloro verso i quali essa si rivolge:
«la parola è un potente signore, che, con un corpo piccolissimo e del tutto invisibile compie opere assolutamente divine: ha, infatti, il potere di fare cessare il timore e di sopprimere il dolore e di suscitare letizia e di accrescere la compassione» (Diels e Kranz 2006: 1633).
Il caso di Elena e di Paride è insomma un pretesto per una riflessione più generale sulla potenza del linguaggio (Reboul 1996: 32-33). Si leggano le parole con cui Gorgia rende conto della forza che la persuasione può esercitare e che sono ancora per noi molto efficaci:
«Sarebbe infatti possibile vedere quanto potere ha la persuasione, che non ha la caratteristica della necessità, ma ne ha la stessa potenza. Infatti, un discorso che sia riuscito a persuadere un’anima, costringe l’anima che ha persuaso, sia a fidarsi di quanto viene detto, sia ad essere d’accordo nei fatti (…) Poiché la persuasione, aggiungendosi alla parola, modella anche l’anima come vuole» (Diels e Kranz 2006: 1635).
L’efficacia della parola, quella che Jakobson definisce la sua funzione conativa (Manetti e Fabris 2006: 32-33), ossia la modalità con la quale l’emittente tende ad esercitare un’azione sul destinatario – che può essere di tipo pragmatico se si configura come un “far fare”, oppure di tipo cognitivo se si risolve in un “far credere” – dipende dal kairós, ovvero la capacità dell’oratore di adattarsi alle diverse circostanze e al tempo, di tenere conto del contesto in cui si svolge il discorso per sapere ciò che è opportuno fare in quel momento. Le circostanze comprendono le disposizioni d’animo sia dell’oratore che del suo uditorio, il momento, il luogo, l’occasione del discorso. È necessario conoscere le diverse regole del discorso per non urtare contro le ragioni dell’opportunità, variare convenientemente l’eloquio, scegliere ciascuna forma in consonanza con ciascun caso.
Il kairós è un elemento fondamentale della retorica che si ritrova anche in Aristotele, e che a sua volta è strettamente legato con quello di politropia, ossia il fatto di padroneggiare diverse modalità di espressione intorno al medesimo argomento. Il modello di questo potere del linguaggio era Ulisse che lo aveva proprio tra i suoi diversi attributi. Questa capacità dai sofisti era vista come un segno distintivo della sapienza, mentre era considerato indice di ignoranza adoperare un’unica forma di discorso con coloro che hanno mentalità e aspettative differenti. Relativamente al concetto di kairós la retorica era accomunata alla medicina, poiché anche la cura degli infermi deve tenere conto delle circostanze, in ragione delle varie predisposizioni e delle diverse condizioni fisiche e psicologiche dei malati.
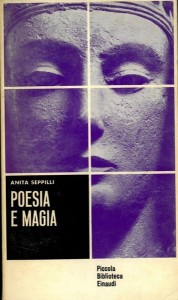 Nell’Encomio di Elena Gorgia si pone l’obiettivo di scagionare Elena, moglie di Menelao, dalla terribile colpa di aver provocato, abbandonando il marito per seguire Paride a Troia, la sanguinosa guerra di Troia. Al fine di spiegare il suo comportamento Gorgia presenta una serie di ipotesi secondo le quali Elena non era realmente colpevole del conflitto tra i greci e i troiani; tutte le ipotesi proposte da Gorgia, infatti, riguardavano solo delle cause estranee alla sua volontà, nessuna di esse prende in considerazione la possibilità che Elena fosse stata indotta a tradire e a fuggire per sua scelta. Elena era innocente, poiché il movente del suo gesto è stato esterno alla sua responsabilità riguardando un decreto degli dèi (Elena non si era potuta opporre al fato), un’azione di forza (Elena era stata rapita), una persuasione irresistibile (era stata convinta dalle parole di Paride), o ancora un coinvolgimento affettivo (era stata vinta dalla passione amorosa). Si noti il fatto che tutte e quattro queste ipotesi soddisfano la condizione dell’innocenza di Elena e costituiscono pertanto una petizione di principio, cioè una strategia argomentativa che dà per acquisita la tesi che bisognerebbe dimostrare, limitandosi ad enunciarla e che è il motore della costruzione del pregiudizio. Tutte le cause possibili che Gorgia attribuisce al comportamento di Elena sono quelle che in effetti la discolpano; non viene presa nemmeno in considerazione l’ipotesi che Elena potesse essere fuggita di sua volontà perché questa non rientra nella tesi considerata valida senza una dimostrazione.
Nell’Encomio di Elena Gorgia si pone l’obiettivo di scagionare Elena, moglie di Menelao, dalla terribile colpa di aver provocato, abbandonando il marito per seguire Paride a Troia, la sanguinosa guerra di Troia. Al fine di spiegare il suo comportamento Gorgia presenta una serie di ipotesi secondo le quali Elena non era realmente colpevole del conflitto tra i greci e i troiani; tutte le ipotesi proposte da Gorgia, infatti, riguardavano solo delle cause estranee alla sua volontà, nessuna di esse prende in considerazione la possibilità che Elena fosse stata indotta a tradire e a fuggire per sua scelta. Elena era innocente, poiché il movente del suo gesto è stato esterno alla sua responsabilità riguardando un decreto degli dèi (Elena non si era potuta opporre al fato), un’azione di forza (Elena era stata rapita), una persuasione irresistibile (era stata convinta dalle parole di Paride), o ancora un coinvolgimento affettivo (era stata vinta dalla passione amorosa). Si noti il fatto che tutte e quattro queste ipotesi soddisfano la condizione dell’innocenza di Elena e costituiscono pertanto una petizione di principio, cioè una strategia argomentativa che dà per acquisita la tesi che bisognerebbe dimostrare, limitandosi ad enunciarla e che è il motore della costruzione del pregiudizio. Tutte le cause possibili che Gorgia attribuisce al comportamento di Elena sono quelle che in effetti la discolpano; non viene presa nemmeno in considerazione l’ipotesi che Elena potesse essere fuggita di sua volontà perché questa non rientra nella tesi considerata valida senza una dimostrazione.
Se un’argomentazione in linea generale è un ragionamento nel corso del quale si intendono fornire ragioni a sostegno di una data affermazione, prendendo in considerazione le possibili contro argomentazioni che devono essere confutate, la petizione di principio è un’argomentazione scorretta perché si limita appunto a trattare solo le spiegazioni che confermano le ipotesi di chi confeziona il discorso, ignorando di proposito tutte le altre. Nonostante la sua manifesta infondatezza, questo tipo di argomentazione può risultare comunque persuasivo se il destinatario non si accorge dell’errore logico che ha di fronte. Il tema del potere persuasivo delle parole è dunque importante perché mette in gioco la nostra capacità di argomentare in modo critico senza la quale viene meno sia la possibilità di risolvere problemi anche semplici ma non intuitivi, sia la nostra indipendenza di giudizio.
Dialoghi Mediterranei, n. 41, gennaio 2020
Riferimenti bibliografici
De Mauro T. (1980), Guida all’uso delle parole, Roma, Editori Riuniti.
Dielz H. e Kranz W. (2006), I presocratici, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani.
Formigari L. (1981), La scimmia e le stelle, Roma, Editori Riuniti.
Goody J. (1981), L’addomesticamento del pensiero selvaggio, Milano, Angeli.
Lévi-Strauss C. (1966), Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore.
Lurija A.R. (1978), Storia sociale dei processi cognitivi, Firenze, Giunti.
Manetti G. e Fabris A. (2006), Comunicazione, Brescia, La Scuola.
Mead M. (1962), Popoli e paesi, Milano, Feltrinelli.
Mortara Garavelli B. (2010), Il parlar figurato. Manualetto di figure retoriche, Roma-Bari, Laterza.
Mortara Garavelli B. (2011), Prima lezione di retorica, Roma-Bari, Laterza.
Ong W.J. (1970), La presenza della parola, Bologna, Il Mulino.
Ong W.J. (1971), Rhetoric, Romance and Technology, Ithaca e London, Cornell University Press.
Ong W.J. (1982), Oralità e scrittura, Bologna, Il Mulino.
Prato A. (2012), La retorica. Forme e finalità del discorso persuasivo, Pisa, Edizioni ETS.
Reboul O. (1996), Introduzione alla retorica, Bologna, Il Mulino.
Seppilli A. (1962), Poesia e magia, Torino, Einaudi.
______________________________________________________________
Alessandro Prato è ricercatore del Dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive (DISPOC) dell’Università di Siena dove insegna Retorica e linguaggi persuasivi e Teoria e tecniche della scrittura. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Comunicazione e potere (a cura di), Aracne, 2018; La retorica. Forme e finalità del discorso persuasivo, Edizioni ETS, 2012; Linguaggio e filosofia nell’età dei lumi. Da Locke agli idéologues, I libri di Emil, 2012, oltre a diversi articoli su riviste nazionali e internazionali.
______________________________________________________________








