di Franco Ferrarotti [*]
Penso di non poter presumere di introdurre in modo adeguato il tema in discussione, secondo una impostazione storicamente e logicamente esauriente. Mi limiterò, doverosamente, consapevole come sono dei miei mezzi intellettuali, a esprimere e a sottoporre alla vostra attenzione alcuni personali principi di preferenza, che potranno forse in avvenire essere falsificati oppure confermati e consolidati da ricerche ulteriori.
Non dispongo di conoscenze linguistiche sufficienti, per esempio, dell’arabo, dell’ebraico e dell’aramaico. Ma mi conforta l’idea che gli antichi Romani, mentre accettavano le credenze religiose e le usanze dei popoli sottomessi, su tutti imponevano l’uso della lingua latina. Forse, secoli prima di Michel Foucault, avevano compreso che il discorso è mezzo di comunicazione, ma anche, se non primieramente, strumento di dominio.
Un’osservazione preliminare si impone. È un’osservazione triste e amara. L’insipienza criminale, l’ignoranza tracotante e l’incompetenza esibita come trofeo di eccellenza, da parte dell’attuale classe dirigente, per valerci della formula, non troppo perspicua, di Gaetano Mosca, ossia dei gruppi governanti e dei gruppi influenzanti, hanno tradito, non solo in Italia, la vocazione naturale del «mare fra le terre», un mare chiuso, dolce, femminile, la mer, aperto solo verso l’Atlantico da una sorta di ufficio doganale, lo stretto di Gibilterra, non per caso indicato dai nostri progenitori classici, greci e latini, come le invalicabili «colonne d’Ercole», e verso il Mar Rosso e l’oceano Indiano dal canale di Suez, un manufatto anglo-francese.
Il mare Mediterraneo è di fatto un grande lago chiuso. È necessariamente il mare dell’interscambio fra le varie culture e religioni, un luogo in cui più viva, polisemica e plurilinguistica, è cresciuta e si è sviluppata la presenza umana da tempo immemorabile. Si pensi solo alla Sicilia dove si sono storicamente incontrate e affrontate e reciprocamente «fertilizzate», per così dire, credenze religiose e culture di ascendenza araba, nordafricana, normanna e naturalmente greco-romana.
L’attuale classe dirigente, sia italiana che europea, per non citare Donald Trump e il suo muro contro i chicanos, ha trasformato questo naturale crogiolo di esperienze e di valori in un cimitero a cielo aperto. Non ha compreso nulla, chiusa nel protetto, ovattato tepore dei suoi uffici, dell’anelito di libertà, del premere delle speranze che anima e muove le masse di migranti alla disperata ricerca di condizioni di vita migliori, più sicure, per sé e i propri figli.
Rispondere positivamente a questi aneliti e a queste speranze è stata tradizionalmente la vocazione storica del Mediterraneo. Per secoli ha goduto della forza delle differenze e della convivenza delle culture, sempre positiva anche nelle fasi di più acuto contrasto.
 L’innovazione tecnica, la forma capitalistica di produzione, con la razionalizzazione dei flussi produttivi e distributivi su vasta scala, che comporta, sono nate e si sono sviluppate con la «rivoluzione industriale» nell’Inghilterra del primo Ottocento, e poi attecchite e cresciute in Francia e Germania e in tutta Europa. C’è però una «legge» sociologica, per così dire, a proposito di certi primati tecnici. È la «penalty of taking the lead», come sosteneva Thorstein Veblen. L’Europa è oggi vittima del suo successo planetario. Non solo gli Stati Uniti, questa «Übertragung», o esagerazione, dell’Europa, a giudizio di Thomas Mann, ma la Russia di Vladimir Putin, la Cina, pur governata da una dittatura comunista, domani e, per certe regioni come Bangalore, già oggi, l’India sotto il pugno nazionalista di Modi.
L’innovazione tecnica, la forma capitalistica di produzione, con la razionalizzazione dei flussi produttivi e distributivi su vasta scala, che comporta, sono nate e si sono sviluppate con la «rivoluzione industriale» nell’Inghilterra del primo Ottocento, e poi attecchite e cresciute in Francia e Germania e in tutta Europa. C’è però una «legge» sociologica, per così dire, a proposito di certi primati tecnici. È la «penalty of taking the lead», come sosteneva Thorstein Veblen. L’Europa è oggi vittima del suo successo planetario. Non solo gli Stati Uniti, questa «Übertragung», o esagerazione, dell’Europa, a giudizio di Thomas Mann, ma la Russia di Vladimir Putin, la Cina, pur governata da una dittatura comunista, domani e, per certe regioni come Bangalore, già oggi, l’India sotto il pugno nazionalista di Modi.
L’eurocentrismo, economicamente e politicamente, è finito. L’Unione europea, nelle sue stesse incertezze, sembra talvolta recitarne piamente le esequie. Una premonizione che viene da lontano, già presente, per quanto in forma sfumata, in Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, quando nelle brillanti Lettres persanes e poi nell’Esprit des lois si rende conto che già nelle nuove scoperte geografiche sta scritta la fine della centralità dell’Occidente, del grande Mediterraneo e dello stesso oceano Atlantico, destinato a diventare il modesto «Atlantic river». Con la scoperta delle Indie gli era chiaro che l’Italia, e con essa il Mediterraneo, non era più al centro del mondo. Si pensi, al confronto, allo spiritoso Voltaire di Le siècle de Louis XIV o anche al Bossuet del Discours sur l’histoire universelle, in cui alla Cina vengono riservate poche righe.
Si potrebbe concludere, con l’irridente scetticismo che troppo spesso copre l’indifferenza e il disimpegno morale, che la storia ha cambiato alloggio. Il Mediterraneo ha ceduto la sua centralità all’Oceano Atlantico, forse fin da ora incalzato da vicino dal Pacifico. L’eurocentrismo del grand siècle, quello di Luigi XIV e dello spiritoso Voltaire, cui penso spesso leggendo il brillante, acuto Raymond Aron, è finito. Per la prima volta, dopo venticinque secoli dall’Atene di Pericle del quinto secolo a.C., il destino dell’Europa non è più nelle mani degli Europei. Dipende dai rapporti fra Russia, Stati Uniti e Cina, in subordine India e Africa.
 Ma i valori europei sono ancora essenziali, nella misura in cui gli Europei ne hanno coscienza e coerentemente li incarnano e li fanno valere. La lezione dei Mediterraneo, in questo senso e in questa prospettiva, è oggi più valida che mai.
Ma i valori europei sono ancora essenziali, nella misura in cui gli Europei ne hanno coscienza e coerentemente li incarnano e li fanno valere. La lezione dei Mediterraneo, in questo senso e in questa prospettiva, è oggi più valida che mai.
Il mare nostrum, come lo chiamavano i nostri progenitori, gli antichi Romani, deve oggi trasformarsi in mare humanum, in armonia con la sua vocazione profonda. Un fatto, agli inizi del terzo millennio, si va rivelando sconvolgente. Si creda o meno al racconto biblico sui tre fratelli Sem, Cam e Jafet, trovi o meno l’UNESCO il coraggio di scrivere la parola «razza» nei suoi documenti ufficiali, quale che sia il colore della pelle o la forma degli occhi, qualunque essere venga al mondo su questo pianeta in sembianze umane è, dalla nascita, titolare di un diritto originario di umanità che toglie qualsiasi fondamento alla pretesa razzistica di una gerarchia fra le religioni, le razze e le culture umane. Dal concetto di sviluppo storico diacronico si passa al concetto di sviluppo storico sincronico. Cade la cesura fra hominitas e humanitas. Attraverso la parola, i gruppi umani creano sistemi e strutture di significati. Non è più concepibile una umanità di Epuloni che lasciano cadere, a loro piacimento, qualche briciola ai loro lazzari che attendono sotto la tavola del banchetto luculliano o negli scantinati della storia. Gli inizi del Terzo Millennio cominciano a conoscere una umanità in cui non si dànno più esclusi, per definizione, o «dannati della terra», per valerci del famoso titolo di Franz Fanon, intere popolazioni tagliate fuori dalla storia, presenti solo come combustibile inerte, massa umana da sfruttare. L’eurocentrismo è al tramonto. Le ragioni di questa tendenza sul piano planetario sono ovvie e temibili. Le insorgenze locali sono scontate.
Nel momento in cui capi politici responsabili, in grado di leggere i segni della storia, dovrebbero farsi «pontefici», cioè costruttori di ponti, si adoperano invece per alzare muri, coltivano il mito dell’invasione di immigrati, dànno corso ad anacronistiche «guerre della tariffa».
 Parlano, o si illudono di parlare, in nome del popolo. Ma non sanno che per i Romani della classicità «populus» vuol dire «popolo in armi» e che il verbo infinito passivo «populari» significa «devastare, saccheggiare, incendiare».
Parlano, o si illudono di parlare, in nome del popolo. Ma non sanno che per i Romani della classicità «populus» vuol dire «popolo in armi» e che il verbo infinito passivo «populari» significa «devastare, saccheggiare, incendiare».
Siamo fortunati: viviamo in tempi di emergenza. Con le due guerre mondiali del secolo scorso, l’Europa ha deciso di commettere suicidio. E tuttavia, siamo fortunati, perché ci è toccato di vivere in tempi di emergenza. L’emergenza fa emergere il problema: la contraddizione flagrante fra una tecnica che ha una portata planetaria, specialmente nelle sue applicazioni elettroniche, e gruppi dirigenti, politici e culturali, governanti e influenzanti, che, al momento in cui dovrebbero essere, come abbiamo detto, «pontefici», costruttori di ponti, alzano muri, non hanno idee, si illudono di garantirsi prosperità e sicurezza chiudendosi dentro i propri angusti confini.
Ma nessuno si salva da solo. La loro inconsapevolezza è così tracotante da riuscire commovente. Non si sa se definirli studenti fuori corso, dilettanti allo sbaraglio o ancora delinquenti in libera uscita. Nessuna meraviglia che la tecnica sia ritenuta il principio-guida dello sviluppo storico. Ma la tecnica è una perfezione priva di scopo, può solo controllare l’esattezza delle proprie operazioni interne. Di qui, un mondo disorientato, né centralizzato né decentrato. Semplicemente, a-centrato in cui i valori strumentali oscurano i valori finali, dominato dalla piattezza interiore, dall’eterno ritorno dell’identico e dalla creazione artificiosa dello spontaneo – completamente in mano alle società multinazionali, fondate sul principio della a-territorialità, dotate di un potere enorme, pubblico e quindi politico – e nello stesso tempo, a vergogna di politici e giuristi, considerate ancora meri domicili privati.
Nella situazione odierna, quando le comunicazioni elettronicamente assistite hanno praticamente abolito la «frizione dello spazio», sarebbe necessario costruire ponti, favorire l’interscambio fra le culture. La scarsa statura storica e morale dei capi politici odierni li induce invece a costruire e a rinchiudersi dentro i muri. Negano l’altro. Non comprendono che l’identità non è un dato; è un processo. Identità e alterità sono pratiche di vita e concetti correlativi. L’elettronica applicata e la stessa economia capitalistica, affamata di sempre nuovi mercati, puntano decisamente alle dimensioni planetarie, ad una globalizzazione commerciale che toccherebbe a capi politici consapevoli e intellettualmente coraggiosi portare a compimento con adeguate strutture sovranazionali e sovrastatuali. Si potrebbe pensare alle Nazioni Unite. Frutto delle due guerre mondiali del secolo XX, che hanno determinato il suicidio finale dell’Europa, le Nazioni Unite restano un foro privo di forza effettiva così come il Parlamento Europeo di Strasburgo è poco più che un’assemblea di inascoltati consiglieri e un quietum servitium per politici e sindacalisti nazionali ritenuti, a torto o a ragione, degni di un congruo pensionamento.
 È in questo quadro che si rende manifesta tutta la sostanza anacronistica e, in senso proprio, reazionaria delle politiche che oggi sembrano sul punto di prendere il sopravvento in Europa, ma anche negli Stati Uniti e nell’America Latina. La guerra dei dazi ne è solo un aspetto. Non si tratta di un neo-isolazionismo, cui gli Stati Uniti, non immemori della dottrina Monroe («L’Europa agli Europei, l’America agli Americani»), si sono nell’800 dedicati, consapevoli di doversi dare una propria fisionomia storica e morale ad evitare di venir considerati una mera appendice dell’Europa. È un protezionismo miope, un sovranismo non nazionalista, ma chiuso nel proprio territorio, che non si rende conto che lo Stato-nazione è finito.
È in questo quadro che si rende manifesta tutta la sostanza anacronistica e, in senso proprio, reazionaria delle politiche che oggi sembrano sul punto di prendere il sopravvento in Europa, ma anche negli Stati Uniti e nell’America Latina. La guerra dei dazi ne è solo un aspetto. Non si tratta di un neo-isolazionismo, cui gli Stati Uniti, non immemori della dottrina Monroe («L’Europa agli Europei, l’America agli Americani»), si sono nell’800 dedicati, consapevoli di doversi dare una propria fisionomia storica e morale ad evitare di venir considerati una mera appendice dell’Europa. È un protezionismo miope, un sovranismo non nazionalista, ma chiuso nel proprio territorio, che non si rende conto che lo Stato-nazione è finito.
Naturalmente, il cadavere è un bel pensiero per il verme. Nel momento in cui masse umane si muovono alla ricerca di una vita diversa e di condizioni esistenziali migliori, da un continente all’altro, i sovranisti negano il diritto di attracco alle navi, fanno del Mediterraneo, del «mare fra le terre», contro la sua vocazione storica, un luogo di tortura o un cimitero a cielo aperto.
Il sovranismo, di cui oggi si blatera per i trivi, non ha nulla a che fare con l’amor di patria, tanto meno può evocarsi in proposito, nella sua versione latina, il classico verso di Tirteo: «Dulce et decorum est pro patria mori». E neppure, soprattutto con riguardo al protezionismo economico instaurato dall’attuale Presidente degli Stati Uniti con la «guerra dei dazi», è lecito pensare ad una nuova edizione dell’isolazionismo nordamericano più sopra ricordato, sulla base di quella dottrina Monroe che godeva all’epoca di una sua dignità.
Ancor meno plausibilmente si può invocare il Genius loci, cui in altra sede ho dedicato qualche riflessione [1]. Il Genius loci si pone come il fondamento delle culture positive e creative. Chi non riconosce o dimentica o recide le proprie radici mette a repentaglio la propria perpetuazione insieme con la propria creatività. Ma non bisogna per questo mitizzare il Genius loci. Feticizzare le proprie radici, blindare la comunità autoctona contro lo straniero significa non comprendere che l’identità si riconosce nell’alterità, e finire, al limite, al Blut und Boden di infausta nazistica memoria e alle tragiche, recenti atrocità della «pulizia etnica» nei Balcani. Forse è vero che gli errori più gravi sono virtù impazzite.
Forse è vero che i fatti storici si presentano dapprima e sono sofferti dalle grandi maggioranze come tragedie e che poi tornano come tragiche farse, frutti di grande emotività collettiva, prodotti di scaltre campagne demagogiche di capocomici improvvisatisi capi politici, aiutati dal web, dai nuovi mezzi di comunicazione elettronicamente assistiti, onnipervasivi, distributori incontrollati, e forse incontrollabili, di notizie sensazionali prive di un qualsiasi fondamento, totalmente mancanti di una critica delle fonti, dominati dalla congiuntiva «e», secondo una tendenza paratattica, in cui tutto è sullo stesso piano, da un discorso del papa alle sfilate di moda.
È stato ancora recentemente osservato, molto puntualmente, che il sovranismo di cui si parla e scrive correntemente oggi, significa il diritto-dovere della priorità degli interessi del proprio Paese. Il popolo è sovrano, si sente ripetere come verità ovvia e incontrovertibile. E questo anche nei confronti dell’Unione Europea così come, al di là dell’Atlantico, tra i Paesi del NAFTA (Messico, Stati Uniti, Canada). Ma nell’uso odierno il sovranismo non si esaurisce nel semplice esercizio della sovranità. Si carica di una peculiare rivendicazione polemica, rifiuta ogni tipo di mediazione, reclama la democrazia diretta, che ammonta in realtà, tramite la Rete, ad una manipolazione di massa. Sarebbe utile riandare in proposito ai «Federalist Papers», in particolare a quel mirabile intervento di James Madison, stretto collaboratore di Thomas Jefferson e quarto presidente degli Stati Uniti, sulla temibile e sempre possibile «tirannide della maggioranza». Rispetto ad essa, la tirannide classica con un solo tiranno conosceva e consentiva di praticare il tirannicidio.
A questo proposito, la Costituzione della Repubblica Italiana del 1947, nel primo articolo afferma: «La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». La frase è perentoria: il popolo non viene identificato con una maggioranza elettorale che ritiene di poter fare quello che vuole e come vuole.
 Ma è probabile che il sovranismo di oggi, così canoramente conclamato, sia solo un atto di nostalgia da parte di un’incompetenza così tracotante e dotata di un’ignoranza storica quasi commovente, che non si rende conto che il sovrano non c’è più, che la democrazia diretta mercé la rete è solo, nel caso migliore, un sondaggio di opinioni, se non una comoda menzogna, o una ricerca di mercato, che è venuto meno il rapporto diretto, vero, a faccia a faccia, che definiva, e ancor oggi definisce, l’autentico processo democratico, cioè un luogo in cui ci si parla, si discute, si riconosce l’altro come interlocutore e non solo come oggetto di insulti, si può cambiare opinione, si arriva a un consenso mediato e a una verità intersoggettiva. La sovranità di una nazione democratica non è un regalo delle circostanze, ancor meno il frutto di pulsioni irrazionali e xenofobiche.
Ma è probabile che il sovranismo di oggi, così canoramente conclamato, sia solo un atto di nostalgia da parte di un’incompetenza così tracotante e dotata di un’ignoranza storica quasi commovente, che non si rende conto che il sovrano non c’è più, che la democrazia diretta mercé la rete è solo, nel caso migliore, un sondaggio di opinioni, se non una comoda menzogna, o una ricerca di mercato, che è venuto meno il rapporto diretto, vero, a faccia a faccia, che definiva, e ancor oggi definisce, l’autentico processo democratico, cioè un luogo in cui ci si parla, si discute, si riconosce l’altro come interlocutore e non solo come oggetto di insulti, si può cambiare opinione, si arriva a un consenso mediato e a una verità intersoggettiva. La sovranità di una nazione democratica non è un regalo delle circostanze, ancor meno il frutto di pulsioni irrazionali e xenofobiche.
Occorre recuperare il rapporto umano diretto, a faccia a faccia; riscoprire la natura del dialogo interpersonale in cui si discute, ci si confronta, si può anche cambiare opinione, si riconosca l’altro come interlocutore, non come a priori nemico.
Il mare Mediterraneo, ossia «il mare fra le terre», è un mare storicamente presente da tempo immemorabile, un luogo in cui più ricca e densa si è fatta l’esperienza storica, un luogo centrale nella storia dell’umanità. Ciò è stato vero almeno fino al 1492, quando ad esso subentra, almeno parzialmente e in un senso del tutto differente, l’oceano Atlantico. Con la caduta della tensione, ideologica e militare, fra Est e Ovest e con il crescere del confronto fra Nord e Sud, forse il Mediterraneo si avvia ad essere nuovamente un centro storicamente rilevante.
In questa prospettiva, è necessario riconsiderare e riprendere criticamente il concetto di cultura. Dalla cultura greca e ciceroniana del kalòs kai agathòs e del vir bonus dicendi peritus è necessario passare alla cultura – non più élitaria, nemica dei polloì – come insieme di esperienze e di valori condivisi e convissuti. L’individualismo aristocratico che sottende la cultura classica e vetero-umanistica presuppone la contrapposizione fra otium e negotium e un’economia fondata sugli schiavi, «macchine animate», secondo Aristotele, e meri «piedi d’uomo», andràpoda, nei termini di Platone.
La ragione profonda della crisi della cultura come termine normativo, di ascendenza classica, che afferma l’individuo colto contro la massa dei comuni mortali, è data dalla sua strumentale incapacità di comunicare con l’altro su un piede di parità. La società multi-culturale che batte alle porte, e non solo metaforicamente, richiede oggi un tipo diverso di cultura – una cultura che sappia riesprimere i criteri di eccellenza e i termini dell’auto-valutazione critica in una società di massa e in un mondo caratterizzato non più dal processo storico diacronico, bensì dalla compresenza sincronica di tutti gli esseri umani su scala planetaria.
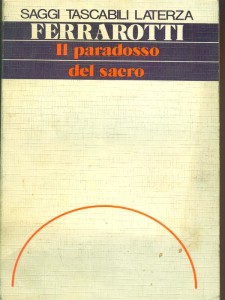 Le tre grandi religioni positive monoteistiche universali devono recuperare la loro unità trascendentale (mi permetto in proposito di rinviare alla mia trilogia: Una teologia per atei, Laterza, 1983; Il paradosso del sacro, Laterza, 1983; Una fede senza dogmi, Laterza, 2000).
Le tre grandi religioni positive monoteistiche universali devono recuperare la loro unità trascendentale (mi permetto in proposito di rinviare alla mia trilogia: Una teologia per atei, Laterza, 1983; Il paradosso del sacro, Laterza, 1983; Una fede senza dogmi, Laterza, 2000).
Questa unità, al di là delle guerre atroci di religione che hanno insanguinato l’Europa fino alla pace di Westfalia nel 1648, va ritrovata nei valori profondi che definiscono e consolidano la coscienza europea, in primo luogo, il lógos greco, che non è solo la «ragione», ma è essenzialmente la «parola». Come dice l’incipit del vangelo giovanneo, «in principio erat Verbum». La parola è senso più significato. Viene prima dell’immagine e va oltre la musica. In secondo luogo, la condanna morale del lavoro schiavile, fatta valere dal Cristianesimo, che per tale via riscatta e valorizza la persona umana, fine e mai strumento. In terzo luogo, l’idea di «uomo singolare» (nella Firenze del ‘400), da dotarsi della responsabilità comunitaria fino a darci quello che oso chiamare l’individuo «autotelico», al di là del dualismo platonico (doxa-epistéme), cristiano (corpo-anima), cartesiano (res cogitans-res extensa), idealistico-hegeliano (Sein-Denken), in nome e all’insegna di un essere in cui passione e ragione garantiscono e inverano l’unità del vivente, in cui si incontrano, pertanto, verità scientifica e conoscenza ordinaria.
Di qui, un diritto che va oltre i diritti umani, più o meno genericamente intesi. È il diritto di umanità, legato alla sacralità della vita. La vocazione del Mediterraneo è a questo proposito essenziale. Come ricordava l’indimenticabile Fernand Braudel, «il Mediterraneo è mille cose insieme; non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi; non un mare, ma un susseguirsi di mari, non una civiltà, ma una serie di civiltà»
Che cosa le tiene insieme? Un valore che è nello steso tempo religioso, culturale e politico: l’uomo come fine, mai come strumento. È un valore che si esprime nel diritto di umanità, di cui ogni essere che nasca in sembianze umane e viva sul pianeta Terra è titolare, un diritto che, nella sua essenza, è dichiarato e in vario modo, storicamente, valorizzato dalle cinque grandi religioni universali, ormai consapevoli che, nella situazione nucleare in cui ci troviamo a vivere, solo il dialogare interreligioso e la convivenza civile possono garantirci contro l’autoannientamento dell’umanità.
Vorrei concludere queste scarne, forse troppo schematiche considerazioni tornando a fare un cenno fugace all’attualità. Credo che l’impostazione del problema-migranti, con le migliori intenzioni, da parte delle organizzazioni umanitarie sia stata erroneamente impostata. Non si tratta di invocare, dal Papa alla Comunità di S. Egidio, bontà e cuori teneri, accoglienza e benevolenza. È in gioco una visione realistica della situazione. Già oggi gli immigrati contribuiscono a pagare le pensioni di un popolo senescente, non raccolgono solo le olive in Calabria o i pomodori in Puglia, né si occupano solo della produzione nelle fonderie del Nord Italia. Si occupano dell’assistenza ai vecchi soli, in numero crescente, e dei bisogni della quotidianità domestica. Gli immigrati sono necessari; non sono solo un problema; sono una risorsa [2].
Spetta all’Europa ritrovare i termini, economico-culturali e storici, per una immigrazione che non sia caotica estraneità, ma, ancora una volta, occasione di arricchimento interculturale e progresso civile. Le difficoltà sono evidenti. Non si tratta di realizzare un melting pot, che riuscirebbe, al più, una babelica congerie, bensì una salad bowl, o «insalatiera», in cui ogni «filo d’erba», vale a dire ogni cultura, manterrebbe la propria identità, pur aprendosi e dialogando con le altre culture, nella piena consapevolezza che oggi, nella situazione nucleare dell’umanità, la condizione per evitare l’autosterminio si lega a un semplice, drammatico dilemma: dialogare o perire.
In altra sede [3] mi sono a lungo intrattenuto sul dialogo religioso ecumenico, a mio parere l’unica via di salvezza per l’umanità. Non esiste solo il fondamentalismo islamico. Alla convocazione del Concilio Vaticano II, papa Giovanni XXIII chiedeva il riconoscimento delle colpe dei cattolici contro l’unità e implicava la domanda e l’offerta di reciproco perdono. Cadeva il principio: «Extra ecclesiam nulla salus». Del movimento ecumenico si parlava come movimento di conversione e di pentimento.
Pur nei suoi limiti di attuazione, il concilio Vaticano II costituisce in questo senso un’importante indicazione positiva. Comune alle tre religioni universali monoteistiche è il viaggio salvifico: a Gerusalemme, alla Mecca e a Roma. Anche per i cristiani Abramo è da considerarsi padre dei credenti. La fede nel Cristo, annunciato dalle Scritture come Figlio di Dio incarnato per la remissione dei peccati del mondo, precede le opere. Quindi Abramo è il capostipite comune per ebrei e cristiani.
Abramo è inoltre il padre fisico di Ismaele con il quale ha fondato alla Mecca la Ka’aba, santuario centrale dell’unico Dio. L’emigrazione di Maometto, da Ur, l’egira, è la rappresentazione del grande viaggio alla Mecca cui ogni fedele dovrà tornare, secondo la rivelazione contenuta nella sua purezza nel Corano.
Oggi, nessuna cultura o religione può considerarsi sovranamente autosufficiente e strumento esclusivo di salvezza. E nessuna gerarchia fra le varie religioni e le varie culture come sistemi di simboli e significati appare oggi sostenibile. Solo l’accettazione e la convivenza di culture e religioni diverse mediante l’elaborazione del concetto e della pratica di «co-tradizioni culturali» sembrano aprire una via d’uscita dalle contraddizioni che oggi pesano sulla vita quotidiana dell’umanità e ne segnano duramente il destino.
Dialoghi Mediterranei, n. 42, marzo 2020
[*] Relazione introduttiva a un corso per la Scuola di Alta Formazione in Sociologia della Religione Safsor che si è aperto il 16 dicembre 2019 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma 3.
Note
[1] Cfr. il mio Emarginazione e creatività, Chieti, Solfanelli, 2018; specialmente il cap. II, «Genius loci e creatività»: 11-20; cfr. inoltre Il senso del luogo, Roma Armando, 2009.
[2] Cfr. in proposito il mio La vocazione del Mediterraneo, Chieti, Solfanelli, 2018, cap. IX, «L’immigrazione come risorsa»: 55-58.
[3] Cfr. il mio La convivenza indispensabile, Bologna, EDB, 2019, passim.
______________________________________________________________
Franco Ferrarotti, tra i protagonisti della istituzionalizzazione della sociologia in Italia negli anni sessanta, il più noto dei sociologi italiani all’estero. Ha insegnato alla Sapienza di Roma ed è autore di numerosissimi libri tradotti in francese, inglese, spagnolo, in russo e in giapponese, ha collaborato con le maggiori riviste scientifiche statunitensi, oltre che europee. I suoi studi hanno riguardato le questioni del mondo del lavoro e della società industriale e postindustriale, i temi del potere e della sua gestione, le dinamiche generazionali, i problemi della marginalità urbana e sociale, delle credenze religiose, delle migrazioni. Una particolare attenzione è stata dedicata nelle sue ricerche alla città di Roma. Ha sempre privilegiato un approccio interdisciplinare e insistito sull’importanza di uno stretto nesso tra impostazione teorica e ricerca sul campo. Ferrarotti è stato consigliere di Adriano Olivetti, diplomatico e deputato del Parlamento nella Terza Legislatura (1958-1963).
_______________________________________________________________









