Da sedici anni insegno Storia orale all’università e Nuto Revelli è sempre stato una tappa imprescindibile del programma, ma in tre occasioni è stato al centro del corso, e lo è stato in modi diversi. Vorrei seguire questa traccia, e sbucciare Nuto Revelli come una cipolla.
La prima volta fu nel 2005. Proposi Revelli come un maestro di storia orale da cui gli studenti avrebbero potuto imparare il mestiere, leggendo i suoi libri come se andassero a bottega da lui e dovessero affiancarlo, osservarlo, e “rubare con gli occhi”.
In effetti, dagli anni Ottanta in avanti Nuto Revelli venne riconosciuto come un maestro dalla generazione più giovane, quella che gli rivelò che lui aveva fatto storia orale anche quando questa denominazione ancora non aveva circolazione in Italia. Fu un maestro inconsapevole, maestro senza cattedra, e sempre sottolineò questa sua condizione di ricercatore indipendente. Ma si prestò a dialogare con i ricercatori più giovani. Nel 1982 Luisa Passerini pubblicò un’intervista a Revelli nel terzo numero della rivista «Fonti orali», il primo bollettino di collegamento tra quello che si stava definendo come il movimento degli storici (e delle storiche) orali italiane: Passerini voleva conoscere «i metodi e le tecniche del suo modo di intervistare, trascrivere, interpretare. Per quanto sia personalissima e probabilmente irripetibile, c’è molto da imparare da questa pratica e dalle riflessioni su di essa»[1].
Undici anni dopo, nel 1993, Daniele Jalla lo intervistò un’altra volta, all’interno del convegno Archivi sonori del Piemonte, Vercelli, 22 gennaio 1993: anche qui un’intervista tecnica, sulla metodologia e anche gli strumenti di registrazione [2].
Queste interviste, insieme ad alcune altre pubblicate nel libro Il testimone, e alle ricche introduzioni ai libri maggiori di Revelli e al diario narrativo di una ricerca che è Il disperso di Marburg, sono una miniera di consigli, e anzi di descrizioni di pratiche con cui condurre una geoesplorazione e una ricerca sul campo attraverso le fonti orali, a partire dalla presa di contatto con i narratori, a come entrare nelle loro case, come suscitare e accompagnare i racconti, come trascrivere, come “restituire” la ricerca alle persone che l’hanno partecipata e resa possibile.
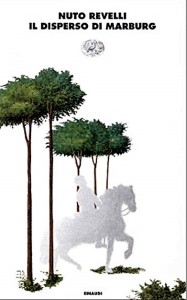 Nel 2005, fu realizzata una sorta di dispensa per il corso: un’antologia con le “buone pratiche di storia orale” tratte – rubate – dai libri di Nuto Revelli, sulla falsa riga di quello che aveva fatto Piero Brunello con Anton Cechov per Minimum fax: due libretti antologici, frutto di una ricerca certosina non solo sulle opere ma anche nell’epistolario di Cechov: estrapolando e antologizzando 99 consigli di scrittura, e un vademecum su come fare un reportage [3].
Nel 2005, fu realizzata una sorta di dispensa per il corso: un’antologia con le “buone pratiche di storia orale” tratte – rubate – dai libri di Nuto Revelli, sulla falsa riga di quello che aveva fatto Piero Brunello con Anton Cechov per Minimum fax: due libretti antologici, frutto di una ricerca certosina non solo sulle opere ma anche nell’epistolario di Cechov: estrapolando e antologizzando 99 consigli di scrittura, e un vademecum su come fare un reportage [3].
Quella dispensa con i metodi e le riflessioni di Nuto Revelli è diventata un punto fermo tra i sussidi didattici anche dei corsi successivi: funziona benissimo, e anzi anno dopo anno, ad ogni rilettura o nuova lettura, diventa più ricca.
Dieci anni dopo Revelli tornò ad avere una posizione preminente all’interno di un corso di Storia orale. Ma sotto una veste un poco diversa. Capitò l’occasione di poter programmare una visita di gruppo, alla fine delle lezioni, a Paraloup, che era da poco stato restaurato ed era diventato una foresteria e un centro didattico per raccontare soprattutto la rinascita della montagna e la memoria della Resistenza in quella zona. Divenne centrale, più che la lezione di metodo, la dimensione etica ed esistenziale di Nuto Revelli. Questo è un aspetto che sempre colpisce, e che sempre commuove anche me quando ne parlo, ogni anno a studenti diversi. Mi riferisco alla catarsi della ritirata di Russia, e alla parresia che ne seguì (raccontare tutto, dire la verità, dare spazio anche alle verità degli altri). Revelli che appartiene alla generazione del littorio, cresciuto nei miti del fascismo e avviato alla carriera militare, quando va alla guerra comincia a vivere una catastrofe che precipita nei giorni e nelle settimane della sconfitta militare. Non mi dilungo perché tutti conosciamo quel che ne scrisse e anche quel che raccontò, per esempio, nell’ intervista filmata con Laura Pariani nel 2003, in occasione del conferimento a Revelli del Premio Omegna [4].
Ciò che colpisce, oltre alla sofferenza della memoria che lo porta a rivivere quei dolori ogni volta che li racconta, è l’effetto che quella tragedia ebbe nel percorso intellettuale e civile di Revelli: la scoperta bruciante di essere stato ingannato (dai padri, dai maestri, dai superiori, dai dirigenti) e l’ammissione disturbante di non esser stato solo vittima ma anche tramite di questo inganno, nei confronti di chi non aveva scelto di andare a fare la guerra ma subìto le decisioni altrui: i “suoi alpini”, i soldati di cui era comandante. Erano i contadini che avrebbe ritrovato durante la Resistenza, in piccola parte partecipi, nella grande maggioranza diffidenti, ma incredibilmente non ostili. Nuto Revelli dedicò il resto della sua vita a elaborare un senso di colpa e a restituire qualcosa a quelle persone: il suo impegno trentennale – ininterrotto, volontario e non retribuito – nel campo della ricerca con le fonti orali ha questa radice, civile, esistenziale, direi anche psicologica.
Questo punto – come dicevo – colpisce molto chi, in un contesto universitario, ascolta per la prima volta il racconto della vita di un ricercatore “di riferimento” e intuisce che la ricerca possa avere delle motivazioni esterne al campo scientifico o accademico.
Il filo conduttore di quel corso che un po’ fortunosamente si concluse a Paraloup era stato in realtà il libro il David Forgacs, Margini d’Italia [5]: una storia d’Italia vista dalla parte degli esclusi, in cinque tappe; è un bel saggio di storia culturale che dimostra come il processo di costruzione dello Stato nazionale abbia attivato non solo processi di aggregazione e integrazione di spazi e gruppi, ma anche un moto contrario di messa ai margini e di costruzione di periferie geografiche, sociali e culturali.
 A Paraluop, e in generale nel Mondo dei vinti, riconoscemmo subito uno dei molti margini d’Italia, e fu facile inscrivere Nuto Revelli in quel novero di intellettuali che è al centro del discorso che fa Forgacs: sociologi, urbanisti, antropologi, etnologi, psichiatri, fotografi e giornalisti d’inchiesta: li potremmo definire cumulativamente come “intellettuali impegnati”, chiamati a essere osservatori e spesso interpreti di mondi sociali “altri”, marginali, subalterni, correndo spesso il rischio di deformare, di costruire stereotipi, di confermare gerarchie. Il punto più alto di questo percorso – e il modello ancora valido, secondo Forgacs – è quello di Ernesto de Martino, a cui è dedicato il capitolo centrale del libro.
A Paraluop, e in generale nel Mondo dei vinti, riconoscemmo subito uno dei molti margini d’Italia, e fu facile inscrivere Nuto Revelli in quel novero di intellettuali che è al centro del discorso che fa Forgacs: sociologi, urbanisti, antropologi, etnologi, psichiatri, fotografi e giornalisti d’inchiesta: li potremmo definire cumulativamente come “intellettuali impegnati”, chiamati a essere osservatori e spesso interpreti di mondi sociali “altri”, marginali, subalterni, correndo spesso il rischio di deformare, di costruire stereotipi, di confermare gerarchie. Il punto più alto di questo percorso – e il modello ancora valido, secondo Forgacs – è quello di Ernesto de Martino, a cui è dedicato il capitolo centrale del libro.
C’è una riflessione in corso su questo fenomeno, che è la seduzione che la “cultura popolare” esercitò nel lungo periodo della storia d’Italia, ma in maniera particolarmente spiccata nel trenta-quarantennio che seguì la fine della Seconda guerra mondiale, fino agli anni Ottanta: furono i “trent’anni gloriosi” della ricerca sul canto sociale, sulla cultura popolare (e anche quelli in cui fece i primi passi la storia orale)[6]. Poi ci fu un lungo silenzio, durato altri trent’anni, in cui la cultura popolare non interessò molto agli studiosi.
Tra l’altro, anche Revelli “svolta” dopo il 1985: dai libri corali, collettivi, direi quasi etnografici dei due decenni precedenti, passa alle storie individuali, come Il disperso di Marburg (1994) e Il prete giusto (1998), al cui centro sta un’esistenza singola, con le sue scelte, mentre il mondo contadino è sullo sfondo [7].
Il rapporto tra intellettuali, “mondi locali” e “culture popolari” è stato il tema del corso di Storia orale del 2019, ed è questo il terzo strato della cipolla che sto sbucciando.
A me pare che Nuto Revelli si collochi appieno all’interno di questa variante italiana del folk revival (inteso non solo in senso musicale, naturalmente) e che ci stia dentro in una maniera particolare che finora non è stata molto messa a fuoco. Le ricerche su questi aspetti del “populismo progressivo” – possiamo definirlo così? – che in quei decenni mobilitò moltissimi intellettuali si sono concentrate sul ruolo svolto sul piano teorico dal pensiero di Gramsci e sul piano politico dal Pci togliattiano (e in parte dal Psi). Anche Asor Rosa, quando scrisse Scrittori e popolo nel 1965, aveva come bersaglio polemico il Partito comunista italiano [8].
Revelli secondo me è ascrivibile a un’altra tradizione: quella del “populismo azionista”, azionista in senso lato, cioè in un senso che recupera a ritroso la cultura del partito d’azione risorgimentale e poi quella liberalsocialista, e in avanti la lunga e ricca coda lasciata nell’Italia repubblicana da quella cometa che ne attraversò il cielo, cioè il Partito d’azione.
Sono categorie – queste del lungo azionismo che attraversa la storia d’Italia – che negli ultimi decenni sono state proposte e discusse soprattutto da Giovanni De Luna e dai molti studiosi che si sono confrontati nei “Cantieri aperti” del Giellismo e Azionismo, e che qui pertanto posso dare per acquisite, non senza osservare che il discorso pubblico e anche la storiografia degli ultimi vent’anni relativi al Partito d’azione hanno messo in evidenza soprattutto altri aspetti del lascito azionista: la dimensione esistenziale e quindi soprattutto individuale e di piccolo gruppo dell’agire politico, la centralità dei ceti medi e anzi della borghesia urbana, il primato della libertà rispetto all’uguaglianza.
Eppure, da Ippolito Nievo a Gaetano Salvemini a Piero Jahier a Emilio Lussu a Tommaso Fiore a Carlo Levi (per certi aspetti, fino a Leone Ginzburg e Franco Venturi [9]), la linea di questo populismo azionista a me pare ben riconoscibile: sono tutti intellettuali democratici o socialisti che hanno individuato la questione contadina come questione nazionale ancora prima che Gramsci la definisse tale, o che il suo pensiero venisse reso pubblico con l’edizione dei Quaderni del carcere. Sono intellettuali che hanno cercato di mettersi in contatto, in ascolto, in dialogo con gruppi sociali, mondi popolari, diversi da quelli di cui essi – intellettuali – erano espressione. Spesso fraintendendo, mitizzando, prendendo abbagli, ma con l’obiettivo di dare fiato e voce a quelli che nessuno ascolta, portare dentro la storia quelli che ne sono stati sempre ai margini, e allo stesso tempo «restituire ad essi la loro storia, con le loro parole» (Paul Thompson)[10].
Forse anche la triade Nuto Revelli, Primo Levi, Mario Rigoni Stern – più volte evocata nel convegno – può essere interrogata a partire da questi presupposti [11]. Che fare di questo populismo azionista? A me sta simpatico, anche se ne riconosco rischi e limiti.
I limiti: su Carlo Levi è stato scritto molto, proprio sottoponendo a critica lo sguardo – paternalista, etnocentrico, coloniale, per quanto carico di affetto – con cui descrive il mondo dei contadini in Cristo si è fermato a Eboli [12]. Su Emilio Lussu è uscito da poco un bel numero della rivista “il de Martino”, costruito intorno a un’intervista che gli fece Gianni Bosio nel 1969: un’intervista un po’ stralunata sui pastori sardi e sulla Brigata Sassari in cui emergono in maniera plastica (e persino imbarazzante) il populismo e addirittura l’atavismo di Lussu [13].
I rischi: che quando il popolo parla e agisce in proprio, è meno gradevole di quando se ne fanno interpreti e traduttori gli intellettuali, e questo talvolta produce in loro un riflesso giacobino e autoritario (come capitò ai Trentin, padre e figlio)[14]. E poi che quando il popolo si arricchisce anche solo un po’, perde immediatamente di interesse (come capitò dagli anni Ottanta in avanti): lo ha ben detto Lucia Carle poco fa, invitando a studiare la storia dei mondi popolari negli ultimi trenta-quarant’anni, dal Mondo dei vinti al Mondo del benessere, con le strategie di adattamento che le persone e le famiglie hanno messo in atto.
Nonostante i rischi e i limiti, a me il populismo azionista sta simpatico perché contiene una critica dello stato presente, un riconoscimento delle distanze sociali e anche una denuncia delle ingiustizie.
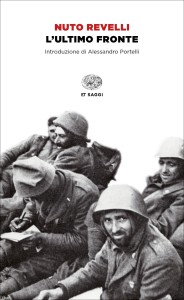 La denuncia della «frattura tra il mondo in basso e il mondo in alto» – mi sono segnato le parole usate da Ezio Mauro – è uno dei motivi fondanti i quattro libri collettivi di Nuto Revelli, quelli pubblicati tra il 1966 e il 1985: La strada del davai, L’ultimo fronte, Il mondo dei vinti, L’anello forte. (Anche se Nuto – e pure questo va sottolineato – ha cura di far sì che nel coro le voci individuali siano preservate e riconoscibili, perché i suoi testimoni sono sempre presentati con il loro nome e cognome e parlano in prima persona singolare).
La denuncia della «frattura tra il mondo in basso e il mondo in alto» – mi sono segnato le parole usate da Ezio Mauro – è uno dei motivi fondanti i quattro libri collettivi di Nuto Revelli, quelli pubblicati tra il 1966 e il 1985: La strada del davai, L’ultimo fronte, Il mondo dei vinti, L’anello forte. (Anche se Nuto – e pure questo va sottolineato – ha cura di far sì che nel coro le voci individuali siano preservate e riconoscibili, perché i suoi testimoni sono sempre presentati con il loro nome e cognome e parlano in prima persona singolare).
Mi sta simpatico, inoltre, perché contiene anche una critica – non distruttiva, ma correttiva – della democrazia liberale e rappresentativa, una contestazione delle sue insufficienze. I libri di Nuto Revelli sono ricchi di questi pensieri, punte e angoli di una scrittura spigolosa e spesso sferzante. Per esempio, la polemica contro le istituzioni, a partire da quella militare fino alla commissione ministeriale di inchiesta sul «presunto massacro di Leopoli». Oppure le parole dette a Sandro Galante Garrone e Paolo Gobetti nel filmato sul “ritorno a Paraloup”, nel 1983: lo scandalo delle borgate abbandonate dove ancora abita qualcuno senza luce elettrica, cinque vecchi che vivono in quelle macerie, mentre a venti chilometri la città cresce, si spende, si investono milioni, lasciando indietro pezzi di società dimenticati: «ci sono delle realtà che quasi quasi ti spingerebbero di nuovo… [pausa – a riprendere le armi, vorrebbe dire] a tornare un pochino da queste parti»[15]. Attenzione a queste parole. Siamo nel 1983, nella coda della stagione del terrorismo, e insieme nel pieno del nuovo miracolo economico degli anni Ottanta.
Due anni dopo, in un’intervista per «Noi Donne», a chi gli rimprovera di parlare solo della campagna povera, rimasta ai margini, invece di magnificare la campagna che si è arricchita, risponde con queste parole: «Questa gente è stata abbandonata perché non teneva la corsa e ora dà fastidio, ma esiste. […] Se far emergere questa realtà dà fastidio, ragione in più per continuare a scavare»[16].
 Possiamo quindi legittimamente parlare di populismo azionista? Ci sarebbe bisogno di indagare e argomentare molto di più, e ora non ce n’è il tempo. Ma queste parole di Nuto le ho sentite risuonare in un libro di Marco, suo figlio, dedicato al populismo contemporaneo, in cui egli riporta l’interpretazione che del fenomeno dà un politologo paraguayano, Benjamin Arditi: il populismo è un «ruido inquietante», un rumore fastidioso e disturbante; potremmo forse tradurre rough music, come lo charivari o il cacerolazo [17].
Possiamo quindi legittimamente parlare di populismo azionista? Ci sarebbe bisogno di indagare e argomentare molto di più, e ora non ce n’è il tempo. Ma queste parole di Nuto le ho sentite risuonare in un libro di Marco, suo figlio, dedicato al populismo contemporaneo, in cui egli riporta l’interpretazione che del fenomeno dà un politologo paraguayano, Benjamin Arditi: il populismo è un «ruido inquietante», un rumore fastidioso e disturbante; potremmo forse tradurre rough music, come lo charivari o il cacerolazo [17].
Il populismo è ruido inquietante – dice Marco Revelli chiosando Arditi – «perché segnala l’apertura di una crepa, di una frattura, nella superficie solo apparentemente compatta della post-democrazia pacificata, attraverso la quale tenderebbero a riaffiorare le tensioni e i fattori di conflitto rimossi e confinati in quella “terra straniera interiore” (come Freud chiamava l’inconscio) da cui ora tenderebbero ad uscire»[18].
Terra straniera interiore: sono i Margini d’Italia; è il rimosso sociale, culturale e politico; ma è anche la memoria, terra straniera dentro di noi che solo in piccola parte conosciamo e manovriamo (che solo in parte “dominiamo”, per riprendere le parole dette da Laura Pariani) e che ogni tanto salta su da sola e ci sorprende, e ci dà fastidio.
Le parole di Nuto Revelli mi sembrano quindi l’epigrafe migliore da apporre al Vademecum contenente i suoi metodi e consigli “di mestiere” per chi vuole imparare a fare storia orale: «Se far emergere questa realtà dà fastidio, ragione in più per continuare a scavare».
Dialoghi Mediterranei, n. 42, marzo 2020
Note
[1] L. PASSERINI, Intervista a Nuto Revelli, «Fonti orali», II (1982), n. 1: 43-50.
[2] Daniele Jalla intervista Nuto Revelli, in Archivi sonori. Atti dei seminari di Vercelli (22 gennaio 1993), Bologna (22-23 settembre 1994), Milano (7 marzo 1995), Ministero per i beni e le attività culturali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1999: 35-46.
[3] A. CECHOV, Senza trama e senza finale. 99 consigli di scrittura, a cura di Piero Brunello, minimum fax, Roma, 2002; ID., Scarpe buone e un quaderno di appunti. Come fare un reportage, a cura di Piero Brunello, minimum fax, Roma, 2004; poi riuniti in ID., Né per fama, né per denaro. Consigli di scrittura e di vita, a cura di Piero Brunello, minimum fax, Roma, 2015.
[4] La si può vedere qui: https://www.youtube.com/watch?v=UwFfN7C5YsU.
[5] D. FORGACS, Margini d’Italia. L’esclusione sociale dall’Unità a oggi, Laterza, Roma-Bari, 2015.
[6] F. BENIGNO, Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia, Viella, Roma, 2013: 79-114; M. PLASTINO, La musica folk. Storie, protagonisti e documenti del revival in Italia, Il Saggiatore, Milano 2016; A. FANELLI, Contro canto. Le culture della protesta dal canto sociale al rap, Donzelli, Roma 2017; F. DEI, La cultura popolare in Italia. Da Gramsci all’Unesco, Il Mulino, Bologna, 2018; B. PALUMBO, Lo strabismo della DEA. Antropologia, accademia e società in Italia, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino, 2018.
[7] G. CINELLI, Nuto Revelli. La scrittura e l’impegno civile dalla testimonianza della Seconda Guerra Mondiale alla critica dell’Italia repubblicana, Aragno, Torino, 2011; L. PASSERINI, La memoria orale: l’opera di Nuto Revelli e la sua ricezione, «Il presente e la storia», n. 55, giugno 1999: 21-48.
[8] A. ASOR ROSA, Scrittori e popolo. Saggio sulla letteratura populista in Italia, Samonà e Savelli, Roma, 1965.
[9] Nel senso del comune interesse per il populismo russo, inteso come «forte simpatia morale e intellettuale nei confronti dei valori espressi dalla società contadina» che Carlo Ginzburg ricordò aver impregnato l’ambiente familiare della propria infanzia: C. GINZBURG, Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Feltrinelli, Milano, 2006: 283-284.
[10] «Oral history gives history back to the people in their own words. And in giving a past, it also helps them towards a future of their own making»: P. THOMPSON with Joanna Bornat, The voice of the past. Oral History, Oxford University Press, New York, 2017: 391 (prima edizione 1978).
[11] A questa triade di narratori – tra l’altro, tutti variamente impegnati intorno al nodo di come “scrivere l’oralità” – si potrebbero aggiungere il Luigi Meneghello di Libera non a malo e I piccoli maestri e gli scrittori “meridionalisti” del dopoguerra: Rocco Scotellaro, Ernesto de Martino, Danilo Dolci; ma forse qualche parentela c’è anche con i socialisti di sinistra Raniero Panzieri, Gianni Bosio e Giovanni Pirelli, e persino con alcune figure di “eretici” e disobbedienti all’interno della chiesa cattolica e del Pci, come Lorenzo Milani e Saverio Tutino. Invece, un antesignano del “populismo azionista” (o post illuminista) potrebbe essere rintracciato in Vincenzo Cuoco, che nel Saggio sopra la rivoluzione napoletana del 1799 scriveva: «In una rivoluzione passiva conviene che l’agente del governo indovini l’animo del popolo e gli presenti ciò che desidera e che da se stesso non saprebbe procacciarsi».
[12] Vedi per esempio R. PETRI, Carlo Levi. Cristo si è fermato a Eboli, in Biblioteca antifascista. Letture e riletture della Resistenza, a cura di Daniele Ceschin, Università Ca’ Foscari-Istresco, Venezia-Treviso, 2006: 114-122.
[13] La trincea e i pascoli. Il socialismo di Emilio Lussu. Un documento inedito dalla nastroteca dell’Istituto Ernesto de Martino, a cura di Antonio Fanelli e Valerio Strinati, numero monografico de «Il de Martino», n. 28, 2018.
[14] A. CASELLATO, «Mio padre si era portato dietro uno schiavo». Modelli familiari, distanze sociali e culture politiche dall’Italia alla Francia, in Liberare e federare. L’eredità intellettuale di Silvio Trentin, a cura di Fulvio Cortese, Firenze University Press, Firenze, 2016: 167-185; ID., Un federalista giacobino. Fascinazione e aporie dell’«autogoverno popolare» nel pensiero di Bruno Trentin, in Bruno Trentin e la sinistra italiana e francese, a cura di Sante Cruciani, École française de Rome, Roma, 2012: 283-299.
[15] Spezzone del film di Paolo Gobetti, Le prime bande (1983), montato all’interno del documentario di Teo de Luigi, Paraloup, breve storia di un ritorno, visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=t0Q_w65V3vI. Vedi Resistenze. Quelli di Paraloup, a cura di Beatrice Verri e Lucio Monaco, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2013.
[16] M. ALLOISIO, Il riposo del guerriero, «Noi Donne», maggio 1985, cit. in N. REVELLI, Il testimone. Conversazioni e interviste. 1966-2003, a cura di Mario Cordero, Einaudi, Torino, 2014: 109.
[17] M. REVELLI, La politica senza politica. Perché la crisi ha fatto entrare il populismo nelle nostre vite, Einaudi, Torino, 2019: 17. «Il populismo assomiglia a un ospite ubriaco in un dinner party della buona società, un “invitado incómodo” che non rispetta le buone maniere a tavola, è rozzo, alza la voce e tenta fastidiosamente di flirtare con le mogli degli altri ospiti. È sicuramente sgradevole, e fuori posto, ma potrebbe anche farsi scappare di bocca una qualche verità sulla democrazia liberale, per esempio che essa si è dimenticata del proprio ideale fondante, la sovranità popolare» (ivi: 9). Attenzione: è esattamente il ruolo che nella nostra tradizione letteraria è stato assegnato a Bertoldo, il rozzo ma sagace contadino che alla corte del re può dire le verità che gli altri non dicono.
[18] Ivi: 17, a commento di B. ARDITI, La política en los bordes del liberalismo. Diferencia, populismo, revolución, emancipación, Gedisa, Barcelona, 2009.
______________________________________________________________
Alessandro Casellato, ricercatore in storia contemporanea all’università Ca’ Foscari di Venezia, dove insegna Storia dell’Italia contemporanea e di Storia orale. È condirettore dell’Istituto per la storia della Resistenza e dellas ocoietà contemporanea della Marca trevigiana e coordinatore della redazione della rivista “ Venetica”. Collabora con “Belfabor. Rassegna di varia umanità”, con “Snodi. Pubblici e privati nella storia contemporanea” e con l’Associazione italiana di storia orale. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Una “piccola Russia”. Un quartiere popolare di Treviso tra fine Ottocento e secondo dopoguerra, Verona, 1998; e I sestieri popolari, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, a cura di Stuart J. Woolf e Mario Isnenghi, Roma 2002.
_______________________________________________________________










