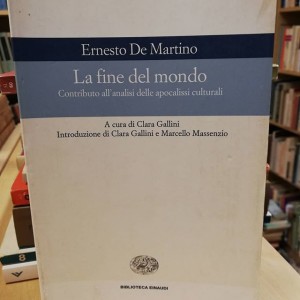Chi ha conosciuto Ernesto De Martino sa che il primo a protestare per una paludata relazione sarebbe stato lui. Procederò in modo desultorio e paratattico, come si conviene quando si deve parlare non di un professore ma di un intellettuale. Ai professori si addice il rigore, agli intellettuali l’immaginazione. Un professore svolge un mestiere dignitoso e nobile: produce, come dice Einstein, discreta del conoscibile rispetto al continuum della realtà, impone il cosmos sul caos. Questo è il suo lavoro. L’impegno dell’intellettuale è del tutto opposto: suo compito è promuovere il caos.
Un grande scrittore algerino, Denis Guedy, di cui la casa editrice Adelphi ha pubblicato un intrigante romanzo: La chioma di Berenice, racconta di Eratostene. Avendo già inteso che il mondo è una sfera – e ci sono voluti, poi, parecchi secoli per capirlo – aveva misurato la circonferenza della terra con un errore di pochi metri. Dopo avere fatto questo monumentale lavoro, si recò dal faraone, Tolomeo Filopatore, e gli presentò il risultato. Al che, il faraone gli disse: «Ma che hai fatto? Tu sei la serva che rassetta il mondo!».
Un intellettuale, il mondo, non lo rassetta, lo inventa, fornendo strumenti agli altri per reinventarlo ogni giorno. Il mondo dell’uomo, infatti, non è qualcosa che si possa incartare e consegnare alla memoria dei posteri, come si illudono alcuni. È una realtà che si fa ogni giorno facendosi e disfacendosi; una realtà, ahimè, e lo vedremo, che, non diversamente da ogni cosa che vive, è destinata a morire.
L’opera di Ernesto De Martino che più ha inciso e ancora più inciderà in futuro sulla nostra cultura, è un’opera non finita, incompleta. In qualche modo, è un insieme non ordinato di materiali. Ciò malgrado è di grande merito. Ci libera da false certezze dietro cui cerchiamo di nasconderci. Mi riferisco a La fine del mondo. Altre opere che pure sono importanti, non hanno lo stesso valore e, comunque, non riguardano quanto mi interessa discutere. La fine del mondo mette in crisi il falso cosmos in cui ciascuno di noi si riconosce. Riesce a farci andare al di là delle apparenze, oltre l’epidermide della realtà, di quanto la nostra limitata percezione ci fa ritenere tale. La realtà dell’uomo, la sua storia, come ha scritto qualcuno, è per converso fatta più di cose invisibili che visibili. Chi è stato così fortunato, nel corso della sua vita, da incontrare i sentimenti? Da vedere i valori? L’uomo è soltanto i suoi sensi? La sua struttura fisica? È solo questo? L’identità di un uomo è solo quanto c’è scritto nella sua carta di identità? È questo un uomo? Siamo ciò che di noi gli altri vedono? Siamo effettualmente questo?
Siamo un’altra cosa e tutt’insieme formiamo un’altra cosa: la storia invisibile che è in noi e che è l’essenza della nostra vita e ne fonda il senso. Questo cercava, nel mondo degli uomini, Ernesto De Martino. Voleva leggerne le strutture profonde, andare al di là dell’epidermide. Dunque, attendersi da un impegno così arrischiato e complesso un’opera ordinata, priva di contraddizioni, è fuorviante. Cercare questo in La fine del mondo ma anche in altre opere di De Martino, come Il mondo magico, significa ostruirsene la comprensione.
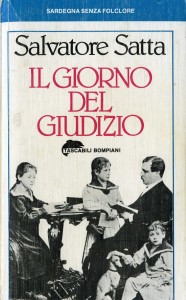 Sono stato per anni sodale con un grande intellettuale, un grande scrittore italiano, Leonardo Sciascia. Ricordo e ricorderò sempre le sue parole: «Quando morirò sulla mia tomba dovete scrivere, contraddisse e si contraddisse». Non lo abbiamo fatto. Abbiamo scritto un’altra sua affermazione solo apparentemente diversa: «Ce ne ricorderemo di questo pianeta». Tale è, infatti, la sua contraddittoria complessità da segnare il futuro possibile della nostra memoria perfino oltre la morte stessa. I professori non si contraddicono, ma gli intellettuali contraddicono e si contraddicono. Scrivono per essere contraddetti.
Sono stato per anni sodale con un grande intellettuale, un grande scrittore italiano, Leonardo Sciascia. Ricordo e ricorderò sempre le sue parole: «Quando morirò sulla mia tomba dovete scrivere, contraddisse e si contraddisse». Non lo abbiamo fatto. Abbiamo scritto un’altra sua affermazione solo apparentemente diversa: «Ce ne ricorderemo di questo pianeta». Tale è, infatti, la sua contraddittoria complessità da segnare il futuro possibile della nostra memoria perfino oltre la morte stessa. I professori non si contraddicono, ma gli intellettuali contraddicono e si contraddicono. Scrivono per essere contraddetti.
L’Italia ha avuto la fortuna, ma gli italiani non lo sanno, di avere Sebastiano Satta. Suo è il romanzo che si chiama, guarda caso, Il giorno del giudizio. A scoprire questo scrittore, a spiegarci che si tratta di un autore di grande valore, è stato uno dei più noti critici letterari del nostro tempo: George Steiner. Di Il giorno del giudizio, un romanzo non finito (abbiamo la prima parte, molto lacunosa e frammentaria e ci restano le prime due pagine della seconda parte), Steiner ha scritto che è un capolavoro assoluto. Giudizio analogo merita La fine del mondo di De Martino. Non solo non finita ma criticabile, criticabilissima da molti punti di vista. I professori possono trovare, con ragione, un numero infinito di cose discutibili. Si tratta, però, di un’opera unica e di altissima qualità.
Ecco perché insisto sulla figura dell’intellettuale, piuttosto che del professore De Martino. Un lavoro scientifico, è questa la sua forza, non deve riflettere le inquietudini di chi lo fa. Uno studioso di astrofisica, quando osserva i pianeti, non può darsi pena per il fatto che la donna che ama è distratta da un altro. Le pene, le lascia a casa. Si preoccuperà in un altro momento delle elezioni perse del suo partito. Passioni, sentimenti, amori e disamori, umori e malumori uno studioso è tenuto a metterli tra parentesi, un intellettuale, no!
Un intellettuale vero, anche quando osserva in una prospettiva scientifica la realtà, non nasconde sentimenti e passioni. Li proietta sui fenomeni che osserva o, per meglio dire, essi sono una sua proiezione. La fine del mondo non è pertanto solo lo studio delle apocalissi culturali o delle apocalissi individuali, è anche un discorso che De Martino fa a se stesso. È la manifestazione di una crisi che, prima che essere individuata nella storia, è profondamente sentita, drammaticamente vissuta.
Si potrebbe, come qualcuno ha fatto, leggere quest’opera come una sorta di testamento della cultura occidentale, come segno della fine di una civiltà; la si potrebbe cioè assumere come indizio di una rinuncia alla speranza di un mondo diverso e migliore. Bene, chi ha letto in questa chiave La fine del mondo di questa opera e di tutta l’opera di Ernesto De Martino non ha capito nulla. In La fine del mondo c’è la percezione di una crisi, c’è il sentimento di un’apocalisse che si appartiene alla società e si appartiene ad Ernesto De Martino, ma ci sono anche gli strumenti ideologici che consentono al lettore di andare oltre, di trascendere, di tracimare la crisi stessa.
Tutte le società, non diversamente dagli individui che la compongono, sono permanentemente travagliate da un’inquietudine, dal dubbio del non esserci, dalla paura di perdere la presenza nel mondo. Per esorcizzare questa paura, dal 1700 in poi, ai bambini danesi si fa imparare a memoria una poesia in cui si parla del loro grande re, Cristiano IV. Durante una disperata battaglia navale, egli rimane sulla sua nave. I suoi compagni sono stati tutti uccisi. Sta per essere sopraffatto dai nemici. Cristiano non cerca di mettersi in salvo. Resta imperterrito e fermo all’albero maestro. Nell’immaginario dei bambini danesi continua ancora a star fermo a quell’albero. È il simbolo della perduranza a resistere, della volontà che ciascuno di noi deve impegnare ogni giorno a non farsi travolgere dal caos di questo mondo.
Non si può capire Ernesto De Martino e La fine del mondo se ci si ferma al perimetro apparente del suo lavoro, se non se ne ricercano le connessioni con tutto il pensiero dell’Occidente. La storia di Ernesto De Martino non è la storia di un intellettuale di provincia. È la storia di uno studioso e di un uomo che ha scelto di stare al centro, nel down-town, del travaglio speculativo della cultura occidentale. Per leggerlo e per intenderlo, bisogna quindi tener conto di quello che è accaduto in Occidente quanto meno da un secolo a questa parte. Tutte le inquietudini della cultura occidentale contemporanea, infatti, si ritrovano, per via diretta o indiretta, nella sua opera. Qualcuno dei suoi critici lo ha accusato di essere un gran pasticcione, un confusionario. È vero: nell’opera di Ernesto De Martino c’è lo storicismo idealista, Croce, c’è lo storicismo marxista, Gramsci, c’è ancora tanto di naturalismo evoluzionista. Non a caso, la psicologia e la psicanalisi, da cui era affascinato, nascono in quest’ultimo contesto e ancora oggi operano all’interno dello stesso orizzonte assiologico. C’è anche Heidegger, e potremmo continuare. Ci sono, insomma, i nodi e gli snodi che prima di essere argomenti di studio, sono stati e sono le vigenze inquietanti della nostra cultura.
Esserne stato partecipe da protagonista – rispondo ad alcuni dei suoi critici – non poteva non portare De Martino a interessarsi di storia delle religioni: la disciplina che si occupa delle domande ultime dell’uomo sul senso del suo esserci nel mondo. Nelle opere degli storici delle religioni, De Martino cercava di fatto la risposta alle inquietudini della cultura occidentale e più ancora alle sue inquietudini come uomo.
Non penso di esagerare quando dico che i crocevia fondamentali della cultura dell’Occidente si dimensionano nel religioso. Fa riflettere che i maggiori studiosi, i padri fondatori di scienze umane, come argomento centrale della loro ricerca abbiano scelto proprio la religione, l’origine della religione. Così Auguste Comte nel Cours de philosophie positive e così il suo continuatore Emile Durkheim nelle Formes elementaires de la vie religieuse, così Spencer, così Schmidt, così Weber, così il nostro Raffaele Pettazzoni. Gli interessi di De Martino per l’ambito storico-religioso non erano dunque motivati solo da ragioni scientifiche. Gli interrogativi che egli si pone non sono quelli del professore Ernesto De Martino. Sono le trame e gli stami di un ordito più grande che è l’ordito del de Martino uomo fra gli altri uomini.
Per fare un ulteriore passo avanti e approssimarci alla comprensione delle apocalissi, bisogna ricordare che gli studiosi di storia delle religioni hanno inteso e chiarito che la percezione religiosa della realtà si dispone in una concezione del tempo diversa da quella laica. Il primo ad avere capito che il tempo non è un dato oggettivo, come noi pensavamo e continuiamo purtroppo a pensare, ma un concetto, è stato, come sappiamo, Albert Einstein. In quanto rappresentazione del flusso cronologico, questo discretum rispetto al continuum spazio-temporale è un prodotto storico. Si è determinato in modi diversi nelle diverse civiltà. I Maya, per esempio, avevano cinque calendari, cioè cinque diverse percezioni del tempo.
Tra tutte le possibili rappresentazioni del tempo nel corso storico delle culture, due si sono affermate sulle altre. La prima, che lo individua come un flusso circolare; la seconda, lineare. La concezione circolare del tempo, che ritroviamo presso tutte le civiltà dell’antico Oriente, nell’India antica, ma anche nella mitologia germanica, è inquietata da un dramma storico, l’angoscia permanente che il tempo stesso, per l’esaurirsi del ciclo dell’anno, possa finire. È questa idea, questa paura a determinare una condizione individuale e collettiva di crisi della presenza.
L’ipotesi innovativa di Ernesto De Martino è che certi complessi mitico-rituali sono la risposta elaborata da diverse civiltà per esorcizzare questa angoscia, per trascenderla. È interessante rilevare che seguendo vie completamente diverse De Martino, la storia delle religioni; Lévi-Strauss, l’algebra di Boole; i due pervengano allo stesso risultato. Quando Lévi-Strauss dice che il mito è la procedura logica attraverso la quale l’uomo sublima e annulla le contraddizioni irresolubili della prassi, sta affermando in termini diversi quanto De Martino attribuisce alle procedure mitico-rituali dirette a destorificare le frustrazioni e i drammi del vissuto.
 L’angosciosa insidia della imminenza della fine appartiene a molte culture. Per la cultura religiosa indù, ogni 360 milioni di anni, Shiva distrugge il mondo, ma alla fine questo si ricostituisce. Tutta la letteratura apocalittica dei primi secoli del cristianesimo esorcizza la temuta fine, individuando nella valle di Giosafat il luogo dove i giusti, in ultimo, avranno accesso a un’altra vita. A proposito dell’attuale conflitto Oriente-Occidente, artatamente presentato come scontro di religioni e culture diverse, è bene ricordare che il cristianesimo è una religione di origine orientale. Gesù parlò in aramaico nel momento in cui andò incontro alla morte e chiamò il Padre. Analoga angoscia della fine ritroviamo nella mitologia germanica. Il Ragnarök, apocalisse nordica, è ancora più devastante rispetto alle apocalissi orientali: anche gli dèi muoiono. Eppure anche lì si ricomincia. È la concezione circolare del tempo a esitare in queste rappresentazioni di una realtà che sempre finisce per un eterno ricominciare. Conosciamo lo splendido saggio di Eliade Il mito dell’eterno ritorno, ma l’idea dell’eterno ritorno è di Nietzsche, ripresa dalla cultura filosofica indiana. Anche questa idea di un eterno ricominciare, dunque, è di provenienza orientale.
L’angosciosa insidia della imminenza della fine appartiene a molte culture. Per la cultura religiosa indù, ogni 360 milioni di anni, Shiva distrugge il mondo, ma alla fine questo si ricostituisce. Tutta la letteratura apocalittica dei primi secoli del cristianesimo esorcizza la temuta fine, individuando nella valle di Giosafat il luogo dove i giusti, in ultimo, avranno accesso a un’altra vita. A proposito dell’attuale conflitto Oriente-Occidente, artatamente presentato come scontro di religioni e culture diverse, è bene ricordare che il cristianesimo è una religione di origine orientale. Gesù parlò in aramaico nel momento in cui andò incontro alla morte e chiamò il Padre. Analoga angoscia della fine ritroviamo nella mitologia germanica. Il Ragnarök, apocalisse nordica, è ancora più devastante rispetto alle apocalissi orientali: anche gli dèi muoiono. Eppure anche lì si ricomincia. È la concezione circolare del tempo a esitare in queste rappresentazioni di una realtà che sempre finisce per un eterno ricominciare. Conosciamo lo splendido saggio di Eliade Il mito dell’eterno ritorno, ma l’idea dell’eterno ritorno è di Nietzsche, ripresa dalla cultura filosofica indiana. Anche questa idea di un eterno ricominciare, dunque, è di provenienza orientale.
La Chiesa ogni anno rifonda il mondo. Anzi ogni giorno durante la messa, perché è scritto: «mortem nostram moriendo destruxit,/ et vitam resurgendo reparavit» (Prefatio Paschalis I). Veniamo, dunque, permanentemente invitati a credere in questa morte e rinascita continua. Ma dobbiamo credere solo in una concezione circolare del tempo che non prevede evoluzione? Anche Pasolini raccomandava di stare molto attenti a non confondere l’idea di evoluzione con l’idea di progresso; non possiamo abbandonarci a una storia dell’uomo che sia solo un dispiegarsi in un cerchio di eventi (o vichianamente in cerchi) immutabile!
Fin dai tempi arcaici, l’uomo accanto a una rappresentazione circolare del tempo, ne ha concepita una lineare. Questa concezione lineare del tempo nasce, come ha chiarito Lommel, nel momento in cui nelle società mesopotamiche e soprattutto nella società egiziana si determina l’esigenza di registrare la successione dei re e dei regni. Solo una successione lineare, non circolare, legittima la continuità del potere. Questa esigenza politica, prodotto di una evoluzione economica, la nascita dell’agricoltura, ha imposto l’idea che il tempo non è un cerchio che ritorna sempre su sé stesso ma una freccia destinata all’infinito.
Nella freccia del tempo, cioè nella concezione lineare e laica del tempo, la via d’uscita dalla realtà è l’utopia. È vero, come dice Italo Calvino, che tutte le utopie, del resto basta leggere Platone, recuperano il passato per disegnare il futuro. I gesuiti, nelle “réducciones” del Paraguay, fingevano il comunismo dei cristiani delle origini. Marx stesso, nel momento in cui delineava la più grande utopia sognata dall’uomo, indica come termine ultimo quella comunità dei beni che gli antropologi alla Morgan, da lui ben conosciuti, ipotizzano come condizione originaria delle società. È vero, dunque, che le utopie, nel momento in cui propongono il futuro, ripropongono il passato. A differenza però dei miti, che rimandano la soluzione delle contraddizioni irresolubili della prassi a una Città Celeste, le utopie rinviano a una Città Terrestre.
Il mito, in sostanza, ed ha ragione De Martino, trascende la storia; l’utopia, al contrario, storicizza il trascendente. L’aspirazione a un mondo senza contraddizioni, a un mondo senza conflitti, è una proiezione permanente del bisogno irrinunciabile di una realtà migliore e diversa, di un Eden che non c’è e che tuttavia dobbiamo credere possibile in questo mondo. È vero, come hanno notato critici benevoli e malevoli dell’opera di De Martino, che in lui c’è una oscillazione continua tra i due diversi poli. Ma io chiedo, perché mi voglio e voglio inquietare: siamo proprio sicuri che l’attesa della fine del mondo, l’apocalisse da risolvere qui o altrove, sia solo un insieme di prodotti storico-sociali di segno mitico o utopico, e non sia invece un fatto strutturale della psiche umana, della percezione umana del futuro? Non fa pensare il fatto che, nel momento in cui grandi studiosi di fisica della materia e di astrofisica, da Prigogine a René Thom, danno per scontata la fine del mondo e del tempo stesso, indicano come segni di questa fine gli stessi fenomeni che sono descritti nella Apocalisse di Giovanni e nella Edda di Snorri?
La scienza prevede, per il nostro mondo, un futuro di ghiacci e fiamme. Forse nei miti si dice qualcosa di diverso? Ma perché andare così lontano. Fermiamoci al presente. Non ricordo Spengler, Klages, Jünger, Rosenberg, filosofi cioè del tramonto dell’Occidente. Mi soffermo sulle parole di chi a proposito di La fine del mondo di De Martino ha scritto: «davvero impressionante la distanza che ci separa da pagine scritte non molti anni fa». Voglio dire che di impressionante c’è solo la grande attualità di queste pagine.
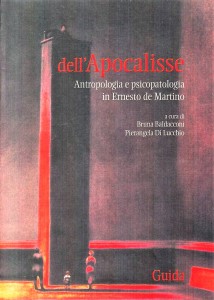 Noi, infatti, stiamo vivendo, senza averne consapevolezza, la fine di un mondo. Marx, che non sempre diceva cose giuste ma ogni tanto ci azzeccava, sosteneva che gli uomini fanno la storia e non sanno di farla. È proprio vero. La limitatezza della nostra misura temporale ci impedisce di cogliere l’estensione dei grandi processi storici. Romolo Augustolo, che fu l’ultimo imperatore romano, riunì suoi amici e parenti e si fece nominare imperatore. Non aveva capito, lui che se ne autoeleggeva a capo, che l’Impero Romano era già tramontato da tempo. Niuna maraviglia, avrebbe detto Vannuccio Biringuccio, se gli uomini del nostro tempo non hanno percezione che la cultura alla quale apparteniamo, dalla quale veniamo e dalla quale non ci possiamo liberare, dopo aver raggiunto il vertice con i maîtres à pensér del Settecento illuminista, questa cultura è sul punto di spegnersi. L’Occidente, per giocare con le parole, è alla fine di quella che Borges chiama la strada d’Occidente. Una ragione, ma non la sola, dell’esaurirsi di questa cultura è il fatto che l’Europa sta conoscendo, anche per effetto di grandi e inarrestabili processi migratori, come conobbe quanto meno a partire dal sesto millennio avanti Cristo, un grande mutamento antropologico.
Noi, infatti, stiamo vivendo, senza averne consapevolezza, la fine di un mondo. Marx, che non sempre diceva cose giuste ma ogni tanto ci azzeccava, sosteneva che gli uomini fanno la storia e non sanno di farla. È proprio vero. La limitatezza della nostra misura temporale ci impedisce di cogliere l’estensione dei grandi processi storici. Romolo Augustolo, che fu l’ultimo imperatore romano, riunì suoi amici e parenti e si fece nominare imperatore. Non aveva capito, lui che se ne autoeleggeva a capo, che l’Impero Romano era già tramontato da tempo. Niuna maraviglia, avrebbe detto Vannuccio Biringuccio, se gli uomini del nostro tempo non hanno percezione che la cultura alla quale apparteniamo, dalla quale veniamo e dalla quale non ci possiamo liberare, dopo aver raggiunto il vertice con i maîtres à pensér del Settecento illuminista, questa cultura è sul punto di spegnersi. L’Occidente, per giocare con le parole, è alla fine di quella che Borges chiama la strada d’Occidente. Una ragione, ma non la sola, dell’esaurirsi di questa cultura è il fatto che l’Europa sta conoscendo, anche per effetto di grandi e inarrestabili processi migratori, come conobbe quanto meno a partire dal sesto millennio avanti Cristo, un grande mutamento antropologico.
È una realtà della quale non abbiamo effettiva e piena percezione. Probabilmente, pensiamo che il problema del cambiamento antropologico del nostro continente sia semplicemente riconducibile alle polemiche tra Bossi e Fini. Non si tratta di questa pochade. Noi stiamo vivendo, e non ce ne rendiamo conto, una svolta epocale nella storia dell’umanità: una fine e sperabilmente un principio.
Che dire allora di Ernesto De Martino e della impressionante attualità di La fine del mondo? Che dire di chi ha elaborato il concetto di ethos del trascendimento, che, prima di essere una prospettiva scientifica, è un progetto per il superamento del tramonto che stiamo vivendo? Come rifiutare questa utopia? Come non apprezzare nel suo giusto valore un intellettuale che riesce, malgrado tutto, ancora a farci sperare?
Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
[*] Si pubblica in anteprima un testo che fa parte del volume postumo Vincere il drago. Tempo, storia, memoria, di Antonino Buttitta, prossimamente in stampa presso l’Editore Di Lorenzo, a cura di Emanuele Buttitta. Questo testo, scritto in occasione di un Convegno organizzato dalla Facoltà di lettere e filosofia della Università della Basilicata, nel cinquantenario (1952-2002) della “spedizione etnologica” di E. de Martino, è contenuto nel volume Dell’Apocalisse. Antropologia e psicopatologia in Ernesto De Martino, a cura di B. Baldacconi, P. Di Lucchio, Guida editore, Napoli, 2005.
__________________________________________________________________________________
Antonino Buttitta (1933-2017), docente dell’Università di Palermo, dove ha insegnato Antropologia culturale e Semiotica. È stato preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dal 1979 al 1992. Ha fondato e diretto numerose riviste, tra le quali: Uomo&Cultura, Nuove Effemeridi, Archivio Antropologico Mediterraneo. Tra le sue opere si segnalano: Cultura figurativa popolare in Sicilia (1961); Ideologia e folklore (1971); La pittura su vetro in Sicilia (1972); Pasqua in Sicilia (1978); Semiotica e antropologia (1979); Il Natale. Arte e tradizioni in Sicilia (1985); Percorsi simbolici (1989); L’effimero sfavillìo. Itinerari antropologici (1995); Dei segni e dei miti. Un’introduzione all’antropologia simbolica (1996); Il mosaico delle feste (2003); Orizzonti della memoria. Conversazioni con Antonino Cusumano (2015); Mito, fiaba, rito (2016). Postumo è stato pubblicato il volume Antropologia e letteratura (2018), scritto con Emanuele Buttitta.
_______________________________________________________________