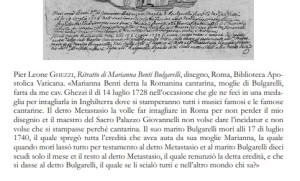di Rosy Candiani [*]
Il mito di Didone è stato raccontato per più di duemila anni con trasmigrazioni geografiche e culturali, e con trasformazioni più o meno significative: ogni forma di ri-narrazione del resto è segno di vitalità della storia ma anche una forma di interpretazione e di iscrizione della storia stessa nelle coordinate di gusto e ideologiche del momento in cui viene ripresa (Bono-Tessitore 1998).
Nonostante Didone – Elyssa sia una figura orientale e nord-africana, la cui storia è attestata almeno dal terzo secolo a.C., il mito occidentale di Didone posa la sua fortuna essenzialmente sui versi del quarto libro dell’Eneide, dove Virgilio lo raccoglie dalle fonti precedenti e racconta, sullo sfondo storico e ideologico della Roma di Augusto.
Fin dall’inizio e tutta la storia della passione della regina per Enea è presentata come “follia d’amore”, gravata dalla percezione delle connotazioni negative di una passione violenta e incontrollabile, pronta a degenerare in conseguenze funeste, contrarie alle regole di comportamento sociale e religioso.
“Ardet amans Dido traxitque per ossa furorem” (Eneide IV, v. 101): ha assorbito nelle ossa il furore morboso.
“Furor” è il termine che caratterizza le reazioni e i gesti di Didone: nell’episodio ricorre tredici volte nelle diverse declinazioni: “furor – furibunda – furens – furiis”, sia nella narrazione del narratore, sia nelle osservazioni degli altri personaggi. Invece, a proposito di se stessa, la regina ricorre a due termini estremamente significativi e patetici: “demens” (Eneide IV, v.370) e “insania (Eneide IV, v.595), con i quali esprime la perdita della “mente”, cioè l’abdicare delle facoltà razionali alla “insania”, la malattia, alla follia incontrollabile; “inops animi “(Eneide IV, v. 300), senza più la facoltà di controllo, Didone si lascia dominare dalla funesta passione che esplode in un crescendo progressivo; cancellando la dignità del suo ruolo,”bacchatur per urbem”, vaga per la città con gesti e abiti discinti consoni alle Baccanti, le Menadi invasate del corteo di Dioniso, finché il funesto delirio la porta al gesto finale del suicidio.
 Attraverso i secoli, il mito di Didone si perpetua nei versi e sulle scene fino ad essere il soggetto del grande capolavoro di Pietro Metastasio, La Didone abbandonata nel 1724. Con un grande coup de thêàtre che contrasta le convenzioni del teatro musicale dell’epoca, l’opera si chiude con lo spettacolare suicidio sull’altare in fiamme. Ma il gesto nasce in questo caso non dalla follia obnubilante, ma dalla lucida, disperata constatazione dell’assenza, per la protagonista, di interlocutori affidabili, del tradimento diffuso e dell’isolamento assoluto dopo la partenza di Enea.
Attraverso i secoli, il mito di Didone si perpetua nei versi e sulle scene fino ad essere il soggetto del grande capolavoro di Pietro Metastasio, La Didone abbandonata nel 1724. Con un grande coup de thêàtre che contrasta le convenzioni del teatro musicale dell’epoca, l’opera si chiude con lo spettacolare suicidio sull’altare in fiamme. Ma il gesto nasce in questo caso non dalla follia obnubilante, ma dalla lucida, disperata constatazione dell’assenza, per la protagonista, di interlocutori affidabili, del tradimento diffuso e dell’isolamento assoluto dopo la partenza di Enea.
Il libretto concepito da Metastasio presenta numerose scelte sperimentali e fuori dalle convenienze teatrali correnti. La sua Didone non è protagonista per la durata della sua presenza scenica, e nemmeno per l’intonazione delle consuete arie di paragone, ma per la forte connotazione drammatica del ruolo. Tutte le arie cantate da Marianna Benti Bulgarelli, fatta eccezione per la celebre “son regina e sono amante” con cui entra in scena, sono fortemente “drammatizzate”: presentano una coesione molto forte con i recitativi, nel contenuto e nella forma – il musicista Domenico Sarro ricorre spesso al recitativo accompagnato e all’arioso per questo ruolo –, sono arie parlanti, se non dialoghi in forma di aria, con didascalie implicite, a-parte, forme allocutorie con l’io-Didone che si rivolge al suo interlocutore o al pubblico. Le arie enfatizzano lo scontro con Enea e la sua decisione di lasciare Cartagine, che Metastasio introduce fin dalla parte finale del primo atto.
Qui, nella scena finale, la diciottesima, che si chiude con l’altrettanto nota aria di Enea “Se resto sul lido”, si svolge il commiato-scontro tra Enea e Didone che termina, a metà scena, con l’aria di uscita della regina. Le ultime battute del recitativo sigillano il distacco e la diversità di sentire dei due protagonisti:
DIDONE Lasciami ingrato.
ENEA E pur a tanto sdegno
Non hai ragion di condannarmi.
DIDONE Indegno.
La rima ricca sottolinea la clausola e avvia verso l’aria, una lunga aria di dodici settenari, che inizia in modo brusco, con una interrogativa e una inversione tra predicato e soggetto che non rispondono certo alla etichetta un po’ abusata della cantabilità metastasiana. In realtà Didone con molta naturalezza nel moto d’ira riprende le parole di Enea «Non ha ragione ingrato / Un core abandonato / Da chi giurogli fé?». Si rivolge poi al pubblico, sollecitando la partecipazione e, forse, risvegliando l’attenzione intorpidita, con l’allocuzione patetica, ma anche con l’uso degli indicatori di persona e con l’imperativo: «Anime innamorate,/ Se lo provaste mai / Ditelo voi per me».
Parallelamente, nella seconda parte dell’aria, i primi tre versi si rivolgono – direttamente, con i pronomi di prima e seconda persona – a Enea e concludono il discorso del recitativo: «Perfido tu lo sai / Se in premio un tradimento / Io meritai da te». Con Enea non c’è più apertura per le parole, l’ira lascia solo spazio alla mimica, al gesto dell’abbandono; ma Didone conclude l’altro dialogo, quello aperto con il pubblico, riprendendo l’espressione “Anime innamorate”, con una considerazione interrogativa sentenziosa, ma concretamente calata nella propria condizione: «E qual saria tormento /Anime innamorate / Se questo mio non è?».
Didone torna in scena al centro e alla fine del secondo atto; poi, dopo un’assenza di ben dieci scene, nel finale del terzo, dalla breve aria che segna il suo ingresso (III.10.) al finale, Didone chiude il secondo atto sola in scena. Anche in questo caso, il Metastasio dedica molta attenzione alla costruzione dei raccordi nel recitativo e alle formule che offrono spazio alla espressività della Romanina. Nel recitativo, prima dell’aria “Va lusingando amore”, sembra preparare il canto con una doppia clausola: la prima concentrata su Enea sull’amore che fortemente la avvince; i pronomi a inizio e fine verso – “mi /sui”–, la figura della derivatio e il chiasmo, il nodo che incrocia e lega i due versi in sequenza, sottolineano il legame che non riesce a spezzare:
Mi piace Enea sdegnato, ed amo in lui
X
Com’effetti d’amor gli sdegni sui.
Seguono tre versi con i quali Didone si rivolge ai Numi, osando un paragone tra la propria condizione e i loro amori (di nuovo l’insistita presenza dei pronomi, soprattutto l’io- mio in rima).
Poi Didone esce di scena e la situazione precipita senza un suo intervento: la sua entrata, con la breve aria all’inizio della scena decima, prelude, è presentimento della catastrofe, ma non consapevolezza. Chiusa nelle sue illusioni d’amore, Didone è stata fisicamente e mentalmente lontana dall’azione: le parole con cui si ripresenta mostrano che non c’è soluzione di continuità nei suoi pensieri. Metastasio riprende il monologo con cui aveva lasciato la scena nel secondo atto e ad esso si collega nell’aria con una serie di raccordi:
Va lusingando <———— ———->Va crescendo
Sento- momento <————- ———> sento- tormento
Duolo <————————- ———–> tormento
e l’invocazione finale agli dèi.
| II.17 |
Va lusingando amore
Il credulo mio core
Gli dice
Sei felice,
Ma non sarà così.
Per poco mi consolo,
Ma più crudele io sento
Poi ritornar quel duolo
Che sol per un momento
Dall’alma si partì.
III.10.
Va crescendo
Il mio tormento
Io lo sento
E non l’intendo
Giusti dèi che mai sarà?
Da questo momento Didone si confronta con i personaggi che crede fedeli – Selene, Araspe e Osmida – scoprendone progressivamente i tradimenti. Non ci sono arie per esprimere la sua disperazione, c’è la lucida constatazione della impotenza della ragione e dei sentimenti nella quotidianità dei rapporti umani: il Metastasio affida – altra scelta sperimentale e innovativa – la riflessione sentenziosa al recitativo (III.16.): «Ó perso ogni speranza / Non conosco timor: ne’ petti umani / il timore, e la speme / Nascono in compagnia, muojono insieme». Di fronte alla insufficienza della parola Didone non “va a morire cantando”, ma sceglie il gesto, tragico, definitivo e silenzioso del suicidio che corrisponde al lungo arioso strumentale finale.
In questa rilettura della tragedia e del mito di Didone, il libretto del Metastasio è sicuramente debitore dell’evoluzione razionalistica del pensiero tardo secentesco e della geometria degli affetti post-cartesiana; ma altrettanto sicuramente è determinato dai meccanismi teatrali e dalla composizione della compagnia di canto con cui il poeta decise di collaborare direttamente, senza mediazioni letterarie, in piena consapevolezza delle esigenze della macchina del teatro professionistico. In particolare per il personaggio di Didone, il ruolo è pensato e realizzato sulla dirompente personalità della sua interprete e sulle sue qualità attoriali più che canore.
Marianna Benti Bulgarelli era stata l’artefice della scelta del giovane Metastasio di dedicarsi alla carriera di poeta di teatro e il poeta si prestò a subordinare le regole astratte alle effettive esigenze del teatro, in questo caso alle qualità dell’interprete; grazie alla Romanina, aveva avviato un periodo di crescente successo itinerante, nelle più importanti piazze teatrali italiane, coronato dalla chiamata a Vienna come Poeta Cesareo, nel 1730.
Allora, come in una sorta di circolare proiezione dalle scene alla vita, la cantante si troverà a vivere il ruolo della “abbandonata”, e come la sua Didone in scena chiuderà la sua esistenza nella afasia della lontananza e nella gabbia asfissiante delle convenienze sociali; su questa vicenda personale vorrei chiudere con qualche osservazione che apre prospettive su un atteggiamento femminile – sindrome di Pigmalione o complesso di Didone – che accomuna molte donne di successo e affascinanti, contagiate a un certo punto della loro vita dal morbo letale della valorizzazione ed elevazione al loro fianco di un uomo di modeste qualità, perlomeno sul piano umano.
Acclamato Poeta Imperiale nel 1730, Metastasio, abile regista della propria persona e del proprio futuro, comprende la necessità di rompere definitivamente con il proprio passato di poeta itinerante, nonché i rapporti con l’ormai ingombrante artefice del suo successo (con la quale conviveva a Roma insieme al marito Domenico Bulgarelli e al proprio fratello). Con sottile diplomazia, e con l’ausilio dell’abate Giuseppe Riva, ministro del Duca di Modena a Vienna, tiene lontana da Vienna la Benti Bulgarelli, definita poco amabilmente dal Riva “la maga Circe”, costringendola a un rapporto epistolare filtrato attraverso il freddo linguaggio delle convenienze e della “filosofia”, condito da allusivi rimproveri e censure delle rimostranze per sfuggire gli argomenti più spinosi, e anche da numerose lamentevoli diquisizioni sul clima e sulla salute.
Le lettere alla Benti Bulgarelli sono esemplari dell’atteggiamento del Metastasio nei confronti dell’universo femminile e del sistema “immunitario” con cui elude il coinvolgimento compromettente (Morelli 1998). La Benti si adeguò, sforzandosi di non angustiare il poeta: accettò, con signorile sensibilità, il ruolo impostole, e fermò a Venezia il suo viaggio verso Vienna, forse per un decreto dell’Imperatore, piuttosto che per un pretesto “ordito” con la mediazione del Riva, somatizzando progressivamente l’ingratitudine del Metastasio.
Una commovente lettera della Benti Bulgarelli al Riva mostra la sincera sofferenza, celata nello sforzo di autocontrollo:
«Le distinte e rare maniere del sig. Metastasio hanno tanta forza, che quasi a chi ha goduto la sorte di esserne per molti anni in possesso muovono l’infinito timore di restarne priva; e bisogna tutto lo spirito della mente per regolare i moti del cuore; costanza che con troppa pena si compra! Vada però la nave in porto, e sia il resto tutto in abbandono all’instabile fortuna» (Carducci 1902).
Razionalità e moti del cuore, la metafora della nave, come in un’aria del Metastasio: o viceversa. Lo struggimento d’amore dei personaggi da lei interpretati e creati dal Metastasio, riproduce la mobilità del cuore umano e forse per questo la scrittura del Poeta è così vicina alle espressioni accorate e struggenti, ma profondamente misurate e dignitose con le quali la Benti Bulgarelli riassume a Giuseppe Riva lo strazio dell’abbandono.
«Giacché conservate tanta amicizia per l’Amico, conservatelo a me, sollevatelo, mantenetelo allegro più che potete, e crediate ch’io non ho altro pensiero al mondo che quello; e se in alcun tempo mai io mi contristo, è perché troppo io conosco il di lui merito, e che l’essere costretta a vivere divisa da lui è il maggior dolore ch’io senta. Sono però così risoluta di non pregiudicare alla di Lui stima, che soffro pazientemente la tirannia di chi permette tanta crudeltà» (Carducci 1902).
Della Romanina non restano lettere nell’epistolario del Metastasio, che si affrettò a chiedere al fratello Leopoldo la distruzione delle missive in possesso della cantante: «queste non possono servir che d’imbarazzo, onde ardetele tutte, come fedelmente lo stesso ho fatto anch’io delle sue».
Dalle poche risposte del Poeta, conservate nel copialettere, possiamo dedurre nella cantante il progressivo spegnersi delle rimostranze e della speranza di rivederlo, interpretate dal Metastasio cone ritorno alla ragione:
«adesso vi riconosco nelle vostre lettere, e la vostra saviezza mi fa compiacere del presente e dà un’altra faccia anche al passato. Avete superata la mia speranza».
Nella società “delle buone maniere” la Virtuosa vituperata si esprime con pudica sensibilità fuori del comune, come le eroine delle scene del Metastasio, e si apparta morendo poco dopo in silenzio, come Didone, mentre ben più fredde suonano le parole del suo pupillo, acclamato maestro dei moti del cuore.
Così, in una sorta di identificazione con la Didone di cui era stata ispiratrice e inevitabile interprete, davanti al silenzio della parola, alla logorrea afasica dei convenevoli, e della incomprensione – «io non ardisco che passi un mese, in cui io vado esente da qualche rimprovero» (19-1-1732) – Marianna Benti Bulgarelli si spegne, senza sentori di malattia, nel disagio che il raffinato poeta dei sentimenti non seppe mai leggere.
Perché – per riprendere una frase di Jerome K. Jerome – «le donne hanno lo strano istinto di aggrapparsi al pugnale che le trafigge»; oppure, come recita Didone nella splendida Lamentaciòn della poetessa messicana Rosario Castellanos (Bono 1998, 330) «perché il dolore – cos’altro sono io se non dolore? – mi ha fatto eterna».
Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020
[*] Il presente contributo è stato presentato al convegno La follia, tra creazione e distruzione, VI Convegno internazionale di studi mediterranei, Tunisi,24/25 febbraio 2020.
Riferimenti bibliografici
Bono Paola – Tessitore Maria Vittoria 1998, Il mito di Didone. Avventura di una regina tra secoli e culture, Milano, Bruno Mondadori.
Candiani Rosy 2004, La cantante e il librettista: il sodalizio artistico del Metastasio con Marianna Benti Bulgarelli, in Il canto del Metastasio, Atti del convegno di studi. Venezia (14-16 dicembre 1999), a c. di Maria Giovanna Miggiani, Bologna, Forni: 671-699.
Carducci Giosuè 1902, Ceneri e faville. Serie III. 1877-1901, Bologna, Zanichelli: 255-260.
Metastasio Pietro 1724, Didone abbandonata, Napoli, Ricciardo.
Metastasio Pietro 1943-1954, Epistolario III in Tutte le Opere, Bruno Brunelli ed., Milano, Mondadori.
Morelli Giovanni 1998, Paradosso del farmacista. Il Metastasio nella morsa del tranquillante, Venezia, Marsilio.
Vaglio Mariangela Galatea 2009, http://ilnuovomondodigalatea.wordpress.com/2009/07/06/il-complesso-di-didone-ma-perche-le-donne-toste-perdono-la-testa-per-gli-enea/
Virgilio 1976, Eneide, Libro quarto, Antonio Pozzi ed., Milano, Signorelli.
______________________________________________________________
Rosy Candiani, studiosa del teatro e del melodramma, ha pubblicato lavori su Gluck, Mozart e i loro librettisti, su Goldoni, Verdi, la Scapigliatura, sul teatro sacro e la commedia musicale napoletana. Da anni si dedica inoltre a lavori sui legami culturali tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sulle affinità e sulle identità peculiari delle forme artistiche performative. I suoi ultimi contributi riguardano i percorsi del mito, della musica e dei concetti di maternità e identità lungo i secoli e lungo le rotte tra la riva Sud del Mediterraneo e l’Occidente.
_______________________________________________________________