di Elio Rindone
Sarebbe superfluo ricordare, se troppo spesso non ce ne dimenticassimo, che le nostre convinzioni dipendono in larga misura dalle informazioni di cui disponiamo, e che, perciò, nuove informazioni possono indurci a cambiare idea. Mi limito a un solo esempio, preso dal nostro tempo: la formazione religiosa dei cattolici prima del Concilio Vaticano II portava a concepire la fede come l’adesione a un elenco di verità proposte da un magistero custode di una divina rivelazione contenuta nella Bibbia e nella Tradizione. La rivoluzione nel campo dell’esegesi biblica avvenuta nel secolo scorso, e di cui si è avuta notizia soprattutto nel periodo post-conciliare, ha dimostrato, invece, che alcune di quelle dottrine non avevano alcun fondamento nella Scrittura, sicché chi ha avuto la possibilità e la volontà di acquisire quelle informazioni ha abbandonato certezze che sembravano incrollabili.
Ma è ugualmente ovvio che, se le tesi in questione appaiono garantite da un’autorità che, come quella ecclesiastica, si autodefinisce, ed è da molti creduta effettivamente, di origine divina, cambiare le proprie convinzioni non è affatto facile. Si richiedono coraggio e determinazione per affrontare un lungo e non di rado doloroso travaglio, che può portare ad abbandonare, per amore della verità, quella che si credeva verità ma che non appare più tale.
Possiamo trovare conferma di tutto ciò se proviamo a spostarci nell’Europa dei primi decenni del XII secolo, quando studenti e professori, provenienti da diverse nazioni, cominciano ad associarsi in corporazioni, creando quelle scuole di alta cultura che si chiamarono università. La crescente domanda di istruzione, la conoscenza di testi divenuti accessibili grazie ai contatti col mondo arabo e la libertà di cui hanno inizialmente goduto, hanno fatto delle università centri culturali di grande vivacità, almeno sino a quando esse non furono poste sotto il controllo delle autorità politiche e soprattutto religiose. Nel XIII secolo infatti, come scrive Jacques Le Goff, gli intellettuali, «sottomessi alla sede apostolica, che li favorisce per addomesticarli, […] dovettero dare un addio all’indipendenza, allo spirito disinteressato degli studi e dell’insegnamento [… al punto da diventare ormai] in una certa misura, ma senza alcun dubbio, degli agenti pontifici»[1].
I testi che circolavano in quelle università erano anzitutto quelli dei pensatori cristiani dei secoli precedenti, la cui teologia era stata decisamente influenzata da Platone, spesso riletto in chiave neoplatonica dato che dei suoi dialoghi si conosceva in realtà solo il Timeo. Si comprende, perciò, quale novità dirompente abbia costituito per gli intellettuali del XII secolo la scoperta, avvenuta proprio in questo periodo grazie ai contatti col mondo arabo, delle opere di Aristotele, di cui prima si conoscevano solo gli scritti, e non tutti, di logica.
Per quanto riguarda il tema della creazione, il corpus aristotelico, e in particolare la Fisica, suggeriva infatti una prospettiva molto differente da quella di Platone – per di più interpretato alla luce di Plotino, che fa derivare tutte le cose dall’Uno – che, col mito del demiurgo che plasma la kora, un ricettacolo o una regione concepita come qualcosa di ontologicamente negativo e quindi quasi un nulla, sembrava adombrare l’idea biblica di un mondo opera di un Creatore.
Aristotele, invece, concepisce il mondo come un tutto che ha una sua consistenza e una sua intellegibilità, eternamente ordinato e già strutturato quale oggi ci appare. Un mondo, quindi, autonomo nella sua composizione di materia e forma, e solo per il suo continuo divenire, inteso come passaggio dalla potenza all’atto, dipendente da un Motore immobile, causa finale ma non efficiente. Si capisce perciò come Aristotele, specialmente nel campo della metafisica e della filosofia naturale, fosse a lungo considerato dall’autorità ecclesiastica un autore sospetto, tanto che nel 1231 Gregorio IX rinnoverà ancora i precedenti divieti di leggere le sue opere «finché non fossero state esaminate e purgate dei loro errori».
Ma nonostante le censure, i testi di Aristotele finiranno col diventare parte integrante del programma di studio delle università, anche se la diffidenza dell’autorità ecclesiastica nei confronti dei pensatori che apprezzano lo Stagirita non verrà meno per tutto il XIII secolo, come dimostrano le condanne, che comprendono persino alcune tesi di Tommaso d’Aquino, pronunciate dal vescovo di Parigi, Étienne Tempier, nel 1270 e nel 1277, e da quello di Canterbury, il francescano John Peckham, nel 1287.
In un simile clima, riscoprendo pure echi delle dottrine epicuree e stoiche, si afferma, come è ovvio, un nuovo interesse per il mondo; entrano presto in crisi certezze acquisite e si comincia a vedere nella natura – scrive Nicola Abbagnano – una «forza motrice, ordinatrice e vivificatrice, … [a cui si riconosce] una certa autonomia: si rende cioè possibile spiegare la natura con la natura […] anche se la natura e l’uomo vengono concepiti non in opposizione al trascendente ma come manifestazioni del trascendente medesimo»[2].
Di questo filone di pensiero due sono i rappresentanti più significativi: il francese Amalrico di Bène (1150-1207) e il belga Davide di Dinant (1160-1214). Il primo, insegnante di filosofia e teologia all’Università di Parigi, affermava in una prospettiva panteistica che tutte le cose sono per essenza una sola. Da tali premesse discendeva, tra l’altro, una svalutazione del ruolo salvifico della Chiesa – contro i cui privilegi già lottavano vari movimenti ereticali, espressione anche di un malcontento di carattere economico-sociale – in quanto il divino era per Amalrico già presente nel mondo della natura. Ma delle sue dottrine sappiamo ben poco perché queste nel 1204 furono condannate dall’università di Parigi e ad Amalrico fu ordinato di abiurare. Nel 1209 quattordici prelati suoi seguaci vennero arrestati: quattro abiurarono, mentre gli altri furono bruciati vivi. Nel 1210, a seguito di una speciale sentenza di scomunica, le ossa di Amalrico furono riesumate e gettate in terra non consacrata.
Il secondo, Davide di Dinant, che ha probabilmente insegnato all’Università di Parigi, oltre che a Scoto Eriugena si ispirava alla Fisica di Aristotele, che poteva leggere direttamente grazie alla sua conoscenza del greco. Pare che egli affermasse che materia e intelletto non sono realmente distinti ma espressione dell’unica sostanza divina. Mentre Amalrico identificava Dio con l’essenza o forma di tutte le cose, Davide lo identificava con l’essere in potenza; «e poiché, come scrive ancora Abbagnano, l’essere in potenza è la materia prima» egli finiva con l’identificare Dio con la materia. Anche di lui sappiamo poco perché nel 1210 i suoi scritti, come quelli di Amalrico, furono ovviamente condannati dall’autorità ecclesiastica locale ad essere bruciati, e chiunque avesse conservato le sue opere sarebbe stato dichiarato eretico.
Ma nel 1215 queste dottrine panteistiche furono condannate formalmente non più da autorità locali bensì da un Concilio ecumenico, il Lateranense IV, voluto dal papa Innocenzo III. Il concilio, che ribadisce che «Una è la chiesa universale dei fedeli, fuori della quale nessuno assolutamente si salva», anzitutto proclama solennemente, oltre alla dottrina della transustanziazione, quella della creazione dal nulla: il vero Dio «Con la sua onnipotente potenza fin dal principio del tempo creò dal nulla l’uno e l’altro ordine di creature: quello spirituale e quello materiale, cioè gli angeli e il mondo, e poi l’uomo, quasi partecipe dell’uno e dell’altro, composto di anima e di corpo». Quindi, dopo aver condannato un opuscolo di Gioacchino da Fiore, si occupa di Amalrico: «Riproviamo e condanniamo anche la stravagante opinione dell’empio Amalrico; la cui mente è stata così accecata dal padre della menzogna, che la sua dottrina non tanto deve giudicarsi eretica, quanto insensata».
E anche se sono passati ormai più di 50 anni da una simile condanna al massimo livello, Tommaso ritiene necessario confutare le ‘false’ dottrine panteistiche, accomunando nella Somma teologica quelle ‘insensate’ di Amalrico e quelle assolutamente ‘stolte’ di Davide: alcuni «hanno affermato che Dio è il principio formale di tutte le cose. Tale, si dice, fu l’opinione dei discepoli di Amalrico. [Un altro] errore è quello di Davide di Dinant, il quale stoltissimamente affermò che Dio è la materia prima. Tutto ciò contiene una falsità manifesta» (Iª q. 3 a. 8). Ciononostante, qualcosa delle dottrine di Amalrico, e soprattutto di quelle di Davide che sembrano addirittura preludere alla visione del mondo della natura suggerita dalla scienza contemporanea, sopravvisse per secoli, arrivando sino a Giordano Bruno.
Con Tommaso d’Aquino (1225-1274) ci troviamo dunque in pieno XIII secolo: il giovane frate domenicano è così brillante che, su proposta del suo maestro Alberto Magno, nel 1252, ad appena 27 anni, comincia a insegnare teologia a Parigi, sebbene gli statuti dell’Università chiedessero l’età minima di 29 anni; e nel corso della sua breve vita si dedicherà con tutte le sue forze all’officium sapientis, al suo lavoro di teologo. Ma come concepisce Tommaso la teologia o sacra doctrina?
Essa è una scienza, nell’accezione aristotelica del termine. Per Aristotele, infatti, la scienza è un sapere che, da determinati principi – verità di per sé evidenti o verità dimostrate da una scienza superiore – ricava conclusioni certe mediante una rigorosa argomentazione razionale. Questa definizione per Tommaso si applica perfettamente alla teologia, i cui princìpi, gli articoli di fede, non sono evidenti ma, se possibile, ancora più indubitabili per i credenti che, grazie alla rivelazione, partecipano di un sapere superiore, quello divino: dunque «la sacra dottrina è una scienza, perché procede da principi conosciuti per lume di una scienza superiore, cioè della scienza di Dio e dei Beati» (ST Iª q. 1 a. 2).
La teologia supera tutte le altre scienze «quanto alla certezza, perché mentre le altre scienze derivano la loro certezza dal lume naturale della ragione umana, che può errare, essa la trae dal lume della scienza divina, che non può ingannarsi» (ST Iª q. 1 a. 5). E se la metafisica può chiamarsi ‘sapienza’ perché si occupa della causa prima, ma per mezzo dell’intelligenza umana, che è finita e che patisce tra l’altro le conseguenze del peccato originale, ancor di più questa denominazione spetta alla teologia, che parla della causa suprema attingendo alla rivelazione divina, per cui giustamente «la sacra dottrina è detta sapienza, in sommo grado» (ST Iª q. 1 a. 6).
La teologia, infine, si serve dell’argomentazione razionale, oltre che per dimostrare i praeambula fidei e per offrire una visione sistematica della rivelazione, anche per controbattere «le ragioni che le si possano opporre. È chiaro, infatti, che poggiando la fede sulla verità infallibile ed essendo impossibile dimostrare il falso da una cosa vera, le prove che si portano contro la fede non sono delle vere dimostrazioni ma degli argomenti confutabili» (ST Iª q. 1 a. 8); e a tale scopo, servendosi delle discipline filosofiche «come di saperi inferiori e di ancelle» (Iª q. 1 a. 5 ad 2), la teologia «utilizza anche l’autorità dei filosofi, quando questi con la ragione naturale arrivarono a conoscere la verità» (ST Iª q. 1 a. 8 ad 2).
 Se ci chiediamo ora quale valore attribuisca l’Aquinate alla filosofia, va subito detto che egli la apprezza enormemente, e non potrebbe essere diversamente dato che per lui l’uomo è un animale razionale, la cui realizzazione dipende appunto dalla conoscenza. E proprio quella filosofica, che studia l’essere in quanto essere cercandone la causa prima, è sul piano naturale la più alta forma di sapere. Elevata poi al piano sovrannaturale con la fede, la conoscenza giunge al suo compimento nell’aldilà con la visione beatifica dell’Essere divino: meta che era stata intravista dai filosofi ma che restava irraggiungibile con le sole forze della natura.
Se ci chiediamo ora quale valore attribuisca l’Aquinate alla filosofia, va subito detto che egli la apprezza enormemente, e non potrebbe essere diversamente dato che per lui l’uomo è un animale razionale, la cui realizzazione dipende appunto dalla conoscenza. E proprio quella filosofica, che studia l’essere in quanto essere cercandone la causa prima, è sul piano naturale la più alta forma di sapere. Elevata poi al piano sovrannaturale con la fede, la conoscenza giunge al suo compimento nell’aldilà con la visione beatifica dell’Essere divino: meta che era stata intravista dai filosofi ma che restava irraggiungibile con le sole forze della natura.
Ma se è vero che sino alla fine della sua vita Tommaso non ha smesso di commentare le opere dei filosofi, e in particolare quelle di Aristotele, bisogna aggiungere che quella della filosofia, dopo l’avvento del cristianesimo, per lui è – come ricorda Pasquale Porro – una «stagione conclusa»[3]. Perché conclusa? Il motivo è ovvio: nel mondo greco, il filosofo, come dice la parola stessa, non possiede il sapere ma lo ama e ne va in cerca. Quel possesso, precluso agli uomini, è proprio degli dèi, che perciò, come scrive Platone, non sono filosofi: «nessun dio si occupa di filosofia e nessuno desidera diventare sapiente, perché tutti lo sono già. Chiunque possegga davvero il sapere, infatti, non fa filosofia» (Simposio 204a).
Nel mondo cristiano, invece, la situazione è ben diversa: grazie alla rivelazione, infatti, gli uomini ormai possiedono quella verità che la ragione aveva conquistato solo in parte e non senza errori. In quanto credenti – ci ha ricordato Tommaso, ma si tratta di una convinzione largamente condivisa per secoli – essi partecipano in qualche modo ‘della scienza di Dio e dei Beati’. Non c’è più spazio, quindi, per una filosofia intesa come ricerca che prescinda da certezze indiscutibili: se volessero usare la ragione senza tener conto della fede, i filosofi rinuncerebbero a quella guida infallibile che può preservarli dall’errore. È il caso, per esempio, di Amalrico di Bène e di Davide di Dinant, poi inevitabilmente condannati dall’autorità ecclesiastica che ha il compito di custodire la verità, eventualmente ricorrendo anche alla pena capitale perché gli eretici, scrive Tommaso, meritano «non solo di essere separati dalla Chiesa con la scomunica ma anche di essere tolti dal mondo con la morte» (Somma teologica II-II q. 11 a. 3). Per l’Aquinate, in sostanza, nel XIII secolo non avrebbe senso, e sarebbe da stolti, fare filosofia senza tener conto della rivelazione – come pare vogliano fare alcuni maestri della Facoltà delle Arti, tra i quali Sigieri di Brabante, contro le cui tesi, già criticate dal francescano Bonaventura da Bagnoregio, Tommaso sferra un duro attacco nel 1270 con l’opuscolo De unitate intellectus contra averroistas – mentre le opere dei filosofi del passato, depurate da possibili errori, vanno sicuramente studiate, e utilizzate con grande profitto, per costruire la grande sintesi della cultura cristiana.
È perciò chiaro il modo in cui Tommaso affronta il nostro tema, quello della creazione dal nulla: in quanto credente, egli sa già qual è la verità e, in quanto teologo, a lui spetta il compito di proporre argomenti di ragione, di solito già elaborati dai filosofi più autorevoli, a sostegno di quella verità che ritiene enunciata in modo evidente nei primi versetti della Genesi, da tempo recepita come articolo di fede e di recente definita solennemente dal magistero nel Concilio Lateranense IV. In effetti, egli non ha dubbi: «niente può esistere nella realtà, che non sia creato da Dio, il quale è causa universale di tutto l’essere. Perciò è necessario affermare che Dio crea le cose dal nulla» (Somma teologica I q. 45 a. 2). Ed è necessario affermarlo anche sulla base della ragione, perché l’Aquinate ritiene che Aristotele e altre auctoritates abbiano già elaborato validi argomenti in tal senso.
Su Aristotele, Tommaso non ha mai nutrito alcun dubbio: infatti, già nel Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo (1254-56) affermava che «Aristotele non errò nell’ammettere più princìpi, poiché affermò che l’essere di tutte le cose dipende soltanto dal primo principio, e da ciò si ricava che c’è un unico principio» (Super Sent., lib. 2 d. 1 q. 2 a. 5 expos.). Per qualche tempo, invece, ha ritenuto che, come Anassagora, Platone fosse in errore: entrambi «posero il mondo creato da Dio ma da una materia preesistente» (De articulis fidei, c. 1, testo da riferire al periodo 1261-1265).
Ma dal De potentia (1265-67) in poi aggiunge ad Aristotele anche Platone. Dopo aver ricordato il lento cammino compiuto dai primi pensatori greci, scrive infatti così: «i filosofi successivi, come Platone, Aristotele e i loro seguaci, giunsero a prendere in considerazione l’essere stesso, e perciò essi soli ammisero una qualche causa universale, per opera della quale tutte le altre cose pervenivano all’essere, come si evince da Agostino. E questo insegnamento è sicuramente in consonanza con la fede cattolica». E, dopo aver riportato argomenti riferibili a Platone, Aristotele e Avicenna, conclude: «così dunque si dimostra con la ragione e si ritiene per fede che tutte le cose sono state create da Dio» (De potentia q. 3 a. 5). Non si dice qui, secondo Étienne Gilson, «che i filosofi abbiano raggiunto esattamente l’oggetto al quale la fede dà il proprio assenso, ma che le conclusioni della ragione e le certezze della fede si accordano, si armonizzano, a tal punto che l’evoluzione dei problemi nel corso della storia fa vedere che il progresso nel modo filosofico di affrontarli e di risolverli avvicina a poco a poco la ragione alle verità di fede che essa finisce per presentire, se non per raggiungere» [4].
Parimenti nella Somma teologica (1269-70) sostiene convintamente che «anche Platone disse che prima di ogni moltitudine è necessario ammettere l’unità. E Aristotele afferma che l’essere, il quale è sommamente ente e sommamente vero, è causa di ogni ente e di ogni vero: come ciò che è caldo in sommo grado, è causa di ogni calore» (Somma teologica I q. 44 a. 1). E qui pare che Tommaso, nonostante le cautele di Gilson, attribuisca ad Aristotele proprio l’idea di creazione.
E ancora nello scritto Sulle sostanze separate o sulla natura degli angeli (1272-73), una delle sue ultime opere, ribadisce chiaramente che «non bisogna ritenere che Platone e Aristotele, per il fatto che ammisero che le sostanze immateriali o anche i corpi celesti siano sempre esistiti, abbiano negato la necessità di una causa del loro essere; infatti non si allontanarono dall’insegnamento della fede perché li considerarono increati ma solo perché ritennero che fossero sempre esistiti: tesi, questa sì, contraria a ciò che afferma la fede cattolica» (De substantiis separatis, cap. 9), ma tuttavia sostenibile, come ipotesi, alla luce della sola ragione naturale, e quindi scusabile in chi non disponeva del lume della fede. Infatti il mondo contingente, anche se non avesse avuto inizio, resterebbe, afferma con grande acume Tommaso, eternamente dipendente da quell’Essere che, essendo essere per essenza, è l’unico che può trarre dal nulla gli enti che non posseggono l’essere di per sé.
Tranne per quanto riguarda l’eternità del mondo, dunque, sintonia perfetta tra fede (Bibbia e Magistero) e ragione (autorità dei grandi filosofi). Questo è quanto un pensatore sicuramente geniale come Tommaso poteva affermare con certezza basandosi sui dati a sua disposizione. Oggi però la situazione è molto cambiata: sarebbe praticamente impossibile, e quindi non è il caso di soffermarsi su questo punto, trovare uno studioso che sostenga che i greci abbiano elaborato, o almeno ‘presentito’, la teoria della creazione. Ma sarebbe pure difficile trovare biblisti pronti a sostenere che il primo versetto della Genesi insegni la creazione dal nulla. Infatti lo stesso Catechismo della Chiesa cattolica (1992), se ribadisce che «La fede nella creazione dal nulla è attestata nella Scrittura come una verità piena di promessa e di speranza» (n. 297), non cita però, come ci aspetteremmo, a sostegno di questa tesi la Genesi, ma II Maccabei (libro deuterocanonico, contenuto nella versione dei LXX e considerato ispirato da cattolici e ortodossi): «Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti [vulgata: ex nihilo fecit]; tale è anche l’origine del genere umano» (7,28).
Il ricorso a questa citazione lascia però molto perplessi. Un insegnamento di tale rilevanza, infatti, non solo è dato en passant – all’interno di un racconto di storia popolare, in cui la madre dei fratelli Maccabei esorta il più giovane di loro a farsi torturare e uccidere come i suoi fratelli pur di non violare la legge ebraica – ma è anche in contrasto con altri passi biblici. Nel libro della Sapienza (anch’esso deuterocanonico), per esempio, mentre si loda la moderazione di Jahvè nel punire gli egiziani, si afferma che il mondo è stato creato da una materia preesistente: «Non era certo in difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo da una materia senza forma [vulgata: ex materia informi], a mandare loro una moltitudine di orsi o leoni feroci» (11, 17).
 In ogni caso, fa bene il Catechismo a non basare la sua tesi su quello che potrebbe sembrare il testo classico per l’argomento in questione, e cioè l’inizio del libro della Genesi: «In principio Dio creò il cielo e la terra (Bereshit bara Elohim et hashamayim ve’et ha’arets)» (1,1). I filologi sono concordi, infatti, nel sostenere che il verbo ‘bara’ non significa creò dal nulla ma fabbricò, produsse, plasmò. E infatti il testo prosegue parlando di una materia informe: «La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque» (1, 2). La Genesi sembra dunque suggerire l’idea che l’iniziativa divina consista non nel creare dal nulla ma nel mettere ordine – separando la luce dalle tenebre, la terra dalle acque e così via – in una realtà prima caotica e desolata. E, in ogni caso, non si tratta di un racconto di carattere storico ma mitico-sapienziale.
In ogni caso, fa bene il Catechismo a non basare la sua tesi su quello che potrebbe sembrare il testo classico per l’argomento in questione, e cioè l’inizio del libro della Genesi: «In principio Dio creò il cielo e la terra (Bereshit bara Elohim et hashamayim ve’et ha’arets)» (1,1). I filologi sono concordi, infatti, nel sostenere che il verbo ‘bara’ non significa creò dal nulla ma fabbricò, produsse, plasmò. E infatti il testo prosegue parlando di una materia informe: «La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque» (1, 2). La Genesi sembra dunque suggerire l’idea che l’iniziativa divina consista non nel creare dal nulla ma nel mettere ordine – separando la luce dalle tenebre, la terra dalle acque e così via – in una realtà prima caotica e desolata. E, in ogni caso, non si tratta di un racconto di carattere storico ma mitico-sapienziale.
Occorre prenderne atto: per secoli si è fatta teologia prendendo alla lettera ogni pagina della Bibbia, non tenendo conto dei diversi generi letterari e costruendo sulla base di un versetto isolato dal contesto una tesi dogmatica di carattere metafisico. Così, il creazionismo è diventato una tesi propria del pensiero cristiano in contrapposizione, checché ne pensasse Tommaso che erroneamente lo attribuiva a Platone e Aristotele, all’autentica concezione greca dell’autosufficienza del mondo. Ma ora questo non è più possibile: non si può più dire, a giudizio degli esegeti contemporanei, che la creazione dal nulla sia una verità rivelata. Si tratta solo di una teoria di ordine razionale, e sarà compito dei filosofi, evitando poco plausibili interpretazioni di Platone e di Aristotele, portare argomenti a favore o contro di essa, vagliando tra gli altri gli argomenti proposti da Tommaso, con la consapevolezza, è bene sottolinearlo, che «la delicatezza del tema della creazione è tale che l’edificio metafisico tomistico regge solo se permane filosoficamente giustificata la posizione della creazione»[5].
Ma c’è di più! Non è cambiata solo l’interpretazione delle opere greche di cosmologia e delle prime pagine della Genesi: negli ultimi decenni è avvenuta una vera e propria rivoluzione nell’ambito dell’esegesi, ed è lo stesso concetto di rivelazione che è stato messo in discussione da molti biblisti, anche cattolici. In effetti, appare ormai poco credibile l’idea che un essere divino abbia parlato in modo vincolante agli uomini e che le sue parole siano fissate in testi da considerare sacri; si pensa piuttosto che ci siano uomini religiosi che abbiano meditato sulle domande di senso, offrendo alcune risposte di grande valore e ancora degne di attenzione. L’espressione ‘parola di Dio’ riferita abitualmente alla Bibbia è da prendere, quindi, non in senso letterale ma in senso abbastanza ampio, in sostanza come una metafora.
A riprova di ciò, mi limito a un paio di esempi: secondo il biblista italiano Carlo Buzzetti, «tenendo conto di quanto la mentalità possa essere legata ad atteggiamenti simbolici e a credenze quasi magiche e di come le espressioni letterarie facciano uso di un certo antropomorfismo, si comprende come la fede di Israele sia potuta giungere a credere di possedere delle parole che potevano essere fatte risalire a Dio stesso… Può essere legittimo chiedersi, almeno come ipotesi di lavoro, se non si debba riconoscere un certo semplicismo nell’atteggiamento della comunità credente che, presto, prese a considerare di natura eccezionale, divina, dei testi che hanno tutta l’apparenza di essere perfettamente normali»[6]. Sulla stessa linea si muove il teologo cattolico tedesco Karl Schelkle: «la riflessione critica si domanda se ora in qualche modo la rivelazione avvenga come reale comunicazione di Dio all’uomo o se ciò che viene detto rivelazione sia soltanto riflessione di uomini religiosi»[7].
E come escludere l’ipotesi che gli averroisti latini del XIII secolo, che non consideravano affatto quella della filosofia una ‘stagione conclusa’, sostenessero l’indipendenza e la superiorità della filosofia sulla teologia – alcune tesi della quale giudicavano semplici frottole – proprio perché, anticipando in qualche modo la concezione attuale, e ormai credo irreversibile, della rivelazione, vedevano nella Bibbia non parole divine ma riflessioni umane, e talvolta anche troppo umane, che portavano il peso e i condizionamenti culturali di epoche ormai passate?
È invece perché non prendevano in considerazione o non accettavano la rivoluzione esegetica del ‘900 – che dopo il Concilio Vaticano II lo stesso Magistero ha rinunciato a contrastare – che pensatori della statura di Étienne Gilson non avevano difficoltà a condividere l’idea di Tommaso che la filosofia, pur autonoma nel suo campo, sia ancilla teologiae e che la teologia sia regina scientiarum perché ci rende partecipi dello stesso sapere divino. Per quanto riguarda la Bibbia, infatti, Gilson non ha mai avuto dubbi, dichiarando senza ambiguità che: «Bisogna prendere alla lettera le parole di san Tommaso: auctor sacrae Scripturae est Deus»[8].
Si capisce, quindi, perché egli affermi che per essere tomisti si debba «filosofare come solo un cristiano può fare, ossia nella fede»[9], sostenga che «tutte le volte che una conclusione filosofica contraddice il dogma, questo è un segno certo che tale conclusione è falsa»[10], e possa concludere: «la teologia, non la metafisica, resta la Sapienza per eccellenza e la sola Regina delle Scienze veramente degna di questo titolo. Tutto il futuro della filosofia cristiana dipende da una riscoperta attesa, desiderata, sperata, dell’autentica nozione della teologia»[11]. Si tratta di posizioni che oggi appaiono difficilmente sostenibili ma che ritengo utile ricordare perché è in questo modo che è stato letto per secoli Tommaso.
La verità fondamentale, su cui l’Aquinate costruisce tutto il suo sistema è, come è noto, quella rivelata a Mosè: «Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono!”» (Esodo 3,14). Non si comprende nulla della Somma teologica, ribadisce Gilson, «se si perdono di vista per un solo istante la rivelazione fatta da Dio della propria esistenza e il nome col quale vi si è rivelato»[12]: filosofia e teologia sono certamente due saperi distinti ma sarebbe ridicolo pensare che non convivano e non collaborino nella mente di un uomo, perché Tommaso «non mantiene con tale fermezza la distinzione formale delle due luci e delle due sapienze che per meglio permettere loro di collaborare, senza confusione possibile ma senza falsi scrupoli e in intima familiarità»[13].
Che Dio esiste dunque, prosegue Gilson, noi lo sappiamo perché lui lo ha rivelato: «Dicendo Ego sum qui sum, Dio proclama la sua esistenza personale di Dio»[14]; ma con quelle parole Dio ha rivelato anche, «se si segue l’interpretazione che ne dà san Tommaso, sia che l’essenza divina è semplice, sia che l’essenza di Dio è il suo essere». Proprio da queste premesse, per quanto riguarda il nostro tema, si ricava facilmente che il mondo è creato. Infatti, solo in Dio non c’è composizione alcuna, perché la sua essenza si identifica con l’esistenza. Le cose del mondo, invece, non sono semplici ma composte: la loro essenza non comprende l’esistenza, questa si aggiunge alla loro essenza, tanto è vero che questo albero o questo cane, per esempio, possono perderla, cessando così di esistere. Quindi, se l’esistenza non l’hanno di per sé, devono riceverla – poiché andare all’infinito non risolverebbe il problema – da Colui che, Essere per essenza, è il solo che può donarla: ecco la prova che il mondo è creato.
È evidente: se Dio è l’Ipsum esse subsistens, fuori di Dio c’è il nulla: non solo non può esistere il mondo che conosciamo ma non può esserci neanche la materia prima aristotelica. La creazione è esattamente productio ex nihilo sui (cioè della cosa che si crea) et subiecti (cioè della sua materia). Gli enti esistono perché tratti dal nulla e mantenuti costantemente nell’essere. Questo mondo, che di per sé sarebbe nulla, esiste dunque solo grazie alla costante dipendenza dal Creatore: «la creazione nelle creature non è altro che una certa relazione verso il Creatore, causa del proprio essere» (Somma teologica I q. 45 a. 3).
Ma a questo punto non è possibile evitare una domanda fondamentale: si può dimostrare con la ragione in maniera rigorosa che negli enti non c’è semplicità ma composizione di due elementi: essenza ed essere? Ci sono «molte ragioni che suggeriscono la composizione di essenza ed essere negli enti, ma nessuna – riconosce onestamente Gilson – la dimostra in modo rigoroso. […] È perché sa, dato che lo ha detto Dio, che il suo nome proprio è Est, che il teologo considera l’ente finito come necessariamente composto»[15]. Ma se non ci sono argomenti rigorosi, se è dubbia la composizione negli enti di essenza ed essere, è chiaro che per conseguenza diventa dubbia anche la tesi della creazione dal nulla.
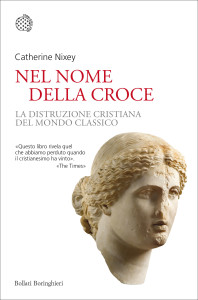 In sostanza, Gilson sta dicendo che questa teoria non è una tesi propriamente filosofica; non è dimostrabile con la sola ragione perché trova il suo fondamento nella rivelazione del nome divino: infatti è il teologo che, sapendo che Dio è l’Essere per essenza, ha motivi per considerare ‘l’ente finito come necessariamente composto’, e quindi di per sé privo di qualunque consistenza e pronto a ricadere nel nulla se non fosse costantemente mantenuto nell’essere dal Creatore. Ma se, come accade oggi, si rifiuta l’idea di rivelazione ancora condivisa da Gilson, si capisce che gli stessi teologi possono benissimo mettere in discussione il creazionismo.
In sostanza, Gilson sta dicendo che questa teoria non è una tesi propriamente filosofica; non è dimostrabile con la sola ragione perché trova il suo fondamento nella rivelazione del nome divino: infatti è il teologo che, sapendo che Dio è l’Essere per essenza, ha motivi per considerare ‘l’ente finito come necessariamente composto’, e quindi di per sé privo di qualunque consistenza e pronto a ricadere nel nulla se non fosse costantemente mantenuto nell’essere dal Creatore. Ma se, come accade oggi, si rifiuta l’idea di rivelazione ancora condivisa da Gilson, si capisce che gli stessi teologi possono benissimo mettere in discussione il creazionismo.
Giunti al termine del nostro percorso, ricordo quanto dicevamo in premessa: le nostre convinzioni dipendono in larga misura dalle informazioni di cui disponiamo, e prendere in considerazione nuove ipotesi non è per nulla facile se esse appaiono in contrasto con insegnamenti che riteniamo di origine divina.
Posto ciò, per quanto riguarda la creazione dal nulla dico subito che, sulla base dei dati di cui dispongo, non sono attualmente in grado di stabilire in che misura questa teoria sia plausibile. E non sono neanche certo che lo stesso Tommaso – se vivesse oggi, facesse non il teologo ma il filosofo, cercando quindi di trovare la verità e non ragioni di convenienza di una verità già data, e disponesse delle informazioni della scienza contemporanea – affermerebbe ancora la creazione dal nulla.
Mi pare però che sia ragionevole porsi alcune domande più generali. E cioè: la sintesi tra filosofia greca e fede biblica costruita da Tommaso – che diverrà la massima espressione di quella che è definita ancora oggi philosophia perennis – sarebbe stata quella che conosciamo o sarebbe stata parecchio differente se non ci fossero stati i pesanti interventi dell’autorità ecclesiastica a cui abbiamo accennato? Cosa sarebbe successo, in particolare:
- se i maestri della Facoltà delle Arti fossero stati liberi riguardo alla interpretazione dei testi aristotelici, al modo di intendere la rivelazione e ai rapporti da stabilire tra filosofia e teologia, invece di essere costretti, per evitare guai peggiori, a ricorrere talvolta alla scappatoia della doppia verità?
- se i biblisti avessero potuto disporre di strumenti esegetici che consentissero una più corretta interpretazione della Scrittura, chiarendo per esempio che i primi versetti della Genesi non parlano affatto della creazione dal nulla?
- se i pensatori che avanzavano nuove ipotesi, che oggi appaiono per certi versi in linea con le acquisizioni della scienza, fossero stati incoraggiati e non condannati, e in alcuni casi mandati al rogo?
- se quella della filosofia non fosse stata considerata una stagione conclusa e il suo compito non fosse stato ridotto alla ricerca di ragioni di convenienza a conferma di una verità già posseduta? E ciò nel caso migliore, quello della corrente domenicana, perché la corrente francescana negava alla filosofia ogni autonomia nel suo stesso campo.
- se il Concilio Lateranense IV, infine, non avesse proclamato solennemente il dogma della creazione dal nulla?
Non è facile rispondere a queste domande, perché si sa che la storia non si fa con i ‘se’. Quello che mi pare si possa affermare con certezza, però, è che nello stesso secolo di Tommaso altre vie di ricerca erano di fatto percorribili, e lo dimostra il caso di Sigieri di Brabante, che interpretava più correttamente di Tommaso i testi dei grandi maestri e sosteneva con chiaro tono polemico che le opinioni di Aristotele e di Averroè non debbono essere nascoste da coloro che hanno il compito di esporre i loro libri, anche se appaiano in contrasto con la rivelazione. E anzi concludeva che, se in quanto credente accettava – non sappiamo quanto sinceramente – determinate verità di fede, come filosofo aveva però il diritto di rivendicare la netta distinzione tra due tipi d’indagine molto diversi tra loro e la sostenibilità in ambito razionale di tesi contrarie alla fede, ponendo le premesse di quel lentissimo processo di liberazione della ragione dai lacci della rivelazione biblica.
Questa tesi – opposta a quella di Tommaso, che basava la sua sintesi proprio sull’accordo necessario e preliminare tra fede e ragione, e solo perciò riteneva utilizzabile in sede teologica la filosofia aristotelica – era troppo pericolosa perché l’autorità ecclesiastica potesse lasciar correre. Eppure, nonostante le condanne, Sigieri continuò a negare, in quanto studioso di Aristotele e di Averroè, che Dio, causa finale dell’universo, ne fosse anche la causa efficiente, ribadendo che la filosofia aristotelica non conosceva la teoria della creatio ex nihilo. Ma proprio il successo che le sue lezioni riscuotevano alla Facoltà delle Arti rese la sua posizione insostenibile. Dovette così lasciare la cattedra parigina e recarsi a Orvieto, residenza della corte pontificia, per chiarire le sue teorie davanti al papa Martino IV, ma qui fu assassinato intorno al 1282, pare da un servo impazzito, mentre finiranno sugli altari sia Tommaso (1323) che Bonaventura (1482), morti entrambi nel 1274.
Certo, anche ad Atene la vita non era stata sempre facile per i filosofi, ma mi pare innegabile che con l’avvento del cristianesimo si sia creata una situazione di intolleranza per il dissenso che ha pochi paragoni nella storia. Un pensatore dell’autorevolezza di Agostino di Ippona (354-430) affermava che «Dio vuole che venga eliminata ogni superstizione dei pagani e dei gentili, Dio lo ha comandato, Dio lo ha profetizzato, Dio ha già cominciato a farlo e in molti luoghi della terra in gran parte l’ha già fatto del tutto» (Discorso 24, 6), e ricordava che gli imperatori hanno un preciso dovere: «i re, obbedendo agli ordini divini, servono Dio in quanto sono re: ordinando nel loro regno il bene e vietando il male, non solo nell’ambito della società umana, ma anche in ciò che concerne la religione divina» (Contro Cresconio, III, 51. 56).
 Senza pretendere di giudicare gli eventi del passato alla luce di criteri oggi comunemente accettati, non è possibile rinunciare a constatare i fatti; e questi parlano con assoluta chiarezza: si è cercato in tutti i modi di imporre un’unica verità, e non per occasionali deviazioni, sempre possibili, ma con invidiabile costanza sin da quando nell’Impero romano è stato attribuito al potere politico il compito di difendere la vera religione e combattere l’errore. Anche qui mi limito solo a un paio di citazioni: «durante il lungo regno di Giustiniano, tra il 527 e il 565, l’uniformità religiosa – scrive Franco Cardini – fu tenacemente e rigorosamente perseguita […]. Eretici e pagani furono duramente perseguitati e sottoposti a mutilazioni, a decapitazioni e persino a crocifissioni. […] Chiudendo tra il 529 e il 532 la scuola filosofica di Atene, confiscandone i beni e vietando ai suoi maestri di insegnare, Giustiniano intese senza dubbio infliggere un colpo finale […] all’antica e già agonizzante religione»[16].
Senza pretendere di giudicare gli eventi del passato alla luce di criteri oggi comunemente accettati, non è possibile rinunciare a constatare i fatti; e questi parlano con assoluta chiarezza: si è cercato in tutti i modi di imporre un’unica verità, e non per occasionali deviazioni, sempre possibili, ma con invidiabile costanza sin da quando nell’Impero romano è stato attribuito al potere politico il compito di difendere la vera religione e combattere l’errore. Anche qui mi limito solo a un paio di citazioni: «durante il lungo regno di Giustiniano, tra il 527 e il 565, l’uniformità religiosa – scrive Franco Cardini – fu tenacemente e rigorosamente perseguita […]. Eretici e pagani furono duramente perseguitati e sottoposti a mutilazioni, a decapitazioni e persino a crocifissioni. […] Chiudendo tra il 529 e il 532 la scuola filosofica di Atene, confiscandone i beni e vietando ai suoi maestri di insegnare, Giustiniano intese senza dubbio infliggere un colpo finale […] all’antica e già agonizzante religione»[16].
Ancora a proposito della chiusura della Scuola di Atene, che ha avuto conseguenze devastanti per tutta la cultura successiva, Catherine Nixey, dopo aver citato la legge giustinianea del 529 – «vietiamo l’insegnamento di qualsiasi dottrina da parte di chi traffica sotto la follia del paganesimo», in modo da evitare che costoro possano «corrompere le anime dei loro discepoli» – ricorda l’insanabile ostilità esistente tra chi rivendicava la libertà di pensiero e le autorità cristiane «profondamente irritate dai filosofi. Parte di quanto essi insegnavano contraddiceva espressamente e intollerabilmente la dottrina. Qualunque ipotesi riguardo all’eternità del mondo, ad esempio, non poteva essere permessa all’interno della dottrina cristiana della creazione. […] I cristiani non avrebbero dovuto sopportare queste irritazioni ancora per molto»[17]. Bisognava distruggere non solo i templi e le statue degli idoli ma anche gli scritti che conservavano quel coacervo di errori: «le abitazioni venivano perquisite alla ricerca di libri e di oggetti ritenuti inaccettabili. Nel caso fossero trovati, sarebbero stati rimossi e bruciati in trionfali falò che si tenevano nelle piazze delle città. Le discussioni pubbliche sulle questioni religiose erano state etichettate come “vergognose insolenze” e vietate per legge» [18]
In effetti, l’incapacità di accettare il pluralismo delle idee, che per altro non deve far dimenticare l’indubbia presenza in altri ambiti di aspetti estremamente positivi, sembra una caratteristica della lunga storia della Chiesa. Un’istituzione che si considera di origine divina – in realtà strutturatasi gerarchicamente, come scriveva ironicamente Alfred Loisy oltre un secolo fa, soltanto dopo la morte di Gesù e la vana attesa del Regno: «Gesù annunciava il regno, ed è venuta la Chiesa»[19] – e che, convinta di aver ricevuto una rivelazione sovrannaturale, non disdegna l’uso della forza per imporre le proprie certezze, credo che divenga necessariamente la negazione della libera ricerca e quindi un ostacolo da cui liberarsi. Più che custode della verità, pare infatti custode di un terribile errore: che la verità non vada cercata ma sia già posseduta.
Dialoghi Mediterranei, n. 48, marzo 2021
Note
[1] J. Le Goff, Gli intellettuali nel Medioevo, Mondadori Milano 1981.
[2] N. Abbagnano, Storia della filosofia, vol. I, Utet Torino 1969.
[3] P. Porro, Tommaso d’Aquino. Un profilo storico-filosofico, Carocci Roma 2019
[4] E. Gilson, Introduction à la philosophie chrétienne, Vrin Paris 1960:40.
[5] A. Ghisalberti, La creazione nella filosofia di S. Tommaso d’Aquino, in Rivista di Filosofia neoscolastica, 1969: 202.
[6] C. Buzzetti, La parola tradotta, Morcelliana Brescia 1973: 35
[7] C. Scherlkle, Teologia del Nuovo Testamento, Dehoniane Bologna 1980, volume II: 61
[8] E. Gilson, Introduction à la philosophie chrétienne, cit.: 49.
[9] E. Gilson, Il filosofo e la teologia, Morcelliana Brescia 1964: 217.
[10] E. Gilson, La philosophie au Moyen Age, Deuxième Paris 1962: 528
[11] E. Gilson, Introduction cit.: 223.
[12] Ivi: 53.
[13] Ivi: 113.
[14] Ivi: 45.
[15] Ivi: 55-56.
[16] F. Cardini, Cristiani perseguitati e persecutori, Salerno ed. Roma 2011: 146-147.
[17] C. Nixey, Nel nome della Croce, Bollati Boringhieri Torino 2017: 247
[18] Ivi:16.
[19] C. Loisy, L’Evangile et l’Eglise, Picard Paris, 1902
______________________________________________________________
Elio Rindone, docente di storia e filosofia in un liceo classico di Roma, oggi in pensione, ha coltivato anche gli studi teologici, conseguendo il baccellierato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Per tre anni ha condotto un lavoro di ricerca sul pensiero antico e medievale in Olanda presso l’Università Cattolica di Nijmegen. Da venticinque anni organizza una “Settimana di filosofia per… non filosofi”. Ha diverse pubblicazioni, l’ultima delle quali è il volume collettaneo Democrazia. Analisi storico-filosofica di un modello politico controverso (2016). È autore di diversi articoli e contributi su Aquinas, Rivista internazionale di filosofia, Critica liberale, Il Tetto, Libero pensiero.
______________________________________________________________












