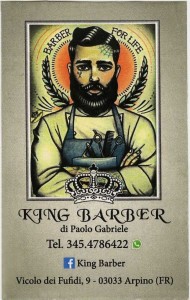di Ugo Iannazzi
Nel precedente intervento sono stati considerati sia la posizione attuale detenuta finora dall’italiano nel mondo, sia l’ingresso esagerato nell’ultimo anno nel nostro Paese di molte migliaia di nuovi anglicismi, che, senza traduzione, e per sostituzione, e spesso senza necessità, hanno occupato il posto dei legittimi, usuali e naturali vocaboli italiani. Nel contributo ne sono stati riportati a centinaia, ripresi ascoltando trasmissioni televisive e radiofoniche, leggendo quotidiani e settimanali, ascoltando gli interventi dei politici che ci governano, osservando la pubblicità nelle varie forme: su strada, su carta stampata, via etere.
Contro questa invasione molto flebile è stata la risposta di contrasto di letterati, linguisti, personaggi della cultura. Se l’italiano non recupera un suo spazio dinamico e vitale, i suoi vocaboli progressivamente spariranno e l’invasione continuerà, tanto da prevedere tra qualche decennio, differentemente dal parere di alcuni studiosi che sottovalutano il problema, che la nostra lingua nazionale possa diventare una minoranza linguistica e le nostre generazioni future siano costrette a leggere le opere di Dante, Leonardo, Galileo, Leopardi, Manzoni, Calvino, Eco… non più nella madre lingua, ma attraverso impresentabili traduzioni nel britannico idioma. Ciò equivarrebbe a determinare il tramonto di tutta la cultura italiana, che da Dante in poi ha affermato un suo straordinario primato culturale nel mondo.
La valanga di inglesismi, che ha invaso il territorio nazionale da qualche decennio, si è enormemente intensificata nell’anno 2020, l’anno della pandemia del Coronavirus. A tal proposito si può consultare anche l’articolo apparso il giorno 23 gennaio 2021 su “D”, supplemento settimanale al quotidiano la Repubblica, a firma della giornalista e scrittrice Francesca Ferri alle pp. 34-37, dal titolo Do you speak Coronalove?
Il 18 gennaio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella sua comunicazione alla Camera dei Deputati ha affermato:
«In questo contesto, occorre garantire e tutelare, con la massima intensità, le autonomie speciali e le minoranze linguistiche. L’interesse nazionale è più che mai connesso, nel solco della nostra migliore tradizione storica e costituzionale, a un sistema che valorizzi, nel quadro dell’unità della Repubblica, le specifiche esigenze economiche e sociali delle diverse realtà territoriali, alcune delle quali – per ragioni geografiche, specificità linguistiche e culturali – indubbiamente meritano attenzione e cura».
È da apprezzare la sua sensibilità per le minoranze linguistiche italiane, che intende “tutelare” e “curare”. Poiché l’italiano si avvia a “scivolare” sulla china di una minoranza linguistica, il suo annuncio potrebbe far ben sperare. Purtroppo nello stesso discorso del 18 gennaio anche lui, come la grande maggioranza dei politici italiani, ha usato vari forestierismi di cui qualcuno poteva essere risparmiato. Insieme a 5 vocaboli di origine latina o greca in un discorso di 18 minuti, ne ha utilizzato ben 36 di origine inglese, uno ogni 30 secondi!
Per ricollegarmi al mio precedente testo, già edito sul n. 47 di Dialoghi Mediterranei, occorre aggiungere che lo sconforto ti prende, quando sul telefonino cerchi la traduzione dall’inglese delle seguenti parole (e simili): colf, baby sitter, gay, export, sprint, comfort, joint venture ecc. e sullo schermo compaiono come risposte gli stessi vocaboli: colf, baby sitter, gay, export, sprint, comfort, joint venture… Questo è il segno che, a parere del telefonino, la tragedia della sostituzione è già irrimediabilmente avvenuta e i citati vocaboli inglesi sono ormai stati assimilati e ospitati nella nostra povera lingua italiana. Non è, quindi, più possibile una traduzione dall’inglese all’italiano: ormai la nostra bistrattata lingua, in cui ci vorremo correntemente esprimere, non c’è più, è sempre più itanglese!
Allora per verificare se nel nostro parlare esistono ancora le corrispondenze italiane (ed esistono: collaboratrice, bambinaia, omosessuale, esportazione, scatto, comodità, associazione di imprese!) occorre digitare le stesse parole inglesi e chiederne, però, il significato in italiano! E allora, perché non torniamo a usare le nostre originali parole di qualche decennio fa? Perché, noi italiani così creativi, non creiamo, quando occorrono, neologismi in italiano? E perché non lo facciamo, prima che la sostituzione linguistica diventi irreversibile?
 L’italiano è nelle mani dei nostri governanti e dei nostri concittadini
L’italiano è nelle mani dei nostri governanti e dei nostri concittadini
Gli studiosi ci informano che sempre più anglicismi creano una lenta obsolescenza degli stessi vocaboli italiani. Se oggi non si pone freno a questa sempre più veloce erosione, si perderanno i binari per mantenere in vita la nostra cultura e tutta la poesia, la prosa, i canti, i testi teatrali, i testi filosofici, i testi scientifici e culturali dei nostri grandi autori cadrebbero nel silenzio e nell’indecifrabilità, perdendo ogni cognizione e pratica della lingua che li ha generati. Crollerebbe la possibilità di entrare in colloquio diretto con le autentiche parole sia dei manoscritti, che dei testi stampati di Dante, di Leonardo, di Michelangelo, di Galilei, di Manzoni, di Carducci, di Ungaretti, di Marconi, di Fermi ecc., che fanno parte di un patrimonio di immenso valore per tutto il pianeta, e di apprezzarne le sfumature gergali, etimologiche, ambientali che il lessico d’origine ha loro conferito.
Si perderebbe in un momento tutto il fascino che l’Umanesimo e tutta la cultura ha sedimentato negli ultimi tre millenni sulla nostra penisola a partire dal greco, dal latino, per giungere ai nostri volgari e infine al nostro prezioso italiano, che tanta difficoltà ha incontrato nell’affermarsi sulla nostra penisola. Quando un’ampia diffusione è stata finalmente raggiunta, stiamo sperperando la nostra lingua, affidando la nostra comunicazione a una lingua importata, politicamente non imposta, ma cresciuta solo sulle spinte di sottocultura di larghi strati di popolazione italiana incosciente, attratta da miraggi commerciali, economici e/o solo di moda. Ma mentre il commerciante usa la lingua come un mezzo, chi fa cultura la usa come fine, potremmo dire come “mercanzia”, o “bene”, o “ricchezza” da tutelare.
Perdere la lingua italiana, equivale a balbettare in altri idiomi e a distruggere tutto il patrimonio di civiltà, costruito dai nostri antenati nel passato. Per questi motivi bisogna proteggere e salvare con forza la nostra lingua, che ha un fascino ineguagliabile e non può di colpo essere considerata di ripiego, o di scarto. Quindi, già da ora, prima che sia troppo tardi, occorre sensibilizzare tutto i nostri connazionali, a partire dagli studiosi, dai letterati, dai poeti, dai linguisti, dai glottologi, dagli storici, dagli studiosi dei dialetti, dai filologi, dai semiologi, dagli esperti di comunicazione e linguaggi, da tutti quelli che hanno ruoli di docenza nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché riescano a convincere i politici a prendere adeguate misure di protezione della lingua e, poi, tutti gli addetti alla comunicazione di massa (su strada, su carta, in etere e in rete), e i giovani, i creativi della pubblicità e gli addetti al commercio, affinché invertano i loro comportamenti attuali di disgregazione e annichilimento linguistico.
 La scuola italiana, che – come afferma il filosofo Umberto Galimberti – già istruisce poco ed educa ancor meno, con il progressivo accantonamento del greco e del latino in molti casi offre alle nuove generazioni condizioni di preparazione scadente, in quanto le leggi della grammatica, della sintassi e dell’analisi logica sono ormai assimilate in modo precario (e l’eloquio di alcuni politici ci dà conferma della scadente qualità della loro comunicazione) e dove il linguaggio delle reti sociali ha portato alle abbreviazioni dei vocaboli, all’immiserimento dei periodi, alla perdita di capacità di lettura dei libri, la scuola italiana, dicevamo, è a un bivio: o deve ripartire su basi moderne, ma solide, legate alla cultura della civiltà italiana, o precipita anche in questo continuo degradante fenomeno di assimilazione dell’inglese superfluo, che corrode alla base la nostra più autentica cultura e “regala” ai popoli anglofoni possibilità di successo su tutti i fronti, economici e di scambio culturale.
La scuola italiana, che – come afferma il filosofo Umberto Galimberti – già istruisce poco ed educa ancor meno, con il progressivo accantonamento del greco e del latino in molti casi offre alle nuove generazioni condizioni di preparazione scadente, in quanto le leggi della grammatica, della sintassi e dell’analisi logica sono ormai assimilate in modo precario (e l’eloquio di alcuni politici ci dà conferma della scadente qualità della loro comunicazione) e dove il linguaggio delle reti sociali ha portato alle abbreviazioni dei vocaboli, all’immiserimento dei periodi, alla perdita di capacità di lettura dei libri, la scuola italiana, dicevamo, è a un bivio: o deve ripartire su basi moderne, ma solide, legate alla cultura della civiltà italiana, o precipita anche in questo continuo degradante fenomeno di assimilazione dell’inglese superfluo, che corrode alla base la nostra più autentica cultura e “regala” ai popoli anglofoni possibilità di successo su tutti i fronti, economici e di scambio culturale.
A questo punto occorrerebbe intervenire con concreti interventi legislativi e con la consulenza di appositi comitati di studiosi nel proteggere i nostri parlari allo stesso modo in cui le varie Soprintendenze tutelano i patrimoni archeologici, storici, artistici, archivistici, ambientali…Quinto Orazio Flacco nell’Ars poetica, vv. 70-72, scriveva:
Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque / quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, / quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi.
Parole cadute in gran numero rivivranno, parole vive periranno, secondo che vorrà l’uso, signore assoluto del linguaggio, fonte del suo diritto e sua legge.
Le acute parole di Orazio ci dicono come sia l’uso, che ne fanno i parlanti, a decretare il mantenimento in vita di una lingua. Allora, se riteniamo importanti il nostro italiano (e i nostri dialetti), perché non li curiamo e nei loro confronti non facciamo opera di efficiente salvaguardia, quando una minoranza di parlanti superficiali li sta irrimediabilmente facendo sparire? La nostra lingua è importantissima e ha lo stesso valore di un Colosseo! Allora perché i grandi monumenti sono considerati patrimoni da difendere con i denti (chi sgretola un frammento al Colosseo è tenuto a pagare multe salatissime) e i nostri linguaggi, invece, sono qualcosa che chiunque può sgretolare, violare, polverizzare, inquinare, cancellare?
Le parlate locali sono ugualmente preziose e il loro pregio va protetto e vivificato. Nessuno deve abbattere un prezioso bene culturale; nessuno deve disperdere o distruggere un’opera dialettale né di alto, né di medio valore. In archeologia non vengono buttati nemmeno i frammenti, che, se sapientemente ricomposti, ci possono offrire, ancora, la bellezza di un’opera d’arte.
Molti nostri concittadini, assertori, più o meno involontari e/o incoscienti, del neocolonialismo linguistico, che spontaneamente stanno favorendo, non si rendono conto del danno che stanno creando. Ma se l’inglese, il francese, il russo, l’indiano, il cinese, quindi tutte le lingue utili, anche quelle che usano altri alfabeti, possono essere tranquillamente tradotte dai telefonini, noi potremmo tornare a essere padroni esclusivi della nostra lingua e della nostra cultura, e continuare a studiare compiutamente i testi originari delle grandi opere letterarie della civiltà italiana, da Dante, a Petrarca, a Boccaccio, a Leonardo, a Machiavelli, fino a Leopardi, Manzoni, Calvino, Levi, Pasolini, Sciascia… e anche dei grandi autori della cultura dialettale.
Leggere, invece, e studiarne le traduzioni in un’altra lingua ne degraderebbe la fruizione, come accennato, sarebbe come studiare la grande pittura di Giotto, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano… non sugli originali, ma solo su copie assolutamente innaturali e fuorvianti.
A questo punto occorrerebbe intervenire con concreti interventi legislativi e con la consulenza di appositi comitati di studiosi nel proteggere le nostre parlate allo stesso modo in cui le varie Soprintendenze tutelano i patrimoni archeologici, storici, artistici, archivistici, ambientali…
Nel 1861 la popolazione italiana raggiungeva poco più di 22 milioni di abitanti. Di essi, quelli che avevano frequentato almeno una classe delle elementari erano circa 200 mila. Secondo Tullio De Mauro, quelli che, accantonando il dialetto, parlavano un italiano esaustivo erano circa 500 mila (toscani e laziali). Secondo Arrigo Castellani, che conteggiava anche altri territori, essi raggiungevano circa i due milioni. Gli altri 20 milioni si esprimevano compiutamente solo nel loro dialetto e di essi oltre l’80% era analfabeta, ma nel Sud si raggiungeva il 90%, e le donne analfabete erano quasi il 100%.
Se nell’Italia del XIX secolo, nella quale erano diffusi moltissimi dialetti, si è avuta, con l’Unità, l’unificazione nazionale della lingua sull’intero territorio ben sette secoli dopo i capolavori di Dante, Petrarca e Boccaccio, oggi è un dovere rispettare questa faticosa conquista, tutelando la vitalità e l’autonomia dell’italiano e rispettando e accogliendo il contributo culturale (letterario, storico, artistico, antropologico) di tutti i dialetti diffusi sulla penisola.
I dialetti, che testimoniano un passato ricco di pensiero, di poesia, di canti, di affermazione di conquiste sociali e, quindi, di storia, non sono più un segno di arretratezza, di discriminazione, di esclusione dall’istruzione pubblica, di distinzione tra ceti sociali, ma di formidabile arricchimento culturale (cfr. il grande sforzo fatto nel XX secolo da Filippo Fichera nel ricercare e pubblicare materiali di letteratura dialettale di tanti autori di poesia, di teatro e di canti vernacolari, sparsi in tutte le Regioni italiane). Difendere il ruolo dei nostri idiomi, sia nazionale, che locali, è oggi una grande necessità, perché insieme si arricchiscono e si integrano. Cospicui, infatti, sono i patrimoni dialettali, praticamente di tutti i territori italiani.
Limitandoci a parlare solo del dialetto romanesco, non va dimenticato il suo grande contributo offerto alla cultura nazionale e, talvolta internazionale, (con autori quali Mario dell’Arco, Giuseppe Gioachino Belli, Giuseppe Berneri, Crescenzo Del Monte, Checco Durante, Aldo Fabrizi, Adolfo Giaquinto, Americo Giuliani, Augusto Jandolo, Elia Marcelli, Mauro Marè, Augusto Marini, Cesare Pascarella, Augusto Sindici, Trilussa, Giggi Zanazzo…). Nel Lazio anche altri dialetti hanno avuto i loro preziosi poeti (Giuseppe Zumpetta, Attilio Taggi, Riccardo Gulia, Filippo Nicolò, Paolino Colapietro, Porfirio Grazioli, Fulvio Cocuzzo…).
Con l’istruzione scolastica, garantita a tutti, e la grande diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, il ruolo della lingua nazionale non dovrebbe essere oggi più in discussione, ha basi solide, da difendere, se diamo vigore agli sforzi dei veri amanti della nostra cultura. Ma molti giornalisti dei nostri mezzi d’informazione, molti pubblicitari, molti intellettuali e scienziati, moltissimi politici e gran parte della classe dirigente, invece di contrastare i forestierismi, favoriscono una loro supina accettazione. Addirittura alcuni linguisti li giustificano come evento naturale e molti negano che l’anglicizzazione della nostra lingua sia un problema.
Senza essere integralisti, nella realtà si assiste a uno straripamento dell’idioma anglosassone accettato acriticamente e, da quanto si legge sui giornali o si ascolta alla radio e alla tv e nella parlata della gente comune, molti italiani si esprimono seguendo questa moda, utilizzando per atteggiamento imitativo locuzioni alloctone, convenzionali e stereotipate, ed espressioni ripetute meccanicamente e banalizzate. Qualche linguista afferma che in alcuni Paesi sta vincendo la logica che vuole condurre tutto il mondo verso un bilinguismo inglese-lingue locali, dove queste sono viste come puri casi, che progressivamente verranno assorbiti dall’inglese globale, già chiamato anche “globalese”.
Questa “neo-lingua” secondo lo studioso tedesco Jürgen Trabant «è tutto il contrario del pluralismo linguistico» e questa strategia sta creando una moderna «diglossia neomedievale che pone barriere sociali nei singoli Stati, con fratture linguistiche e culturali tra chi parla l’inglese e chi no, tra le classi sociali alte e quelle basse». Da alcuni decenni sono nate associazioni, che si battono contro il monolinguismo e per il multi-culturalismo, che si opponga al colonialismo linguistico. L’attore e regista teatrale Ulderico Pesce ha affermato:
«Io sento molto l’occupazione linguistica e culturale da parte dell’Inghilterra e degli Stati Uniti. Non l’accetto e sono molto dubitativo su questo processo: dietro c’è l’arroganza di un popolo colonizzatore che prima saccheggia risorse, poi impone la sua lingua. Così facendo, un Paese colonizzatore ti schiavizza. Io mi sento un occupato, ma la maggior parte di noi non se ne accorge».
A sostegno di queste riflessioni, troppo facilitate dell’ingresso dell’inglese, vi sono anche i riferimenti alla straripante invasione di dischi, film, telefilm, prodotti della rete, canzoni e produzioni letterarie strettamente anglo-americane nelle varie nazioni Europee, che trovano facile canale di accesso e ricca soddisfazione di guadagni. Al contrario, le omologhe produzioni nelle altre lingue europee incontrano fortissimi ostacoli nell’entrare nel mondo anglofono. Perché non riequilibrare il sistema, per dirla in modo provocatorio, come si usava in altre epoche, magari, con una qualche politica dei dazi?
Giorgio Pagano, prematuramente scomparso nel trascorso mese di marzo 2020, infaticabile segretario dell’Associazione per la Democrazia Linguistica, in questi ultimi trent’anni ha promosso convegni, dibattiti, interventi radiofonici e televisivi su questo tema, sostenendo un’azione mirata verso la Comunità Europea per la scelta di usare l’esperanto come lingua del continente, invece dell’inglese, che, con l’uscita della Gran Bretagna dalla Comunità, non ha addirittura più alcun titolo di lingua ufficiale, dichiarando che l’esperanto:
1. si nutre di vocaboli prelevati dalle varie lingue,
2. vive “accanto” alle lingue native delle varie Nazioni,
3. non fa opera di erosione dei loro lemmi ed ha affermato che, non avendo una lingua comune:
«Ciascun popolo subisce linguisticamente la legge del più forte che, spesso, vuole ergersi a più giusto definendo con il termine internazionalizzazione ciò che, nella sostanza, è la nazionalizzazione linguistica di altri Stati e popoli, un colonialismo delle menti che produce linguicidio, discriminazione ed effetti socio-economici, politici e culturali devastanti».
ha inoltre, anche, affermato:
«La nostra classe dirigente, intellettuale, mediatica, non può più fingersi ignara del disegno imperialista alle spalle dell’imposizione dell’inglese a noi e ai nostri figli; da questo momento, chi attacca al suo stesso popolo il giogo linguistico è automaticamente responsabile del declino del Paese e consapevole di derubare delle pari opportunità le nuove generazioni».
Giorgio Pagano nei manifesti che promuovevano le sue iniziative ha sempre riprodotto il volto del Mahatma Gandhi, che già nel 1908 aveva affermato:
To give millions a knowledge of English is to ensalave them.
Dare a milioni di persone una conoscenza dell’inglese significa schiavizzarli.
Lo stesso Tacito descrisse in modo analogo il metodo con cui i Romani sottomisero i popoli germanici: fecero loro desiderare la cultura di Roma, proponendola come modello superiore da imitare, sì da far passare per “cultura”, quello che fu un vero piano di asservimento.
A sostegno di questa tesi, Giorgio Pagano mise in rete nel 2014, qualificandolo come manifesto di colonizzazione linguistica, un importante discorso del 1943, in cui Winston Churchill esprimeva con chiara lucidità l’idea di mettere in atto un piano per la diffusione massiccia della lingua inglese in tutti i continenti. Un discorso che, sotto le vesti del miglioramento dei contatti tra i popoli, mostra ancora oggi l’intenzione di funzionare da cavallo di Troia per interessi più spiccatamente di supremazia economica, politica e culturale.
Questo discorso fu tenuto negli Stati Uniti in occasione del conferimento al premier britannico della laurea ad honorem da parte del presidente dell’Università di Harvard, James Bryant Conant, e fu diffuso alla radio inglese a onde corte il 6 settembre 1943. In esso Churchill accennò ai giovani studenti delle due nazioni, impegnati nella seconda guerra mondiale, che, interrompendo gli studi, erano partiti per il fronte. Parlò, poi, delle grandi responsabilità delle Nazioni e del mondo che si rimpiccoliva, grazie ai moderni progressi dell’aeronautica e ai forti legami di sangue e di storia esistenti tra l’Inghilterra e gli Stati Uniti per comunanza di leggi, lingua e letteratura. Affermò che già il cancelliere tedesco Bismarck aveva osservato che un elemento molto importante tra queste due Nazioni era l’avere la stessa lingua, che permetteva di condurre la guerra in una perfetta e comune armonia. Tra esse la lingua inglese era un fondamento di civiltà.
Alla conclusione del discorso, poi, parlò dei piani per il dominio dei popoli con l’unificazione linguistica, teorizzando che l’impero del futuro, sarebbe stato l’impero delle menti. Questo è lo stralcio conclusivo del suo intervento:
«Questo dono di una lingua comune è un’eredità inestimabile e un giorno potrebbe diventare il fondamento di una cittadinanza comune. Mi piace pensare a inglesi e americani che si muovano liberamente ognuno sui vasti territori dell’altro, senza alcuna sensazione di essere stranieri gli uni agli altri. Ma non vedo perché non dovremmo provare a diffondere la nostra lingua comune ancora più ampiamente in tutto il mondo e, senza cercare un vantaggio egoistico su nessuno, impadronirci di questo inestimabile bene e diritto di nascita.
Alcuni mesi fa ho convinto il governo britannico a istituire un comitato di ministri per studiare e riferire sull’inglese di base (basic english). L’altra sera, quale è stata la mia gioia, del tutto inaspettata, quando ho sentito il Presidente degli Stati Uniti parlare dei meriti del basic english. E non è, forse, una coincidenza, con tutto questo in mente, che io debba arrivare ad Harvard a soddisfare un invito di lunga data a ricevere questa laurea, con cui il presidente Conant mi ha onorato? La commissione di Harvard sugli studi della lingua inglese è illustre sia per la sua ricerca, che per il suo lavoro pratico, in particolare sull’introduzione dell’uso dell’inglese di base in America [...], da insegnare ai bambini americani e agli stranieri che si preparano alla cittadinanza. Mi congratulo con voi, perché questo potrebbe essere un potente, fertile e salutare fiume.
Sarebbe certamente un grande vantaggio per tutti noi, essere in grado di muoverci liberamente in tutto il mondo, come saremo in grado di fare, più liberamente che mai prima, con lo sviluppo della scienza nel mondo e trovare ovunque un mezzo (l’inglese basico) di relazione e comprensione. Non potrebbe anche essere un vantaggio per molte razze e un aiuto per la costruzione della nuova struttura per preservare la pace? Tali piani (per la diffusione della lingua inglese) offrono bottini molto migliori che portar via le province o le terre di altri popoli o schiacciarli nello sfruttamento. Gli imperi del futuro sono gli imperi della mente».
A conclusione di questa digressione si possono fare alcune opportune valutazioni. La cedevolezza degli italiani ad abbeverarsi all’idioma inglese e a preferirlo a qualunque altro modo di comunicare, dilaga su molti fronti, ma addirittura rischia il ridicolo solo se, come già visto nei paragrafi precedenti, si esamina l’insensato comportamento dei politici a dare nomi eterodossi a leggi, procedure, iter burocratici e indicazioni normative che, se non sono sintomi di sudditanza culturale, sono altrimenti una espressione mistificata e di mascheramento delle scelte politiche in atto.
E, mettendo da parte l’efficace resistenza ai bombardamenti nazisti e il decisivo e fondamentale contributo dato alla vittoria degli Alleati nella seconda guerra mondiale contro le nazioni dell’Asse, gli Americani, e soprattutto gli Inglesi nella storia, da abitanti di un’isola, hanno spesso perseguito politiche molto discutibili, con un imperialismo duro e spregiudicato, in alcuni momenti con mezzi di forte violenza schiavista, con cui conquistarono molta parte dei continenti, il più vasto impero nella storia dell’uomo, che comprendeva dominion, colonie, protettorati, mandati e altri territori governati o amministrati dal Regno Unito. Rimanendo avvolti da un complesso di superiorità, che li ha indirizzati su idee soggettive e in contrasto con chiunque si alleasse con loro, gli Inglesi hanno conservato, rispetto al mondo, sempre la propria moneta e l’istituto della monarchia. Quella inglese ha una storia millenaria e, su 195 Nazioni nel mondo, è tra le poche, refrattarie al cambiamento.
Gli Inglesi hanno tardato ad accettare il sistema metrico decimale, che ha uniformato le esigenze di una vastissima popolazione mondiale e ancora oggi mantengono largamente in uso alcune anacronistiche misure del Sistema Imperiale (pollice, mano, spanna, piede, yarda, oncia, libbra, pinta, gallone…). E così anche in questa epoca in cui la pandemia del Coronavirus è dilagata nel mondo, le decisioni inglesi di contrasto, sia in Inghilterra, sia negli stati Uniti, soprattutto nell’anno 2020 hanno avuto caratteri singolari, illogici, insensati, assurdi, rispetto a tutte le politiche mondiali di prudente contenimento, finché il loro premier Boris Jonhson non è stato colpito dal morbo.
Irrazionale è stato, poi, il comportamento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, propugnatore di un conservatorismo ottuso. Ha condiviso con gran parte degli americani la condizione che ognuno dovesse difendersi da solo dal contagio. Ha dichiarato che solo le Nazioni governate dai comunisti potevano imporre a cittadini, nati liberi, leggi restrittive per porre freno all’epidemia. Ha negato a lungo l’esistenza della pandemia, ha suggerito di combatterla con l’uso di comuni prodotti igienizzanti. Ha impedito agli scienziati di condurre politiche sanitarie di prudenza e di rigore scientifico. Ha condiviso, invece, le idee insensate di varie comunità religiose, che rifiutavano l’uso delle mascherine, perché Iddio ha creato gli uomini capaci di respirare liberamente e non per essere soffocati da filtri opprimenti. E poi, ci avrebbe pensato Dio a proteggere chi avesse fede.
Inghilterra e Stati Uniti, a parte la gratitudine, che dobbiamo loro, per il contributo dato alle sorti della seconda guerra mondiale, a rifletterci bene non sono stati negli ultimi decenni dei buoni modelli di politica internazionale. Troppo spesso ci siamo trovati a dissentire dai loro indirizzi e programmi. La politica di orgoglio e presunzione ha portato l’Inghilterra nel 2019 a decretare la sua uscita dall’Europa. Tale scelta (la Brexit) non ha portato, però, vantaggi economici, anzi: dal referendum sull’uscita dalla Comunità Europea fino al momento della pandemia, la sterlina inglese ha avuto andamenti molto instabili e un crollo di valore rispetto al dollaro di oltre il 20%.
Quindi, è anche ragionevole chiederci: vale la pena per noi italiani ispirarci al pensiero e ai programmi dei due più potenti Stati anglofoni nel mondo, che negli ultimi anni hanno talvolta espresso dirigenti e politiche discutibili, improvvisate e non collimanti con le aspirazioni di moltissimi Paesi del pianeta e della Comunità europea? Mantenere un’autonomia di pensiero e soprattutto di cultura non è per noi un diritto inalienabile da difendere? Riappropriarci della nostra lingua e proteggerla in modo coraggioso non è il primo atto di dignità e di indipendenza morale e culturale, che dobbiamo intraprendere?
Stiamo, per colpa nostra perdendo, minuto per minuto, la nostra lingua natia, con tutte le conseguenze culturali, economiche e sociali che ne derivano. E, tranne rare eccezioni, la gran parte dei nostri intellettuali più in vista non crea alcuna difesa contro questa sottrazione, anzi, con la sottovalutazione, o ingenuità, o scarso coraggio, la agevola. O forse pensano che il mito del progresso sia da identificare nel parlare in modo anglo-americano?
La lingua è il più importante e prezioso vettore di cultura. Perderla, equivale a dissipare tutto il patrimonio di civiltà, costruito dai nostri antenati nel passato. Per questi motivi bisogna proteggere con forza l’italiano, bisogna custodirlo, bisogna curarlo, facendolo vivere, garantendogli al meglio una purezza, non aggredita da ingiustificati inquinamenti e trasmettendo la memoria della sua evoluzione nei secoli.
Come per il paesaggio, come per le antiche sementi, come per le specie botaniche e gli esseri viventi in via di estinzione, come per determinate usanze del passato, noi dovremmo con coraggio andare controcorrente ed essere fermi “difensori” della nostra preziosa lingua e dei nostri magnifici dialetti. A loro volta questi nostri modi di comunicare sono scrigni di “memoria”, e i dialetti non sono solo modi del colloquiare domestico, ma elementi che custodiscono molte tappe e saperi della nostra secolare civiltà.
L’italiano ha un fascino ineguagliabile e non può di colpo essere considerato idioma inutile e ormai obsoleto. Se si sottovaluta il suo valore, se ne decreta la perdita. Quanti dessero spazio a questo criminoso sperpero dovrebbero essere giudicati irrimediabilmente masochisti e distruttori delle basi della nostra conoscenza. Guai a perdere le parole che possano esprimere la nostra civiltà!
Il linguaggio richiede d’essere accordato come un violino: e proprio come troppe o troppo poche vibrazioni nella voce d’un cantante o nel tremolìo d’una corda daranno la nota falsa, così troppe parole (ma potremmo sostituire questo termine con ‘troppe intrusioni di forestierismi’, ndr) defrauderanno il messaggio (Oscar Wilde, De Profundis).
In verbis etiam tenuis cautusque serendis dixeris egregie, notum si callida verbum reddiderit iunctura novum.
E il tuo linguaggio, anche nella lievità e nella prudenza, sarà unico e raro, se un accostamento astuto farà, della parola conosciuta, la parola nuova (Orazio Flacco, Ars poetica: vv. 46-48).
 Il dolore di Ignazio Buttitta, orfano delle sue parole
Il dolore di Ignazio Buttitta, orfano delle sue parole
Si riporta, in chiusura, una straordinaria poesia dialettale, forse la più conosciuta, del 1970 del poeta siciliano Ignazio Buttitta (Bagheria, 1899-1997), in cui lamenta un irreparabile “furto” linguistico. La scomparsa, lo smarrimento, la perdita della sua parlata d’origine (una chitarra cui viene tolta una corda al giorno) è per lui una tragedia: è la distruzione per sempre di una cultura plurisecolare, è la sparizione di un’identità.
Credo/confido possa essere condivisa da tutti coloro che sono sensibili al tema del pericolo in atto, della perdita (qualcuno ha iniziato a chiamarla “necrosi”) e svalutazione della nostra lingua italiana e dei nostri preziosi dialetti.
Lingua e dialettuUn populumittitilu a catinaspughiatiluattuppatici a vuccaè ancora libiru.Livatici u travagghiuu passaportu a tavulaunnu manciau lettu unnu dormi,è ancora riccu.Un populodiventa poviru e servuquannu ci arrubbano a linguaaddutata di patri:è persu pi sempri.Diventa poviru e servuquannu i paroli non figghianu parolie si mancianu tra d’iddi.Mi n’addugnu ora,mentri accordu la chitarra du dialettoca perdi na corda lu jornu.Mentre arripezzua tila camulutaca tissiru i nostri avicu lana di pecuri siciliani.E sugnu poviru:haiu i dinarie non li pozzu spènniri;i giuiellie non li pozzu rigalari;u cantunta gaggiacu l’ali tagghiati.Un poviruc’addatta nte minni strippida matri putativachi u chiama figghiupi nciuria.Nuatri l’avevamu a matri,nni l’arrubbaru;aveva i minni a funtana di lattie ci vìppiru tutti,ora ci sputanu.Nni ristò a vuci d’idda,a cadenza,a nota vasciadu sonu e du lamentu:chissi no nni ponnu rubari.Non nni ponnu rubari,ma ristamu poverie orfani u stissu. |
Lingua e dialettoUn popolomettetelo in catenespogliatelotappategli la boccaè ancora libero.Levategli il lavoroil passaportola tavola dove mangiail letto dove dorme,è ancora ricco.Un popolodiventa povero e servoquando gli rubano la linguaricevuta dai padri:è perso per sempre.Diventa povero e servoquando le parole non figliano parolee si mangiano tra di loro.Me ne accorgo ora,mentre accordo la chitarra del dialettoche perde una corda al giorno.Mentre rappezzola tela tarmatache tesserono i nostri avicon la lana di pecore siciliane.E sono povero:ho i danarie non li posso spendere;i gioiellie non li posso regalare;il cantonella gabbiacon le ali tagliate.Un poveroche allatta dalle mammelle aridedella madre putativa,che lo chiama figlioper scherno.Noialtri l’avevamo, la madre,ce la rubarono;aveva le mammelle a fontana di lattee ci bevvero tutti,ora ci sputano.Ci restò la voce di lei,la cadenza,la nota bassadel suono e del lamento:queste non ce le possono rubare.Non ce le possono rubare,ma restiamo poverie orfani lo stesso. |
Dialoghi Mediterranei, n. 48, marzo 2021
Appendice
di Tommaso Cecilia
[...] Leggendo il testo La difesa dei nostri patrimoni linguistici dall’inglese superfluo di Ugo Iannazzi, pubblicato sul n. 47 di Dialoghi Mediterranei, ho preso spunto per andare a rivedere il libro di linguistica di Emilio Garro, in adozione molti decenni fa nel mio corso di studi ginnasiali e ho verificato con stupore che vi si esprimeva la stessa rabbia, la stessa indignazione di Ugo Iannazzi.
La mania di alcuni di ricorrere ai barbarismi, secondo il Garro, avveniva «per il vezzo e per la voglia di parer singolari” pensando di “farsi belli… col fiorettare la loro meschinità” ricorrendo a “parole altisonanti e peregrine… e darsi così una certa aria esotica».
Un malcostume lamentato anche nel ‘700 dal Parini, che mal sopportava “tale invadenza gallica” e affermava:
«Misere labbra, che temprar non sanno
con le galliche grazie il sermon nostro,
sì che men aspro a’ delicati spirti
e men barbaro suon fieda (ferisca ndr) gli orecchi!».
Mi vien voglia di dire: niente di nuovo sotto il sole. Nell’appello di Iannazzi è riportata una lunga lista di parole straniere, ieri francesi, oggi inglesi, che vanno a sostituire quelle italiane. Ma il fenomeno odierno mostra una gravità molto superiore a quella del Settecento e una necessità di intervento assolutamente non più dilazionabile. Molte pagine di giornali, molte pubblicità, molti articoli di argomento finanziario, o tecnologico sono pubblicati oggi su organi d’informazione italiani con sempre maggiore intrusione di vocaboli stranieri e senza traduzione. Forse tra qualche anno queste pagine saranno scritte solo in lingua straniera.
Porre un freno e arginare questa dilagante assuefazione generale, operata dai massimi utilizzatori della nostra lingua (politici, direttori di giornali e telegiornali, giornalisti, scrittori, pubblicitari, gente in cerca di visibilità…) e, a caduta, da tanti altri imbonitori e venditori di fumo, è un atto necessario e improrogabile per tutelare il nostro patrimonio linguistico e per evitare che l’idioma inglese compia non solo in Italia una micidiale opera di linguicidio, via, via aggredendo l’italiano, necrotizzandolo e lasciando traccia anche nei dialetti.
Promuovere quest’atto è un segno di grande civiltà e di rispetto per la cultura italiana, ma vale anche per altre culture del mondo.
_________________________________________________________
Ugo Iannazzi, architetto, museografo, studioso di tradizioni popolari, ha realizzato ad Arpino (FR) il Museo dell’Arte della Lana e redatto progetti per i Musei della Liuteria e delle Arti tipografiche. Con Eugenio Beranger ha creato ad Arce (FR) il Museo antropologico della “Gente di Ciociaria” nel 2004 e pubblicato nel 2007 il relativo saggio storico-critico, che raccoglie le vicende territoriali, gli usi e i costumi popolari del mondo rurale e artigiano locale. In collaborazione con Antonio Quaglieri ha pubblicato nel 2016 Chi parla i sparla nen perde ma’ tiempe. La civiltà contadina, una filastrocca, un pretesto e nel 2018, in collaborazione con Ercole Gabriele Gli apologhi di Fedro tradotti in dialetto arpinate. Ha in corso di stampa Il pensiero popolare, detti, proverbi, motti, raccolti da Luigi Venturini nel 1911 e da Antonio Quaglieri nel 2011; e in preparazione, un saggio sul poeta dialettale Giuseppe Zumpetta e uno sugli incontri a Firenze tra Gioacchino Rossini e il letterato Filippo Mordani.
______________________________________________________________