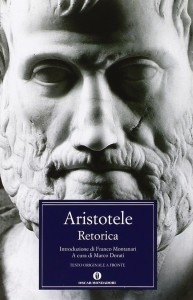In molti casi i protagonisti della comunicazione politica hanno sentito l’esigenza di elaborare strategie per piacere al proprio pubblico, influendo sia sulla formazione delle opinioni, sia sulla diffusione di abitudini e stili di vita, avendo come unico obiettivo solo il puro convincimento ideologico, senza tenere conto della verità fattuale. In quest’ottica per influenzare i comportamenti del pubblico si è fatto uso di strategie discutibili e razionalmente infondate, con lo scopo di manipolarlo e condurlo a posizioni che andavano a vantaggio di chi detiene il potere, escludendo qualsiasi altra finalità che esuli dalla persuasione fine a se stessa. Questo modo di intendere la comunicazione persuasiva – e sul quale si basa oggi gran parte del discorso pubblico – viene considerato da Meyer (1993: 29) un esempio di “retorica-manipolazione”.
L’efficacia delle tecniche di manipolazione dipende dal fatto che il rapporto tra verità e politica è spesso di tipo conflittuale: secondo l’autorevole punto di vista di Hannah Arendt, la verità spesso si configura come un elemento antipolitico, al punto che tutti coloro che dimostrano di essere in grado di accollarsi il peso della verità e della coerenza con il dato di fatto reale si collocano generalmente al di fuori della sfera politica, o comunque in forte tensione con essa: «Nessuno ha mai dubitato del fatto che verità e politica siano in rapporti piuttosto cattivi l’una con l’altra e nessuno, che io sappia, ha mai annoverato la sincerità tra le virtù politiche» (Arendt 1968: 92).
In molti casi la politica tende a ignorare e a emarginare la verità perché la considera un ostacolo agli interessi di potere e ai particolarismi che essa rappresenta; interessi che spesso sono consolidati facendo sì che l’opinione pubblica creda vero ciò che invece non è comprovato o non resiste alla prova di falsificazione (D’Agostini 2012: 54). Gli apparati politici cercano poi in ogni modo di appiattire qualsiasi verità fattuale al livello dell’opinione, in modo che i cittadini non siano in grado di cogliere alcuna differenza tra di loro:
«Ciò che appare ancora più allarmante è che nei Paesi liberi, nella misura in cui delle verità di fatto sgradite sono tollerate, esse sono spesso, consciamente o inconsciamente, trasformate in opinioni; come se fatti quali il sostegno a Hitler da parte della Germania o il crollo della Francia davanti all’esercito tedesco nel 1940 o la politica del Vaticano durante la seconda guerra mondiale, non fossero dei fatti storici documentati, ma delle questioni d’opinione» (ivi: 41).
Il perno di questa visione della retorica quale sofistica all’interno dell’intero ambito politico è costituito dalla relazione conflittuale ed apparentemente irrisolvibile tra verità e politica, teorizzata dalla filosofa di Hannover. Tuttavia nelle pagine finali di Truth and politics è la stessa Hannah Arendt a suggerire una via d’uscita da quello che sembra un vicolo senza fondo:
«Dal momento che qui mi sono occupata della politica dalla prospettiva della verità e quindi da un punto di vista esterno all’ambito politico, non ho menzionato neanche di sfuggita la grandezza e la dignità di ciò che accade all’interno di esso. Ho parlato come se l’ambito politico non fosse che un campo di battaglia per interessi parziali e in conflitto, dove non conterebbero che il piacere e il profitto, la faziosità e il desiderio di dominio. In breve, mi sono occupata di politica come se anch’io credessi che tutti gli affari pubblici sono governati dall’interesse e dal potere, che non vi sarebbe alcun ambito politico se non fossimo costretti a preoccuparci della necessità di vita. La ragione di questa deformazione è che la verità di fatto si scontra con la sfera politica soltanto a questo più basso livello degli affari umani [...]. In questa prospettiva, restiamo ignari del contenuto effettivo della vita politica, della gioia e della gratificazione che derivano dall’essere in compagnia dei nostri pari, dall’agire insieme e dall’apparire in pubblico, dall’inserirci nel mondo attraverso la parola e l’azione, acquisendo e sostenendo così la nostra identità personale e dando inizio a qualcosa di completamente nuovo» (ivi: 77).
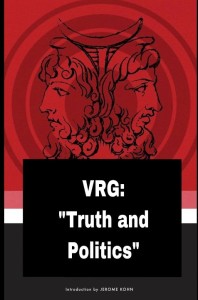 Dunque il contrasto tra verità e politica non va interpretato come totale ed irreversibile, ma come uno scontro che avviene solo ad un determinato livello di realtà, e non tout court. Detto altrimenti, la politica non può considerarsi solo come uno spazio di conquista di potere individuale e di perseguimento di interessi personali, per il raggiungimento del quale si arriva allo scontro con la verità, ma deve anche essere interpretata come una sfera nella quale il cittadino interviene per trasformare in positivo la realtà, magari partendo proprio da essa e dalla verità che ne rende conto. Come conseguenza di ciò, la politica resta dunque un terreno di semina possibile per la retorica che non vuole degenerare in sofistica, poiché in essa, diversamente da quanto accade con la propaganda (che non a caso è un settore limitato della comunicazione politica), è possibile una retorica che parta non da una necessità esclusivamente persuasiva, mirante solo ad ottenere un consenso, ma da una volontà di convincere sulla base di fatti veri o verosimili, sul quale poi si articoleranno le argomentazioni destinate a persuadere.
Dunque il contrasto tra verità e politica non va interpretato come totale ed irreversibile, ma come uno scontro che avviene solo ad un determinato livello di realtà, e non tout court. Detto altrimenti, la politica non può considerarsi solo come uno spazio di conquista di potere individuale e di perseguimento di interessi personali, per il raggiungimento del quale si arriva allo scontro con la verità, ma deve anche essere interpretata come una sfera nella quale il cittadino interviene per trasformare in positivo la realtà, magari partendo proprio da essa e dalla verità che ne rende conto. Come conseguenza di ciò, la politica resta dunque un terreno di semina possibile per la retorica che non vuole degenerare in sofistica, poiché in essa, diversamente da quanto accade con la propaganda (che non a caso è un settore limitato della comunicazione politica), è possibile una retorica che parta non da una necessità esclusivamente persuasiva, mirante solo ad ottenere un consenso, ma da una volontà di convincere sulla base di fatti veri o verosimili, sul quale poi si articoleranno le argomentazioni destinate a persuadere.
La strategia volta a equiparare i dati di fatto alle interpretazioni – che la Arendt rifiuta radicalmente (Flores D’Arcais 2006: 55-58) – è il tratto costitutivo di ogni sistema propagandistico che rappresenta appunto il tentativo di indirizzare il pensiero di un determinato numero di persone verso una posizione di parte, attraverso un utilizzo della persuasione caratterizzato dall’alterazione della verità e dei fatti. Le definizioni del termine “propaganda” sono state numerose e in molti casi dissonanti, tuttavia al di là delle differenze di valutazione è possibile ritrovare un filo conduttore comune proprio nel processo di manipolazione di opinioni e di atteggiamenti attuato attraverso l’uso deliberato di suggestioni collettive. È rimasta celebre la definizione di propaganda offerta da Bernays, uno dei più importanti teorici della comunicazione politica della prima metà del Novecento:
«la propaganda è la manipolazione consapevole e intelligente delle opinioni e delle abitudini delle masse che svolge un ruolo importante in una società democratica, coloro i quali padroneggiano questo dispositivo sociale costituiscono un potere invisibile che dirige veramente il paese» (Bernays 1928: 25).
Attraverso la propaganda sono anche attivate le strategie patemiche che hanno lo scopo di suscitare emozioni forti di generi differenti: paura, odio, orgoglio, senso di appartenenza, rabbia. È fondamentale per i fini persuasivi della propaganda suggerire in primis la paura e, successivamente, mettere in evidenza l’azione necessaria per sciogliere la situazione pericolosa creata dallo spavento. I messaggi emozionali sono privilegiati nel flusso comunicativo perché risultano molto più efficaci, in quanto offrono al pubblico una rappresentazione semplificata della realtà che prevede solo la presenza di due sistemi di valore antitetici – come il bene e il male, il positivo e il negativo, il modello e l’antimodello – tra i quali le possibilità di scelta sono obbligate.
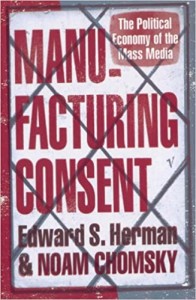 Una seconda modalità con cui la politica ridisegna i sistemi di verità è rappresentata dall’uso della cosiddetta “nobile menzogna” che si propone lo scopo di guidare il popolo verso ciò che viene ritenuto il bene e, a questo fine, di educarne i comportamenti. È stato Chomsky a dimostrare quanto questa concezione – che ammette un uso consapevole, finalizzato al bene, della menzogna – possa costituire il fondamento teorico delle strategie politiche e della loro applicazione nella propaganda del Novecento: «Secondo questa teoria solo un’élite [...] è in grado di comprendere gli interessi comuni, quelli che ci stanno a cuore, e di avere chiaro il fatto che questi argomenti non prevedono il coinvolgimento dell’opinione pubblica» (Chomsky 1994: 17). In questo caso Chomsky fa riferimento allo sviluppo che i sistemi di propaganda hanno avuto nella società anglosassone della prima metà del Novecento, uno sviluppo determinato e regolato dal potere politico che si avvale della collaborazione di elementi altamente specializzati, rappresentanti di un’élite perfettamente consapevole del proprio ruolo decisionale e della propria discrezionalità nel controllare i mezzi di comunicazione. Di questa élite hanno fatto parte, ad esempio, due grandi esponenti del pensiero politico europeo come Walter Lippmann e Edward Bernays.
Una seconda modalità con cui la politica ridisegna i sistemi di verità è rappresentata dall’uso della cosiddetta “nobile menzogna” che si propone lo scopo di guidare il popolo verso ciò che viene ritenuto il bene e, a questo fine, di educarne i comportamenti. È stato Chomsky a dimostrare quanto questa concezione – che ammette un uso consapevole, finalizzato al bene, della menzogna – possa costituire il fondamento teorico delle strategie politiche e della loro applicazione nella propaganda del Novecento: «Secondo questa teoria solo un’élite [...] è in grado di comprendere gli interessi comuni, quelli che ci stanno a cuore, e di avere chiaro il fatto che questi argomenti non prevedono il coinvolgimento dell’opinione pubblica» (Chomsky 1994: 17). In questo caso Chomsky fa riferimento allo sviluppo che i sistemi di propaganda hanno avuto nella società anglosassone della prima metà del Novecento, uno sviluppo determinato e regolato dal potere politico che si avvale della collaborazione di elementi altamente specializzati, rappresentanti di un’élite perfettamente consapevole del proprio ruolo decisionale e della propria discrezionalità nel controllare i mezzi di comunicazione. Di questa élite hanno fatto parte, ad esempio, due grandi esponenti del pensiero politico europeo come Walter Lippmann e Edward Bernays.
Lippmann è la personalità che forse più ha segnato il giornalismo americano del Novecento; ha ricoperto la carica di sottosegretario aggiunto USA alla guerra e nel 1922 ha pubblicato lo studio sull’opinione pubblica, certamente la sua opera più conosciuta e che ancora oggi conserva intatta la sua ricchezza descrittiva e il suo valore euristico. Con questo libro egli ha analizzato il processo complesso mediante il quale si viene a formare l’opinione pubblica, descrivendo i vari tipi di figure che la compongono (i modelli da seguire, i nemici da esecrare, i preconcetti e i pregiudizi) e i meccanismi che traducono poi l’opinione pubblica dominante in fine sociale e in volontà collettiva. Lippmann è convinto del fatto che lo Stato (in questo caso gli USA) deve essere diretto da un’avanguardia di persone competenti e responsabili e tutti gli altri cittadini devono lasciar fare, delegando le proprie decisioni a questa avanguardia; da ciò emerge la necessità di usare le tecniche di propaganda per controllare le masse, tecniche che fanno parte di
«un’arte vecchissima che era stata data per morta quando apparve la democrazia. Ma non è morta. In realtà ne è stata migliorata enormemente la tecnica, perché ora si fonda sull’analisi piuttosto che sulla pratica. E così, per effetto della ricerca psicologica abbinata ai moderni mezzi di comunicazione, la prassi democratica ha subìto una svolta. Sta avvenendo una rivoluzione, infinitamente più significativa di qualsiasi spostamento di potere economico» (Lippmann 1922: 234).
La manipolazione è dunque l’elemento comune e trasversale che accomuna tutte le forme della comunicazione propagandistica in tutti i contesti in cui è stata applicata: «Ormai chiamiamo tutto questo propaganda. Un gruppo di persone, in grado di impedire il libero accesso ai fatti, ne manipolano la notizia in vista di un loro fine» (ivi:31).
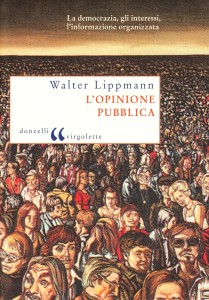 Questa necessità di controllare ciò che le persone pensano, di irreggimentare le loro coscienze è sentita anche da Bernays, anche lui membro, come Lippmann, dell’apparato ufficiale di propaganda del presidente americano democratico Wilson (in carica dal 1913 al 1921), noto anche come “Commissione Creel”. Anche Bernays è consapevole dell’importanza delle strategie propagandistiche impiegate dal leader politico per convincere i cittadini della giustezza delle proprie idee, con la finalità ultima di ottenere l’adesione del pubblico al suo programma. La manipolazione consapevole e intelligente, delle opinioni e delle abitudini delle masse svolge un ruolo importante in una società democratica, coloro i quali padroneggiano questo dispositivo sociale costituiscono un potere invisibile che dirige veramente il Paese:
Questa necessità di controllare ciò che le persone pensano, di irreggimentare le loro coscienze è sentita anche da Bernays, anche lui membro, come Lippmann, dell’apparato ufficiale di propaganda del presidente americano democratico Wilson (in carica dal 1913 al 1921), noto anche come “Commissione Creel”. Anche Bernays è consapevole dell’importanza delle strategie propagandistiche impiegate dal leader politico per convincere i cittadini della giustezza delle proprie idee, con la finalità ultima di ottenere l’adesione del pubblico al suo programma. La manipolazione consapevole e intelligente, delle opinioni e delle abitudini delle masse svolge un ruolo importante in una società democratica, coloro i quali padroneggiano questo dispositivo sociale costituiscono un potere invisibile che dirige veramente il Paese:
«Noi siamo in gran parte governati da uomini di cui ignoriamo tutto, ma che sono in grado di plasmare la nostra mentalità, orientare i nostri gusti, suggerirci cosa pensare (…) in tutti gli aspetti della vita quotidiana, dalla politica agli affari, dal nostro comportamento sociale ai nostri valori morali, di fatto siamo dominati da un piccolo gruppo di persone capaci di comprendere i processi mentali e i modelli sociali delle masse» (Bernays 1928: 25-26).
Gli esempi di Lippmann e Bernays dimostrano che la propaganda moderna è nata nella società anglosassone agli inizi del Novecento, non solo negli Stati Uniti ma anche in Inghilterra dove del resto già esisteva un Ministero dell’informazione. Ciò non deve stupire perché la propaganda risulta particolarmente congeniale proprio ai sistemi democratici dove, essendo in vigore la libertà di pensiero e di parola, è necessario impiegare strumenti propagandistici il più possibile indiretti e sfumati, in modo che non siano riconosciuti dal pubblico come tali. Poiché sia l’Inghilterra che gli USA erano anche allora due Paesi a larga partecipazione democratica, era necessario studiare ed affinare strategie per controllare le opinioni e prevedere i comportamenti sociali, non essendo possibile usare direttamente la forza per orientare il consenso, se non in casi eccezionali:
«quando le società si democratizzano e la coercizione smette di essere uno strumento di controllo e di emarginazione facile da mettere in opera, le élites si rivolgono naturalmente alla propaganda. Si tratta di un fenomeno non soltanto naturale, ma del tutto consapevole, apertamente analizzato nelle opere scientifiche o meno che preconizzano l’uso della propaganda» (Chomsky 2003: 20).
Chomsky insiste sulla maggiore credibilità e persuasività della propaganda all’interno dei regimi democratici in virtù della teorica situazione di libero mercato delle idee e di libera concorrenza in cui la popolazione tenderebbe a sentirsi garantita circa la natura “corretta” della comunicazione politica: gli effettivi legami tra politica e media all’origine della propaganda sono resi praticamente invisibili da un’apparenza concorrenziale e liberale del mercato. La presenza della propaganda in democrazia non solo non è affatto occasionale, ma risulta strutturata e pianificata sia in quanto effetto del legame d’interessi tra lobby e media, sia in virtù della concezione elitaria del potere. La connivenza tra media e vertici politici garantisce in molti casi il radicamento di questo sistema di manipolazione:
«Quello che ci accingiamo a descrivere è un sistema di mercato guidato la cui guida è fornita dal governo, dai leader del mondo produttivo, dai proprietari e dai dirigenti dei media più importanti [...]. Nella maggior parte dei casi, comunque, i leader dei media agiscono sostanzialmente nello stesso modo perché vedono il mondo attraverso le stesse lenti, risentono degli stessi vincoli e degli stessi incentivi, e quindi raccontano le vicende o mantengono il silenzio in modo concorde» (Chomsky e Hermann 1998: 10-11).
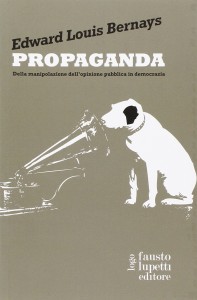 Analizzando in particolare il contesto americano, Chomsky denuncia questo evidente conflitto di interessi tra le proprietà dei grandi media e i rappresentanti del potere, giungendo di conseguenza alla conclusione che i media in apparenza liberi sono un “braccio armato” informativo del potere (ivi: 18-37). Si pensi a tutte le situazioni di belligeranza (asimmetrica, regionale ecc.) che sono apparse negli ultimi anni e che hanno portato a fenomeni come il giornalismo embedded (Chiais 2008: 28-33) e ad una tendenza all’appiattimento dei media sulle posizioni ufficiali: basti pensare al generale marchio di “eroismo” o di “dovere” assegnato agli interpreti dei conflitti bellici, sulla cui legittimità spesso si dibatte, ma sulle cui conseguenze altrettanto spesso vi è la tendenza a limitarsi alla riproposizione di posizioni enfatiche ed epidittiche di stampo prettamente propagandistico.
Analizzando in particolare il contesto americano, Chomsky denuncia questo evidente conflitto di interessi tra le proprietà dei grandi media e i rappresentanti del potere, giungendo di conseguenza alla conclusione che i media in apparenza liberi sono un “braccio armato” informativo del potere (ivi: 18-37). Si pensi a tutte le situazioni di belligeranza (asimmetrica, regionale ecc.) che sono apparse negli ultimi anni e che hanno portato a fenomeni come il giornalismo embedded (Chiais 2008: 28-33) e ad una tendenza all’appiattimento dei media sulle posizioni ufficiali: basti pensare al generale marchio di “eroismo” o di “dovere” assegnato agli interpreti dei conflitti bellici, sulla cui legittimità spesso si dibatte, ma sulle cui conseguenze altrettanto spesso vi è la tendenza a limitarsi alla riproposizione di posizioni enfatiche ed epidittiche di stampo prettamente propagandistico.
Nei sistemi totalitari, invece, la politica costruisce dei dogmi sociali che, attraverso un uso della menzogna molto più diretto, tendono a presentarsi come un surrogato della verità. Nei regimi totalitari l’uso della propaganda è più trasparente, più facilmente leggibile e dunque meno interessante per la ricerca. Nei regimi totalitari la propaganda si estende pervasivamente in tutta la società, permeando in maniera rilevante anche l’ambito educativo di cui rendevamo conto precedentemente, con il quale essa tende a sovrapporsi a causa dell’unica fonte che in questi regimi gode di credibilità ed insostituibilità: lo Stato.
Di conseguenza, l’assenza del contraddittorio e di una normale dialettica politica è l’altro elemento che contraddistingue la propaganda nel totalitarismo: essa infatti si presenta in questi sistemi di potere come una forma di comunicazione manipolatoria proveniente da una sola forza politica che si identifica con lo Stato e che non offre alcuna possibilità di replica o di dialogo. Le tecniche di propagande usate dai regimi totalitari sono state per la gran parte elaborate sul modello di quelle già presenti nella società anglosassone: lo stesso Hitler non mancava nel suo Mein Kampf (La mia battaglia) – il saggio in cui Hitler espose il suo pensiero politico e descrisse il programma del partito nazista, accompagnandolo da una autobiografia – di esprimere la sua ammirazione per l’apparato propagandistico che gli Stati Uniti avevano usato durante la prima guerra mondiale.
I mezzi di informazione operano secondo una prospettiva che possiamo definire gramsciana, in base alla quale i mezzi d’informazione sono pensati come terreno di scontro di forze politiche ed economiche; per questa ragione sono sempre stati consapevoli del potere persuasivo delle parole e hanno sentito l’esigenza di controllarne l’uso per poter conseguire il controllo delle opinioni e orientarle nella direzione desiderata. Giocando con le parole si possono manipolare i fatti e, alla fine della catena, l’intera memoria collettiva.
L’eufemismo è un esempio di questa manipolazione ingannevole che passa attraverso una riformulazione rilassante e rassicurante di un fenomeno, col fine di renderlo innocuo, ossia non più in grado di suscitare reazioni ostili come l’indignazione o la protesta. Nei giornali, in televisione, nelle dichiarazioni dei personaggi pubblici, sempre più spesso quando si fa riferimento a temi controversi e drammatici come la negazione dei diritti umani, la violenza, la morte, si ricorre a questo tipo di strategia retorica che ne ridisegna il loro contenuto negativo mediante l’uso di espressioni il più possibile sfumate e generiche.
Un tema scottante di questi ultimi anni, legato agli abusi commessi a Guantánamo, ad Abu Ghraib, al G8 di Genova o nel caso di Giulio Regeni, è quello della tortura. La molteplicità documentata dei casi riscontrati non lascia dubbi che questa pratica aberrante, denunciata e stigmatizzata dagli illuministi in primis, sia tornata tristemente di attualità e riguardi anche i sistemi democratici. Per fare in modo che l’opinione pubblica non sia consapevole di questo, la tecnica usata dalla gran parte dei media è appunto quella di non usare il termine diretto, nella convinzione che non impiegare il nome comporti la rimozione sociale del fenomeno. La tortura viene allora sostituita da formule eufemistiche come tattiche di interrogatorio rafforzato, interrogatori coercitivi, pressioni psicologiche, interrogatori in profondità, interrogatorio potenziato. L’effetto semantico di questa mistificazione verbale è il tentativo di forzare il concetto stesso di legalità a proprio uso e consumo, in un inquietante scenario in cui la legge perde la sua funzione fondamentale di tutelare le vittime e si trasforma in uno strumento per perpetrare l’impunità dei loro carnefici. Lo stesso tipo di strategia viene utilizzato per descrivere la guerra che per sua natura, e per gli orrori che comporta, si conferma essere l’ambito privilegiato per l’impiego degli eufemismi: si preferisce allora parlare di operazione di polizia internazionale, azione militare, azione preventiva, uso della forza, opera di pacificazione; quest’ultima espressione è del tutto menzognera, essendo la guerra tutto tranne che una pacificazione di una nazione. Ci sono anche esempi in cui il tabù rappresentato dalla guerra è superato e si ricorre all’uso della parola accompagnandola però da un aggettivo che ha funzione eufemistica perché rappresenta la sua palese negazione: è il caso degli ossimori guerra umanitaria, guerra etica o fuoco amico [1]. La stessa strategia retorica è alla base dell’espressione tortura leggera (coniata qualche tempo fa dal settimanale Newsweek), o consegne straordinarie per fare riferimento al rapimento e alla sparizione di persone (Rushdie 2006).
 Altre volte si aggiunge un complemento di fine totalmente contraddittorio, come nel caso dell’incredibile espressione di sapore orwelliano guerra per la pace, usata da Bush nel discorso indirizzato alle famiglie dei soldati feriti in Iraq. Nella stessa ottica per riferirsi alle vittime della guerra si dice che sono degli errori, degli effetti o danni collaterali; i suoi protagonisti spesso mercenari sono chiamati security contractors o manager della sicurezza. In altri contesti l’eufemismo trova un’ampia sfera di applicazione nel revisionismo, cioè nel far sì che gli eventi del passato siano riletti seguendo l’ottica dell’ideologia dominante: i nazifascisti di Salò sono definiti da Violante ragazzi di Salò, come se fossero i protagonisti di una gita, oppure da Ciampi giovani che fecero scelte diverse (Giacché 2016: 330-31).
Altre volte si aggiunge un complemento di fine totalmente contraddittorio, come nel caso dell’incredibile espressione di sapore orwelliano guerra per la pace, usata da Bush nel discorso indirizzato alle famiglie dei soldati feriti in Iraq. Nella stessa ottica per riferirsi alle vittime della guerra si dice che sono degli errori, degli effetti o danni collaterali; i suoi protagonisti spesso mercenari sono chiamati security contractors o manager della sicurezza. In altri contesti l’eufemismo trova un’ampia sfera di applicazione nel revisionismo, cioè nel far sì che gli eventi del passato siano riletti seguendo l’ottica dell’ideologia dominante: i nazifascisti di Salò sono definiti da Violante ragazzi di Salò, come se fossero i protagonisti di una gita, oppure da Ciampi giovani che fecero scelte diverse (Giacché 2016: 330-31).
L’uso di perifrasi eufemistiche non è solo un fenomeno della nostra contemporaneità, ma risale a tempi assai più remoti: dalle espressioni scelte per la denominazione dell’uccisione consapevole delle minoranze etniche, come campo di concentramento o soluzione finale, all’espressione pulizia etnica che si è affermata in luogo di genocidio o sterminio durante la guerra nei Balcani. Analogamente il bombardamento sistematico dei centri abitati, l’uccisione e la cacciata dei loro abitanti viene definita opera di pacificazione (Orwell 1946: 179). Anche negli articoli dedicati alla questione palestinese gli eufemismi sono frequenti: lo stato di occupazione da parte di Israele, ad esempio, diventa una controversia, come se lo scenario che abbiamo di fronte fosse una pacifica aula di tribunale e non uno stato di guerra permanente. L’effetto semantico di questo offuscamento è chiaro: se la terra palestinese non è occupata ma semplicemente parte di una controversia legale che potrebbe essere risolta in una corte di giustizia, o in pacifiche discussioni, allora un bambino palestinese che lancia una pietra ad un soldato israeliano nel suo territorio sta chiaramente agendo in modo insano. Il muro costruito da Israele alto otto metri e lungo centinaia di chilometri viene definito recinto difensivo, o barriera difensiva, ricalcando pedissequamente la definizione israeliana del muro (security fence) e minimizzando l’impatto negativo che ha avuto e continua ad avere sulla popolazione palestinese. Le azioni israeliane di colonizzazione della terra araba contro ogni legge internazionale diventano insediamenti o avamposti o quartieri ebraici. Per l’ufficiale israeliano che finisce di uccidere una bambina palestinese di tredici anni dopo averla colpita più volte si dice che ha eseguito la procedura di accertamento della morte (Giacché 2016: 330). Ci viene detto che ciò con cui abbiamo a che fare in Medio Oriente sono le narrazioni concorrenti. Questa frase dal falso linguaggio antropologico elimina la possibilità che un gruppo di persone sia occupato, mentre un altro sia l’occupante: secondo quest’ottica non c’è giustizia, né ingiustizia, non c’è oppressione né oppresso, ma solo alcune amichevoli narrazioni concorrenti, collocate su un piano di parità perché le due parti sono in concorrenza. L’obiettivo è far sì che l’opinione pubblica non si renda conto di ciò che è realmente accaduto in Palestina.
In altri casi invece la menzogna si riveste della figura dell’iperbole che ha la funzione contraria dell’eufemismo, se questo serve a minimizzare e nascondere un fenomeno negativo, l’iperbole esagera ed accentua la rappresentazione a discapito della corrispondenza con la realtà. L’esagerazione serve per colpire l’attenzione del pubblico ed imprimersi nella sua memoria, più che per sollecitare il ragionamento. È una figura che per la sua mancanza di verosimiglianza trova la sua più congeniale applicazione nella pubblicità, tuttavia negli ultimi anni trova sempre più spazio nella comunicazione politica. Ecco allora che anche in questo ambito le espressioni iperboliche sono sempre più numerose: ad esempio Guerra infinita e Scontro di Civiltà per riferirsi alle guerre in Medio Oriente, oppure il nuovo miracolo italiano promosso da Berlusconi nel 2001. Questo fenomeno dipende dal fatto che «nel discorso pubblico contemporaneo l’aspetto decisivo è rappresentato dalla messa in scena, dal contesto teatrale, e non dai contenuti» (ivi: 338).
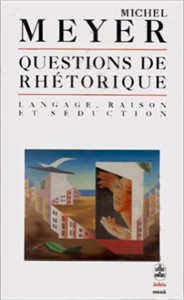 La cronaca giornalistica di questi ultimi anni ci offre innumerevoli casi di ricorso alla menzogna come strumento di persuasione ingannevole e di promozione della disinformazione. Ci limiteremo in questa sede ad analizzare due casi emblematici. Il primo riguarda l’avvocato David Mills di cui si è occupata la Corte di Cassazione nel febbraio 2010 (Carofiglio 2010: 30-35; Travaglio 2020: 119-24). Mills, che gestiva numerose società estere del gruppo Fininvest, era stato accusato di un reato molto grave, cioè la corruzione in atti giudiziari in concorso con Silvio Berlusconi: l’ex premier avrebbe corrotto Mills con un versamento di 600 mila dollari per indurlo a testimonianze reticenti nell’ambito dei processi All Iberian e tangenti alla Guardia di finanza che lo vedevano imputato. Il tribunale ha confermato le tesi dell’accusa ritenendo che l’avvocato inglese fosse responsabile del reato di corruzione e lo ha condannato in primo grado e in appello a quattro anni e sei mesi di reclusione. La Cassazione nel febbraio 2010 ha confermato la sussistenza del reato dichiarando però la prescrizione. Le cronache giornalistiche del tempo, sia della carta stampata che dei telegiornali più seguiti, invece, hanno detto a più riprese che Mills era stato assolto e che la sua assoluzione comportava il fatto che lo stesso Berlusconi non avrebbe dovuto più presentarsi in tribunale per discolparsi visto che se non c’è più il corrotto non ci può più essere neppure il corruttore. È evidente l’esercizio della manipolazione ingannevole in questo modo di presentare i fatti che considera i due termini di assoluzione e di prescrizione come se fossero interscambiabili, quando essi hanno in comune solo in fatto che l’imputato non subisce la pena, mentre per tutto il resto sono radicalmente diversi. Nel primo caso si riconosce che la persona non ha commesso il reato; nel secondo, invece, la sussistenza del reato è certa ma l’esecuzione della pena è estinta per il decorso dei termini, in quanto si ritiene che a distanza di molto tempo dal fatto lo Stato non abbia più interesse a punire quel determinato atto. In altre parole la prescrizione implica come premessa logica e giuridica la sussistenza del reato che coinvolge sia il corrotto che il corruttore. Questo uso abusivo della parola assoluzione dà luogo a una narrazione menzognera che pretende di manipolare i dati della cronaca – e in prospettiva della storia – falsificandoli, sfruttando la capacità che la comunicazione ha di creare quella che noi chiamiamo la realtà (Watzlawick 1976: 7).
La cronaca giornalistica di questi ultimi anni ci offre innumerevoli casi di ricorso alla menzogna come strumento di persuasione ingannevole e di promozione della disinformazione. Ci limiteremo in questa sede ad analizzare due casi emblematici. Il primo riguarda l’avvocato David Mills di cui si è occupata la Corte di Cassazione nel febbraio 2010 (Carofiglio 2010: 30-35; Travaglio 2020: 119-24). Mills, che gestiva numerose società estere del gruppo Fininvest, era stato accusato di un reato molto grave, cioè la corruzione in atti giudiziari in concorso con Silvio Berlusconi: l’ex premier avrebbe corrotto Mills con un versamento di 600 mila dollari per indurlo a testimonianze reticenti nell’ambito dei processi All Iberian e tangenti alla Guardia di finanza che lo vedevano imputato. Il tribunale ha confermato le tesi dell’accusa ritenendo che l’avvocato inglese fosse responsabile del reato di corruzione e lo ha condannato in primo grado e in appello a quattro anni e sei mesi di reclusione. La Cassazione nel febbraio 2010 ha confermato la sussistenza del reato dichiarando però la prescrizione. Le cronache giornalistiche del tempo, sia della carta stampata che dei telegiornali più seguiti, invece, hanno detto a più riprese che Mills era stato assolto e che la sua assoluzione comportava il fatto che lo stesso Berlusconi non avrebbe dovuto più presentarsi in tribunale per discolparsi visto che se non c’è più il corrotto non ci può più essere neppure il corruttore. È evidente l’esercizio della manipolazione ingannevole in questo modo di presentare i fatti che considera i due termini di assoluzione e di prescrizione come se fossero interscambiabili, quando essi hanno in comune solo in fatto che l’imputato non subisce la pena, mentre per tutto il resto sono radicalmente diversi. Nel primo caso si riconosce che la persona non ha commesso il reato; nel secondo, invece, la sussistenza del reato è certa ma l’esecuzione della pena è estinta per il decorso dei termini, in quanto si ritiene che a distanza di molto tempo dal fatto lo Stato non abbia più interesse a punire quel determinato atto. In altre parole la prescrizione implica come premessa logica e giuridica la sussistenza del reato che coinvolge sia il corrotto che il corruttore. Questo uso abusivo della parola assoluzione dà luogo a una narrazione menzognera che pretende di manipolare i dati della cronaca – e in prospettiva della storia – falsificandoli, sfruttando la capacità che la comunicazione ha di creare quella che noi chiamiamo la realtà (Watzlawick 1976: 7).
 Il secondo esempio di disinformazione riguarda il caso di Eluana Englaro [2] che ha avuto per un lungo periodo un’eco mediatica di grande rilevanza e che è per noi molto interessante perché mostra come le parole possono essere impiegate con effetti nocivi per ingannarci, inducendoci a dare credito a una rappresentazione dei fatti distorta e fuorviante che arriva a manipolare tutta la memoria collettiva. I giornali che fanno riferimento all’area di centro-destra, e i più seguiti telegiornali nazionali come il TG1, hanno raccontato la sua tragica vicenda in modo inadeguato e fuorviante, utilizzando parole del tutto incongrue. Si pensi, per esempio, al modo in cui viene presentata al pubblico l’alimentazione forzata a cui Eluana è sottoposta da tanti anni: da una parte viene definita come una terapia, questo termine però è fuorviante perché nel significato di questa parola è implicito il riferimento a dei trattamenti adottati per curare o prevenire la malattia, ma la situazione di Eluana era irrimediabile, il concetto di cura è in questo contesto del tutto fuori luogo. In altri casi, invece, questa pratica medica viene descritta come semplice somministrazione di acqua e cibo, un atto dovuto a chiunque non sia in grado di farlo da solo, con riferimento alle sette opere di misericordia e con l’implicita conclusione che chi vuole negare questo atto è un malvagio o un assassino.
Il secondo esempio di disinformazione riguarda il caso di Eluana Englaro [2] che ha avuto per un lungo periodo un’eco mediatica di grande rilevanza e che è per noi molto interessante perché mostra come le parole possono essere impiegate con effetti nocivi per ingannarci, inducendoci a dare credito a una rappresentazione dei fatti distorta e fuorviante che arriva a manipolare tutta la memoria collettiva. I giornali che fanno riferimento all’area di centro-destra, e i più seguiti telegiornali nazionali come il TG1, hanno raccontato la sua tragica vicenda in modo inadeguato e fuorviante, utilizzando parole del tutto incongrue. Si pensi, per esempio, al modo in cui viene presentata al pubblico l’alimentazione forzata a cui Eluana è sottoposta da tanti anni: da una parte viene definita come una terapia, questo termine però è fuorviante perché nel significato di questa parola è implicito il riferimento a dei trattamenti adottati per curare o prevenire la malattia, ma la situazione di Eluana era irrimediabile, il concetto di cura è in questo contesto del tutto fuori luogo. In altri casi, invece, questa pratica medica viene descritta come semplice somministrazione di acqua e cibo, un atto dovuto a chiunque non sia in grado di farlo da solo, con riferimento alle sette opere di misericordia e con l’implicita conclusione che chi vuole negare questo atto è un malvagio o un assassino.
Questa descrizione però è del tutto ingannevole visto che stiamo parlando di un trattamento medico effettuato con un sondino naso-gastrico, la cui applicazione richiede un intervento invasivo che come tale può avere controindicazioni ed effetti indesiderati (Defanti 2009: 88-91). Non è insomma una misura ordinaria di assistenza come imboccare o lavare una persona non autosufficiente, ma un’operazione che prevede il consenso del malato o del suo delegato e che, come tale, può essere rifiutato. Parlare in questo contesto di fame e di sete è del tutto fuori luogo perché per quanto ne sappiamo Eluana non era consapevole di vivere e non aveva sensazioni di alcun tipo, essendo ridotta a un corpo privo della capacità di provare qualsiasi esperienza (ivi: 87). Quotidiani come Il Foglio e l’Avvenire, ma anche le gerarchie cattoliche e perfino il Ministero della Salute, riferendosi alla possibilità di interrompere l’alimentazione forzata, hanno parlato di “morte orribile fra atroci sofferenze”, o di “voler far morire Eluana di fame e di sete”, o ancora di “acqua per Eluana”, facendo leva sul significato simbolico di questi termini (Mori 2008: 36) e ricorrendo a un artificio retorico di pessimo gusto.
 Anche la maniera in cui sono state descritte le condizioni generali di vita di Eluana dopo tanti anni di coma irreversibile è del tutto irrealistica e menzognera, degna di una propaganda aberrante. È stata infatti presentata l’immagine di una ragazza bella, piena di vita e di fascino, presentando in continuazione su tutti i media le foto di quando era in vita, dicendo a più riprese che Eluana “sorride”, “potrebbe mangiare da sola”, “potrebbe avere un figlio”. Si è costruita una narrazione totalmente inverosimile, del tutto sganciata dalla realtà, che ha avuto un effetto di suggestione collettiva di cui è rimasta vittima soprattutto la parte meno avvertita dell’opinione pubblica come testimoniano le ridicole immagini – riprese in modo del tutto acritico anche dai telegiornali – in cui si vedono gruppi di persone che depositano per Eluana bottiglie d’acqua e panini davanti i cancelli della clinica dove era ricoverata. Inoltre le immagini danno l’impressione che a protestare davanti alla clinica fossero gruppi numerosi di persone che occupano tutta l’area antistante il suo ingresso. In realtà invece si tratta di un effetto retorico ingannevole prodotto dalla sineddoche visiva con cui si mostra solo una parte della scena, coerente con il messaggio che vogliamo inviare, escludendo tutto il resto che lo contraddice. Altre immagini che in seguito sono state diffuse anche su internet hanno mostrato infatti quanto il numero delle persone presenti fosse esiguo, occupando solo lo spazio immediatamente davanti l’ingresso della clinica, mentre tutto il resto della strada era vuoto.
Anche la maniera in cui sono state descritte le condizioni generali di vita di Eluana dopo tanti anni di coma irreversibile è del tutto irrealistica e menzognera, degna di una propaganda aberrante. È stata infatti presentata l’immagine di una ragazza bella, piena di vita e di fascino, presentando in continuazione su tutti i media le foto di quando era in vita, dicendo a più riprese che Eluana “sorride”, “potrebbe mangiare da sola”, “potrebbe avere un figlio”. Si è costruita una narrazione totalmente inverosimile, del tutto sganciata dalla realtà, che ha avuto un effetto di suggestione collettiva di cui è rimasta vittima soprattutto la parte meno avvertita dell’opinione pubblica come testimoniano le ridicole immagini – riprese in modo del tutto acritico anche dai telegiornali – in cui si vedono gruppi di persone che depositano per Eluana bottiglie d’acqua e panini davanti i cancelli della clinica dove era ricoverata. Inoltre le immagini danno l’impressione che a protestare davanti alla clinica fossero gruppi numerosi di persone che occupano tutta l’area antistante il suo ingresso. In realtà invece si tratta di un effetto retorico ingannevole prodotto dalla sineddoche visiva con cui si mostra solo una parte della scena, coerente con il messaggio che vogliamo inviare, escludendo tutto il resto che lo contraddice. Altre immagini che in seguito sono state diffuse anche su internet hanno mostrato infatti quanto il numero delle persone presenti fosse esiguo, occupando solo lo spazio immediatamente davanti l’ingresso della clinica, mentre tutto il resto della strada era vuoto.
Uno dei compiti fondamentali di un’informazione indipendente dovrebbe proprio essere quello di rifiutare questo uso distorto delle parole e delle immagini che tanto possono influenzare il pubblico. Nella maggior parte dei casi, invece, i media hanno rinunciato a svolgere questa importante funzione, rendendosi complici di un sistema di propaganda molto discutibile. L’individuazione e il conseguente smascheramento di queste strategie di manipolazione costituiscono allora uno dei compiti fondamentali del pensiero critico che chiama in causa innanzitutto coloro che lavorano nell’informazione, sottolineando la loro responsabilità (Said 1994:106), ma che coinvolge più in generale tutti noi in quanto cittadini che siamo i destinatari del discorso pubblico. La questione ha anche una componente educativa di grande importanza: è dalla capacità di esercitare il nostro diritto di critica che dipende quella possibilità di scelta che altrimenti ci è negata.
Dialoghi Mediterranei, n. 48, marzo 2021
Note
[1] La presenza degli ossimori nel discorso politico è rilevante e riguarda anche altri ambiti, basti pensare all’abusata espressione capitale umano che rispecchia l’esasperato economicismo del capitalismo che, considerando ogni cosa nell’ottica aziendalistica, riduce a merce l’uomo stesso (Timpanaro 2001: 234-35).
[2] La tragica vicenda di Eluana Englaro è stata lunga e complessa (essendo iniziata nel 1994) e ha dominato, soprattutto negli ultimi anni del suo svolgimento (dal 2006 al 2009), le cronache giornalistiche sia dei quotidiani e settimanali, sia dei canali televisivi. Per una sua ricostruzione dettagliata si veda Englaro – Pannitteri (2009), Mori (2008), Rodotà (2009).
Riferimenti bibliografici
Arendt H. (1968). “Truth and Politics”, in Id., Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought, New York, The Viking Press (tr. it. Verità e politica, Torino, Bollati Boringhieri, 1995).
Bernays E. L. (1928) Propaganda, New York, Horace Liveright (tr. it. Propaganda, Della manipolazione dell’opinione pubblica in democrazia, Bologna, Lupetti, 2008).
Carofiglio, G. (2010) La manomissione delle parole, Milano, Rizzoli.
Chiais M. (2008) Menzogna e propaganda: armi di disinformazione di massa, Milano, Lupetti.
Chomsky N. (1994) Powers and prospects, London, Pluto Press (tr. it.Il potere dei media, Firenze, Vallecchi, 1996).
Id. (2003) Deux heures de licidité, Paris, Éditions des arénes (tr. it. Due ore di lucidità, Milano, Baldini &Castoldi, 2005).
Id. (2005) Imperial Ambitions, New York, Metropolitan Books (tr. it. America: il nuovo tiranno, Milano, Rizzoli, 2006).
Id. (2017) Le dieci leggi del potere, Milano, Ponte alle Grazie.
Chomsky N. – Hermann E.S. (1998) Manufacturing consent, New York, Pantheon Books (tr. it. La fabbrica del consenso, Milano, Tropea, 2001).
D’Agostini F. (2012) Menzogna, Torino, Bollati Boringhieri.
Defanti C.A. (2009) “Eluana, verità e disinformazione”, in Micromega, 2: 87-100.
Englaro, B. – Pannitteri, A. (2009). La vita senza limiti. La morte di Eluana in uno stato di diritto, Milano, Rizzoli.
Flores D’Arcais, P. (2006) Hannah Arendt. Esistenza e libertà, autenticità e politica, Roma, Fazi.
Giacché V. (2016) La fabbrica del falso, Milano, Imprimatur.
Lippmann W. (1922) Public opinion, New York, Macmillian (tr. it. L’opinione pubblica, Roma, Donzelli, 2000).
Meyer, M. 1993, Question de la rhétorique. Langage, raison et séduction, Paris, Librairie Générale Française (tr. it. La retorica, Bologna, Il Mulino, 1997).
Mori M. (2008) Il caso Eluana Englaro, Bologna, Pendragon.
Orwell G. (1946) “Politics and the English language”, Horizon, 1946, (tr. it. in G. Orwell, Letteratura palestra di libertà, Milano, Mondadori, 2013, pp. 167-84).
Prato A. (2019) “The abuse of words: the case of Euphemism”, in American International Journal of Social Sciences, vol. 8, n. 3: 10-14.
Rodotà S. (2009) “Il caso Englaro: una cronaca istituzionale”, in Micromega, 2009, 2: 77-86.
Rushdie S. (2006) “La violenza del mondo nascosto dalle parole”, in La Repubblica, 9 gennaio 2006.
Said, E. (1994) Representation of the intellectual, New York, Vintage Books (tr. it. Dire la verità. Gli intellettuali e il potere, Milano, Feltrinelli, 1995).
Timpanaro, S. (2001) Il verde e il rosso, Roma, Odradeck.
Travaglio, M. (2020) Bugiardi senza gloria, Roma, PaperFirst.
Watzlawick P. (1976) How real is real? Confusion, Disinformation, Communication, New York, Random House.
______________________________________________________________
Alessandro Prato, è ricercatore del Dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive (DISPOC) dell’Università di Siena dove insegna Retorica e linguaggi persuasivi e Teoria e tecniche della scrittura. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Comunicazione e potere (a cura di), Aracne, 2018; La retorica. Forme e finalità del discorso persuasivo, Edizioni ETS, 2012; Linguaggio e filosofia nell’età dei lumi. Da Locke agli idéologues, I libri di Emil, 2012, oltre a diversi articoli su riviste nazionali e internazionali.
______________________________________________________________