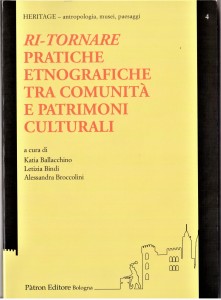il centro in periferia
di Antonino Cusumano
Non c’è forse disciplina scientifica meno disciplinata, che abbia cioè conosciuto un così profondo e incessante processo di autoanalisi e di trasformazione teorico-metodologica come l’antropologia, destinata per vocazione statutaria e paradossale contrappasso a perennemente interrogarsi sulla sua identità, sulle sue responsabilità. Come in una sorta di lunga e ininterrotta espiazione dalle complicità coloniali, dal rimorso del “fardello dell’uomo bianco”, dal peccato originale della sua fondazione nel “cuore di tenebre” dell’Occidente delle “missioni civilizzatrici”, l’antropologia, tra le scienze umane la più fragile e la più versatile, sembra essere condannata a scontare questi debiti mai del tutto risolti, a misurarsi sempre in prima linea con le sfide del cambiamento e del critico ripensamento che la politica e la società impongono.
Alla parola “sviluppo” è rimasta a lungo legata in un rovinoso e incestuoso rapporto con le istituzioni economiche e politiche quella che ancora oggi chiamiamo con qualche approssimazione “antropologia applicata”, troppo spesso colpevole di connivenza, di soggezione ai poteri costituiti, di asservimento funzionale agli interessi dei committenti, delle agenzie imprenditoriali o addirittura militari. La partecipazione a progetti di cooperazione internazionale continua ad esporre gli studiosi, “esperti delle differenze”, al rischio di rispondere a logiche di perizia e consulenza sovente più conformi a criteri di natura burocratica che scientifica, conservando un modello di relazione costitutivamente asimmetrica. Oggi è forse più corretto (politically correct) parlare di “antropologia pubblica”, per le responsabilità sociali di cui è investita, le ricerche-azioni progettate e realizzate fuori dall’accademia, le implicazioni di carattere etico e professionale conseguenti all’evoluzione epistemologica della disciplina, alla apertura ai nuovi approcci e alle pratiche dello sperimentalismo etnografico.
La materia per elezione impegnata nello studio delle culture e nella decostruzione del senso comune è in prima istanza vincolata alla decostruzione di se stessa, dei suoi saperi e del suo ruolo pubblico. Da un generoso processo di autocritica muove la stagione postmoderna della “riflessività” che ha rovesciato forme e modelli delle rappresentazioni etnografiche, ha scompaginato le retoriche dell’antropocentrismo e ristrutturato la cassetta degli attrezzi dell’antropologo. Non più strettamente impigliato nelle dicotomie tra natura e cultura, universale e particolare, somiglianze e differenze, lo studioso è interprete, traduttore e mediatore del dialogo tra i diversi mondi che la globalizzazione e la contemporaneità hanno avvicinato, dislocato e decentrato. Tanto più che la sua funzione nel pensiero critico di oggi è quella di far conoscere e riconoscere le soggettività di quanti dalla subalternità o dalla marginalità irrompono nella storia da protagonisti al centro della scena, così che gli osservati sono diventati osservatori e scopriamo che gli altri, gli indigeni, siamo noi. Nel segno dell’agency, della capacità che hanno gli individui di dare significato agli eventi, del valore paradigmatico e universalistico dei diritti umani, delle rivendicazioni identitarie irriducibili all’omologazione, le frontiere si sono spostate, i confini sfumati, le posture invertite o rimescolate.
Nella tensione tra partecipazione empatica e distacco scientifico, adesione emotiva e rigore intellettuale, l’antropologo deve fare i conti con i soggetti della ricerca sempre più consapevoli di sé e desiderosi di riscatto e di riconoscimento, mettendo in discussione il suo ruolo e ragionando sulla sua autorità senza rinunciare alla necessità di oggettivare la conoscenza, di dare forma intelligibile agli esiti del lavoro svolto. Questioni di riposizionamento sul campo, di politiche e di deontologia. Svolte ermeneutiche che hanno aperto nuovi e più complessi scenari nell’orizzonte teorico della disciplina come nelle pratiche metodologiche a favore di una maggiore trasparenza e di una più feconda sinergia tra i diversi attori del dialogo culturale e della interazione umana.
 In questo contesto di profondo rivolgimento di temi e strategie, di prospettive e processi critici e autocritici si è imposta più recentemente una riflessione sui concetti di comunità, di patrimonio immateriale, di beni comuni e di territorio, anche in relazione all’influenza delle Convenzioni patrocinate dall’Unesco per il riconoscimento formale e istituzionale della tutela e salvaguardia. La formazione delle Liste Rappresentative ha innescato e mobilitato fenomeni di larga partecipazione popolare, di spinte al cambiamento e di protagonismo collettivo, fino alla creazione di quelle “comunità di eredità” che, nella consapevolezza del valore patrimoniale dell’heritage territoriale, si intestano il compito di promuoverne gli aspetti peculiari per testimoniarne e tramandarne senso, memoria e vitalità alle future generazioni.
In questo contesto di profondo rivolgimento di temi e strategie, di prospettive e processi critici e autocritici si è imposta più recentemente una riflessione sui concetti di comunità, di patrimonio immateriale, di beni comuni e di territorio, anche in relazione all’influenza delle Convenzioni patrocinate dall’Unesco per il riconoscimento formale e istituzionale della tutela e salvaguardia. La formazione delle Liste Rappresentative ha innescato e mobilitato fenomeni di larga partecipazione popolare, di spinte al cambiamento e di protagonismo collettivo, fino alla creazione di quelle “comunità di eredità” che, nella consapevolezza del valore patrimoniale dell’heritage territoriale, si intestano il compito di promuoverne gli aspetti peculiari per testimoniarne e tramandarne senso, memoria e vitalità alle future generazioni.
È noto il dibattito intorno alle criticità delle politiche di patrimonializzazione, ai rischi di mercificazione, di reificazione, di burocratizzazione, anche in relazione alla straordinaria crescita della domanda e al legittimo moltiplicarsi dei soggetti coinvolti: istituzioni, gruppi, comunità, associazioni, reti, semplici cittadini. Un attivismo e un movimentismo cui non sono estranei logiche di potere, interessi economici, speculazioni ideologiche. Del resto, la “produzione della località” che abbiamo imparato a studiare con Appadurai non può non accompagnarsi alla “produzione del patrimonio”, e quindi anche alla possibilità della nota “invenzione della tradizione” di cui hanno scritto Hobsbawm e Ranger. Nella sfida alla costruzione delle identità locali o nazionali per la candidatura e l’inclusione nelle Liste sono in gioco, in tutta evidenza, bisogni collettivi e diritti democratici, ma anche tattiche e strategie, retoriche e schieramenti, potenziali derive di populismo, di essenzialismo e di etnicismo.
Pur nei limiti e nelle ambiguità di queste pratiche resta indubitabile la svolta di partecipazione dal basso e di definitiva emancipazione popolare da una concezione e gestione elitaria dei patrimoni culturali, la ridefinizione del concetto transnazionale dei beni inalienabili, il valore pubblico e civico delle eredità immateriali nella trasmissione da una generazione all’altra. Portatori di riconoscibili rappresentanze e interpreti in vari modi del diritto di esprimere e rivendicare la propria cultura, singoli e collettività si rendono protagonisti di nuove prerogative e responsabilità nell’amministrazione e nella governance dei patrimoni, nella loro valorizzazione identitaria, nella loro condivisione e affezione. Tutto questo non senza tensioni e conflittualità, coefficienti che sono nella dialettica della vita, nella dinamica dei fatti che muovono, tra attriti, resistenze e dissonanze, dal passato al futuro. Le culture – gli oggetti tangibili e intangibili – si conservano attraverso e finché gli uomini le rigenerano, le rifunzionalizzano e le testimoniano. Ecco perché quel che comprendiamo nell’accezione di heritage è sempre l’esito di attualizzazioni e di elaborazioni collettive, di processi di selezione, in cui intervengono enti e istituzioni ma anche le cosiddette “comunità di eredità”, che – ha scritto Pietro Clemente (2016:15) – «per gli antropologi sono una straordinaria occasione per farsi mediatori culturali, attivatori di empowerment, recuperando e reinventando nel presente antiche missioni che li volevano al fianco delle “culture subalterne”».
 Da qui la questione chiave dei rapporti nel campo etnografico tra quanti sono impegnati nelle politiche di salvaguardia del patrimonio immateriale, le sinergie di intenti e le asimmetrie nei ruoli, il dialogo, le frizioni e le incomprensioni, le reciprocità, i debiti, gli scambi ineguali. Esperienze felici di collaborazione, di successo, di crescita umana e intellettuale ma anche casi di delusione e frustrazione, fraintendimenti, rimpianti e fallimenti. Il patto stabilito tra ricercatori, comunità, autorità locali e committenti, postula una circolarità di azioni e di volontà, un confronto aperto e leale, una corrispondenza empatica e umana. Superate le pratiche predatorie del passato già nel tempo in cui Gianni Bosio teorizzava intorno all’“intellettuale rovesciato” che ascolta e impara prima di scrivere e di insegnare, si impongono problemi connessi alla co-autorialità dei testi, al controllo delle informazioni e alla loro proprietà, alle complesse dinamiche di negoziazione di ruoli, significati e rappresentazioni.
Da qui la questione chiave dei rapporti nel campo etnografico tra quanti sono impegnati nelle politiche di salvaguardia del patrimonio immateriale, le sinergie di intenti e le asimmetrie nei ruoli, il dialogo, le frizioni e le incomprensioni, le reciprocità, i debiti, gli scambi ineguali. Esperienze felici di collaborazione, di successo, di crescita umana e intellettuale ma anche casi di delusione e frustrazione, fraintendimenti, rimpianti e fallimenti. Il patto stabilito tra ricercatori, comunità, autorità locali e committenti, postula una circolarità di azioni e di volontà, un confronto aperto e leale, una corrispondenza empatica e umana. Superate le pratiche predatorie del passato già nel tempo in cui Gianni Bosio teorizzava intorno all’“intellettuale rovesciato” che ascolta e impara prima di scrivere e di insegnare, si impongono problemi connessi alla co-autorialità dei testi, al controllo delle informazioni e alla loro proprietà, alle complesse dinamiche di negoziazione di ruoli, significati e rappresentazioni.
Incontri etnografici si intitolava il volume curato da Clara Gallini e Gino Satta e pubblicato da Meltemi nel 2007. Un titolo demartiniano per una riflessione collettiva sulla dimensione eminentemente relazionale del sapere antropologico, sulle diverse e mutevoli condizioni storiche nelle quali le conoscenze vengono prodotte, sulla «legittimazione politica della ricerca, le strategie di gestione delle relazioni etnografiche, la “restituzione” dei risultati delle ricerche» (Satta 2007: 13). A distanza di circa quindici anni dalla stampa di questo testo collettaneo è stato recentemente editato da Pàtron di Bologna il libro a cura di Katia Ballacchino, Letizia Bindi e Alessandra Broccolini, Ri-tornare. Pratiche etnografiche tra comunità e patrimoni culturali. In mezzo alle due pubblicazioni l’intenso dibattito che si è sviluppato, se ha sgombrato il campo dagli equivoci derivanti dalla presunzione (o illusione) dell’antropologo di “farsi nativo”, ha tuttavia portato alla luce nuove questioni relative alle responsabilità e all’uso pubblico dell’antropologia in funzione delle soggettività emergenti, dei contesti politici e sociali sempre più ampi che richiedono di immaginare nuovi modi di pensare e di organizzare i rapporti interpersonali con gli interlocutori delle ricerche.
Della restituzione scrivono soprattutto gli autori dei saggi raccolti in questo volume che sembra per tanti aspetti dialogare con quello del 2007, introducendo però nella grammatica etnografica il lessico connesso alla parola chiave del “patrimonio”, la sintassi associata ai concetti di comunità, eredità, bene culturale, condivisione di mappe ed inventari. Parole e concetti di nuova generazione, formalizzate a livello internazionale dall’Unesco, che però ripropongono il vecchio e ineludibile banco di prova per l’antropologia applicata come per la demoetnoantropologia, impegnate entrambe nella gestione dei processi di relazione con tutti gli attori del campo. Ritornare nei luoghi della ricerca per restituire i debiti contratti, rendicontare i risultati del lavoro d’indagine, rispondere alle attese pubbliche e ai desideri di informatori, testimoni, committenti e comunità è – scrive opportunamente Letizia Bindi – «un delicato rapporto di traduzione tra codici culturali diversi che passa per la prossimità, la raccolta di dati di prima mano e l’intimità culturale all’interno di un dato contesto». Il tradurre è, del resto, la cifra del laboratorio dell’antropologo, l’andirivieni tra il linguaggio informale e quello disciplinare, tra le parole dette e quelle scritte, «la curvatura dell’esperienza» di cui ha scritto Leonardo Piasere (2002) che descrive la traiettoria etnografica dalla vita privata al campo, dal campo al testo e da questo a quello in un incessante movimento circolare.
Caduta la presunta neutralità scientifica, la comprensione profonda delle dinamiche antropologiche passa attraverso il filtro delle esperienze umane, le amicizie e gli obblighi morali, le promesse e i compromessi, le transazioni e le confidenze. E l’etnografo altro non sarebbe che l’interprete di queste mediazioni, diventando «lievito delle comunità» ma anche «facilitatore capace di coadiuvare i processi partecipativi e di incrociare le volontà della committenza» (Bindi), rischiando a volte di apparire portatore di interessi di categoria oppure militante succube delle retoriche ideologiche. «Chi ha esperienza di rapporti etnografici empatici – annota Katia Ballacchino – e ha ricevuto lettere dal campo sa cosa si prova a divenire, suo malgrado, un punto di riferimento per i soggetti indagati e quanto spesso si voglia fuggire da quella responsabilità che la ricerca non avrebbe voluto avere nelle sue ipotesi e nei suoi assunti iniziali». Amicale o conflittuale, la restituzione in forma di scrittura o in altri modi è sempre problematica e non priva di ambiguità, restando oggettivamente impigliata nelle maglie di fragilissimi equilibri.
Restituire, ritornare sul terreno o – come preferisce Alessandra Broccolini – condividere sono i verbi ricorrenti nelle pagine del volume che identifica nei musei gli spazi dove si cimenta e si materializza l’antropologia applicata, i luoghi per eccellenza di restituzione del patrimonio alla collettività. Qui – precisa la studiosa – la restituzione «è il segno di un profondo mutamento di scenario epocale e di prospettiva, in quanto voluta e rivendicata dalle comunità interessate e non, come in passato, “concessa” o voluta dal ricercatore per ragioni etico/politiche». Qui, forse più che altrove, la reciprocità consustanziale alla condivisione rinvia al paradigma maussiano del dono, alla sequenza dare-ricevere-ricambiare, potente circolo virtuoso di legami e simbiosi. Nello scambio si legittimano e si riconoscono i saperi e i ruoli, i diritti e i doveri di ciascuno degli interlocutori coinvolti nell’esperienza etnografica. Nell’organizzazione museale si accende il protagonismo delle comunità, si costruisce una progettualità fondata sulla coscienza del luogo, sulla affezione ai beni comuni del territorio, sulla memoria condivisa.
 Il volume, che si inserisce nella collana Heritage dell’editore di Bologna, non si limita a ragionare su questi temi centrali nella metodologia della ricerca etnografica ma offre anche un ampio repertorio esemplificativo di esperienze che documentano numerosi processi di tutela e patrimonializzazione, nati dal basso, coordinati e orientati dagli studiosi, spesso in bilico tra la coerenza a competenze scientifiche, l’osservanza di procedure normative e burocratiche, la volontà delle popolazioni o delle istituzioni di rappresentanza. Apprendiamo degli articolati percorsi di elaborazione delle Mappe di comunità in due comuni della Toscana, grazie anche al supporto di un sistema reticolare di ecomusei, all’attivazione di laboratori didattici e di incontri in setting con i giovani del luogo. Ne scrivono Emanuela Rossi, Costanza Lanzara e Marco D’Aureli che si interrogano sulla “sfida della partecipazione” e sullo sforzo collettivo di negoziazione tra le diverse ragioni dell’adesione al progetto, perché – concludono – «una cosa è mappare un patrimonio, altro è fare in modo che sia la comunità stessa a immaginare e costruire una propria autorappresentazione patrimoniale».
Il volume, che si inserisce nella collana Heritage dell’editore di Bologna, non si limita a ragionare su questi temi centrali nella metodologia della ricerca etnografica ma offre anche un ampio repertorio esemplificativo di esperienze che documentano numerosi processi di tutela e patrimonializzazione, nati dal basso, coordinati e orientati dagli studiosi, spesso in bilico tra la coerenza a competenze scientifiche, l’osservanza di procedure normative e burocratiche, la volontà delle popolazioni o delle istituzioni di rappresentanza. Apprendiamo degli articolati percorsi di elaborazione delle Mappe di comunità in due comuni della Toscana, grazie anche al supporto di un sistema reticolare di ecomusei, all’attivazione di laboratori didattici e di incontri in setting con i giovani del luogo. Ne scrivono Emanuela Rossi, Costanza Lanzara e Marco D’Aureli che si interrogano sulla “sfida della partecipazione” e sullo sforzo collettivo di negoziazione tra le diverse ragioni dell’adesione al progetto, perché – concludono – «una cosa è mappare un patrimonio, altro è fare in modo che sia la comunità stessa a immaginare e costruire una propria autorappresentazione patrimoniale».
La distanza tra le domande culturali delle popolazioni locali e le risposte formalizzate nei codici delle strutture ministeriali competenti è al centro del contributo di Valeria Trupiano, funzionaria essa stessa faticosamente impegnata a far dialogare i soggetti e le istituzioni, privilegiando la tutela di quei beni patrimoniali «riconosciuti quali riferimenti identitari condivisi ed espressione di valori di cittadinanza». Un piccolo comune Palomonte, ai confini tra Salernitano, Irpinia e Basilicata è il contesto di cui Simone Valitutto racconta le fasi di restituzione di un ampio e significativo lavoro di documentazione visuale: un’esperienza a tutto campo che ha contribuito a diffondere conoscenza e coscienza del luogo e a «generare sentimenti di orgoglio e riconoscenza verso chi si è adoperato per concretizzare questo processo». In un altro piccolo comune, Paciano, in provincia di Perugia, si è sperimentato un originale progetto di valorizzazione delle memorie e dei saperi dell’artigianato locale (TrasiMemo), del quale Monica Maria Giacomelli, Cinzia Marchesini, e Daniele Parbuono ricostruiscono in una sorta di bilancio partecipato e di condivisione pubblica i risultati e le prospettive delle attività condotte in collaborazione tra antropologi, amministratori e artigiani.
Sul ruolo strategico dei musei quali crocevia di ricerche sul territorio scrivono Valentina Lusini e Paolo De Simonis. La prima si occupa del Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga, nel Senese, per conto del quale ha curato e coordinato con un’equipe interdisciplinare un’esemplare ricognizione etnografica. Nel suo saggio ne descrive il percorso e le scelte metodologiche ispirate all’onesto compromesso «tra le spinte di commercializzazione delle risorse paesaggistiche, l’esigenza di sperimentare narrative di restituzione alternative alla comunicazione accademica, la volontà di lavorare in una prospettiva “di contatto” e la necessità di mantenere uno sguardo riflessivo su questi processi». Il difficile slalom tra le esigenze diverse dei diversi interlocutori in campo offre una significativa rappresentazione del terreno accidentato in cui si muove l’antropologo e della fondamentale importanza della trasparente restituzione pubblica del suo lavoro. Paolo De Simonis muove invece da alcune esperienze toscane per proporre una ricostruzione storica e critica dei modelli museali e ragionare su «un immaginario museo riflessivo dove si cerca di “fare etnografia” esponendo non la definizione di reperti e idee quanto piuttosto la loro processualità».
Omerita Ranalli è studiosa coinvolta in prima persona nel processo di candidatura nelle Liste dell’Unesco della festa di S. Domenico di Cocullo nell’Aquilano e autrice del contributo al volume che nel ripercorrere le vicende ne documenta i controversi rapporti tra antropologi e istituzioni, le ambiguità nei processi di patrimonializzazione, i rischi che comprometterebbero «la libertà della ricerca, piegando l’etnografia alla macchina del finanziamento pubblico ai fini di un riconoscimento istituzionale per l’inserimento in una lista di eccellenze che, per definizione, stride con la natura stessa delle culture popolari». Nelle pagine di Ranalli si compendiano davvero tutte le potenzialità e le criticità dell’antropologia patrimoniale attenta oggi a mettere in dialogo le istanze dell’Unesco con la volontà popolare delle comunità e la autorità scientifica della ricerca. Il libro infine si chiude con un testo firmato da Silvia Cibolini e Fabio Perrone, i quali illustrano il “Progetto San Ginesio” in cui convergono studi artistico-iconografici e concreti interventi di recupero e restauro di strumenti musicali danneggiati dal sisma del 2016. La restituzione in questo caso diventa letteralmente riconsegna al comune dei preziosi beni patrimoniali restaurati.
 Le varie testimonianze e i diversi sguardi raccolti in questo volume mettono insieme teorie e pratiche intorno ad uno snodo cruciale dell’antropologia pubblica, come oggi è più corretto definire l’impegno etnografico nella sua disseminazione sociale e politica. Le molteplici esperienze riportate tra committenze istituzionali e rapporti con le comunità locali mi ha ricordato il censimento dei beni etnoantropologici avviato dalla Regione Siciliana nel 1979, cui partecipai come uno dei coordinatori scientifici nominati per conto dell’Università di Palermo. Si trattò di un’operazione di notevole portata culturale, uno straordinario sforzo di capillare ricognizione territoriale estesa su tutta l’Isola che coinvolse più di 700 giovani dei comuni siciliani e ha prodotto più di 18 mila schede di catalogazione degli strumenti di lavoro tradizionale. Questa ambiziosa impresa progettuale è stata possibile grazie alla felice sinergia tra le pubbliche amministrazioni, le istituzioni accademiche e i soggetti attivi del territorio. Si deve ai giovani, che si sono nel tempo trasformati in vere e proprie figure sociali nel proficuo confronto con le comunità di appartenenza e in un positivo processo di restituzione, la promozione di numerosissime iniziative di piccole e grandi mostre etnoantropologiche che si sono incrementate e diffuse nello spazio di pochi anni in tutta la Sicilia. Alcune di esse sono nate all’interno delle scuole, esiti di didattiche innovative, altre, grazie al supporto tecnico-scientifico offerto dal Servizio Museografico della Facoltà di Lettere di Palermo e al sostegno finanziario delle pubbliche amministrazioni, sono diventate realtà espositive stabili e persino musei permanenti.
Le varie testimonianze e i diversi sguardi raccolti in questo volume mettono insieme teorie e pratiche intorno ad uno snodo cruciale dell’antropologia pubblica, come oggi è più corretto definire l’impegno etnografico nella sua disseminazione sociale e politica. Le molteplici esperienze riportate tra committenze istituzionali e rapporti con le comunità locali mi ha ricordato il censimento dei beni etnoantropologici avviato dalla Regione Siciliana nel 1979, cui partecipai come uno dei coordinatori scientifici nominati per conto dell’Università di Palermo. Si trattò di un’operazione di notevole portata culturale, uno straordinario sforzo di capillare ricognizione territoriale estesa su tutta l’Isola che coinvolse più di 700 giovani dei comuni siciliani e ha prodotto più di 18 mila schede di catalogazione degli strumenti di lavoro tradizionale. Questa ambiziosa impresa progettuale è stata possibile grazie alla felice sinergia tra le pubbliche amministrazioni, le istituzioni accademiche e i soggetti attivi del territorio. Si deve ai giovani, che si sono nel tempo trasformati in vere e proprie figure sociali nel proficuo confronto con le comunità di appartenenza e in un positivo processo di restituzione, la promozione di numerosissime iniziative di piccole e grandi mostre etnoantropologiche che si sono incrementate e diffuse nello spazio di pochi anni in tutta la Sicilia. Alcune di esse sono nate all’interno delle scuole, esiti di didattiche innovative, altre, grazie al supporto tecnico-scientifico offerto dal Servizio Museografico della Facoltà di Lettere di Palermo e al sostegno finanziario delle pubbliche amministrazioni, sono diventate realtà espositive stabili e persino musei permanenti.
A ripensare a quegli anni e a quella stagione di mobilitazione e di tessitura di progetti e ricerche etnografiche sul campo, di allestimenti spontanei di piccoli musei contadini, di realizzazione di grandi centri di raccolta e documentazione, si può forse trarre una lezione per l’oggi, per il tempo presente che conosce nelle aree interne e periferiche del nostro Paese impoverimento economico e spopolamento demografico, per tornare a praticare quell’antropologia performativa che spinge a “sporcarsi le mani”, ad assumere la responsabilità etica e politica dell’impegno scientifico, a perseguire l’obiettivo non solo di leggere e interpretare la realtà ma anche di trasformarla, di rinnovarla. Dalle passioni, ormai spente o tradite, di quell’ultimo scorcio del Novecento la lezione che ereditiamo sembra avere i caratteri di una sfida, di un appello, di una testimonianza che, nel passaggio da una generazione all’altra degli antropologi, ribadisce e rimarca i doveri verso le collettività che incontriamo, verso il territorio che investighiamo.
Questioni, riflessioni e interrogativi che gli autori del libro, Ri-tornare. Pratiche etnografiche tra comunità e patrimoni culturali, ripropongono ragionando attorno al tema della restituzione, quanto mai denso di implicazioni problematiche e di suggestioni deontologiche. «Restituire – ha scritto Letizia Bindi nella sua introduzione – diviene una sorta di luogo di rifondazione delle scienze sociali», una cartina di tornasole dei processi democratici che legittimano la nostra presenza sul campo e ne muovono le azioni, un modo per confrontarsi e discutere con gli altri di spazi e ruoli, di saperi e interessi, di autorità e diritti di parola. Nel trauma della pandemia che ci ha insegnato a riscoprire il valore della comunità in cui è indissolubilmente iscritta e segnata la vita di ciascuno di noi, si è fatto più urgente e palese il bisogno di ripensare il sistema di relazioni che governa e condiziona il lavoro di chi ha l’ambizione di studiare gli uomini e le loro culture, un compito oggi declinato – anche in relazione alle politiche dell’Unesco – nel paradigma dei patrimoni locali, materiali e immateriali, da identificare, valorizzare, rivendicare, ereditare, restituire. Un impegno che ci fa dire che l’antropologia, oggi più di ieri, o è “applicata” o non è.
Dialoghi Mediterranei, n. 49, maggio 2021
Riferimenti bibliografici
Appadurai A., Modernità in polvere, Meltemi Roma 2001.
Ballacchino K, Bindi L, Broccolini A. (a cura), Ri-tornare. Pratiche etnografiche tra comunità e patrimoni culturali, Pàtron editore Bologna 2020
Bosio G., L’intellettuale rovesciato, Edizioni Bella Ciao Milano 1975
Clemente P., Communitas, in “Antropologia Museale”, nn. 37-39, 2016: 11-15
Gallini C., Satta G. (a cura), Incontri etnografici. Processi cognitivi e relazionali nella ricerca sul campo, Meltemi Roma, 20007
Hobsbwan E., Ranger T, L’invenzione della tradizione, Einaudi Torino, 2002
Padiglione V., Broccolini A., Uscirne insieme: farsi comunità patrimoniale, in “Antropologia Museale”, nn. 37-39, 2016: 3-10
Piasere L., L’etnografo imperfetto, Laterza Bari Roma 2002.
______________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. Nel 2015 ha curato un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (De Lorenzo editore). La sua ultima pubblicazione, Per fili e per segni. Un percorso di ricerca, è stata edita dal Museo Pasqualino di Palermo (2020).
_______________________________________________________________