per l’italiano
Sui numeri 47 e 48 di «Dialoghi Mediterranei» (da ora in poi: DM) si è aperto un dibattito su una questione che appare alquanto foriera di esiti poco favorevoli per la nostra cultura e per la nostra identità linguistica. Negli ultimi decenni, infatti, abbiamo subìto una straordinaria inondazione di parole inglesi che sembra aver sommerso la nostra lingua. L’esperienza storica ci dice che nel corso degli ultimi due millenni la nostra penisola è stata abitata o invasa da diverse popolazioni straniere che ci hanno lasciato in eredità, soprattutto a livello delle parlate locali, migliaia di vocaboli assimilati così bene da non poterli distinguere più da quelli autoctoni. Non è qui il caso di fare lunghi elenchi, ma tutti noi sappiamo che nel nostro parlare e scrivere usiamo, senza nemmeno sospettarlo, parole di derivazione greca e bizantina, longobarda, francese, spagnola, tedesca, araba, ecc. ecc. Ai tempi del ginnasio, nel mio manuale di Prosodia e metrica (si intitolava proprio così) erano elencati pochi vocaboli stranieri che all’università avrei imparato a chiamare “prestiti”; potrei citarli quasi tutti a memoria: cognac, vermuth, alpenstock, leit-motiv … anche bar, che cominciava a sostituire “caffè”.
Se molti anni fa si poteva parlare di prestiti (ma per il linguista Sgroi – DM, 48 – è meglio dire “doni”; e difatti non li abbiamo restituiti, ce li siamo tenuti) che riguardavano pochi termini, ai giorni nostri con l’ingresso di voci relative allo sport, al cinema, ad Internet, alle conversazioni che possiamo fare con il computer (chiedo venia: con il calcolatore elettronico) e con i telefonini cellulari, il mio antico prontuario di prosodia diventerebbe voluminoso come il vocabolario di greco del Rocci.
Davanti a questa invasione linguistica qualcuno si preoccupa, altri si indignano, i molti supinamente continuano a ripetere ok, (che in un film Totò tradusse con “Oh cacchio”) bye bye, week-end, bed-and-breakfast ...Qualche rappresentante della Crusca, come il professor Sabatini, ogni tanto invita, flebilmente, ad usare i termini italiani al posto di quelli inglesi. Ma è l’antica vox clamans in deserto. La televisione, imperterrita, continua a farci vedere la pubblicità delle automobili con messaggi (slogan?) redatti totalmente in lingua inglese.
Una voce, invece, che vuol farsi sentire è quella dell’architetto Iannazzi che, sul n. 47 di DM, pubblica un lungo e articolato intervento sulla questione, fornendo anche elenchi molto ampi di termini anglosassoni, a testimonianza di questa invasione di campo. Quello di Iannazzi è insieme un grido di dolore e un’accusa di lesa maestà. Sul grido di dolore mi sento di condividere pienamente, perché proprio, quando siamo seduti davanti al televisore, tra canzonette, automobili e profumi, ci sembra di essere in America; sul delitto di lesa maestà nutro alcuni dubbi ed è da questi che vorrei iniziare le mie argomentazioni.
La lamentela di Iannazzi ha un tono apocalittico che mi ricorda quello dei folkloristi di fine Ottocento che si stracciavano le vesti per l’imminente fine delle tradizioni popolari, quasi totalmente nate nel mondo contadino che allora sembrava agonizzare di fronte all’avanzata dell’industrializzazione. Eppure un secolo dopo, negli ultimi trenta anni del Novecento, ho potuto raccogliere una buona messe di tradizioni folkloriche, il che vuol dire che non tutto era sparito; eppure con me c’erano ricercatori che s’affannavano ancora a raccogliere il più possibile perché convinti che tutto a breve sarebbe scomparso definitivamente. Cosicché ho l’impressione che prima che l’inglese si sostituisca all’italiano passeranno ancora tanti decenni … Dello stesso mio parere è il signor Tommaso Cecilia il quale, in un commento all’articolo di Iannazzi (DM, 47), ricorda che della morte dell’italiano si è cominciato a parlare già al tempo della neonata Accademia della Crusca.
 Lo stesso tono apocalittico si ritrova ancora nel secondo intervento di Iannazzi (n. 48 di DM), addirittura espresso con maggiore enfasi, perché qui si dà quasi per scontato il pericolo che i nostri nipoti possano leggere i classici italiani, da Dante a Calvino ed Eco, in inglese anziché nella lingua del bel sì. A riprova di questa triste ipotesi, Iannazzi ci riferisce di un suo esperimento fatto con il telefono cellulare che nella sua memoria elettronica conserva non solo i vocabolari di un centinaio di lingue straniere ma perfino il dispositivo capace di tradurre da una lingua all’altra. Egli ha chiesto al telefono di tradurre “in italiano” alcuni vocaboli: colf, baby-sitter, chat… Il traduttore gli ha riproposto: colf, baby-sitter, chat … Al che ha desunto che ormai non c’è più speranza, ormai l’inglese si è sostituito alla nostra lingua nazionale. Ma non si è chiesto se coloro che implementano (lo so: implementare deriva dall’inglese implement, ma questo a sua volta ha il suo etimo nel latino implēre …) le memorie dei telefonini siano lessicografi o studiosi di lingue. E se fossero dei semplici tecnici che meccanicamente inseriscono quelle nozioni linguistiche che hanno imparato freneticamente smanettando, come è d’uso ormai per milioni di persone, sulle tastierine per mandare migliaia di messaggini insipidi e del tutto inutili? Io non li prenderei in considerazione e se proprio voglio tradurre quei termini nella mia lingua, preferisco affidarmi ad un buon dizionario inglese-italiano.
Lo stesso tono apocalittico si ritrova ancora nel secondo intervento di Iannazzi (n. 48 di DM), addirittura espresso con maggiore enfasi, perché qui si dà quasi per scontato il pericolo che i nostri nipoti possano leggere i classici italiani, da Dante a Calvino ed Eco, in inglese anziché nella lingua del bel sì. A riprova di questa triste ipotesi, Iannazzi ci riferisce di un suo esperimento fatto con il telefono cellulare che nella sua memoria elettronica conserva non solo i vocabolari di un centinaio di lingue straniere ma perfino il dispositivo capace di tradurre da una lingua all’altra. Egli ha chiesto al telefono di tradurre “in italiano” alcuni vocaboli: colf, baby-sitter, chat… Il traduttore gli ha riproposto: colf, baby-sitter, chat … Al che ha desunto che ormai non c’è più speranza, ormai l’inglese si è sostituito alla nostra lingua nazionale. Ma non si è chiesto se coloro che implementano (lo so: implementare deriva dall’inglese implement, ma questo a sua volta ha il suo etimo nel latino implēre …) le memorie dei telefonini siano lessicografi o studiosi di lingue. E se fossero dei semplici tecnici che meccanicamente inseriscono quelle nozioni linguistiche che hanno imparato freneticamente smanettando, come è d’uso ormai per milioni di persone, sulle tastierine per mandare migliaia di messaggini insipidi e del tutto inutili? Io non li prenderei in considerazione e se proprio voglio tradurre quei termini nella mia lingua, preferisco affidarmi ad un buon dizionario inglese-italiano.
Iannazzi non solo si lamenta e denuncia ma chiede anche l’intervento dei direttori delle testate giornalistiche e televisive, che possono intervenire, e non lo fanno, in sede di redazione, bocciando i testi in cui inutilmente si addensano termini stranieri; e chiede pure l’intervento dei governanti attraverso provvedimenti legislativi e amministrativi. In effetti i responsabili della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa potrebbero intervenire di più, ma forse temono di essere scambiati per passatisti mentre l’abuso della lingua straniera sembra farli apparire meno ingessati, più sportivi, più liberi; ma soprattutto, più all’avanguardia. Al provincialismo non c’è mai fine.
L’intervento delle istituzioni politiche mi sembra inopportuno, come dimostrò Graziadio Isaia Ascoli opponendosi alla proposta manzoniana che, nell’intento di eliminare l’analfabetismo e per aiutare gli italiani a parlare e a scrivere in lingua toscana, divenuta nazionale, prevedeva di fornire a tutte le famiglie un Novo vocabolario, di assumere in tutte le scuole maestri presi dalla Toscana (dove allora c’era l’80% di analfabetismo) e dare incarico alle prefetture (con apposito funzionario, sempre toscano) di scrivere in lingua toscana le ordinanze e tutti i bandi e gli avvisi da affiggere sui muri di paesi e città. Iannazzi, inoltre, diseppellisce l’antico e mai realizzato progetto dell’esperanto: un veloce sguardo sulla storia linguistica gli avrebbe impedito di farlo perché nessuna lingua artificiale (tranne quella per i sordomuti, forse) è riuscita ad interessare una cerchia più vasta di quella dei suoi inventori e degli amici di costoro.
 C’è qualcosa, comunque, negli interventi di Iannazzi che mi trova totalmente d’accordo e che è espresso lucidamente nel suo seguente passo: «Questo mondo, reso più vicino da un presunto legame linguistico, risponde a soli interessi economici e cancella del tutto gli interessi culturali, che i patrimoni linguistici delle comunità hanno accumulato nei millenni».
C’è qualcosa, comunque, negli interventi di Iannazzi che mi trova totalmente d’accordo e che è espresso lucidamente nel suo seguente passo: «Questo mondo, reso più vicino da un presunto legame linguistico, risponde a soli interessi economici e cancella del tutto gli interessi culturali, che i patrimoni linguistici delle comunità hanno accumulato nei millenni».
Sempre sullo stesso n. 47 di DM interviene il linguista Luciano Giannelli che elegantemente smorza i toni apocalittici, riconducendo la questione ai processi storici che incidono sulla evoluzione delle lingue; non crede, o almeno spera che la lingua italiana non si riduca a strumento di comunicazione vernacolare, cioè come lingua di subalterni. Aggiunge poi che se c’è qualche lingua che deve temere di essere emarginata o addirittura eliminata da una dominante, essa non può che appartenere al mondo dei dialetti, che sono lingue domestiche e come tali non si occupano né di filosofia, né di arte, né della teoria quantistica. Inermi davanti ad una lingua parlata e scritta da poeti, letterati, scienziati, filosofi, i dialetti sono destinati a soccombere o ad essere destinati, appunto, agli affetti domestici. Fino a che la lingua italiana rimane strumento di espressione del pensiero filosofico e scientifico e della letteratura, secondo Giannelli con cui concordo, essa non diventerà un vernacolo, una lingua, cioè, parlata dai servi di casa, come erano i vernae nell’antica Roma.
Pietro Clemente, intervenendo dopo Iannazzi (DM, 48), con pacatezza e sommo equilibrio spiega perché non è bene usare un tale profluvio di termini inglesi, quando il nostro lessico conta uno sterminato numero di voci con lo stesso significato. Il suo è un discorso molto politico ma è svolto facendo finta che non lo sia. Tra l’altro richiama l’attenzione su altri aspetti che il dominio anglosassone non ci fa vedere: è bene rifuggire dagli anglismi inutili, ma è opportuno anche evitare espressioni improprie ed approssimative come “aprire un fascicolo” e “sono stati processati 150.000 tamponi”…Questa sua notazione mi richiama alla mente uno dei problemi gravi dell’Italia di oggi che rischia di diventare, nella bocca e nella penna dei giornalisti e di chi li imita, una scenetta comica. Spesso ci lamentiamo della lentezza della magistratura, ci scandalizziamo se un processo dura parecchi anni e soprattutto se a causa di questa lunghezza dibattimentale gravi delitti cadono in prescrizione. Uno spirito beffardo potrebbe spiegarsi questa situazione critica col fatto che i magistrati, anziché avviare indagini giudiziarie si mettano, aprendo fascicoli, a leggere giornali e riviste, o si mettano a processare i tamponi. Purtroppo non sono i giudici a svolgere lavori strani, sono i giornalisti ad essere ammalati gravemente di pigrizia mentale e presuntuosamente convinti di usare, attraverso una metafora, un linguaggio lontano da quello burocratico.
Che fare dunque? Secondo me non è con prediche e interventi amministrativi che si supera il problema. Il difetto, come si dice volgarmente, sta nel manico e cioè nel basso tasso di istruzione scolastica che provoca un drammatico analfabetismo di ritorno. Negli ultimi trenta anni la scuola, che necessitava di una buona riforma, ha dovuto subire o ministri che volevano svecchiarla portandola al livello, piuttosto basso, di quella americana e privilegiando le attività indirizzate verso il lavoro (prima Berlinguer, poi Renzi – la “buona scuola”? o la “scuola buona”?), o ministri che non avevano la minima idea di cosa siano la cultura e la sua trasmissione didattica (Moratti, Gelmini, Azzolina). Ma la responsabilità di una scuola allo sfascio comincia già dal 1963/64, quando si istituì l’attuale scuola media. L’intento era quello di dare a tutti i ragazzi la stessa base culturale e linguistica, di “democratizzare” la scuola. Ovviamente, si sa, che quando si vuole farsi capire da tutti occorre abbassare il livello dei contenuti e della comunicazione linguistica; la riforma però era giusta, solo che bisognava approntare una classe insegnante adeguata, perché andava bene abbassare i toni, ma solo agli esordi: in seconda e terza media occorreva predisporre gli alunni a licenziarsi possedendo una robusta preparazione che non creasse nessun analfabetismo di ritorno e dare loro una preparazione adeguata ad affrontare qualsiasi scuola media superiore. Niente di tutto ciò.
La scuola, diventata di massa, soffriva di mancanza di insegnanti, così si riempì di docenti improvvisati e impreparati: furono chiamati maestri in pensione e studenti universitari; frotte di avvocati, di ingegneri, di biologi, di agronomi furono assunti come insegnanti di lettere, di lingue straniere, di matematica, di scienze. Dopo qualche anno buona parte di quei precari passò di ruolo, anche se non sapeva cosa fosse la didattica ed anche se i contenuti didattici erano piuttosto vaghi, con la gravissima conseguenza che i nuovi insegnanti capirono bene solo una cosa: che a scuola si può insegnare anche se non si è all’altezza del compito. Tra l’altro si discusse a lungo se introdurre il latino e non si spese nemmeno una sillaba per ammodernare programmi e didattica, che restarono quelli di un’Italia contadina rivestita con l’orbace fascista.
Il lassismo cominciò a penetrare nella scuola dell’obbligo per poi comodamente dilagare ovunque. Anziché convincere gli allievi della necessità di uno studio serio e approfondito (un po’ populisticamente dicevo ai miei che lo studio è un lavoro, esattamente come quello che molti loro coetanei meno fortunati svolgevano nei campi e nelle officine), gli insegnanti esaltavano l’intuizione e la creatività anche quando questa era insulsa (tutti ricordiamo la maestra che fece inorgoglire perfino il primo ministro perché un suo scolaretto aveva scritto che il fiore è “petaloso”). Eh già, l’intuizione e la creatività sono spontanee, non sono faticose come la “disciplina” e la schola.
Secondo le statistiche, nelle case degli Italiani entra appena un libro l’anno; ho l’impressione che se gli insegnanti ne comprassero mediamente due, gli esiti della statistica sarebbero meno preoccupanti. Tranne quei pochi che lo studiano seriamente e poi vanno per mesi in Inghilterra, tutti gli altri imparano l’inglese “ad orecchio”, attraverso le canzonette, i film, la televisione, Internet. Diventa quasi il gergo di chi vuol sentirsi aggiornato e moderno, di chi imita acriticamente il chiacchiericcio dei salotti televisivi. Una pandemia di infantilismo ha infettato tutti. C’è perfino chi in possesso di questo inglese orecchiato si è avventurato a parlare di Rinascimento in terra saudita.
Ma forse è soltanto una moda? È certo anche una moda. Che può diventare pericolosa, quindi meglio essere cauti e previdenti. Come suggeriva Clemente, oltre all’anglofilia linguistica ci sono altri problemi che affliggono la lingua italiana: la sciatteria, la superficialità, l’approssimazione sono spesso presenti nella quotidiana comunicazione scritta ed orale. Poiché non voglio diventare lungo e noioso, mi limito qui ad elencare le mie personali idiosincrasie.
Intanto non sopporto, per chiamarla come i linguisti, la “dislocazione a sinistra” (ma c’è anche quella “a destra”), che spesso appare in frasi come la seguente: «Io questo libro l’ho comprato» (struttura sintattica che purtroppo è ricorrente anche presso coloro che scrivono libri e vogliono fare letteratura). Per far capire che questa costruzione è paradossale, invitavo i miei alunni a farne l’analisi logica; i quali alla fine dell’esercizio si trovavano con un superfluo pronome “lo” in funzione di doppio complemento oggetto. Solo nel caso di un’espressione enfatica la costruzione diventa accettabile: «Se vuoi saperlo, questo libro l’ho comprato io». È probabile che a monte ci sia il tentativo di una costruzione passiva del verbo: «Questo libro è stato comprato da me», ma, siccome essa è più complicata di quella attiva, ci fermiamo subito, non senza prima aver scritto o detto «questo libro». Senza accorgercene, l’italiano sta scivolando verso una semplicità (povertà?) grammaticale e sintattica simile a quella dell’inglese.
E poi c’è l’infame burocratese, anche questo scambiato, come l’inglese, per simbolo di modernità e per raffinato linguaggio tecnico. Ed ecco la sfilza di neologismi come «attenzionare» che ti fanno venire l’ulcera intestinale; e poi il sublime «portare avanti» usato in tutte le salse e che sostituisce, per ignoranza lessicale, almeno una decina di voci con significati più idonei e corretti. Per non parlare della confusione che esiste tra dove e quando, cioè tra il luogo e il tempo: «Nel Medioevo dove c’era molta superstizione», ormai fatta propria non solo dalle persone comuni, ma da giornalisti, letterati, storici ecc. ecc. A cui si aggiunge l’incapacità dei più di declinare il pronome relativo che: «Conosci la mia amica che vado al cinema?».
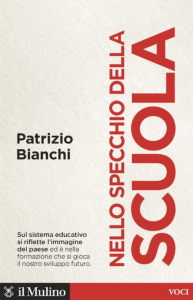 Per concludere, parliamo dell’italiano di Facebook (come tradurlo nella nostra lingua?) e dei messaggini telefonici in cui si usano codici e segni non linguistici, come quelli dell’aritmetica: «Mio fratello è – bravo di me ma + di te»; e poi le abbreviazioni con la “x”: x te, xtanto, ecc. Pare che in un concorso per magistrati una candidata abbia scritto nel compito che si trattava di «una veperata quaestio». Voleva semplicemente scrivere vexata quaestio, ma si vede che frequentava Facebook e non aveva studiato il latino (chissà come avrà fatto con il Diritto romano …).
Per concludere, parliamo dell’italiano di Facebook (come tradurlo nella nostra lingua?) e dei messaggini telefonici in cui si usano codici e segni non linguistici, come quelli dell’aritmetica: «Mio fratello è – bravo di me ma + di te»; e poi le abbreviazioni con la “x”: x te, xtanto, ecc. Pare che in un concorso per magistrati una candidata abbia scritto nel compito che si trattava di «una veperata quaestio». Voleva semplicemente scrivere vexata quaestio, ma si vede che frequentava Facebook e non aveva studiato il latino (chissà come avrà fatto con il Diritto romano …).
Già, non si studia più il latino. Qualcuno attribuisce la colpa di questo sfacelo linguistico al fatto che non si studia più quell’antica lingua. È vero, non è solo una nostalgia di conservatori barbogi. Ma torniamo indietro nel tempo, quando ero ancora fanciullo. Alla scuola media i programmi prevedevano quattro ore a settimana di italiano e quattro di latino. Nelle ore di italiano leggevamo qualche racconto e qualche poesia, facevamo i riassunti (esercizio noioso ma molto efficace; si imparava a “capire”, oggi molti non capiscono ciò che leggono), imparavamo a memoria la coniugazione dei verbi irregolari, e sempre a memoria imparavamo avverbi, preposizioni e congiunzioni, ma senza capire a cosa servivano. In compenso ci tartassavano con la grammatica latina, centellinata in tre anni di scuola media e poi la tortura della sintassi nei due primi anni del Classico e dello Scientifico (chi ha fatto il Classico sa che al ginnasio grammatica latina e greca avevano il dominio su tutto, a scapito delle altre materie). Essendo l’Italiano una lingua neolatina era forse giustificabile che si avesse una superficiale infarinatura della grammatica italiana dopo esserci soffermati tanto su quella di Cicerone. Ma una volta tolto il latino, si continuò a non far studiare la grammatica italiana, a parte far mandare a memoria i verbi irregolari.
I luminari del Ministero di Trastevere se ne accorsero quando negli anni ‘80 del secolo scorso promossero la riforma dei programmi della scuola elementare. Pensarono bene di addestrare gli insegnanti con corsi di aggiornamento che li mettessero a conoscenza di cosa era accaduto nelle discipline fondamentali negli ultimi cento anni. Sennonché nella scuola non si investe e se si danno soldi questi sono sempre pochi; così si organizzarono corsi di aggiornamento da svolgere nel giro di un mese e che si ridussero a brevi esposizioni ex cathedra delle teorie innovative sulla didattica delle materie d’insegnamento. Nessun seminario, niente laboratori linguistici e scientifici, nessuna sperimentazione didattica: solo parole parole parole … Che ovviamente volano senza lasciare traccia.
E poi è venuto Luigi Berlinguer con le domande (o i test?) a risposta singola o multipla. Adesso, per superare esami e concorsi, è sufficiente che alle elementari abbiamo imparato a fare le crocette, per il resto basta avere un po’ di orecchio. Degli epigoni berlingueriani non so nulla, quindi, seguendo i consigli di un filosofo, taccio (però: chi ricorda la riforma “epocale”, diceva lei, della Gelmini?).
A questo punto è chiaro che per me la difesa migliore contro l’invasione di corpi estranei nell’organismo della nostra lingua non può essere né la lamentela, né un provvedimento amministrativo. Il vero vaccino contro la propagazione e il contagio dell’inglese o di qualsiasi altra lingua straniera non può essere che la scuola: una buona scuola in cui ci siano insegnanti scientificamente preparati (e ben pagati), aule, laboratori e palestre come si conviene. I programmi per le elementari del 1985 possono essere un buon punto di partenza, occorre estenderne la loro visione e la loro metodologia agli altri ordini e gradi della scuola; riformare orari e programmi delle superiori (senza eliminare Storia e Geografia) in maniera da presentarli non come oggetti museali da studiare coattivamente, ma come contenuti che dialogano continuamente con la realtà quotidiana.
Purtroppo il ministro della Pubblica Istruzione scelto dal Presidente Draghi appartiene al mondo dell’economia; per questo ho lo stesso timore manifestato da Iannazzi: in questo mondo dominato dal denaro, tutto si fa per difendere ed esaltare gli interessi economici, a scapito della crescita culturale dei cittadini. Pare che il ministro Franceschini sia pronto a dargli una mano.
Dialoghi Mediterranei, n. 49, maggio 2021
______________________________________________________________
Mariano Fresta, già docente di Italiano e Latino presso i Licei, ha collaborato con Pietro Clemente, presso la Cattedra di Tradizioni popolari a Siena. Si è occupato di teatro popolare tradizionale in Toscana, di espressività popolare, di alimentazione, di allestimenti museali, di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, Giovanni Pascoli e il mondo contadino, Lo stile narrativo nel Pinocchio del Collodi). Ha pubblicato sulle riviste Lares, La Ricerca Folklorica, Antropologia Museale, Archivio di Etnografia, Archivio Antropologico Mediterraneo. Ultimamente si è occupato di identità culturale, della tutela e la salvaguardia dei paesaggi (L’invenzione di un paesaggio tipico toscano, in Lares) e dei beni immateriali. Fa parte della redazione di Lares. Ha curato diversi volumi partecipandovi anche come autore: Vecchie segate ed alberi di maggio, 1983; Il “cantar maggio” delle contrade di Siena, 2000; La Val d’Orcia di Iris, 2003. Ha scritto anche sui paesi abbandonati e su altri temi antropologici.
_______________________________________________________________








