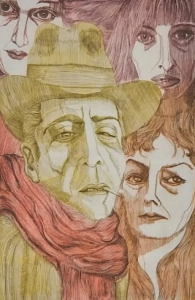per la cittadinanza
di Augusto Cavadi
Se per diritti di cittadinanza intendiamo – secondo l’uso linguistico oggi prevalente – l’insieme dei diritti civili, politici e sociali spettanti a chi sia o cittadino di uno Stato o, almeno parzialmente, equiparato ad esso, potremmo chiederci: in che misura la presenza, all’interno dei confini di uno Stato, di un sistema di dominio mafioso limita l’esercizio di tali diritti?
Ai miei occhi non si tratta di una questione peregrina o prevalentemente accademica. Nasce, infatti, da esperienze frequenti che vivo sulla mia pelle o di cui ho contezza sfogliando le pagine dei quotidiani. Esperienze che contrastano – stranamente – con una sorta di opinio communis (tanto più radicata quanto meno espressa) secondo cui la mafia è ormai morta, o per lo meno agonizzante. Per cui politici e intellettuali, ma un po’ anche magistrati e forze dell’ordine, potrebbero concentrarsi su altre ‘emergenze’. Questa opinione – abbastanza tacita – è declinata in almeno due versioni principali.
La prima, piuttosto volgare, identifica le cosche mafiose con le associazioni criminali e terroristiche in genere, per cui – se non scoppiano bombe in autostrada o non saltano chiese a Roma – la mafia è in crisi. È una tesi storicamente infondata: la mafia alza il tiro non quando è in auge, ma quando è in difficoltà perché si allentano le relazioni con alcuni esponenti dello Stato tradizionalmente collusi e, anzi, altri esponenti dello Stato democratico la mettono alla sbarra o ne limitano i traffici illeciti.
Una seconda versione è più raffinata e non priva di aspetti veritieri: la mafia – o almeno la confederazione mafiosa Cosa nostra – è stata duramente colpita sul piano giudiziario ed è dunque indebolita militarmente. Ma essa era forte perché, intorno ai 5.000 (circa) “uomini d’onore” in servizio permanente effettivo, ruotava un giro di conniventi, complici, collusi (da Tommaso Buscetta quantificati in circa un milione di siciliani) di ogni età e condizione sociale che, pur non essendo ‘interni’ a Cosa nostra, ne erano a disposizione per interesse, per paura, per consonanza culturale o altre ragioni. La tesi – esposta ad esempio in maniera brillante da Giacomo di Girolamo – è che questa “zona grigia” (Nino Amadore) [1], questo “contesto” (Leonardo Sciascia) [2], questo “blocco sociale” (Umberto Santino) [3] circostante Cosa nostra, abbia isolato e rinnegato i ‘padrini’. La mafia
«non ha più delle regioni di appartenenza, si è presa l’Italia tutta.
Non ha più i padrini di una volta: sono stati fatti fuori per limiti d’età.
Puzzavano di crasto e vino cotto.
Erano troppo legati ai riti, ai codicilli.
Siamo noi, i Grigi.
Siamo quelli che hanno in mano tutto.
Noi siamo una cosa diversa.
Il sottobosco che è diventato foresta,
l’ombra che si è mangiata la luce.
Siamo senza colore, ancora, e senza forma.
Siamo Cosa Grigia.
[…]
La mafia fa schifo. Anche per noi.
L’abbiamo masticata, divorata, ingoiata. Metabolizzata.
E adesso la mafia siamo noi» [4].
Questa teoria, senz’altro suggestiva, racconta metà della storia (e dunque è incompleta e, se assolutizzata, errata e fuorviante). Infatti è vero che, senza il reticolo di complicità in varie fasce sociali, soprattutto medio-alte (la “borghesia mafiosa” di cui, sulla scia di Leopoldo Franchetti, hanno parlato Mario Mineo e Umberto Santino [5]), la mafia non sarebbe stata la mafia, bensì una delle innumerevoli bande criminali che sono presenti da sempre e dovunque sul pianeta. Ed è anche verosimile che, sotto i colpi delle autorità giudiziarie e delle forze dell’ordine, il nucleo armato di Cosa nostra abbia perduto sicumera e arroganza nei confronti dei “colletti bianchi” esperti in transazioni bancarie o in sistemi informatici. Ma non possiamo dimenticare né che, all’interno stesso di Cosa nostra, si sono trovati nel passato anche medici e avvocati, prìncipi e preti, notai e burocrati (e non solo proletari campagnoli che odoravano «di becco, di montone, cioè di pecorume, di stalla»[6]) né che ancor oggi, ai vertici di Cosa nostra, spadroneggiano personaggi di scarsa istruzione – che provano «a vestirsi bene, a darsi un tono e un’aria, a mostrarsi urbani, cittadini del mondo», ma rimangono sempre «viddrani arrinisciuti, contadini che si sono fatti i soldi» [7] – bravi solo nell’uccidere senza scrupoli morali.
Più che una “mutazione genetica” [8] da Cosa nostra a Cosa grigia, vedrei piuttosto uno spostamento di equilibri interni fra la componente diplomatico-militare e la componente politico-amministrativa all’interno di un sistema mafioso che ha sempre intrecciato “continuità e trasformazione” [9], tradizione e innovazione: se ci fermiamo agli elementi ereditati dal passato, cadiamo nel pittoresco e nel folclorico (e ci dimentichiamo che sin dalle origini tra i mafiosi non ci sono stati solo contadini e pastori, ma anche parlamentari e professoroni); se ci concentriamo esclusivamente sugli elementi di novità, perdiamo di vista pezzi importanti del mosaico (e ci vietiamo di constatare che ci sono ancora le strutture organizzative e militari, con boss anche senza diploma e gregari analfabeti, con i riti e i santini, con i miti e gli ‘inchini’ [10], i proverbi dei bisnonni e i pregiudizi sulle donne).
Insomma, per non farla lunga: la mafia, purtroppo, c’è. Anche se si vede di meno. Anche se preferisce l’immersione o, per lo meno, il basso profilo. Ma ciò non significa che sia “invisibile”: è una questione di sguardi. È invisibile se uno la cerca sull’asfalto insanguinato, ignorando che la violenza mafiosa è stata sempre l’extrema ratio cui fare ricorsi quando la seduzione, lo scambio di favori, la co-interessenza criminale non funzionano.
Proverò, sia pur sommariamente, a spostare lo sguardo sui diritti di cittadinanza e a verificare se, alla radice di tante negazioni degli stessi, non vi sia quel sistema di dominio mafioso costituito inestricabilmente dalla componente gerarchica e militare (interclassista: ci sono boss incapaci di leggere e scrivere che provengono da ceti popolari, ma altri plurilaureati e professionalmente qualificati appartenenti a famiglie rinomate) e dall’area “grigia” (altrettanto interclassista: dal presidente della Giunta regionale disposto a concordare con i gestori delle cliniche private il tariffario dei rimborsi delle prestazioni sanitarie alla casalinga che, con l’aiuto dei figli minorenni, spaccia droga in casa) che ne è il terreno di coltura, la barriera protettrice, la longa manus operativa nei gangli dello Stato e nel tessuto sociale.
Il sistema di dominio mafioso impedisce l’esercizio dei diritti civili
Lo Stato democratico prevede, nella sua stessa Costituzione, una serie di auto-limitazioni nell’esercizio del “monopolio della forza” di cui, secondo Max Weber, è titolare. La mafia non solo contesta allo Stato democratico l’esclusività dell’uso della forza fisica, pretendendo di condividerne la titolarità, ma – in aggiunta e in aggravamento – la esercita senza nessuna auto-limitazione di principio. Così, dalle origini della mafia (convenzionalmente dall’Unificazione italiana del 1861) in poi, mentre lo Stato ritiene «inviolabile» la «libertà personale»; non ammette «forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria» ed esclude tassativamente la liceità di «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» (art. 13), le organizzazioni criminali – come le organizzazioni mafiose – ritengono di poter disporre della vita dei concittadini (e, a fortiori, della loro libertà di movimento) senza limitazioni programmatiche.
Il «domicilio» altrui, che secondo lo Stato repubblicano è «inviolabile» (art. 14), è invece metodicamente individuato – insieme al luogo di lavoro (laboratorio, industria, negozio…) – come oggetto privilegiato per attentati intimidatori nei confronti di chi, per le ragioni più svariate, non ha accettato le “offerte” di “protezione” o altri messaggi da parte delle associazioni mafiose.
Le medesime associazioni hanno in più occasioni (dal comizio di Girolamo Li Causi a Villalba nel 1944 alla strage di Portella della Ginestra del 1947) calpestato quel «diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi», «anche in luogo aperto al pubblico», che l’articolo 17 della Costituzione garantisce a ogni cittadino. Un diritto di riunione che, negato agli altri, riservano per sé in forme aberranti, sino alla violazione, permanente, di quell’articolo 18 che proibisce «le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».
Il lungo elenco di giornalisti assassinati con certezza dalla mafia (da Giuseppe Impastato a Mario Francese, da Mauro Rostagno a Beppe Alfano) attesta, da solo, quanto sia falso che, nei territori in cui essa impera, sia possibile, effettivamente, godere del diritto – contemplato dall’articolo 21 – di «manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». L’esazione del “pizzo”, la gestione in nero della manodopera sia locale che immigrata, la compartecipazione allo sfruttamento – operato da mafie straniere trasferitesi in Sicilia – di donne schiavizzate sono altrettante trasgressioni frontali dell’articolo 23: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Intimidazioni e minacce – indirizzate a parti lese, a testimoni o a giudici “popolari” – vanificano, inoltre, la previsione dell’articolo 24, secondo il quale «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi».
Laddove per la Costituzione «la responsabilità penale è personale» (art. 27), il sistema giudiziario ‘parallelo’ mafioso ha più volte decretato l’uccisione di persone innocenti, “ree” solo di essere congiunte o affini di mafiosi ritenuti (a torto o a ragione) colpevoli di tradimento e di collaborazione con l’avversario (lo Stato). Superfluo, e amaramente grottesco, sarebbe chiedersi se lo stesso sistema giudiziario mafioso rispetti, come il sistema giudiziario statale, il dettato del quarto e ultimo comma del medesimo articolo: «Non è ammessa la pena di morte».
Nei periodi più fiorenti, comunque, il mafioso non ha bisogno né di uccidere né di esercitare altre forme di violenza fisica: basta il gioco della corruzione (quando egli è esterno a un’istituzione ed entra in relazione con un funzionario ‘pubblico’) e della concussione (quando è dentro un’istituzione ed entra in relazione con un cittadino ‘comune’). In entrambi i casi conta sulla complicità dei sodali, soprattutto se magistrati e alti burocrati, per non incorrere nelle conseguenze previste dall’articolo 28: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti».
Il sistema di dominio mafioso impedisce l’esercizio dei diritti sociali
Se l’articolo 29 «riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», a prima vista si potrebbe affermare che esso rientri perfettamente nella visione-del-mondo mafiosa. A ben vedere, invece, anche in questo ambito ciò che appare è diverso da ciò che è. Innanzitutto, infatti, va notato che il “familismo amorale” rintracciabile nella cultura mafiosa maschera la subordinazione assiologica della famiglia anagrafica e biologica alla ‘famiglia’ criminale, su ordine della quale padri hanno commissionato l’assassinio di figlie, e fratelli hanno ucciso proditoriamente fratelli. Inoltre, anche nei casi di ménage coniugale ‘normale’, il mafioso – che deve evitare la macchia del divorzio – può moltiplicare a piacimento il numero delle amanti e non è tenuto alla fedeltà effettiva nei confronti della moglie. Alla quale, dunque, è negato il diritto costituzionale all’«eguaglianza morale e giuridica» con il marito.
L’articolo 32 sancisce il compito della Repubblica di tutelare «la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Sappiamo quanto si è lontani da ciò: la precedenza per le visite o per le operazioni chirurgiche è riservata ai ricchi, nelle strutture private, o ai ‘raccomandati’ nelle strutture pubbliche. È senza significato il dato statistico che la maggior parte dei professionisti organici alla mafia, o in connessione stretta con essa, appartengano all’ordine dei medici o siamo comunque operatori nell’ambito della sanità?
Secondo l’articolo 33, «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». A meno che, in territori di densità mafiosa, non si tratti di scienze storico-sociologiche. Nel corso di un incontro di aggiornamento che ho tenuto anni fa a Patti (Messina), una collega confessò candidamente di aver ricevuto, tre giorni dopo aver assegnato in classe un tema sulle stragi del ‘92, l’invito esplicito – a nome del nonno in galera di una delle alunne – a «non occuparsi di queste cose». E di aver immediatamente e definitivamente obbedito. Sarebbe troppo lungo snocciolare gli episodi del genere che mi sono capitati personalmente, alcuni dei quali da me raccontati in altre sedi [11]. Non posso trascurare, però, almeno un accenno al mercato clamorosamente illegale dei diplomi rilasciati da scuole private gestite da personaggi (talora ecclesiastici) indistinguibili da esponenti delle cosche mafiose. Chi ha messo piede in questi gironi infernali ha visto cose che gli umani non possono immaginare: dal ricatto agli insegnanti (ti assumo, firmi la busta paga, ma non ti do un centesimo perché ti basta guadagnare punteggio valevole per le graduatorie statali) alla falsificazione dei registri (dove risultano interrogazioni e persino presenze in aula mai avvenute), sino alla burla degli esami di Stato (o di Maturità, secondo il gusto dei ministri in carica).
Insomma: il dettato dell’articolo 33 («La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale») viene pedissequamente disatteso punto per punto. Non un capitolo, ma un’enciclopedia a sé, meriterebbe il comma riguardante le Università dove l’illegalità è arrivata a livelli talmente radicati e diffusi da risultare fisiologica. Alcuni atenei, come il messinese, sono stati teatri di assassini di docenti come esito di dissensi su manovre clientelari [12]. Giambattista Sciré ha fondato un vero e proprio movimento per tentare di contrastare, in Sicilia all’inizio e poi nell’intera Penisola, questo regime di corruzione sistemica (cfr. www.trasparenzamerito.org ).
Ma almeno i mafiosi rispettano l’articolo 34 («La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi»)? Con i propri figli, senz’altro (e anzi assicurano ad essi le scuole, soprattutto private, più esclusive). Non altrettanto con i figli degli altri: quando anni fa, nell’ambito di un centro sociale auto-gestito nel quartiere palermitano Ballarò, una signora (dottoressa in medicina) si avvicinò a due ragazzini per convincerli a frequentare la scuola elementare, ricevette dopo pochi giorni la visita di un individuo che, con modi molto cortesi ma altrettanto decisi, la pregò: “Se vi portiamo i ragazzini al centro sociale, siamo contenti che li accogliate. Ma se altri ragazzini ci servono, fatevi i fatti vostri”.
Il sistema di dominio mafioso impedisce l’esercizio dei diritti economici
L’articolo 35 proclama solennemente che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». La mafia fa esattamente l’opposto. Una delle sue manifestazioni più eclatanti e più dannose – se non delle più gravi nel lungo periodo – è il condizionamento delle attività imprenditoriali e delle prestazioni di lavoro dipendente. Chiede il ‘pizzo’, impone assunzioni nel settore privato e interferisce, in una logica clientelare, nei meccanismi di selezione del personale nel settore pubblico.
Ovviamente chi è stato assunto da imprese mafiose o para-mafiose o filo-mafiose non può neppure lontanamente ipotizzare la rivendicazione dei diritti previsti dagli articoli 36 («il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi») e 37 («la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione»). C’è da precisare che il sistema di dominio mafioso non è l’unico a disattendere questi diritti dei lavoratori: ormai il lavoro in nero, specialmente nell’Italia centro-meridionale, costituisce una pratica diffusa anche tra imprenditori non sistematicamente vicini ai mafiosi.
Altrettanto si può ribadire per quanto riguarda gli articoli 39 (il cui primo comma recita: «L’organizzazione sindacale è libera») e 40 («Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano»). In altri periodi la mafia si scomodava anche per vietare, o comunque ridurre, questi diritti: da qualche tempo non è più necessario. Perdita di credibilità dei sindacati e calo della coscienza socio-politica dei lavoratori hanno reso superflui gli interventi intimidatori e ricattatori.
Gli articoli 41 (comma 1: «L’iniziativa economica privata è libera») e 42 («La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti») sono, ovviamente, altrettanto disattesi da associazioni criminali (e complici vari) che riconoscono il diritto di proprietà esclusivamente ai propri sodali, alterano il gioco dell’offerta e della domanda nel libero mercato e usano dei beni economici dello Stato come fossero privati.
Quanto i mafiosi abbiano contribuito alla «trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive», agevolando «la piccola e la media proprietà» (art. 44) lo attestano, alla fine dell’Ottocento, il contributo dei gabelloti al soldo degli agrari nella repressione dei “Fasci siciliani” e – negli anni immediatamente successivi alla proclamazione della Repubblica italiana – gli omicidi ‘politici’ di sindacalisti siciliani e le stragi come quella del 1 maggio 1947 a Portella della Ginestra.
L’articolo 47, secondo cui la Repubblica «disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito», escluderebbe – a garanzia dei cittadini – le cosche mafiose da un ambito in cui sono particolarmente attive: sia condizionando i criteri delle banche (sin dai tempi dell’omicidio Emanuele Notarbartolo del 1893 propense a prestare denaro a chi è potente, anche se poco affidabile, e a negarlo a chi ne ha più bisogno) sia esercitando direttamente, al di fuori dai circuiti bancari, il prestito a interessi usurari.
Il sistema di dominio mafioso impedisce l’esercizio dei diritti politici
Secondo il comma 2 dell’articolo 48 «il voto è personale ed eguale, libero e segreto». Sappiamo quanto le mafie condizionino questo diritto di cittadinanza sia con modalità intimidatorie sia (più frequentemente) mediante o elargizioni immediate di ricompense materiali o promesse (più o meno illusorie) di favori futuri. Ed è proprio attraverso il condizionamento del voto popolare che il sistema di dominio mafioso lede il diritto dei cittadini – esterni ed estranei alla sua sfera d’influenza – a candidarsi, nelle «condizioni di eguaglianza» (previste dall’articolo 51), «alle cariche elettive».
L’articolo 53 stabilisce che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita` contributiva», ma le cifre da capogiro delle evasioni e delle elusioni fiscali attribuibili a privati ed imprese di area mafiosa documentano quanto questo obbligo venga disatteso da certi settori imponendo a Parlamento e Governo la scelta fra tagliare sulla spesa sociale (a danno dei diritti elementari dei cittadini più indigenti) o aumentare il carico tributario dei cittadini onesti (scoraggiando l’avvio o il mantenimento di iniziative imprenditoriali).
A conclusione di queste troppo sintetiche note, mi permetterei un suggerimento: non rispondiamo più alla domanda se la mafia è ancora forte in base, esclusivamente, alle relazioni dei magistrati in apertura degli anni giudiziari o alle pubblicazioni scientifiche dei professori universitari (in questi decenni, infatti, molti di loro non sono stati in grado di rispondervi adeguatamente perché non si sono accorti – o hanno fatto finta di non accorgersi – di essere appollaiati sull’albero criminoso che sostenevano di non vedere). Chiediamoci, piuttosto, quanto siamo liberi come cittadini di una Repubblica democratica: misurando le limitazioni all’esercizio dei nostri diritti elementari di cittadinanza (per molti versi coincidenti con i diritti dell’uomo), potremo evincere la persistenza di una dittatura militare, ma anche culturale, politica, economica e pedagogica. Dittatura che sembra aver raggiunto l’obiettivo più ambizioso: convincere i cittadini che essa sia inevitabile e, perciò, velleitario ogni tentativo di scardinarla.
Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio 2021
Note
[1] N. Amadore, La zona grigia. Professionisti al servizio della mafia, La Zisa, Palermo 2007.
[2] L. Sciascia, Il contesto. Una parodia, Adelphi, Milano 2006.
[3] U. Santino, Breve storia della mafia e dell’antimafia, Di Girolamo, Trapani 2011 (2° ed.): 29 – 30.
[4] G. Di Girolamo, Cosa Grigia. Una nuova mafia invisibile all’assalto dell’Italia, Il Saggiatore, Milano 2012: 19- 20.
[5] Cfr. U. Santino, La borghesia mafiosa. Materiali di un percorso d’analisi, Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, Palermo 1994.
[6] G. Di Girolamo, Cosa Grigia, cit.: 22. Con onestà intellettuale Di Girolamo stesso ricorda, poco dopo, la «mafia in guanti gialli» di Gaetano Mosca e le persone, «in ogni segmento professionale», legati ai killer da «intrecci inconfessabili e continuità compiacenti», di cui parlava Pietro Grasso da procuratore nazionale antimafia.
[7] Ivi:21.
[8] Ivi: 25.
[9] U. Santino, Breve storia, cit.: 51.
[10] Cfr. D. Fadda, L’inchino del patrono al padrino. Santi, processioni e mafiosi nel Meridione italiano, Di Girolamo, Trapani 2021 (in fase di stampa).
[11] Cfr. Fascista no, mafioso sì in A. Cavadi, 101 storie di mafia che non ti hanno mai raccontato, Newton Compton, Roma 2014 (seconda edizione): 148-151.
[12] R. Gugliotta- G. Pensavalli, Matteo Bottari: l’omicidio che sconvolse Verminopoli, IMGpress, Messina 2007.
___________________________________________________________________________________
Augusto Cavadi, tra i pionieri della filosofia-in-pratica contemporanea, già docente presso il Liceo “G. Garibaldi” di Palermo, è fondatore della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone”. Collabora stabilmente con La Repubblica-Palermo. I suoi scritti affrontano temi relativi alla filosofia, alla pedagogia, alla politica, con particolare attenzione al fenomeno mafioso, nonché alla religione, nei suoi diversi aspetti teologici e spirituali. Tra le ultime sue pubblicazioni si segnalano: Il Dio dei mafiosi (San Paolo, 2010); La bellezza della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo, 2011); Il Dio dei leghisti (San Paolo, 2012); Mosaici di saggezze – Filosofia come nuova antichissima spiritualità (Diogene Multimedia, 2015); La mafia desnuda – L’esperienza della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone” (Di Girolamo, 2017); Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia e contro i mafiosi (Di Girolamo, 2018), Dio visto da Sud. La Sicilia crocevia di religioni e agnosticismi (SCe, 2020).
_______________________________________________________________