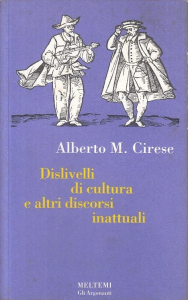di Antonello Ciccozzi
Proposito di questo scritto – volutamente prima che inevitabilmente polemico – è una breve riflessione sul valore incompreso di alcuni frammenti osceni del discorso di Mario Alberto Cirese, inerenti un tentativo prospettico – generalmente perlopiù marginalizzato e osteggiato in ogni sua forma e provenienza dal mainstream accademico – di inserire la tematica antropologica di critica antiegemonica all’Occidente in un impianto argomentativo capace di non cadere nella tentazione manichea, ormai da anni dominante, di una postura normativa contrappassistica, di demonizzazione di tutto il portato storico della “nostra” civiltà (a cui complementarmente corrisponde un engagement intellettuale sempre più intransigente di sostegno ideologico sacralizzante rivolto alla nebulosa intersezionale di diversità che all’Occidente in un modo o nell’altro si oppongono).
Se nell’ultima parte del Novecento si assiste alla piena maturazione dell’allineamento dell’antropologia italiana al tema cardine della critica postcoloniale di «messa in discussione della nozione di “civilizzazione” come storica missione attribuita alla civiltà occidentale» (Lanternari, 1997: 7), diversamente nella produzione finale di Cirese – coeva di quell’epoca e successiva al suo pensionamento accademico – emergono e si palesano segni occasionali ma rilevanti di uno sforzo di ponderare, attraverso significativi inviti alla misura, quella messa in discussione che si faceva sempre più radicale. Non a caso Cirese chiude il suo Dislivelli di cultura e altri discorsi inattuali con una presa di posizione netta rispetto alla questione della diversità culturale, della società multietnica, affermando perentoriamente che «ogni cultura e ogni identità ha uguale diritto di essere rispettata e protetta, compresa, qui da noi, la nostra» (Cirese, 1997:210).
Allo stesso modo in Il dire e il fare nelle opere dell’uomo si legge che «la società occidentale a cui apparteniamo ha avuto tra l’altro il non piccolo merito di aver scoperto l’etnocentrismo, di aver compiuto uno sforzo per sottoporre a critica i propri cardini di riferimento morali, storici, politici. Se il principio è che tutte le culture sono equivalenti, io mi domando “perché la mia no? perché la mia non va bene?”. Se ognuno ha diritto di difendere la sua cultura con tutti i mezzi di cui dispone, torno a domandarmi “perché io no?”» (Cirese, 1998: 115). In questo voler ricordare che l’Occidente ha anche qualche merito e che questi meriti sono finanche difendibili, lo scopo dell’Autore è quello dichiarato di evitare l’«abrogazione della nostra tradizione culturale, in luogo della sua rivisitazione» (ibid.: 117).
Si tratta di segni quantitativamente mimimali ma qualitativamente dirompenti, che oggi possono risultare particolarmente indigesti, soprattutto se accostati all’emergere di una postura anti-identitaria “biforcuta” per cui l’identità viene in larga parte giustamente derubricata a costrutto, fluidificata, criticata, finanche abolita. Questo però avviene prevalentemente in riferimento al Nord del mondo: viceversa, quando l’identità si riferisce a realtà e situazioni subalterne, inerenti a dislivelli interni o esterni all’Occidente egemonico, viene difesa in nome di essenzialismi strategici (Spivak, 1987), politiche del riconoscimento, di sostegno appassionato di configurazioni intersezionali. Insomma: da quando l’identità è diventata una parola di destra, per l’antropologia l’identità nostra, occidentale, è brutta cosa, mentre quella altrui va salvaguardata politicamente e celebrata esteticamente, in nome della tutela delle minoranze, della monumentalizzazione delle subalternità (Finkielkraut 2015). Abbiamo finalmente e giustamente capito che ‘identità’ è una parola pericolosa ma non capiamo che può essere pericoloso anche l’identitarismo altrui. Questo in sostanza è quello che voleva dirci Cirese.
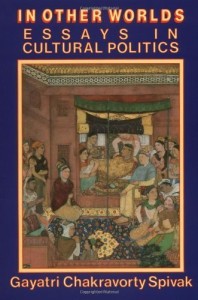 È una tematica comunque di lungo corso, già da prima ravvisabile nel posizionamento di quest’intellettuale, seppure per molto in forma carsica. D’altra parte l’umanesimo etnografico di Ernesto De Martino, subito denominato “etnocentrismo critico” da Lanternari, è lo sfondo epistemologico implicito dell’impianto antropologico di Cirese; che arriva a cercare di rivendicare una qualche paternità di quest’ultima denominazione (Cirese, 1998: 127). In ultima analisi, questa postura ermeneutica oggi in netto disuso suggerisce che l’incontro etnografico con l’altro può essere utile se non necessario per rimettere in discussione apriorismi categoriali del “noi” occidentale, un noi a cui però non si arriva a negare diritto di esistenza in nome di esotismi contrappassisticamente appoggiati su storiografie punitive che vedono nell’Occidente solo orrendi peccati coloniali da espiare, e a cui non si nega l’universalità di un portato positivo (all’opposto dell’universalità in negativo con cui la critica postcoloniale racconta unicamente il Nord del mondo).
È una tematica comunque di lungo corso, già da prima ravvisabile nel posizionamento di quest’intellettuale, seppure per molto in forma carsica. D’altra parte l’umanesimo etnografico di Ernesto De Martino, subito denominato “etnocentrismo critico” da Lanternari, è lo sfondo epistemologico implicito dell’impianto antropologico di Cirese; che arriva a cercare di rivendicare una qualche paternità di quest’ultima denominazione (Cirese, 1998: 127). In ultima analisi, questa postura ermeneutica oggi in netto disuso suggerisce che l’incontro etnografico con l’altro può essere utile se non necessario per rimettere in discussione apriorismi categoriali del “noi” occidentale, un noi a cui però non si arriva a negare diritto di esistenza in nome di esotismi contrappassisticamente appoggiati su storiografie punitive che vedono nell’Occidente solo orrendi peccati coloniali da espiare, e a cui non si nega l’universalità di un portato positivo (all’opposto dell’universalità in negativo con cui la critica postcoloniale racconta unicamente il Nord del mondo).
Il tutto si delinea sullo sfondo di un universalismo di ispirazione gramsciana (che, per esigenze rappresentazionali, la critica postcoloniale ha rimosso dal Gramsci che ha eletto ad antenato mitico), con cui, quasi fino alla caduta del muro di Berlino, si definiva un telos progressista che non aveva timore della propria aspirazione all’universalità, che non cercava fuori da sé principi ordinatori, che voleva educare, emancipare l’alterità subalterna sia dal giogo del dominio di classe che da quello dei propri arcaismi, dove la liberazione reale del “sotto” consisteva nella liberazione non solo dall’egemonia borghese ma anche dal carattere reazionario di alcuni momenti del folklore inteso come weltanschauung delle classi subalterne (Cirese, 2003: 219-223).
Siamo di fronte a un dispositivo che comprende che il negativo può venire anche dal subalterno e che anche nell’egemonico ci può essere del positivo; che non gioca su facili manicheismi in cui il “sopra”, il potere, il centro è il male e carnefice assoluto e il “sotto”, il popolo, le moltitudini, finisce, come conseguenza della complementarietà di questo dispositivo descrittivo, con il vestire panni di vittima assoluta e bene da difendere (dall’intellettuale che si erge a paladino delle minoranze). Qui invece il folklore, il “sotto”, che la demologia di Cirese interpreta attraverso Gramsci, può essere sia rivoluzionario che reazionario: i dislivelli di cultura non sono solo scavati dall’esclusivismo del “sopra” ma possono derivare anche dalla resistenza del “sotto” che rifiuta la cultura egemonica (Cirese, 1971, 1976). Viceversa, da qualche decennio l’affermazione della critica postcoloniale come paradigma dominante ha silenziosamente istituito un regime di verità accademica che ci priva proprio di questa prospettiva della tensione, della complessità, dell’ambivalenza, della contraddizione; lo fa per approdare a una semplificazione manichea che si manifesta nella santificazione del subalterno-marginale in tutte le sue forme e nella complementare demonizzazione dell’Occidente egemonico (Ciccozzi, 2014).
Oggi questi frammenti di etnocentrismo critico “radicale” dell’ultimo Cirese vengono al più visti o, ancora di più, evitati, derubricati ai margini dei convegni come scivolamenti reazionari senili. Per come ho conosciuto e frequentato di persona Cirese dal 2001 al 2011, l’anno della sua morte, egli invece li intendeva con enfasi come elementi centrali della sua visione dei dislivelli di cultura, ed era apertamente infastidito dalla parzialità che rilevava nell’engagement antropologico sempre più orientato a confondere la lotta alla xenofobia con un antietnocentrismo di maniera, esotista, xenofilo e antioccidentale. Non era cambiato Cirese, e non aveva perso il senno con l’età: aveva capito che stava cambiando il mondo, che la globalizzazione dal basso che si annunciava non era solo una marcia trionfale della diversità verso l’orizzonte del riconoscimento universale; essa recava in seno un elemento perturbante; e questo elemento era proprio il misconoscimento, il complementare disprezzo del “noi” occidentali per i quali invocava una difesa.
Aveva tutti i torti? Certo, sarà che, con il suo passato terribile, il verbo “difendere” accanto al sostantivo “Occidente” suscita pavloviane reazioni di rifiuto antirazzista; ma, viceversa, se una difesa tout court è inammissibile, vorrei capire perché non si può decostruire il portato dell’Occidente e articolarlo nella sua complessità e ambivalenza distinguendo lo sfruttamento dall’emancipazione (Ciccozzi, 2001). Davvero non è possibile ricucire la trama storica di una dialettica tra dominio e liberazione che ha segnato la modernità sia in senso di chiusura che di apertura? Non si può salvare qualcosa?
Si può mettere in guardia dal rischio che l’autocritica che l’Occidente ha intrapreso contro se stesso degeneri in un generalizzato odio di sé? Sembra di no. Oggi il tema è diventato quello dell’oicofobia, dell’odio di sé dell’Occidente; è stato subito ideologizzato, bollato come argomento da conservatori sovranisti. Oggi vige un’interdizione a praticare certe parole se non per sconfessarle, pena il sospetto di “porgere il fianco alle destre”. Così l’oicofobia è derubricata a brutto sentimento, a invenzione dell’antropofobia, definita come paura della diversità, e opposta al buon pensare dell’antropofilia, che riconosce che la diversità è ricchezza (Favole, 2015). Ma la varietà è sempre apprezzabile? La diversità è sempre ricchezza? Il problema è che la paura di porgere il fianco allo zombie del fascismo nostrano può avere l’effetto di chiudere gli occhi sui fascismi emergenti degli altri. Dal momento in cui il multiculturalismo santificato apre all’assimilazionismo altrui, la poetica dei ponti contro quella dei muri si espone paradossalmente al rischio – non calcolato ma rimosso – di lasciare che sui ponti passino costruttori di muri che vengono da fuori.
 Cirese quando richiamava la sua riflessione sul biculturalismo (Cirese, 1972), ossia sul fatto che il nostro sé si fonda sull’incorporazione variegata di elementi culturali sia locali che globali, amava ricordare che bisognerebbe imparare a stare «con i piedi nel borgo e la testa nel mondo». È proprio a proposito che andrebbe sottolineato che la contemporaneità ci pone di fronte all’eventualità della spinta assimilazionista dell’altro, del caso che tra chi approda in Occidente ci sia chi vuole mettere i piedi nel mondo mentre rimane con la testa nel borgo. Le migrazioni in fondo sono trasfigurazioni di dislivelli di cultura che da esterni diventano interni, e l’alterità nella circostanza in cui sia mossa dalla sacralizzazione della propria religione, dei propri arcaismi, dei propri tribalismi, della propria identità, può usare il multiculturalismo come cavallo di Troia per innestare sue pulsioni e progetti assimilazionisti: progetti più o meno impliciti, spontanei, irrelati, sotterranei, clandestini, che non dobbiamo necessariamente accettare senza batter ciglio in nome di malintesi sensi di tolleranza che non riconoscono la possibilità dell’intolleranza altrui.
Cirese quando richiamava la sua riflessione sul biculturalismo (Cirese, 1972), ossia sul fatto che il nostro sé si fonda sull’incorporazione variegata di elementi culturali sia locali che globali, amava ricordare che bisognerebbe imparare a stare «con i piedi nel borgo e la testa nel mondo». È proprio a proposito che andrebbe sottolineato che la contemporaneità ci pone di fronte all’eventualità della spinta assimilazionista dell’altro, del caso che tra chi approda in Occidente ci sia chi vuole mettere i piedi nel mondo mentre rimane con la testa nel borgo. Le migrazioni in fondo sono trasfigurazioni di dislivelli di cultura che da esterni diventano interni, e l’alterità nella circostanza in cui sia mossa dalla sacralizzazione della propria religione, dei propri arcaismi, dei propri tribalismi, della propria identità, può usare il multiculturalismo come cavallo di Troia per innestare sue pulsioni e progetti assimilazionisti: progetti più o meno impliciti, spontanei, irrelati, sotterranei, clandestini, che non dobbiamo necessariamente accettare senza batter ciglio in nome di malintesi sensi di tolleranza che non riconoscono la possibilità dell’intolleranza altrui.
In merito la dogmatica della diversità che arricchisce “senza se e senza ma” funziona come un imperativo categorico che ci impedisce di considerare l’eventualità per cui l’alterità possa manifestarsi in forma di estraneità ostile. Ci impedisce di riflettere sulla possibilità che il migrante, l’altro sé, colui che traghetta la sua diversità qui-da-noi, se lo fa in una postura non aperta alle negoziazioni con il suo altro da sé (cioè “noi”, i suoi stranieri), si fa agente di processi di chiusura, rifiuto, predazione. Processi che assumono forme di delitti d’onore, infibulazioni, tribunali religiosi paralleli, fondamentalismo religioso, e che facciamo uno sforzo immane per rimuovere da uno sguardo critico che sa rivolgersi solo contro il Nord del mondo. Così non vediamo che in questi casi il migrante può farsi traghettatore di un folklore reazionario che sottende il rischio di un pulviscolare e rizomatico imperialismo dal basso, che andrebbe problematizzato fuori dalle semplificazioni antropofile oggi diventate moda accademica (semplificazioni per cui seguitano a immaginare il presente in una rappresentazione mono-imperialistica, in cui il posto del dominio è assegnato solo all’Occidente, in un finalismo interpretativo assiomatico da cui tutti gli altri imperialismi emergenti nel globo sono estromessi, uscendo così immunizzati dal discorso critico e rafforzati attraverso questa complice indifferenza).
Perché considerare l’eventualità dell’estraneità ostile dell’altro? Per riabilitare poetiche e politiche sovraniste? Giammai. Si tratta di ragionare sul rischio di abdicare al sovranismo altrui in nome di un multiculturalismo ideologizzato e daltonico nel suo vedere arcobaleni ovunque ci sia esotismo, anche di fronte al nero che viene dall’altro. Si tratta di capire che se l’immigrazionismo (termine bandito dal mondo accademico in quanto usato dalle destre) è la sacralizzazione delle migrazioni come fenomeno assolutamente positivo (e la demonizzazione di qualsiasi forma di controllo delle stesse), il dogma “la diversità è ricchezza” è la cifra del rassicurazionismo immigrazionista, lo strumento ideologico con cui, derubricando a paranoia sovranista, suprematista, fascista, qualsiasi dubbio su questa entrata solenne dell’altro in Occidente, si inibisce attraverso la stigmatizzazione, qualsiasi percezione dell’eventualità dell’estraneità ostile dell’altro, aumentando così l’esposizione al rischio di subirne le conseguenze. Oggi pensare le migrazioni in termini che possano includere anche il rischio dell’Occidente è un tabù antropologico. Predichiamo di abbattere i confini ma il confine metodologico tra l’antropologia delle migrazioni e l’antropologia del rischio è un muro invalicabile che si ferma al riconoscimento del rischio del solo migrante. Il rischio del “noi” è tema associato alle destre e quindi interdetto. E se l’immaginario collettivo progressista è inibito dal vedere rischi da questa divisione meta-tribale del mondo tra sinistra e destra (da cui l’antropologia non riesce a trascendere), l’invocare difese risulta ancora più inammissibile, oltre che inattuale.
Usciti dall’abisso della Shoah e posti di fronte all’evidenza delle violenze coloniali passate e al loro estendersi al presente, abbiamo capito che la difesa generalizzata del “noi” occidentale porta inesorabilmente al suprematismo fascista, razzista. Giustissimo e sacrosanto, ma non comprendiamo che, all’opposto, la abrogazione netta, incondizionata, di qualsiasi istanza di difendibilità seppure parziale, circostanziata, particolare, può aprire al pericolo dell’odio antioccidentale, del razzismo, del fascismo, del suprematismo altrui, dell’ostilità e della predazione di nebulose di senso altre che non sono disposte a negoziare bilateralmente disarmi identitari. E questo avviene mentre l’apoteosi accademica della critica postcoloniale consegna all’altro un autoritratto a tinte fosche dell’Occidente come luogo nient’altro che degenerato, patria di sfruttatori, aguzzini, sanguisughe (Buruma, Margalit, 2004). Non capiamo che si rappresenta in tal modo un topos del male pronto per fare da capro espiatorio per tutti i mali del mondo.
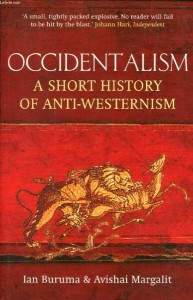 Dal momento in cui la narrazione dell’Occidente ispirata alla critica postcoloniale forclude tutto il portato positivo di emancipazione, sussumendo l’intera società (auto)accusata in una sineddoche monotetica che racconta solo in negativo sfruttamento, dominio, assoggettamento, tirannia, da questo momento si produce un’estetica antioccidentale radicale che può tragicamente trasformarsi in politica eliminatoria, come è già successo nella storia quando un gruppo umano è stato demonizzato, rappresentato come un insieme di parassiti da cui liberarsi come soluzione palingenetica per migliorare il mondo. In fondo la critica postcoloniale descrive l’Occidente in modo sinistramente simile a come i nazisti descrivevano gli ebrei, a come i serbi descrivevano i bosniaci, a come gli Hutu descrivevano i Tutsi. Credo che questo debba preoccupare.
Dal momento in cui la narrazione dell’Occidente ispirata alla critica postcoloniale forclude tutto il portato positivo di emancipazione, sussumendo l’intera società (auto)accusata in una sineddoche monotetica che racconta solo in negativo sfruttamento, dominio, assoggettamento, tirannia, da questo momento si produce un’estetica antioccidentale radicale che può tragicamente trasformarsi in politica eliminatoria, come è già successo nella storia quando un gruppo umano è stato demonizzato, rappresentato come un insieme di parassiti da cui liberarsi come soluzione palingenetica per migliorare il mondo. In fondo la critica postcoloniale descrive l’Occidente in modo sinistramente simile a come i nazisti descrivevano gli ebrei, a come i serbi descrivevano i bosniaci, a come gli Hutu descrivevano i Tutsi. Credo che questo debba preoccupare.
Questo è il rischio del blaming antioccidentale, della colpevolizzazione assoluta del Nord del mondo ispirata dalla critica postcoloniale e per questo penso che le osservazioni di Cirese siano un invito alla prudenza meno reazionario di quello che si è voluto intendere: esse rivelano un gesto razionale di bilanciamento di certe pulsioni manichee e archetipiche di inversione rituale, di idealizzare la rivoluzione come rovesciamento totale, assoluto, generalizzato dell’ordine costituito. Pulsioni che non comprendono che all’opposto del male non c’è il suo contrario, il bene, ma il rischio di incontrare il male dell’altro non solo come sua sofferenza (non sempre e necessariamente causata solo da noi) ma anche come sua volontà predatoria di potenza (Ciccozzi, 2008).
Indubbiamente, queste righe sono piene di “noi” e “altri”, e ancor più indubbiamente sarebbe bello giungere a un futuro in cui simili opposizioni saranno fenomenicamente dissolte, ma vivere nel noumenico postulato di questa liquefazione propiziata come se fosse già avvenuta è una forma di incoscienza. Un conto è cantare “Immagine” di John Lennon, altro è immaginare di viverci dentro (senza contare che, peraltro, egli parlava di un mondo senza religioni tra le pre-condizioni per il suo sogno di pace cosmopolita): bisogna “abbattere i confini”, certo; ma per farlo andrebbero prima create le condizioni culturali ed economiche, vanno prima risolti i dislivelli di cultura che i confini spesso non solo sostengono ma seguono; questo al fine di evitare il rischio di sterminarci a sassate con le macerie dei muri appena abbattuti. Bisogna abbattere i confini, e capire che per farlo bene ci vuole tempo.
È questa la lezione che ho appreso dal vecchio Cirese in pensione (e tradotto in un discorso che ho svolto negli anni e che qui ho riproposto in sintesi). E mi riferisco anche all’antropologia orale e intima di quando mi riceveva nel suo appartamento romano di piazza Capri da dietro un tavolinetto rotondo con un telo verde. Venti anni fa, per diverse volte nel corso degli anni, dopo che gli portai la mia tesi di laurea sui dislivelli di cultura. Parlammo di antropologia anche quando, avendo saputo che era in punto di morte, gli andai a fare visita nella clinica dove era ricoverato. Si sollevò dal letto, si aggiustò il camicione bianco che portava e anche questa volta mi fece una lezione privata. I suoi occhi scuri erano vivi e penetranti come sempre, e come sempre l’indice alzato in aria accompagnava il suo salmodiare. Rimasi stupito nel momento in cui gli raccontai una questione teorica di antropologia del rischio su cui stavo scrivendo, il tema del “rassicurazionismo”: sorridente l’afferrò subito, mostrando anche questa volta una velocità e una cogenza impressionante. Era estremamente lucido, come sempre, ma intrappolato negli ultimi momenti che gli concedeva il suo corpo ormai vecchissimo e fragile. Quella visione mi suscitò profonda tenerezza e, nel congedarmi da lui in quella che sapevamo essere l’ultima volta, lo abbracciai commosso. Lo ringrazio ancora per il tempo che mi ha dedicato: è a partire dalla sua lezione che seguito a osservare i dislivelli di cultura.
Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio 2021
Riferimenti bibliografici
Buruma I., Margalit A., 2004, Occidentalismo. L’Occidente agli occhi dei suoi nemici, Einaudi, Torino.
Ciccozzi A., 2001, “Società globalizzata e dislivelli culturali”, in, Meridione, Sud e Nord nel mondo, anno I, n° 5, ESI, Napoli.
Ciccozzi A., 2008, Neoprimitivismo, folklore, rivoluzione: per un’antropologia della cultura antisistemica, Prefazione di Alberto Mario Cirese, Arkhè, L’Aquila.
Ciccozzi A., 2014 “Interculturalità, critica postcoloniale, immigrazionismo”, in, Humanitas, a cura di, D’Anna, G. – Santasilia, S., n°4-5, Morcelliana, Brescia.
Cirese A. M., 1971, Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale, Palumbo, Palermo.
Cirese A. M., 1972 Folklore e antropologia tra storicismo e marxismo. A cura di A.M. Cirese. Con scritti di G. Angioni, C. Bermani, G.L. Bravo, P.G. Solinas, Palumbo, Palermo.
Cirese A. M., 1976, Intellettuali, folklore, istinto di classe. Note su Verga, Deledda, Scotellaro, Gramsci, Einaudi, Torino.
Cirese A. M., 1997, Dislivelli di cultura e altri discorsi inattuali, postfazione di Pietro Clemente e Eugenio Testa, Meltemi, Roma.
Cirese A. M., 1998, Il dire e il fare nelle opere dell’uomo, Bibliotheca, Gaeta.
Cirese A. M., 2003 Tra cosmo e campanile. Ragioni etiche e identità locali, Protagon, Siena.
Favole A., 2015, Antropofobia, (aprile) http://lettura.corriere.it/debates/antropofobia/.
Finkielkraut A. 2015 L’ identità infelice, Guanda, Milano.
Lanternari V., 1997, L’«incivilimento dei barbari» identità, migrazioni e neo-razzismo, Dedalo, Bari.
Spivak, G. C., 1987, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, Methuen, New York.
________________________________________________________
Antonello Ciccozzi è professore associato di Antropologia culturale presso Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. Si è laureato con una tesi sulla teoria ciresiana dei dislivelli di cultura. S’interessa dei processi di rappresentazione sociale della diversità culturale, di causalità culturale in ambito giuridico, di antropologia del rischio, dell’abitare, delle istituzioni, della scienza, delle migrazioni. Ha svolto ricerche etnografiche nell’Appennino rurale, in contesti di marginalità giovanile urbana, in ambito post-sismico, in luoghi di lavoro precario dei migranti.
______________________________________________________________