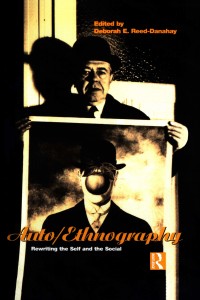Io, immigrato iraniano, vivo in Italia e vorrei raccontare la mia storia, le esperienze che ho vissuto sulla mia pelle. L’auto-etnografia è una forma di ricerca qualitativa in cui un autore usa l’auto-riflessione e la scrittura per esplorare l’esperienza aneddotica e personale e collegare questa storia autobiografica a significati e interpretazioni culturali, politiche e sociali più ampie. Essendo una forma di narrazione di se stessi, l’auto-etnografia «colloca il sé in un contesto sociale» (Reed-Danahay, 1997: 9) e mette in luce «strati multipli di coscienza, collegando il personale al culturale» (Ellis e Bochner, 2000:739). Il racconto di esperienze personali viene alternato all’analisi etnografica propriamente detta. Un aspetto interessante del testo auto-etnografico è che il discrimine che oppone l’etnografo agli «altri» diventa incerto. Mentre l’etnografia tende ad essere intesa come un metodo qualitativo nelle scienze sociali che descrive i fenomeni umani sulla base di lavoro sul campo, nell’auto-etnografia è l’autore stesso ad essere il principale partecipante/oggetto della ricerca nel processo di scrittura di storie personali e di racconti.
L’attività narrativa come risorsa culturale di formazione e trasformazione del Sé – la narrazione, intesa come attività di costruzione del significato e come risorsa semiotica per la formazione dell’identità individuale e collettiva. Rappresenta uno strumento universale di socializzazione. In quanto pratica sociale interattivamente prodotta, la narrazione assume un ruolo centrale nell’espressione, trasmissione e trasformazione culturale (Ochs, 2006:21).
Date alcune indicazioni sul significato dell’auto-etnografia, torniamo ora a me. Nell’estate del 2018, i miei genitori sono venuti a trovarmi a Palermo per fare una vacanza insieme. Abbiamo deciso di andare in Austria con il treno. Prima di attraversare il confine con l’Austria, ho comprato un caffè all’interno del bar presente sul treno. Era due euro. In seguito, al confine austriaco, è salito a bordo un gruppo di poliziotti italiani per controllare i documenti dei passeggeri. Nel nostro vagone eravamo insieme ad un gruppetto di italiani e ad un ragazzo di colore; molti passeggeri parlavano tra di loro continuamente.
 Arrivati al confine con l’Italia, è salito a bordo un gruppo di poliziotti italiani per controllare i documenti dei passeggeri. Appena hanno messo piede sul treno, improvvisamente tra i passeggeri è calato il silenzio. Ebbi, così, una strana sensazione: era come se il vagone, affollato e rumoroso, si fosse svuotato all’istante, come se fosse diventato uno spazio vuoto; il silenzio non è uno spazio vuoto, ma in questo caso era nato direttamente da noi, come una conseguenza diretta e istintiva dell’arrivo dei poliziotti. Era come se fosse stato il cuore di tutti noi a ispirarlo.
Arrivati al confine con l’Italia, è salito a bordo un gruppo di poliziotti italiani per controllare i documenti dei passeggeri. Appena hanno messo piede sul treno, improvvisamente tra i passeggeri è calato il silenzio. Ebbi, così, una strana sensazione: era come se il vagone, affollato e rumoroso, si fosse svuotato all’istante, come se fosse diventato uno spazio vuoto; il silenzio non è uno spazio vuoto, ma in questo caso era nato direttamente da noi, come una conseguenza diretta e istintiva dell’arrivo dei poliziotti. Era come se fosse stato il cuore di tutti noi a ispirarlo.
I poliziotti, in maniera educata e gentile, hanno controllato alcuni documenti dei passeggeri; dopodiché, sono passati davanti a me e ai miei genitori e hanno pensato che fossimo italiani, quindi non hanno controllato i nostri documenti. In seguito, sono andati da un ragazzo di colore, seduto accanto a noi, e hanno chiesto i documenti in maniera alquanto sgarbata. Il ragazzo non aveva con sé il documento perché il governo italiano non glieli aveva ancora procurato. I poliziotti allora lo hanno invitato a scendere dal treno.
Se vediamo la questione dal punto di vista di Goodwin, il significato di questa frase è complesso. A volte una stessa frase assume più significati: la frase “Non ho il documento”, pronunciata da quel ragazzo, non stava a significare che egli non volesse dare il documento, ma che semplicemente non lo aveva ancora a causa del governo; per il poliziotto, invece, era importante soltanto il fatto che non lo avesse, e quindi doveva scendere dal treno, come se quella frase non contemplasse altro significato che una mancanza da parte del ragazzo. Goodwin, nel suo lavoro, ha dimostrato che il significato di un enunciato può cambiare più volte mentre viene pronunciato (Goodwin, 2003:11).
Per spiegare appieno tutto questo, è necessario fare una parentesi sulla questione dell’identità. Per l’UE, avere un documento ci rende tutti uguali poiché significa avere un’identità; è il documento che ci identifica come persona. Ma, in realtà, l’identità di una persona non è data soltanto da un pezzo di carta, ma da tante altre cose.
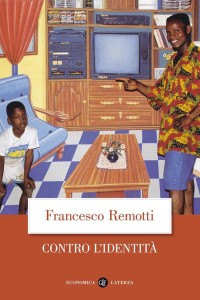 È vero, in natura, così come nella cultura, esistono forme stabili, o strutture, che pure ci attraggono: un paesaggio, un quadro, un edificio, immagini più o meno ferme, di cui l’occhio compone i vari elementi in una forma-oggetto individuale. Ma sia in natura, sia nella cultura, esistono anche i fenomeni che potremmo chiamare “di flusso”: fenomeni di mutamento incessante da cui le forme emergono e in cui sono destinate a scomparire. Il mutamento è quasi sempre collocato sullo sfondo, considerato come qualcosa di oscuro, indecifrabile, scarsamente rappresentabile. L’identità di una persona, di un “Io”, è considerata come una struttura psichica, come un “ciò che rimane” al di là del fluire delle vicende e delle circostanze, degli atteggiamenti e degli avvenimenti, e questo rimanere non è visto come una categoria residuale, bensì come il nocciolo duro, il fondamento perenne e rassicurante della vita individuale. L’identità “dipende”: dipende non solo dal nome, ma da un insieme di atteggiamenti e di scelte (tra cui quelle relative alla denominazione). Dipende – potremmo dire – da ciò che vogliamo trattenere di un fenomeno; dipende dal nostro tipo di interessi per quel fenomeno; dipende dal modo con cui intendiamo perimetrarlo, recingerlo, con bordi più larghi o più stretti. L’identità, allora, non inerisce all’essenza di un oggetto; dipende invece dalle nostre decisioni, l’identità è un fatto di decisioni (Remotti, 2001: 3).
È vero, in natura, così come nella cultura, esistono forme stabili, o strutture, che pure ci attraggono: un paesaggio, un quadro, un edificio, immagini più o meno ferme, di cui l’occhio compone i vari elementi in una forma-oggetto individuale. Ma sia in natura, sia nella cultura, esistono anche i fenomeni che potremmo chiamare “di flusso”: fenomeni di mutamento incessante da cui le forme emergono e in cui sono destinate a scomparire. Il mutamento è quasi sempre collocato sullo sfondo, considerato come qualcosa di oscuro, indecifrabile, scarsamente rappresentabile. L’identità di una persona, di un “Io”, è considerata come una struttura psichica, come un “ciò che rimane” al di là del fluire delle vicende e delle circostanze, degli atteggiamenti e degli avvenimenti, e questo rimanere non è visto come una categoria residuale, bensì come il nocciolo duro, il fondamento perenne e rassicurante della vita individuale. L’identità “dipende”: dipende non solo dal nome, ma da un insieme di atteggiamenti e di scelte (tra cui quelle relative alla denominazione). Dipende – potremmo dire – da ciò che vogliamo trattenere di un fenomeno; dipende dal nostro tipo di interessi per quel fenomeno; dipende dal modo con cui intendiamo perimetrarlo, recingerlo, con bordi più larghi o più stretti. L’identità, allora, non inerisce all’essenza di un oggetto; dipende invece dalle nostre decisioni, l’identità è un fatto di decisioni (Remotti, 2001: 3).
Torniamo adesso alla situazione che ho vissuto. Mi porgo le seguenti domande: “Perché non hanno controllato i documenti dei miei genitori, anche se siamo stranieri? Che rapporto c’è tra colore e controllo dei documenti? I poliziotti erano consapevoli o no di andare dal ragazzo di colore? Il comportamento dei poliziotti era il classico ‘guardare dall’alto verso il basso’ in segno di superiorità rispetto al ragazzo?”.
Quest’ultimo, quindi, non aveva i documenti ed è stato invitato a scendere dal vagone. Dopo qualche ora dal passaggio del confine, sono andato allo stesso bar e ho pagato lo stesso caffè ad un prezzo doppio rispetto al precedente. Questo mi ha molto scosso ed ho chiesto al barista il perché di tale comportamento. La risposta è stata: “Perché abbiamo passato il confine”. Mi pongo così un’altra domanda: un passeggero, regolare o irregolare che sia, deve pagare la dogana?
Le frontiere non sono soltanto luoghi di pregiudizio razziale ma anche e soprattutto di discriminazione sessuale e di genere. Le donne e, in misura minore, gli uomini rischiano la violenza sessuale da parte non solo dei banditi e dei contrabbandieri ma anche delle guardie frontaliere. Sui confini lo stupro è una prassi sistematica, consolidata e segue gli stessi modelli in ogni luogo del mondo. Non è infatti una strategia deterrente o punitiva, ma un «pedaggio»: chi cerca di attraversare il confine paga il diritto di accesso con il proprio corpo (Khosravi, 2019:79). Quindi, i migranti, siano essi regolari o irregolari, per passare dei confini devono pagare.
 Dopo il nostro viaggio, siamo rientrati in Italia seguendo lo stesso tragitto. Questa volta, nel nostro vagone erano presenti gruppi di persone austriache, i quali, come è noto, avevano quasi tutti la pelle bianca e i capelli biondi. Al confine con l’Italia è salito a bordo un gruppo di poliziotti austriaci per controllare i documenti dei passeggeri. Al loro arrivo sul treno, hanno incontrato gli austriaci i quali li hanno salutati (in tedesco): questo è stato per i poliziotti come un segnale ad indicare la loro cittadinanza e la loro regolarità (altrimenti non avrebbero salutato con tale disinvoltura), e quindi non hanno controllato i loro documenti. Dopodiché, si sono diretti verso me e mio padre, ed essendo noi di una carnagione più scura e con i capelli neri, ci hanno chiesto in maniera sgarbata e senza rispetto, il documento. Inoltre, nonostante avessimo presentato regolare passaporto, il poliziotto ha continuato a visionare più volte il documento, quasi a voler trovare un’irregolarità, e ha pure chiamato l’altro poliziotto per effettuare un ulteriore controllo, quasi a dover decidere se dovessimo scendere o no. A mia madre, invece, non è stato richiesto il documento, in quanto lei ha i capelli biondi e gli occhi chiarissimi come gli altri passeggeri austriaci. È stato il colore dei capelli e della pelle ad attirarli verso me e mio padre. È utile, al fine di capire meglio e di riflettere più approfonditamente, fare una comparazione con un esempio fornito da Khosravi, nel suo libro (Io sono confine 2019), racconta un fatto successo gli all’aeroporto di Bristol che gli consente di esprimere il significato di “essere confine”:
Dopo il nostro viaggio, siamo rientrati in Italia seguendo lo stesso tragitto. Questa volta, nel nostro vagone erano presenti gruppi di persone austriache, i quali, come è noto, avevano quasi tutti la pelle bianca e i capelli biondi. Al confine con l’Italia è salito a bordo un gruppo di poliziotti austriaci per controllare i documenti dei passeggeri. Al loro arrivo sul treno, hanno incontrato gli austriaci i quali li hanno salutati (in tedesco): questo è stato per i poliziotti come un segnale ad indicare la loro cittadinanza e la loro regolarità (altrimenti non avrebbero salutato con tale disinvoltura), e quindi non hanno controllato i loro documenti. Dopodiché, si sono diretti verso me e mio padre, ed essendo noi di una carnagione più scura e con i capelli neri, ci hanno chiesto in maniera sgarbata e senza rispetto, il documento. Inoltre, nonostante avessimo presentato regolare passaporto, il poliziotto ha continuato a visionare più volte il documento, quasi a voler trovare un’irregolarità, e ha pure chiamato l’altro poliziotto per effettuare un ulteriore controllo, quasi a dover decidere se dovessimo scendere o no. A mia madre, invece, non è stato richiesto il documento, in quanto lei ha i capelli biondi e gli occhi chiarissimi come gli altri passeggeri austriaci. È stato il colore dei capelli e della pelle ad attirarli verso me e mio padre. È utile, al fine di capire meglio e di riflettere più approfonditamente, fare una comparazione con un esempio fornito da Khosravi, nel suo libro (Io sono confine 2019), racconta un fatto successo gli all’aeroporto di Bristol che gli consente di esprimere il significato di “essere confine”:
«Il 18 settembre 2006 atterrai all’aeroporto di Bristol con un gruppo di colleghi dell’Università di Stoccolma. Ero co-organizzatore di un seminario sulla “migrazione irregolare in Europa” che si teneva all’interno del congresso bi-annuale dell’European Association of Social Anthropologists (EASA). Arrivati alla dogana, i miei colleghi biondi proseguirono indisturbati, mentre io fui fermato da una guardia di sicurezza. Nel bel mezzo di un corridoio angusto la guardia inscenò un mini-interrogatorio durato mezz’ora. Il mio status di cittadino svedese era evaporato davanti al discrimine razziale del confine: lì valeva la mia faccia. La guardia prima fece domande su di me: chi ero, dove avevo studiato, dove lavoravo, qual era lo scopo della mia visita a Bristol; poi mi chiese dei miei genitori: come si chiamavano, dove abitavano, che mestiere facevano [...]. Quando rifiutai di rispondere alle domande sui miei genitori la guardia minacciò di trattenermi. La nuova legge antiterrorismo le dava il diritto di mettermi in stato di fermo da nove ore a nove giorni. Non si prese neanche la briga di negarlo: “Voialtri volete ucciderci” disse. “Dovremo pur difenderci”. Inutile dire che quel “voialtri” mi metteva nel mucchio con i terroristi. A quel punto decisi di tornarmene subito in Svezia. Non può, mi informò lei: prima dovevo rispondere alle sue domande. Mi aveva messo in una condizione di immobilità paralizzante, non potevo né proseguire né tornare indietro. Ero indistinguibile dal confine. Ero il confine» (Khosravi, 2019:168-9).
Ritorniamo adesso nuovamente all’analisi della mia situazione. Il comportamento di questi poliziotti non è un comportamento da uomini di legge: sappiamo infatti che il controllo del documento è necessario per la sicurezza, ma il comportamento che i poliziotti avevano con noi, che già avevamo presentato il nostro regolare passaporto, non era per garantire la sicurezza, ma era dovuto al fatto che, siccome noi eravamo stranieri, come ricorda Sayad (2002: 35), un immigrato è anche e sempre un emigrato. Per loro non poteva esserci una perfetta correlazione fra avere il passaporto e poter passare regolarmente il confine, ma è come se ci fosse un sistema, uno spazio vuoto, un margine d’azione fra legge e documento, che si forma soltanto se non fai parte dell’UE e giustifica tali comportamenti.
Un altro paragone può tornare utile. Boochani, un rifugiato sull’isola di Manaus nella prigione di Kyriarcale, descrive così il sistema nel suo libro, Nessun amico se non le montagne (2919):
«Il Sistema Kyriarcale della prigione è architettato per produrre sofferenza. Queste celebrazioni sono una forma di resistenza che dice: “È vero che siamo stati imprigionati senza che sia stata nemmeno formulata un’accusa e siamo stati esiliati, però guardate qui, stronzi… guardate come siamo felici e allegri”. Ma si tratta del solito vecchio e semplice trucco cui ricorrono tutti gli esseri umani: sottrarsi alla paura mentendo a se stessi. La performance si svolge in modo talmente naturale che gli stessi prigionieri dimenticano che non c’è alcuna ragione logica per festeggiare [...]. È tutto collegato: la gioia, la paura, l’odio, l’invidia, la vendetta, il dispetto e persino la gentilezza» (Boochani, 2019:151-152).
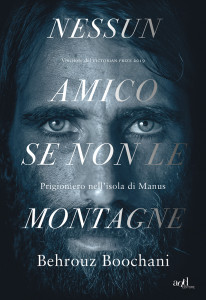 Alla fine, nonostante tutto, ci hanno lasciato andare e siamo tornati in Italia. Io in realtà non mi sento di aver fatto un viaggio perché avevo un documento. Dovuto al mio colore della pelle, però, per uno Stato sono cittadino italiano, per l’altro uno straniero. Mi sento come se fosse stato il mio corpo, la mia pelle a funzionare da confine.
Alla fine, nonostante tutto, ci hanno lasciato andare e siamo tornati in Italia. Io in realtà non mi sento di aver fatto un viaggio perché avevo un documento. Dovuto al mio colore della pelle, però, per uno Stato sono cittadino italiano, per l’altro uno straniero. Mi sento come se fosse stato il mio corpo, la mia pelle a funzionare da confine.
Penso che l’auto-etnografia sia uno strumento importante per meglio riflettere sulle questioni che ho trattato: significato dell’identità, nozione di confine, relazioni interpersonali. L’auto-etnografia non è solo un metodo di ricerca, ma anche un modo di scrittura, che collega i concetti teorici con l’esperienza vissuta nel contesto socio-politico e storico. Questa è una cosa che mi affascina dell’auto-etnografia: non ha una definizione specifica, ma per me iraniano residente in Italia, è anche una “via di fuga”.
Dal mio punto di vista, possiamo paragonare un lavoro accademico ad un’autostrada con tante vie d’uscita, tanti segnali e quindi tanti percorsi che possono essere intrapresi ma con una precisa via di inizio e di fine; l’auto-etnografia, invece, è come una strada senza inizio, senza segnali, senza indicazioni, senza regole prestabiliti: una volta che la intraprendi non sai dove arriverai e a quale conclusione giungerai.
Un lavoro che mi viene in mente per spiegare queste connessioni di cui parlo è Sonno, sogno e veglia. Quattro variazioni in chiave auto-etnografica, pubblicato in “Dialoghi Mediterranei”.
«Nel sogno, mi trovavo in un grande giardino pubblico e m’imbattevo in un grosso coccodrillo verde. Non so perché decidevo di caricarlo in auto e di portarmelo a casa. Rubavo un coccodrillo? Era questa la sensazione che avevo: di sottrarre di soppiatto qualcosa a qualcuno. A chi? Per farne che? E che posso saperne! Non ricordo di aver fatto nessuno sforzo, tra l’altro. E mi sembra così strano, adesso, da sveglio. Il coccodrillo era di notevoli dimensioni: lungo e panciuto. Eppure, lo ricordo bene, l’ho trasportato in auto senza eccessiva fatica. L’amico che era con me e mio figlio mi ha aiutato. Ma, riflettendoci, ero io che sostenevo gran parte del peso [...]. E questo lo era. Può un coccodrillo, stipato in un’auto, starsene tranquillo in attesa delle persone che lo hanno sottratto al suo ambiente naturale? No, certo che no, nella realtà! Ma può sicuramente avere luogo nell’immaginazione» (Montes, 2021).
L’auto-etnografia è come uno spazio che ti dà la possibilità di osservare la realtà da un punto di vista privilegiato, che per me è quello della persona, non del cittadino, che viene considerato “straniero” o “residente”. Quindi, l’auto-etnografia consente di esprimersi e legare insieme diverse componenti della vita.
Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022
Riferimenti bibliografici
Boochani, B., Nessun amico se non le montagne, ADD editore, Torino, 2019.
Ellis, C. Bochner, A. P., “Autoethnography, personal narrative, reflexivity; researcher as subject, in N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (eds) The handbook of qualitative research, Thousand Oaks. C.A.: Sage New York, 2000:733-68.
Goodwin, C., Il senso del vedere, Meltemi, Roma, 2003.
Khosravi, S., Io sono confine, Elèuthera, Milano, 2019 (ed. or. 2010).
Montes, S., “Sonno, sogno e veglia. Quattro variazioni in chiave auto-etnografica”, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 47, gennaio 2021.
Ochs, E., Linguaggio e cultura. Lo sviluppo delle competenze comunicative, Carocci Roma, 2006.
Reed-Danahay, D. E., Auto/ethnography, Berg., ed: routledge. New York, 1997.
Remotti, F., Contro l’identità, Laterza, Bari-Roma, 2001.
Sayad, A., La doppia assenza, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002.
_____________________________________________________________
Davoud Mohammadi, nato a Teheran, vive a Palermo, si è laureato nel 2014 in Scienze Sociali e Antropologiche presso l’Università di Teheran, con una tesi dal titolo: “Monografia classica su una città iraniana”. Nel 2020 ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Storiche, Antropologiche e Geografiche presso l’Università di Palermo, con una tesi dal titolo: “Processi migratori e contesti culturali. Una riflessione auto-etnografica”.
__________________________________________________________________________