 il centro in periferia
il centro in periferia
di Costantino Cossu
Con l’approvazione in via definitiva da parte della Camera dei deputati, avvenuta a fine luglio, dell’articolo 119 della Carta il principio di insularità è stato inserito nella Costituzione della Repubblica. Avviato alcuni anni fa con la raccolta di 200mila firme, il percorso che s’è concluso a Montecitorio ha come obiettivo dichiarato quello di compensare le difficoltà cui, secondo i promotori dell’iniziativa, vanno incontro le isole rispetto agli altri territori del Paese.
Vedremo qui, innanzitutto, che cosa prevede la riforma dell’articolo 119, per analizzare, poi, i termini del dibattito che intorno all’iniziativa si è sviluppato in Sardegna, dove tutto è nato, e avanzare, infine, alcune considerazioni di sintesi.
L’iniziativa di modifica costituzionale è partita da Roberto Frongia, presidente dei Riformatori sardi, una formazione di centro che si ricollega all’eredità politica delle correnti più moderate di quella che fu la Democrazia cristiana. Vi ha aderito un fronte trasversale che va dal centrosinistra al centrodestra. Che cosa si è riusciti a ottenere? Dopo il quinto comma dell’articolo 119, la riforma approvata dalla Camera inserisce la seguente formulazione: «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità». In sostanza, dal riconoscimento delle peculiarità insulari derivanti dalla condizione geografica si parte per indicare una previsione di effettiva parità delle isole rispetto al resto del Paese.
Nelle dichiarazioni rese alla stampa dopo l’approvazione della modifica dell’articolo 119, Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori sardi, ha così spiegato il senso dell’iniziativa: «Abbiamo introdotto in Costituzione un principio fondamentale: la Repubblica prende atto che le isole hanno un problema ineliminabile che è rappresentato dalla discontinuità territoriale. Che non è una questione di distanza, ma di discontinuità dovuta alla presenza del mare. Una condizione che ha una ripercussione sull’intero sistema produttivo. Tra gli ambiti che potranno giovarsi dell’applicazione del principio di insularità ci sono il sistema dei trasporti, quello delle infrastrutture e quello dell’energia». «Con l’inserimento del principio di insularità in Costituzione – ha specificato in un intervento sul Sole 24 Ore Romina Mura, deputata sarda del Pd e presidente della commissione Lavoro della Camera – non risolveremo tutti i problemi relativi alla condizione geografica di insularità e non libereremo tutte le potenzialità dell’essere noi isola al centro del Mediterraneo. Però introdurremo nel dibattito politico su regionalismo differenziato e specialità autonomistica (che oramai va avanti da decenni, in modo particolare dalla riforma costituzionale del 2001) un importante elemento di chiarezza.
 Nel caso della Sardegna, ma vale anche per la Sicilia, si dovrà, vista la particolare condizione di autonomia delle due isole, giocare questa carta e coniugarla con le prerogative già riconosciute in sede statutaria sia nel rapporto con lo Stato sia nella riorganizzazione territoriale interna. E sarà nel contempo un ulteriore strumento con cui il governo nazionale potrà incidere nella modifica della normativa europea in materia di aiuti di Stato e concorrenza».
Nel caso della Sardegna, ma vale anche per la Sicilia, si dovrà, vista la particolare condizione di autonomia delle due isole, giocare questa carta e coniugarla con le prerogative già riconosciute in sede statutaria sia nel rapporto con lo Stato sia nella riorganizzazione territoriale interna. E sarà nel contempo un ulteriore strumento con cui il governo nazionale potrà incidere nella modifica della normativa europea in materia di aiuti di Stato e concorrenza».
Queste dunque le motivazioni dei promotori della modifica dell’articolo 119. Motivazioni che sono al centro di un dibattito nel quale ad essere contestato è il fondamento stesso della riforma dell’articolo 119, ovvero che la disparità delle isole, e della Sardegna in particolare, abbia la sua causa in fattori meramente geografici, di «discontinuità territoriale dovuta alla presenza del mare», per usare la formulazione di Michele Cossa.
«La condizione geografica – spiega in un documento sul tema il coordinamento dei Comitati sardi per la democrazia costituzionale – di per sé non esprime alcun particolare valore o disvalore. Non è infatti l’insularità in sé che giustifica la necessità di una ridefinizione dei rapporti tra la Sardegna e lo Stato, bensì la situazione di dipendenza economica e sociale dell’isola conseguente a una disparità di rapporti politici, di potere, tra isola e Stato». Posizione ripresa, in un intervento pubblicato sulla rivista online “Il Manifesto Sardo”, da Andrìa Pili, ricercatore all’Università di Cagliari, studioso dei rapporti tra istituzioni e sottosviluppo nella storia della Sardegna: «La geografia è l’elemento chiave della nostra condizione attuale? Classifiche dei Paesi per Pil, studi su sviluppo e crescita, storia economica sembrano smentire tale tesi: conosciamo casi in cui due Stati, in uno stesso contesto geografico, si trovano in differenti condizioni di sviluppo (ad esempio Stati confinanti Usa/Messico; Nord/Sud Corea); isole che sono riuscite a divenire centri economici, malgrado la propria insularità (Gran Bretagna e Giappone), altre la cui performance è stata positiva (ad esempio Taiwan e Irlanda)». «L’inserimento della Corsica nella Costituzione francese come entità autonoma – aggiunge Pili – è una proposta dei nazionalisti còrsi, ora al governo dell’isola, al fine di garantire all’isola un’ampia forma di autonomia superando l’ordinamento territoriale attuale, entro cui le deliberazioni dell’assemblea còrsa possono essere cassate da Parigi, come avviene sistematicamente, sulle materie più importanti.
Evidente, sul piano della cultura politica, il distacco tra la proposta còrsa e quella dei Riformatori sardi e dei loro alleati: i primi chiedono maggiore potere per determinare lo sviluppo; i secondi, di fatto, vogliono il riconoscimento di un naturale handicap geografico che lo Stato dovrebbe colmare perennemente». «Il messaggio “insularista” – conclude Pili – è che il nostro sottosviluppo sia un fatto intrinseco, insuperabile. Rivendicare i nostri diritti e la nostra dignità significherebbe ottenere, con forza costituzionale, un principio di dipendenza/assistenza da parte di Roma. È necessario, dicono gli insularisti, mettere in campo tutte le azioni possibili per essere economicamente forti, perché solo questo ci permetterà davvero di autodeterminarci. Un po’ contraddittorio: il riconoscimento di una dipendenza inevitabile per natura potrebbe garantirci “forza” economica per autodeterminarci; si tratta della riedizione del principio illogico (inversione causa ed effetto) secondo cui prima dovremmo diventare ricchi e poi indipendenti».
 Argomentazioni, quelle di Pili, arricchite dall’analisi di Gianpaolo Cherchi, studioso di filosofia e ricercatore all’Università di Sassari. Nel saggio “Il problema dell’insularità” pubblicato nel volume collettaneo Filosofia de Logu: decolonizzare il pensiero sardo (edito da Meltemi e curato da Sebastiano Ghisu e da Alessandro Mongili) Cherchi evidenzia la natura storica e dialettica del concetto di insularità, che non è un fatto meramente geografico, ma ha invece un’essenziale connotazione relazionale. Si definisce cioè – nei modi di una dialettica storica mobile e conflittuale – attraverso il rapporto tra isola e continente. Un rapporto in cui, nella maggioranza dei casi, si determina uno squilibrio di potere che vede le isole in posizione di sudditanza rispetto ai propri continenti; squilibrio di potere cristallizzato in un’organizzazione dello Stato che nei suoi assetti costituzionali codifica in maniera formale la subordinazione delle isole. Ne consegue che se si vuole incidere davvero su condizioni di svantaggio ciò che occorre non è richiedere, come fanno i promotori della riforma dell’articolo 119 della Carta della Repubblica italiana, più aiuti economici, ma più potere. E ciò comporta inevitabilmente rompere gli equilibri statuali vigenti; comporta che le isole, nel loro rapporto dialettico e conflittuale con gli Stati, rivendichino e ottengano non assistenza ma autodeterminazione. «Quando l’isola – scrive Cherchi – si trova a dipendere dal continente attraverso una forma di organizzazione politica basata sulla concezione centralistica dello Sato, allora il problema dell’insularità si configura come problema dello Stato; e non potrà essere affrontato in maniera puntuale e concreta mantenendo inalterati i rapporti di potere tra isola e continente, ma soltanto ed esclusivamente attraverso una riformulazione e una riconfigurazione di questi stessi rapporti, vale a dire attraverso una riconfigurazione della forma stessa dello Stato».
Argomentazioni, quelle di Pili, arricchite dall’analisi di Gianpaolo Cherchi, studioso di filosofia e ricercatore all’Università di Sassari. Nel saggio “Il problema dell’insularità” pubblicato nel volume collettaneo Filosofia de Logu: decolonizzare il pensiero sardo (edito da Meltemi e curato da Sebastiano Ghisu e da Alessandro Mongili) Cherchi evidenzia la natura storica e dialettica del concetto di insularità, che non è un fatto meramente geografico, ma ha invece un’essenziale connotazione relazionale. Si definisce cioè – nei modi di una dialettica storica mobile e conflittuale – attraverso il rapporto tra isola e continente. Un rapporto in cui, nella maggioranza dei casi, si determina uno squilibrio di potere che vede le isole in posizione di sudditanza rispetto ai propri continenti; squilibrio di potere cristallizzato in un’organizzazione dello Stato che nei suoi assetti costituzionali codifica in maniera formale la subordinazione delle isole. Ne consegue che se si vuole incidere davvero su condizioni di svantaggio ciò che occorre non è richiedere, come fanno i promotori della riforma dell’articolo 119 della Carta della Repubblica italiana, più aiuti economici, ma più potere. E ciò comporta inevitabilmente rompere gli equilibri statuali vigenti; comporta che le isole, nel loro rapporto dialettico e conflittuale con gli Stati, rivendichino e ottengano non assistenza ma autodeterminazione. «Quando l’isola – scrive Cherchi – si trova a dipendere dal continente attraverso una forma di organizzazione politica basata sulla concezione centralistica dello Sato, allora il problema dell’insularità si configura come problema dello Stato; e non potrà essere affrontato in maniera puntuale e concreta mantenendo inalterati i rapporti di potere tra isola e continente, ma soltanto ed esclusivamente attraverso una riformulazione e una riconfigurazione di questi stessi rapporti, vale a dire attraverso una riconfigurazione della forma stessa dello Stato».
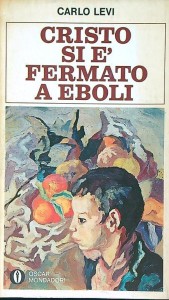 Pili e Cherchi si richiamano a correnti di analisi (gli studi postcoloniali ma anche i cultural studies) che hanno rotto il paradigma occidentalista attraverso il quale si è a lungo guardato non soltanto al mondo oltre e fuori gli orizzonti della “civilizzazione atlantica” ma anche alle realtà di subordinazione e di dominio interne a quell’universo storico. Nel sottolineare il ruolo che lo Stato ha svolto e svolge nell’instaurazione e nel mantenimento degli squilibri di potere attraverso i quali si definiscono tutte le relazioni di subordinazione, Cherchi richiama nel suo saggio anche una posizione che, già prima della rottura epistemologica postcoloniale, indicava lo Stato come attore e garante fondamentale di un equilibrio di potere segnato da relazioni di dominio. Richiama, Cherchi, il pensiero democratico radicale di Carlo Levi, che in Cristo si è fermato a Eboli scrive: «Per tutti [nella realtà lucana analizzata nel libro] lo Stato avrebbe dovuto fare qualcosa, qualcosa di molto utile, benefico e provvidenziale; e mi avevano guardato con stupore quando io avevo detto che lo Stato, come essi lo intendevano, era l’ostacolo fondamentale a che si facesse qualunque cosa». «Il problema del Meridione – aggiunge Levi – non si risolve dentro lo Stato attuale, né dentro quelli che, senza contraddirlo radicalmente, lo seguiranno. Si risolverà soltanto fuori di essi, se sapremo creare una nuova idea politica e una nuova forma di Stato, che sia anche lo Stato dei contadini». Ciò che vale, nel pensiero di Levi, per il Meridione vale per le isole. L’organizzazione centralistica dello Stato sancisce e sostiene un rapporto di dominio che può essere superato, con tutte le condizioni di svantaggio che esso comporta, soltanto superando quell’organizzazione per sostituirla con una forma nuova, che sancisca un’effettiva acquisizione di potere, di autodeterminazione, sia da parte delle classi subalterne sia da parte dei territori che, nello svolgersi di processi storici segnati da una forte dinamica conflittuale, sono stati privati di potere e conseguentemente marginalizzati (le isole e non soltanto le isole).
Pili e Cherchi si richiamano a correnti di analisi (gli studi postcoloniali ma anche i cultural studies) che hanno rotto il paradigma occidentalista attraverso il quale si è a lungo guardato non soltanto al mondo oltre e fuori gli orizzonti della “civilizzazione atlantica” ma anche alle realtà di subordinazione e di dominio interne a quell’universo storico. Nel sottolineare il ruolo che lo Stato ha svolto e svolge nell’instaurazione e nel mantenimento degli squilibri di potere attraverso i quali si definiscono tutte le relazioni di subordinazione, Cherchi richiama nel suo saggio anche una posizione che, già prima della rottura epistemologica postcoloniale, indicava lo Stato come attore e garante fondamentale di un equilibrio di potere segnato da relazioni di dominio. Richiama, Cherchi, il pensiero democratico radicale di Carlo Levi, che in Cristo si è fermato a Eboli scrive: «Per tutti [nella realtà lucana analizzata nel libro] lo Stato avrebbe dovuto fare qualcosa, qualcosa di molto utile, benefico e provvidenziale; e mi avevano guardato con stupore quando io avevo detto che lo Stato, come essi lo intendevano, era l’ostacolo fondamentale a che si facesse qualunque cosa». «Il problema del Meridione – aggiunge Levi – non si risolve dentro lo Stato attuale, né dentro quelli che, senza contraddirlo radicalmente, lo seguiranno. Si risolverà soltanto fuori di essi, se sapremo creare una nuova idea politica e una nuova forma di Stato, che sia anche lo Stato dei contadini». Ciò che vale, nel pensiero di Levi, per il Meridione vale per le isole. L’organizzazione centralistica dello Stato sancisce e sostiene un rapporto di dominio che può essere superato, con tutte le condizioni di svantaggio che esso comporta, soltanto superando quell’organizzazione per sostituirla con una forma nuova, che sancisca un’effettiva acquisizione di potere, di autodeterminazione, sia da parte delle classi subalterne sia da parte dei territori che, nello svolgersi di processi storici segnati da una forte dinamica conflittuale, sono stati privati di potere e conseguentemente marginalizzati (le isole e non soltanto le isole).
Nella posizione di Levi si sente forte l’influenza del pensiero meridionalista più avanzato. Si sente l’eco della battaglia condotta da Emilio Lussu per affermare in Costituzione un ordinamento federale dello Stato. Battaglia, come si sa, persa nel momento in cui anche a sinistra si preferì prendere la strada di un’organizzazione centralistica dello Stato, tradendo in questo modo non soltanto l’ispirazione federalista che animava, insieme con il pensiero di Lussu, tutto un filone del pensiero meridionalista, ma anche la lettura che degli stessi temi aveva dato Antonio Gramsci nelle sue “Note sulla questione meridionale”: senza una nuova forma di Stato in cui a operai e contadini fosse riconosciuto un effettivo potere di autodeterminazione, nessun superamento della condizione di subordinazione del Meridione sarebbe mai stata possibile. Quale distanza abissale ci sia tra Lussu e Gramsci (e il grande processo emancipatorio che, nella seconda parte del Novecento, ha avuto come protagonisti i movimenti anti coloniali) e i promotori della riforma dell’articolo 119 della Costituzione, è facilissimo vedere. A una prospettiva di effettiva emancipazione viene sostituita una logica assistenzialistica, quella di sempre. Una logica secondo la quale le risorse economiche messe a disposizione dallo Stato sono poi gestite nelle isole da un ceto politico locale che si fa garante del mantenimento degli equilibri di potere vigenti, ovvero della perpetuazione di una realtà di subordinazione.
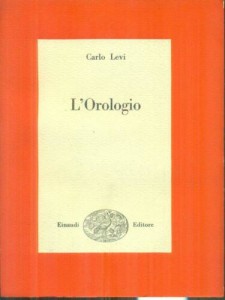 Ancora Carlo Levi, allora, e don Luigino, il podestà fascista (e maestro di scuola) di “Cristo si è fermato a Eboli”, emblema, per lo scrittore piemontese, del ceto politico e intellettuale meridionale e delle isole. “I Luigini”, chiamava Levi quel ceto assimilandolo al podestà del suo romanzo. Da L’orologio, altro testo di Levi pubblicato nel 1950 ma ancora attualissimo, citiamo: «E i Luigini, chi sono? Sono grande maggioranza della sterminata, informe, ameboide piccola borghesia, con tutte le sue specie, sottospecie e varianti, con tutte le sue miserie, i suoi complessi d’inferiorità, i suoi moralismi e immoralismi, e ambizioni sbagliate, e idolatriche paure. Sono quelli che dipendono e comandano; e amano e odiano le gerarchie, e servono e imperano. Sono la folla dei burocrati, degli statali, dei bancari, degli impiegati di concetto, dei militari, dei magistrati, degli avvocati, dei poliziotti, dei laureati, dei procaccianti, degli studenti, dei parassiti. Ecco i Luigini. Anche i preti, naturalmente, per quanto ne conosca molti che credono a quello che dicono […]. E anche gli industriali e commercianti che si reggono sui miliardi dello Stato, e anche gli operai che stanno con loro, e anche gli agrari e i contadini della stessa specie. […] Poi ci sono i politicanti, gli organizzatori di tutte le tendenze e qualità […]. I Luigini hanno lo Stato, la Chiesa, i Partiti, il linguaggio politico, l’Esercito, la Giustizia e le parole. I Contadini non hanno niente di tutto questo: non sanno neppure di esistere, di avere degli interessi comuni. Sono una grande forza che non si esprime, che non parla. Il problema è tutto qui».
Ancora Carlo Levi, allora, e don Luigino, il podestà fascista (e maestro di scuola) di “Cristo si è fermato a Eboli”, emblema, per lo scrittore piemontese, del ceto politico e intellettuale meridionale e delle isole. “I Luigini”, chiamava Levi quel ceto assimilandolo al podestà del suo romanzo. Da L’orologio, altro testo di Levi pubblicato nel 1950 ma ancora attualissimo, citiamo: «E i Luigini, chi sono? Sono grande maggioranza della sterminata, informe, ameboide piccola borghesia, con tutte le sue specie, sottospecie e varianti, con tutte le sue miserie, i suoi complessi d’inferiorità, i suoi moralismi e immoralismi, e ambizioni sbagliate, e idolatriche paure. Sono quelli che dipendono e comandano; e amano e odiano le gerarchie, e servono e imperano. Sono la folla dei burocrati, degli statali, dei bancari, degli impiegati di concetto, dei militari, dei magistrati, degli avvocati, dei poliziotti, dei laureati, dei procaccianti, degli studenti, dei parassiti. Ecco i Luigini. Anche i preti, naturalmente, per quanto ne conosca molti che credono a quello che dicono […]. E anche gli industriali e commercianti che si reggono sui miliardi dello Stato, e anche gli operai che stanno con loro, e anche gli agrari e i contadini della stessa specie. […] Poi ci sono i politicanti, gli organizzatori di tutte le tendenze e qualità […]. I Luigini hanno lo Stato, la Chiesa, i Partiti, il linguaggio politico, l’Esercito, la Giustizia e le parole. I Contadini non hanno niente di tutto questo: non sanno neppure di esistere, di avere degli interessi comuni. Sono una grande forza che non si esprime, che non parla. Il problema è tutto qui».
Sì, il problema (mutato tutto ciò che c’è da mutare rispetto alla realtà descritta da Levi) è tutto qui. Ci sono i grandi movimenti emancipatori e ci sono i Luigini. E finché il gioco lo condurranno loro, non ci sarà partita.
Dialoghi Mediterranei, n. 57, settembre 2022
______________________________________________________________
Costantino Cossu, laureato presso l’università “Carlo Bo” di Urbino (facoltà di Sociologia e Scuola di giornalismo), è giornalista professionista dal 1985, cura le pagine di Cultura del quotidiano la Nuova Sardegna. Collabora con il quotidiano Il manifesto e con la rivista “Gli Asini”. Ha scritto i libri: Sardegna, la fine dell’innocenza (Cuec, 2001), Gramsci serve ancora? (Edizioni dell’Asino, 2009). Ha curato il volume di autori vari La Sardegna al bivio (Edizioni dell’Asino, 2010) e il testo di Salvatore Mannuzzu, Giobbe (Edizioni della Torre, 2007).
_______________________________________________________________







