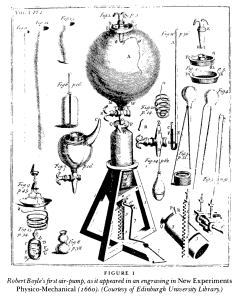On n’échappe pas de la machine
Gilles Deleuze
Premessa sul tempo e il potere
Ogni accademico dispone di due indicatori per misurare indirettamente il successo della propria carriera: la frequenza con cui si viene assillati dalle proposte dei predatory journals, e la quantità di pratiche valutative e burocratiche che inesorabilmente si accumula nella propria casella mail.
Man mano che si scala la gerarchia universitaria cala drasticamente il tempo che è possibile dedicare alla ricerca pura, sostituito non solo dalla didattica, ma da tutta una serie di attività collaterali che, in misura più o meno diretta, hanno a che fare con la “qualità” del proprio lavoro. Torna in mente quel famoso calcolo fatto da Umberto Eco sulle sue ore lavorative: «Facendo tre lezioni settimanali di due ore l’una e un pomeriggio di ricevimento studenti, l’università mi prende, per la ventina di settimane in cui si condensa l’insegnamento, 220 ore di didattica, a cui aggiungo 24 ore di esami, 12 di discussione tesi, 78 tra riunioni e consigli vari» (Eco 2016: 132). Sintomatico che nel 1992, quando questo estratto venne pubblicato la prima volta, non figurasse il tempo speso per occuparsi della produzione di documenti, griglie e indicatori riguardanti il proprio lavoro.
Oggi invece, dal dottorato in avanti, ciascuno è obbligato a confrontarsi con questo mondo parallelo: la compilazione di bandi europei o del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’h-index della propria produzione scientifica, la suddivisione identitaria dei vari settori scientifico-disciplinari, i meccanismi dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), le griglie di valutazione dei Dipartimenti, gli elenchi e le classi ANVUR delle riviste, la normativa sulla Terza missione, l’adeguamento alle nuove riforme dell’Università italiana. L’elenco potrebbe continuare, secondo l’esperienza e la pazienza di ciascuno. Se tutto ciò è quasi universalmente materia di lamentele, molto meno spesso è oggetto d’analisi precipua, il che rende ancora più apprezzabili certe riflessioni.
 Le procedure e i (possibili) cambiamenti nell’ASN, ad esempio, sono stati trattati in modo puntuale da Lia Giancristofaro nello scorso numero di Dialoghi Mediterranei (Giancristofaro 2022). Letizia Bindi, dal canto suo, ha preso in considerazione certi aspetti critici del rapporto tra istituzioni museali italiane e antropologi, intesi come professionisti DEA (Bindi 2022). Le sue riflessioni toccano molti dei punti emersi anche nei lavori della Commissione per i Beni culturali e il Patrimonio di ANPIA: in particolare lo scarso coinvolgimento in mostre, progetti e iniziative che sono prettamente antropologici nei contenuti o nelle modalità espositive; la difficoltà di rendere un’esperienza lavorativa più che un’eccezione; la mancanza di un riconoscimento della figura dell’antropologo e delle sue competenze specifiche da parte di stakeholder pubblici e privati. Si conferma, secondo Bindi, una «progressiva dismissione e invisibilizzazione delle specificità disciplinari» (Bindi 2022), che tende ad escluderci perfino da quelle tematiche di forte attualità che una parte dell’antropologia (nazionale e non) è riuscita a presidiare, rivendicando un’elaborazione originale: Antropocene, post-sviluppo sostenibile, multispecismo, ecc. Tematiche che, per inciso, stanno venendo rapidamente cooptate dalle istituzioni pubbliche e dalle aziende private sotto la spinta del Recovery Plan europeo, del PNRR e della “transizione ecologica”.
Le procedure e i (possibili) cambiamenti nell’ASN, ad esempio, sono stati trattati in modo puntuale da Lia Giancristofaro nello scorso numero di Dialoghi Mediterranei (Giancristofaro 2022). Letizia Bindi, dal canto suo, ha preso in considerazione certi aspetti critici del rapporto tra istituzioni museali italiane e antropologi, intesi come professionisti DEA (Bindi 2022). Le sue riflessioni toccano molti dei punti emersi anche nei lavori della Commissione per i Beni culturali e il Patrimonio di ANPIA: in particolare lo scarso coinvolgimento in mostre, progetti e iniziative che sono prettamente antropologici nei contenuti o nelle modalità espositive; la difficoltà di rendere un’esperienza lavorativa più che un’eccezione; la mancanza di un riconoscimento della figura dell’antropologo e delle sue competenze specifiche da parte di stakeholder pubblici e privati. Si conferma, secondo Bindi, una «progressiva dismissione e invisibilizzazione delle specificità disciplinari» (Bindi 2022), che tende ad escluderci perfino da quelle tematiche di forte attualità che una parte dell’antropologia (nazionale e non) è riuscita a presidiare, rivendicando un’elaborazione originale: Antropocene, post-sviluppo sostenibile, multispecismo, ecc. Tematiche che, per inciso, stanno venendo rapidamente cooptate dalle istituzioni pubbliche e dalle aziende private sotto la spinta del Recovery Plan europeo, del PNRR e della “transizione ecologica”.
Prima di soffermarmi sulla recente riforma della carriera universitaria, vorrei riprendere il dialogo avviato dalle due studiose per trattare brevemente alcuni aspetti della separazione tra contesto professionale e attività accademica, tra il mestiere pubblico dell’antropologo e l’antropologia come disciplina e settore scientifico-disciplinare. Le due questioni, infatti, non possono e non devono essere affrontate separatamente; certo, ciascuna pone problemi specifici, ma entrambe rimandano insieme a una debolezza costitutiva dell’antropologia in Italia. Una sua particolare espressione è quella sorta di atteggiamento bipolare per cui ciò che attiene alle nostre ricerche viene analizzato criticamente, usando tutti i dispositivi epistemologici che il nostro sapere ci fornisce; ma ciò che invece riguarda il lato quotidiano del nostro lavoro – ossia valutazioni, esami, report, ecc – viene rimosso o vissuto come qualcosa di non attinente all’antropologia perché non riguarda il nostro oggetto di ricerca primario; o anche perché, in effetti, continuare a decostruire e criticare è una pratica faticosa, e spesso non è l’ideale per fare conversazione. Ma il punto in fondo è proprio questo: che si sia a casa con la famiglia, al bar con gli amici o in vacanza col proprio cane, quei meccanismi – quel rimosso – sono sempre su di noi, come ci ricorda Deleuze in esergo. Per noi antropologi si tratta di un atteggiamento decisamente problematico, dato che a differenza dei colleghi STEM possediamo degli strumenti critici che sono integrati nella disciplina.
Tutto ciò diventa particolarmente evidente quando guardiamo al rapporto della maggior parte dell’antropologia con la sfera del potere e delle sue espressioni sociali: quando sono oggetto di studio vengono sottoposte ad attente analisi critiche, spesso accompagnate da pratiche di advocacy verso i soggetti più deboli; quando assunti nel contesto universitario sono riconosciuti e accettati obtorto collo come un elemento inevitabile della vita accademica: dai meccanismi concorsuali ai rituali bizantini delle peer review, fino alla recente riforma universitaria. Probabilmente, parte dell’insofferenza verso gli abusi e le rigidità dell’Università italiana si lega ad una certa “cratofobia” latente: un’avversione verso il potere e chi lo detiene, che come un gradiente «attraversa in varia misura la produzione scientifica e pubblicistica di molti, forse di tutti, e che dipende da un clima culturale che ha trovato progressivamente spazio in Occidente nel secondo dopoguerra in diverse tradizioni disciplinari delle scienze sociali» (Vereni 2021: 12).
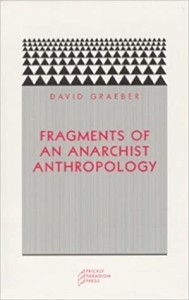 David Graeber è probabilmente l’autore che più si è scagliato contro una certa theoretically correctness nel contesto statunitense, prendendone le distanze e impegnandosi in prima persona sul versante politico. Egli si interroga – e ci interroga – su quel bipolarismo evocato poc’anzi. Non manchiamo di coerenza quando ci ergiamo a difensori dei più deboli all’interno dei contesti della ricerca – quando “facciamo” antropologia – nonostante siamo incapaci di difendere noi e la nostra disciplina dentro l’università? Lavorare in un sistema accademico di cui accettiamo le regole, pur criticandole, non è un atteggiamento ipocrita? Tuttavia anche la prospettiva anarchica di Graeber (2004), contrapposta a ogni autorità costituita e a ogni struttura gerarchica, si basa su una concezione essenzialmente cratofobica del potere.
David Graeber è probabilmente l’autore che più si è scagliato contro una certa theoretically correctness nel contesto statunitense, prendendone le distanze e impegnandosi in prima persona sul versante politico. Egli si interroga – e ci interroga – su quel bipolarismo evocato poc’anzi. Non manchiamo di coerenza quando ci ergiamo a difensori dei più deboli all’interno dei contesti della ricerca – quando “facciamo” antropologia – nonostante siamo incapaci di difendere noi e la nostra disciplina dentro l’università? Lavorare in un sistema accademico di cui accettiamo le regole, pur criticandole, non è un atteggiamento ipocrita? Tuttavia anche la prospettiva anarchica di Graeber (2004), contrapposta a ogni autorità costituita e a ogni struttura gerarchica, si basa su una concezione essenzialmente cratofobica del potere.
Lo stesso può dirsi di Mark Fisher, che come Graeber si rifà alle analisi di Jameson sul post-modernismo. Egli propone però una lettura molto più sconsolata di quella dell’antropologo americano, soffermandosi in particolare sull’ipocrisia delle narrazioni capitaliste e sulla pervasività della burocrazia (Fisher 2018). Se per Graeber un’alternativa sociale è possibile, per quanto idealizzata e insostenibile nella realtà (Vereni 2021: 20-23), per Fisher non si danno altre possibilità fuori dal realismo capitalista. Ogni narrazione, specialmente quelle critiche, sono rapidamente assunte all’interno del paradigma vigente. Anzi, esso ha tutto l’interesse a mantenere e “legittimare” questi attacchi contro sé stesso (Fisher 2018: 46-48), dando modo alle persone di protestare ed esprimere dissenso senza mettere davvero a rischio la propria (precaria) posizione sociale. Questo perché:
«Fintantoché, nel profondo dei nostri cuori, continuiamo a credere che il capitalismo è malvagio, siamo liberi di continuare a partecipare agli stessi scambi propri del capitalismo. […] crediamo che i soldi siano soltanto simboli insensati e senza alcun valore intrinseco, ma agiamo come se avessero un valore sacro» (Fisher 2018: 45-46).
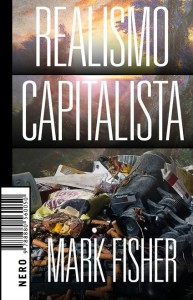 Certo, la proliferazione della burocrazia e delle pratiche valutative è una forma di disciplinamento imposto dall’alto, giustificata sulla base di criteri performativi malsani, che integra sempre di più il lavoro accademico – didattico e di ricerca – nei meccanismi auto-referenziali dell’industria culturale. E non serve leggere Graeber o Fisher per capire qualcosa di cui, come antropologi, facciamo esperienza quasi quotidianamente. Benissimo, ma detto ciò? La tendenza verso un’accentuazione di questo fenomeno è piuttosto chiara, come traspare anche dall’ultima riforma della carriera universitaria. Possiamo farci forti di questa consapevolezza, rivendicare una posizione morale superiore mentre guardiamo con rabbia, timore o cinismo l’affermarsi di queste tendenze. Ma il fatto è che continuiamo ad agire in accordo con esse, dando un consenso implicito con le nostre pratiche; consapevoli del gioco, certo, ma consapevoli anche che non ci si può permettere di infrangere palesemente le regole prima di aver raggiunto una certa sicurezza personale. Agiamo, insomma, con una buona dose di “realismo accademico”. O agiamo, a nostro rischio e pericolo, fuori dall’accademia.
Certo, la proliferazione della burocrazia e delle pratiche valutative è una forma di disciplinamento imposto dall’alto, giustificata sulla base di criteri performativi malsani, che integra sempre di più il lavoro accademico – didattico e di ricerca – nei meccanismi auto-referenziali dell’industria culturale. E non serve leggere Graeber o Fisher per capire qualcosa di cui, come antropologi, facciamo esperienza quasi quotidianamente. Benissimo, ma detto ciò? La tendenza verso un’accentuazione di questo fenomeno è piuttosto chiara, come traspare anche dall’ultima riforma della carriera universitaria. Possiamo farci forti di questa consapevolezza, rivendicare una posizione morale superiore mentre guardiamo con rabbia, timore o cinismo l’affermarsi di queste tendenze. Ma il fatto è che continuiamo ad agire in accordo con esse, dando un consenso implicito con le nostre pratiche; consapevoli del gioco, certo, ma consapevoli anche che non ci si può permettere di infrangere palesemente le regole prima di aver raggiunto una certa sicurezza personale. Agiamo, insomma, con una buona dose di “realismo accademico”. O agiamo, a nostro rischio e pericolo, fuori dall’accademia.
Tra burocrazia e professionalizzazione
«Il risultato è che, per sopravvivere, si deve imparare a dire ciò che si fa in maniera che sembri appropriato per i documenti che si devono produrre» (Zuolo 2022). Una frase che potrebbe commentare gran parte del costante lavorìo burocratico in cui sono impegnati ricercatori e docenti. Bullshit jobs, come li definiva Graeber nell’omonimo libro (Graeber 2004). Lavori di fuffa, a voler tradurre gentilmente, una parola che secondo l’etimo toscano descrive un ingarbugliamento dei fili di una matassa. E spesso si ha davvero la sensazione frustrante di trovarsi di fronte a complicazioni inutili, che nulla hanno a che fare con l’attività didattica o di ricerca. Tuttavia, e sempre di più, queste attività sono divenute oggetto di valutazione e auto-valutazione, come parte di una “modernizzazione” dell’Università italiana fondata sì su parametri e modelli internazionali, ma recepiti e adattati in modo alquanto miope (Zuolo 2022). Non uso questo aggettivo a caso: tutta questa produzione di documenti crea delle istantanee assai dettagliate di un certo Dipartimento, un certo ateneo, un certo ricercatore o progetto.
Concediamo pure il fatto che queste valutazioni siano davvero precise e aderenti al contesto cui si applicano, cosa sulla quale permangono molti dubbi. Ma anche fosse così, esse rimangono ancorate ad un presentismo e a una fattualità esasperante, rischiando d’avere la stessa utilità dei giudizi sintetici a posteriori di Kant: limitate a constatazioni di fatto, ad un impilarsi di conoscenze che, come le previsioni del tempo, non possono andare oltre l’esperienza immediata, o quasi. Sono miopi poiché non vedono granché lontano, e non possono farlo perché a monte, in quelle istituzioni che sono chiamate ad esprimere visioni specifiche e direttrici di lungo termine, queste sono palesemente assenti.
Certo, una gestione aziendale delle università e degli istituti di ricerca non richiede particolari visioni politiche per funzionare (nonostante ne sposi implicitamente alcune). Il problema è che non funzionano, e mentre assistiamo (e critichiamo) la crisi del modello manageriale capitalista, esso ci viene ostinatamente riproposto. È sorprendente come l’Università italiana abbia pienamente adottato un simile modello di gestione aziendale – di cui l’esasperazione dirigenziale e burocratica è una delle espressioni più tipiche – in un momento storico in cui è consapevolezza diffusa che quel modello sia fallace e dannoso (Fisher 2018: 98). Il settore burocratico-amministrativo è corresponsabile di questo processo, ma sarebbe fuorviante immaginare queste persone come individui compiaciuti del proprio potere, arroccati in un castello kafkiano da cui emanano ordini contraddittori per l’agrimensore di turno. Spesso le persone che lavorano nel settore amministrativo devono cercare di tradurre le direttive che giungono attraverso le leggi, il Ministero o altre fonti istituzionali, in qualcosa di comprensibile e integrabile nel meccanismo universitario in cui lavorano.
Demonizzare la burocrazia, immaginandola come un sistema malvagio e ottuso che complica la nostra vita, ci fa dimenticare che essa è il risultato del lavoro di persone che – concediamoglielo, pur con le migliori intenzioni – si trovano a dover fare da ponti tra mondi diversi: quello dell’autorità, delle scelte politiche, e quello della didattica e della ricerca. In un certo senso la burocrazia insegue su scala ridotta quel vecchio sogno illuministico di creare un linguaggio universale, razionale e auto-evidente. Lo fa attraverso moduli e categorie, regolamenti e criteri valutativi, che possano essere applicati al più ampio ventaglio possibile di persone inquadrate nel sistema universitario. Ma quando le istanze che provengono dall’autorità sono confuse e contraddittorie, quando le richieste imposte mancano di qualunque visione articolata, la burocrazia si trova nella stessa condizione di Boyle quando risucchiava l’aria con la sua pompa a vuoto: rimane con una prigione di vetro da cui tutto è stato estratto, salvo quei pensieri così volatili che solo Hobbes – con le sue categorie immateriali e il suo principio di autorità inumana – potrebbe apprezzare (Latour 2009: 30-34). Non è un caso che l’autore di Non siamo mai stati moderni (che si apre proprio col racconto di questo episodio) sia stato tra i pochissimi ricercatori sociali ad occuparsi della costruzione delle leggi e della burocrazia “d’alto livello”. Il suo studio sul Consiglio di Stato (Latour 2020), importante organo giurisdizionale francese, rimane però un’eccezione. Privilegio di uno dei più grandi intellettuali della nostra epoca, si dirà. Eppure, si tratta di un’operazione quanto mai necessaria:
«L’antropologia che io pratico, quella che ha lo scopo di studiare le forme moderne di produzione di verità, non poteva ignorare coloro i quali producono il diritto. Così come ha dovuto rinnovare la descrizione delle scienze, delle tecniche, della religione e dell’economia, allo stesso modo dovrà giungere a modificare le modalità di descrizione della forza dei legami giuridici» (Latour 2020: 293-294).
 E, aggiungiamo noi, dei vincoli burocratici. Del resto, se prendiamo sul serio l’immagine di questi impiegati come costruttori di linguaggi in bilico tra differenti mondi sociali, come antropologi non possiamo fare a meno di riconoscere una certa “familiarità”. Di fatto, la proliferazione delle procedure valutative ha obbligato molti ad apprendere un linguaggio sempre più utilizzato, guadagnando una discreta dimestichezza nella compilazione di bandi europei, progetti interdipartimentali, proposte di PRIN, ecc. Non è invece pensabile il movimento opposto, con un trasferimento di conoscenze e competenze dal “basso” verso il settore amministrativo. Per quanto auspicabile, una simile “personalizzazione” del regime burocratico è totalmente incompatibile con l’approccio top-down della gestione manageriale. Il fatto che la compilazione di documenti sia affidata al singolo non garantisce né una comprensione maggiore del sistema organizzativo, né un controllo più elevato sull’uso dei dati che produce. E tuttavia, è proprio questa produzione che influenza l’assegnazione di fondi e risorse economiche alle università e ai vari dipartimenti. Abbiamo a che fare con un sistema necessariamente rigido, che deve poter essere calato su ciascuna realtà universitaria italiana in modo “oggettivo”, senza adattamenti di sorta che andrebbero a contraddire il principio fondante della burocrazia: la sua pervasività.
E, aggiungiamo noi, dei vincoli burocratici. Del resto, se prendiamo sul serio l’immagine di questi impiegati come costruttori di linguaggi in bilico tra differenti mondi sociali, come antropologi non possiamo fare a meno di riconoscere una certa “familiarità”. Di fatto, la proliferazione delle procedure valutative ha obbligato molti ad apprendere un linguaggio sempre più utilizzato, guadagnando una discreta dimestichezza nella compilazione di bandi europei, progetti interdipartimentali, proposte di PRIN, ecc. Non è invece pensabile il movimento opposto, con un trasferimento di conoscenze e competenze dal “basso” verso il settore amministrativo. Per quanto auspicabile, una simile “personalizzazione” del regime burocratico è totalmente incompatibile con l’approccio top-down della gestione manageriale. Il fatto che la compilazione di documenti sia affidata al singolo non garantisce né una comprensione maggiore del sistema organizzativo, né un controllo più elevato sull’uso dei dati che produce. E tuttavia, è proprio questa produzione che influenza l’assegnazione di fondi e risorse economiche alle università e ai vari dipartimenti. Abbiamo a che fare con un sistema necessariamente rigido, che deve poter essere calato su ciascuna realtà universitaria italiana in modo “oggettivo”, senza adattamenti di sorta che andrebbero a contraddire il principio fondante della burocrazia: la sua pervasività.
In questo senso, la recente riforma universitaria è un’ottima dimostrazione del rasoio di Hanlon: nata sotto i migliori auspici, con l’intento di semplificare la carriera post-dottorale e ridurre la precarietà nel settore accademico, promette di fare l’esatto opposto. O meglio, con una di quelle visioni tipicamente miopi di tanta parte della burocrazia, prevede di eliminare il precariato eliminando i precari. Non, fortunatamente, con soluzioni swiftiane di cattivo gusto (nonostante la riforma si atteggi a ben più di una modest proposal), ma semplicemente non garantendo fondi economici specifici per attuare appieno la riforma stessa. In sostanza, l’articolo 14 del Decreto Legge n.36 del 30 aprile 2022 (facente parte del cosiddetto PNRR 2) elimina gli assegni di ricerca introducendo la nuova figura del contrattista, vincolato a progetti specifici di durata biennale e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni. L’importo percepito sarà deciso sulla base di una contrattazione nazionale, mentre la partecipazione al concorso è vincolata al requisito di dottore di ricerca. Di fatto, si cancellano tutte quelle figure intermedie e quelle borse a progetto a favore di un’unica figura post-dottorale. Tuttavia, si vincolano anche le università a “bloccare” per almeno due anni una cifra minima di 80 mila, dato che l’annualità del contratto sarà di circa 40 mila, ma senza le facilitazioni fiscali dell’assegno di ricerca e con un netto percepito non così rilevante. Senza fondi dedicati, i dipartimenti dovranno giocoforza ridurre il numero di questi nuovi contratti, escludendo molti di quelli che attualmente godono di un assegno o di piccole borse a progetto.
Tralasciando gli effetti nefasti sulle dinamiche, già di per sé malsane, di competizione per questi nuovi posti da contrattista di ricerca, la conseguenza immediata sarà un aumento della precarietà post-laurea, con tutte quelle forme di auto-disciplinamento e sfruttamento che il periodo pandemico aveva già contribuito a cronicizzare. L’alternativa per chi rimane fuori sono i contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro.) ancora permessi dalla riforma, che andranno a ingrossare una riserva di lavoratori accademici sempre in attesa, speranzosi che il prossimo concorso sia “quello giusto”. Parimenti, la riforma ha creato la figura del ricercatore unico a tempo determinato (massimo sei anni), fondendo gli attuali RtdA e RtdB. Lo scatto di carriera al ruolo di professore associato può avvenire dietro richiesta del ricercatore e tramite valutazione interna all’università. Qui la questione non è più tanto economica, ma sulle logiche di fidelizzazione sottese a questo percorso, che sostanzialmente tende a conservare le strutture di potere interne agli atenei. C’è un evidente problema di auto-referenzialità che attraversa la legge e che, almeno in questo caso, è in perfetto accordo con il contesto universitario italiano.
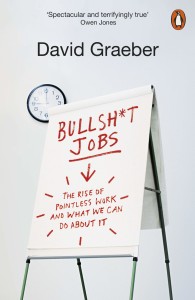 Ma anche aumentando i fondi a disposizione dei Dipartimenti, anche se venisse davvero riformato il sistema concorsuale con l’adozione di algoritmi impossibilmente “oggettivi”, la questione di fondo rimarrebbe inalterata. Fintanto che una borsa di dottorato o un assegno di ricerca semestrale saranno l’unica alternativa economica concreta al precariato perenne, ogni riforma universitaria è destinata a fallire. Per questo motivo è necessario insistere sulla professionalizzazione dell’antropologia, per creare (1) riconoscimento pubblico nella società civile, (2) maggior potere di contrattazione con istituzioni e aziende, e soprattutto (3) uno spazio lavorativo extra-accademico altrettanto valido, che dreni il precariato post-laurea. Questi tre punti sono in un certo senso solidali tra loro, e vanno di pari passo con un percorso di inquadramento istituzionale della professione su cui ANPIA lavora già da alcuni anni. Chiaramente si tratta di un processo lungo, che non produrrà effetti davvero significativi prima di un decennio, e che rischia costantemente di essere ostacolato da interessi corporativistici e rivalità interne. Personalmente non vedo scorciatoie, né credo che interventi ex machina del Ministero di turno o ex cathedra del singolo intellettuale di spicco possano essere davvero risolutivi.
Ma anche aumentando i fondi a disposizione dei Dipartimenti, anche se venisse davvero riformato il sistema concorsuale con l’adozione di algoritmi impossibilmente “oggettivi”, la questione di fondo rimarrebbe inalterata. Fintanto che una borsa di dottorato o un assegno di ricerca semestrale saranno l’unica alternativa economica concreta al precariato perenne, ogni riforma universitaria è destinata a fallire. Per questo motivo è necessario insistere sulla professionalizzazione dell’antropologia, per creare (1) riconoscimento pubblico nella società civile, (2) maggior potere di contrattazione con istituzioni e aziende, e soprattutto (3) uno spazio lavorativo extra-accademico altrettanto valido, che dreni il precariato post-laurea. Questi tre punti sono in un certo senso solidali tra loro, e vanno di pari passo con un percorso di inquadramento istituzionale della professione su cui ANPIA lavora già da alcuni anni. Chiaramente si tratta di un processo lungo, che non produrrà effetti davvero significativi prima di un decennio, e che rischia costantemente di essere ostacolato da interessi corporativistici e rivalità interne. Personalmente non vedo scorciatoie, né credo che interventi ex machina del Ministero di turno o ex cathedra del singolo intellettuale di spicco possano essere davvero risolutivi.
La speranza di una palingenesi, di un sovvertimento del sistema accademico in cui viviamo e lavoriamo rimane, per l’appunto, una speranza. Chi pretende di cambiare isolatamente un settore così specifico della nostra società com’è quello accademico dimostra di non capire affatto le molteplici connessioni tra mercato del lavoro, industria della cultura e ricerca scientifica. Tutto quello che è possibile fare oggi, allo stato dei fatti e tenendo conto del peso assolutamente marginale che l’antropologia possiede nel contesto accademico italiano e nei confronti delle istituzioni nazionali (siano esse politiche come il Ministero dell’istruzione o scientifiche come il CNR o l’ANVUR) è innescare cambiamenti minimi, marginali e probabilmente temporanei. Certo, questi cambiamenti possono essere l’occasione per trasformazioni più ampie, così come certe attività di ricerca possono creare dei precedenti per nuove forme di contrattualizzazione o riconoscimento pubblico.
Più probabilmente, tutto ciò rimarrà a quello stadio potenziale, bloccato dai corporativismi, dagli interessi dei singoli atenei e dalle logiche competitive che alimentano la carriera. In questo senso il realismo accademico è un atteggiamento essenzialmente conservatore, che tollera variazioni minime. Eppure, rimangono degli spazi di manovra. Per Latour, il diritto è «più vuoto di un merletto, [...] costituito al 99,99% di buchi» (Latour 2020: 296); questo vale anche nel caso della burocrazia accademica: per quanto rigida – e proprio perché così rigida – non sarà mai del tutto impermeabile a errori, scappatoie e spiragli in cui l’elemento umano può fare breccia. Ma anche se sarebbe bello consolarci con questa prospettiva, come antropologi non ci è concessa alcuna facile idealizzazione: è solo con il nostro agire che decideremo se queste brecce saranno occasioni per una convivenza migliore, o l’ennesimo spazio dove riaffermare le regole di un gioco spietato.
Dialoghi Mediterranei, n. 58, novembre 2022
Riferimenti bibliografici
Bindi, Letizia, 2022, “Oleg sulla tavola del vernissage. Nuove collezioni, mercato delle culture e sistemi esperti nella ri-progettazione culturale del MUCIV”, Dialoghi Mediterranei 57, settembre 2022, https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/oleg-sulla-tavola-del-vernissage-nuove-collezioni-mercato-delle-culture-e-sistemi-esperti-nella-ri-progettazione-culturale-del-muciv/ [controllato 22/09/22].
Eco, Umberto, 2016, Come viaggiare con un salmone, Milano: La Nave di Teseo.
Fisher, Mark, 2018, Realismo capitalista, Roma: NERO.
Giancristofaro, Lia, 2022, “La valutazione interna dei demo-etno-antropologi tra corporativismi e forze centrifughe”, Dialoghi Mediterranei 57, settembre 2022, https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-valutazione-interna-dei-demo-etno-antropologi-tra-corporativismi-e-forze-centrifughe/ [controllato 22/09/22].
Graeber, David, 2004, Fragments of an Anarchist Anthropology, Chicago: Prickly Paradigm Press.
Graeber, David, 2018, Bullshit jobs, Milano: Garzanti.
Latour, Bruno, 2009, Non siamo mai stati moderni, Milano: Elèuthera
Latour, Bruno, 2020, La fabbrica del diritto. Etnografia del Consiglio di Stato, Varazze: PM edizioni.
Vereni, Piero, 2021, “Arcana imperii e le semplificazioni radicali del reale. Una introduzione”, Rivista di Antropologia Contemporanea 1: 9-34.
Zuolo, Federico, 2022, “«Bullshit jobs» in università: un’autodenuncia”, Valigia Blu, 10 giugno 2022, https://www.valigiablu.it/burocrazia-universita/ [controllato 22/09/22].
______________________________________________________________
Nicola Martellozzo, dottorando presso la Scuola di Scienze Umane e Sociali (Università di Torino), negli ultimi due anni ha partecipato come relatore ai principali convegni nazionali di settore (SIAM 2018; SIAC 2018, 2019; SIAA-ANPIA 2018). Con l’associazione Officina Mentis conduce un ciclo di seminari su Ernesto de Martino in collaborazione con l’Università di Bologna. Ha condotto periodi di ricerca etnografica nel Sud e Centro Italia, e continua tuttora una ricerca pluriennale sulle “Corse a vuoto” di Ronciglione (VT). Ha pubblicato recentemente la monografia Traduzioni del potere, Quaderni di “Dialoghi Mediterranei” n. 2, Cisu editore (2022).
______________________________________________________________