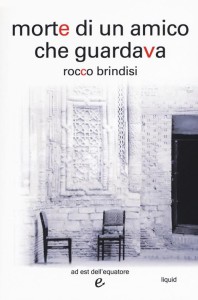«Quando penso al dialetto, penso ai silenzi, alla voce, al corpo, all’infanzia di mia madre. Mia madre mi prendeva in giro per il fatto che “mi stancavo a pensare alle poesie”». Così Rocco Brindisi nella sua Nota dell’autore introduttiva all’ultimo suo libro di poesie, Morte de nu fra che uardava.
Rocco Brindisi, nato a San Cataldo (PZ) nel 1944, poeta che sta davanti a una finestra, o dietro a una porta se si preferisce, e scrive come creando fiabe, incantamenti, sogni, trascrizioni da una lingua d’altrove (legata a doppio filo alla lingua materna), racconti formidabili e segreti, in umana e letteraria corrispondenza con un altro straordinario autore di racconti, Giorgio Messori.
L’esordio poetico di Rocco Brindisi risale al 1984: due suoi poemetti, Lucia che non ama il mare (1976-79) e Mia madre, Miskin e la neve (1980) sono inseriti nel volume collettaneo pubblicato da Einaudi Nuovi poeti italiani 3 a cura di Walter Siti. È un esordio in lingua, un “italiano” che ha già tutti i caratteri dei dialetti di San Cataldo e di Potenza e che caratterizzerà la raccolta successiva, Rosa du Pruatorie. È la lingua dell’infanzia – radice profonda e salda – la lingua della madre, quella che Rocco adopera in Lucia che non ama il mare per parlare di una donna, di un’amata: «tu Madre della Lingua / comare di San Giovanni del Palato / e del Prurito degli Angeli / stendemmo una coperta sul pavimento / cominciammo a beccarci come due uccelli». La lingua della madre è il senso col quale Rocco osserva il mondo, una parlata fatta spesso di gesti, silenzi d’amore: «si staccava l’amore dai tuoi silenzi e impazziva / tra le mie gambe».
 Spesso è il non detto, la stasi tra sistole e diastole o lo spazio vuoto il luogo di elezione della poesia di Rocco Brindisi, che dice ma non pretende di concludere con le parole, che suggerisce però il dispiegarsi improvviso di una rivelazione: «la tua lingua oscillava tra la neve e Dio / m’invitavi a ballare strizzando l’occhio / ma ero così felice di guardarti / bambino che invitato a creare il mondo / si accontenta di essere il primo ad essere / sognato dalla luce / scendevi dalle montagne di Dio per appartenere / soltanto alla tua bellezza». È questo il corpo femminile, un corpo che balla, che mangia, che ama; un corpo che è parola quotidiana, “bassa” ma con punte di verticalità improvvisa (gli angeli sempre presenti nelle opere di Rocco)[1]; un corpo di donna inserito in un lessico che danza tra dialetto e lingua italiana, un lessico così intimamente legato ai bisogni primari, agli organi genitali, ai luoghi del margine che Antonio Devicienti definisce “territori del rimosso”. A questi anfratti bui appartiene il senso religioso della poesia di Brindisi, una religiosità carnale, panica, una coralità di voci, di riti che ci rimandano ai paesi, a questi luoghi abbandonati per definizione eppure così carichi di storie, di miti e memoriali scritti sugli stipi delle case, sulle pietre.
Spesso è il non detto, la stasi tra sistole e diastole o lo spazio vuoto il luogo di elezione della poesia di Rocco Brindisi, che dice ma non pretende di concludere con le parole, che suggerisce però il dispiegarsi improvviso di una rivelazione: «la tua lingua oscillava tra la neve e Dio / m’invitavi a ballare strizzando l’occhio / ma ero così felice di guardarti / bambino che invitato a creare il mondo / si accontenta di essere il primo ad essere / sognato dalla luce / scendevi dalle montagne di Dio per appartenere / soltanto alla tua bellezza». È questo il corpo femminile, un corpo che balla, che mangia, che ama; un corpo che è parola quotidiana, “bassa” ma con punte di verticalità improvvisa (gli angeli sempre presenti nelle opere di Rocco)[1]; un corpo di donna inserito in un lessico che danza tra dialetto e lingua italiana, un lessico così intimamente legato ai bisogni primari, agli organi genitali, ai luoghi del margine che Antonio Devicienti definisce “territori del rimosso”. A questi anfratti bui appartiene il senso religioso della poesia di Brindisi, una religiosità carnale, panica, una coralità di voci, di riti che ci rimandano ai paesi, a questi luoghi abbandonati per definizione eppure così carichi di storie, di miti e memoriali scritti sugli stipi delle case, sulle pietre.
In Mia madre, Miskin e la neve Rocco dialoga con la madre morta: i morti e la morte evocati dal poeta tornano a vivere nel dialogo che solo la poesia può intessere con le assenze, con gli assenti: «poi mi venne vicino e mi strinse con forza la testa sul petto / prima di morire, in ospedale, aveva fatto lo stesso gesto / era stesa sulla barella e la stavano portando di sopra // mi aveva spinto la testa sulla sua pancia / sorridendo con la sua piccola bocca di uccellino rosa / mi aveva spettinato i capelli con la mano per farmi sentire / che stava giocando / e invece stava morendo». Tenerezza e tragedia si compendiano, vita e morte si scambiano, la pancia che ha generato è luogo dell’addio: «Forse era venuta a chiedermi di non morire così presto / lei che continuava a vivere solo grazie al mio potere di creare sempre nuove metafore del suo corpo». La madre è la lingua orale, il racconto, la fiaba: a Rocco il compito di trasformare in scrittura, in pagina, le storie ascoltate, quasi un testamento che la madre lascia al figlio scrittore: sono le donne che raccontano, che del tempo che passa fanno storia e memoria.
Come scrive Manuel Cohen, «Tutta l’opera in versi di Brindisi è segnata come uno stigma, come un ossesso, dal fitto dialogo instaurato con la madre, meglio: con la memoria della madre che si carica di significati ancestrali e tocca gli aspetti domestici, si fa emblema di una intera genealogia familiare femminile» [2].
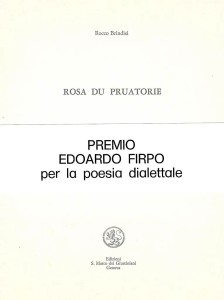 In Rosa du Pruatorie (1986, libro vincitore del premio “Luigi Firpo” per la poesia dialettale) Rocco Brindisi sceglie definitivamente la parlata necessaria al suo dire poetico: un miscuglio di dialetto di san Cataldo e di Potenza. Bene dice Antonio Porta nella prefazione a questo libro definendo la poesia in dialetto ormai perfettamente apparentabile alla presunta nobiltà di quella in lingua nazionale: il dialetto, infatti, è in Rocco Brindisi come in altri grandi poeti che scrivono nella lingua madre non già rifugio elitario, fuga per trovare un angulus separato dal mondo e dalla storia, ma operazione onesta, virtuosa connessione tra parole e cose. Scrivere in dialetto vale così emancipazione dalla pretesa ingenuità che ci si aspetterebbe romanticamente da un poeta vernacolo a favore di un verso meditato, complesso, ricco di evocazioni.
In Rosa du Pruatorie (1986, libro vincitore del premio “Luigi Firpo” per la poesia dialettale) Rocco Brindisi sceglie definitivamente la parlata necessaria al suo dire poetico: un miscuglio di dialetto di san Cataldo e di Potenza. Bene dice Antonio Porta nella prefazione a questo libro definendo la poesia in dialetto ormai perfettamente apparentabile alla presunta nobiltà di quella in lingua nazionale: il dialetto, infatti, è in Rocco Brindisi come in altri grandi poeti che scrivono nella lingua madre non già rifugio elitario, fuga per trovare un angulus separato dal mondo e dalla storia, ma operazione onesta, virtuosa connessione tra parole e cose. Scrivere in dialetto vale così emancipazione dalla pretesa ingenuità che ci si aspetterebbe romanticamente da un poeta vernacolo a favore di un verso meditato, complesso, ricco di evocazioni.
La prima parola del libro è “carna”, carne amara, luogo di sofferenza, umanità esposta, vita di ogni giorno; Totore, Rosetta, Michele, Iuccio: nomi che sono mesi, anni, storie da raccontare con un verso fulmineo, un accordo in minore che dice di malattie, affanni, canzoni, bestie vicine ancora all’uomo. Il rapporto di “Rocchino” con la madre è un rapporto d’amore senza il tabù filiale, un rapporto che si suggella nella lingua: «nun nfussarm’ inda la dengua, figlie / pur’ lu Nfiérn tèn nu cuor’ / magnàr’ da li càn, figlie (non seppellirmi nella tua lingua, figlio / pure l’Inferno ha un cuore / mangiato dai cani, figlio)» [3].
Donne e uomini nella poesia di Rocco Brindisi muovono il tempo come personaggi di un meccanismo boemo: Elena ha un rapporto col primo sole, con la sera che si apre sulle sue ginocchia. È quello di Rocco un misticismo carnale, fatto di puzza e sudori e mani, deiezioni e angeli in continua e ossessiva dialettica. Basso e alto nella sua poesia si scambiano le parti e l’impressione per chi legge è di ascoltare una musica, una porta che sbatte solitaria in un angolo del paese; si ha l’impressione di vedere attraverso un montaggio delle immagini tipicamente cinematografico, con cambi improvvisi di inquadratura e silenzi lunghi, come in un film di Paradžanov. È soprattutto la Morte la protagonista di questo tourbillon che definiamo vita, una Morte intimamente presente, quasi una buona compagna della vita; vivi e morti entrano in dialogo attraverso il medium della poesia: «Rosetta murès’ a diciott’ann’ / assiggillàren li port’ // ta ssir’ scennìa da lu valcon’ / p’ girla a v’ré / Totor’ partès p’ la uerra / Rosa du Pruatorie era lu Sol’ (Rosetta morì a diciotto anni / sigillarono le porte / tuo padre si calava dal balcone per andarla a vedere // Totore partì per la guerra / Rosa del Purgatorio era il mattino)» [4].
 La lingua poetica di Brindisi differisce da quella di Raffaele Nigro suo corregionale proprio dal punto di vista della necessità di scrittura, ovvero della parola – nel caso di Nigro – culturale e mediata dalla riflessione intellettuale e di ricerca, mentre nel caso di Brindisi la parola assume forza poietica e affabulatoria, quasi una parola delle origini che troviamo anche nelle prose poetiche di Rocco (Il silenzio della neve, La figliola che si fidanzò con un racconto, Il bambino che viveva nello specchio, Cose e il recente Morte di un amico che guardava).
La lingua poetica di Brindisi differisce da quella di Raffaele Nigro suo corregionale proprio dal punto di vista della necessità di scrittura, ovvero della parola – nel caso di Nigro – culturale e mediata dalla riflessione intellettuale e di ricerca, mentre nel caso di Brindisi la parola assume forza poietica e affabulatoria, quasi una parola delle origini che troviamo anche nelle prose poetiche di Rocco (Il silenzio della neve, La figliola che si fidanzò con un racconto, Il bambino che viveva nello specchio, Cose e il recente Morte di un amico che guardava).
La raccolta che segue Rosa du Pruatorie è Cariénn’ li nir’ da li ccaggie, libro in cui Rocco Brindisi adopera, secondo Ferdinando Giordano, un dialetto quale «lingua dominante, sfrondata di ogni lirismo manierato ed estetizzante, la cui versione italiana a piè di pagina altrettanto godibile (non una mera traduzione bensì, come dire, una variante sul tema, con un proprio diverso respiro poetico) accresce il rammarico, in chi legge, di un imperfetto possesso dei codici linguistici originari» [5]. In questo libro, più che nel precedente, Brindisi tesse un vero e proprio dialogo tra il dialetto e la lingua nazionale, con versioni in italiano davvero autonome rispetto al testo dialettale. Il dialetto è un impasto ben riuscito di fonemi napoletani, potentini, pugliesi; i versi sono lunghi e narrativi, le figure quelle emblematiche della poesia di Rocco: ragazze, angeli bambini, Dio e il diavolo, il mondo degli invisibili così cari a Giorgio Messori. Incastonato nel libro è uno splendido canto del pane, la sequenza anaforica “Pan’ candàr’”, in cui con modulo tipico di una litania il poeta canta la meraviglia del pane, cibo materiale e cibo spirituale, vivanda di povertà e ricchezza della casa, cibo sacro, parto della terra. Anche la morte degli ammazzati è morte sacra, momento di rivelazione: è il racconto in versi “U rre a dd’nar’” nel quale Ndònie il trainiere viene ammazzato per strada con una coltellata, ma sogna che non lo aiuti nessuno per potere raggiungere la sua casa e morire nel suo letto.
 Del 2010 è un libro davvero atipico di Brindisi (quale libro di Rocco in fondo non lo è?): La moglie di Youssef gioca con i fiocchi di neve. È un libro di versi e di prose in un continuum musicale, è in fondo il libro cui Rocco aspira fin dal suo esordio: una sceneggiatura in versi. C’è una stazione, una ragazza, un cane accucciato; in filigrana una storia da raccontare che però la ragazza pare non ricordare. Ci sono i film amati da Rocco: Anna di Alberto Grifi, poi Lubitsch, Herzog, Ozu, Hugo Fragonese… Questo poemetto narrativo esplode a ogni verso di immagini, luoghi di periferia, città di donne e uomini che passeggiano. E ancora film, questa volta immagini di attrici e attori: Andrea Checchi, Abbe Lane in una scenografia di neve, la scenografia dell’inverno a Potenza. In questo libro Rocco Brindisi invita al dialogo il lettore, che non può mai stare in disparte passivamente: interagisce con l’autore, sente la pena per queste donne e questi uomini così veri, gli angariati, gli emigrati da terre sempre troppo lontane, i bambini, gli ultimi della lista che sono le persone con le quali passa il proprio tempo Rocco e ce ne dà conto per umana necessità, perché il sacro è sempre nascosto, lo troviamo spesso dove c’è abbandono, nelle storie “sbagliate” come quella di Frances Farmer, nella storia di Eluana Englaro.
Del 2010 è un libro davvero atipico di Brindisi (quale libro di Rocco in fondo non lo è?): La moglie di Youssef gioca con i fiocchi di neve. È un libro di versi e di prose in un continuum musicale, è in fondo il libro cui Rocco aspira fin dal suo esordio: una sceneggiatura in versi. C’è una stazione, una ragazza, un cane accucciato; in filigrana una storia da raccontare che però la ragazza pare non ricordare. Ci sono i film amati da Rocco: Anna di Alberto Grifi, poi Lubitsch, Herzog, Ozu, Hugo Fragonese… Questo poemetto narrativo esplode a ogni verso di immagini, luoghi di periferia, città di donne e uomini che passeggiano. E ancora film, questa volta immagini di attrici e attori: Andrea Checchi, Abbe Lane in una scenografia di neve, la scenografia dell’inverno a Potenza. In questo libro Rocco Brindisi invita al dialogo il lettore, che non può mai stare in disparte passivamente: interagisce con l’autore, sente la pena per queste donne e questi uomini così veri, gli angariati, gli emigrati da terre sempre troppo lontane, i bambini, gli ultimi della lista che sono le persone con le quali passa il proprio tempo Rocco e ce ne dà conto per umana necessità, perché il sacro è sempre nascosto, lo troviamo spesso dove c’è abbandono, nelle storie “sbagliate” come quella di Frances Farmer, nella storia di Eluana Englaro.
L’ultimo libro di versi fin ora pubblicato da Brindisi è il già citato Morte de nu fra che uardava, vincitore del Premio nazionale di poesia in dialetto “Ischitella – Pietro Giannone” 2007. Un libro composto da quattro poemetti e una poesia. Lo stesso Rocco dichiara in premessa che il dialetto, oltre a essere lingua della madre, è anche e parimenti lingua di una mancanza, lingua diremmo della neve e delle storie, della poesia infine. Lingua del dolore così vicina a quella adoperata da Assunta Finiguerra di San Fele. Il primo poemetto, “Piccinne”, parla dell’infanzia, della tenerezza, del mondo del vero cui appartengono i morti e i bambini: « I piccininne ca restene criature… / a quinnesce anne, spurene sova la mane e fanne lu mare, / gecchene i pipele, quanne passa na dascerta… / dìscene ca lu ciele addòra’ de chiuse…(I bambini che restano creature… / a quindici anni, si sputano sulla mano e fanno il mare, / gettano petali di ginestre quando passa una lucertola // si lamentano del cielo / che odora di chiuso…)» [6].
Il secondo poemetto, “Morte de nu fra che uardava”, oltre a dare il titolo all’intera raccolta sarà il titolo, questa volta in lingua italiana che Brindisi dedicherà all’amico morto Giorgio Messori: Morte di un amico che guardava. Straordinario il rapporto che in vita (e in morte) lega Giorgio a Rocco: un’amicizia umana ancor prima che letteraria, un’amicizia di viaggi, fotografie, film visti insieme. Due uomini così diversi per cultura di riferimento (Messori padano, Brindisi uomo radicalmente del Sud) e incontri, Rocco e Giorgio danno vita a un sodalizio artistico che rimane nella memoria e nella scrittura di Brindisi: «vieneme a tuzzulà, / cume ha fatte mi mamma… // i morte nu se mettene sccuorne de uardà na finestra… / nu nsacce addù staie… / e manche la neve, / ca agge cresciù inte la vendra de mi mamma / me savesse accumbagnà… (Perché non vieni a trovarmi, / come ha fatto mia madre?… // i morti non hanno paura di guardare dentro una finestra… // non so dove stai… / e neanche la neve, / che ho cresciuta dalla pancia di mia madre / saprebbe accompagnarmi…)» [7]. La neve, forse il simbolo più ricorrente nell’opera di Rocco Brindisi – insieme al personaggio della Morte – è il correlativo oggettivo della mancanza, della mancanza che si fa racconto e quindi della possibilità stessa di narrare (ricordiamo le storie imprigionate nei ghiacciai del Gargantua e Pantagruele, le parole imprigionate nella neve udibili soltanto quando i ghiacci si sciolgono). La neve gelata viene sollevata dal vento, e questo movimento viene reso dalla parola “pulvinie” che dà il titolo al poemetto eponimo.
La neve nasce dal sonno della madre, ma non è la neve paralizzante del finale de I morti, racconto che chiude i Dubliners di Joyce: come lo scrittore irlandese Brindisi usa l’elemento naturale della neve come catalizzatore, come richiamo per i morti, per le storie da raccontare, ma la neve è nella sua opera legata al movimento, alla parola; essa prepara all’epifania del fuoco che riscalda, il fuoco che fa lieve il dolore, il fuoco delle storie.
Sono i lenzuoli gli oggetti di riferimento dell’ultima poesia del libro, i “Denzuole”: «U vecchie, arranzare a la finestra, / tenìa a mmende li figliole / ca stennienne i panne a u sole…(Il vecchio, affacciato alla finestra, / guardava le figliole / che stendevano i panni al sole…)» [8]. Anche nella poesia di Albino Pierro la neve è un elemento naturale legato al racconto, al ricordo: il poeta ricorda un ritratto che gli fecero in un giorno di festa: «Le stipe ancore u ritratte / ca mi fècere u jurne di na feste: / ci natèje, / – vistute a gghianche, tanne –, / come nd’ ‘a nive di prima matine…(Lo conservo ancora il ritratto / che mi fecero il giorno di una festa: / ci nuotavo / – vestito di bianco allora –, / come nella neve di prima mattina…)» [9].
Silenzio e neve fanno da contraltare al racconto che è fuoco, parola che fluisce: «Miska, u criature mie… / u delòre ca nun u pozze uardà, / nu delore dosce…/ scurìa bbella di ccittà ch’amme fatte l’amore…/ u sole di matine, figliole asciure da na febbra sccattosa…/ delòre di fenestre, di vianove, / la risa di vecchie accucculare, / c’aspettene u tram, piccininne mpastare cu li vvosce… / vulesse scrive nu cunte pe Miska / nu cunte cu nu delore dosce na cundandezza dosce / cume a nu delore dosce… / u chiarore de na finestra… (A volte penso a Miska, il mio bambino… // il dolore di non vederlo / un dolore buono / come il buio delle città che ho amato / la luce dei mattini era il languore di una ragazza sfebbrata… / il dolore buono delle finestre, dei viali / il sorriso delle vecchie accoccolate, in attesa del tram / i bambini impastati con le voci… // vorrei scrivere un racconto per Miska, / un racconto con un dolore buono, / una felicità buona come un dolore buono… / il chiarore dentro una finestra…)» [10]. In quest’ultimo testo è tutto l’immaginario poetico di Brindisi: il vento, i bambini, le figliole, i vecchi che osservano i giovani, le canzoni che sono antidoto contro la vera morte, la dimenticanza.
Dialoghi Mediterranei, n. 58, novembre 2022
Note
[1] Cfr. a questo proposito Il racconto del Sanfelese presente sulla rivista on line “zibaldoni e altre meraviglie” all’indirizzo https://www.zibaldoni.it/2007/12/09/sanfelese/, fiaba nella quale appare un angelo che mangia ciliegie seduto su un ramo: fiaba che ci ricorda certe storie scurrili raccolte da Afanas’ev.
[2] Cfr. il commento ad alcune poesie di Rocco Brindisi contenuto in L’Italia a pezzi. Antologia dei poeti italiani in dialetto e in altre lingue minoritarie tra Novecento e Duemila, Gwynplaine, Ancona 2015: 52.
[3] In Rosa du Pruatorie, San Marco dei Giustiniani, Genova 1986: 17.
[4] In Rosa du Pruatorie, op.cit.: 21
[5] Cfr. la prefazione di Ferdinando Giordano a Cariénn’ li nir’ da li ccaggie, San Marco dei Giustiniani, Genova 1990.
[6] Cfr. Rocco Brindisi, Morte de nu fra che uardava, Cofine, Roma 2007: 5
[7] Cfr. Morte de nu fra che uardava, op. cit. :14
[8] Ibidem: 30.
[9] In Albino Pierro, Ci uéra turnè. Poesie nel dialetto di Tursi tradotte in italiano dall’autore, Edizioni del girasole, Ravenna 1982: 16-17.
[10] Ibidem: 24.
______________________________________________________________
Nicola Grato, laureato in Lettere moderne con una tesi su Lucio Piccolo, insegna presso le scuole medie, ha pubblicato tre libri di versi, Deserto giorno (La Zisa 2009), Inventario per il macellaio (Interno Poesia 2018) e Le cassette di Aznavour (Macabor 2020) oltre ad alcuni saggi sulle biografie popolari (Lasciare una traccia e Raccontare la vita, raccontare la migrazione, in collaborazione con Santo Lombino); sue poesie sono state pubblicate su riviste a stampa e on line e su vari blog quali: “Atelier Poesia”, “Poesia del nostro tempo”, “Poetarum Silva”, “Margutte”, “Compitu re vivi”, “lo specchio”, “Interno Poesia”, “Digressioni”,“larosainpiù”,“Poesia Ultracontemporanea”. Ha svolto il ruolo di drammaturgo per il Teatro del Baglio di Villafrati (PA), scrivendo testi da Bordonaro, D’Arrigo, Giono, Vilardo. Nel 2021 la casa editrice Dammah di Algeri ha tradotto in arabo per la sua collana di poesia la silloge Le cassette di Aznavour. Con Giuseppe Oddo ha recentemente pubblicato Nostra patria è il mondo intero (Ispe edizioni).
______________________________________________________________