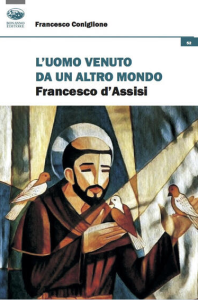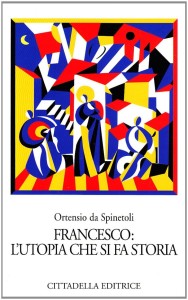Nella denominazione “cristianesimo” rientrano, in questi due millenni e nel panorama contemporaneo, centinaia di organizzazioni ecclesiali molto differenti fra loro e, perfino, al loro interno. In questo arcipelago non è per nulla facile orientarsi, ma una prima discriminante è individuabile nel IV secolo quando il cristianesimo “perseguitato” viene affiancato – e via via quasi soppiantato – dal cristianesimo “tollerato” prima (editto di Costantino, 315) e “obbligatorio” dopo (editto di Teodosio, 380). Così il “movimento” spirituale-politico avviatosi nel nome di Gesù di Nazareth diventa una “religione” istituzionalizzata; il messaggio minoritario e rivoluzionario diventa l’ideologia della maggioranza a servizio della conservazione del potere politico di turno; l’ortoprassi, misurata con il metro della solidarietà attiva gratuita, cede il primato all’ortodossia, stabilita in dogmi immodificabili formulati secondo le categorie culturali dell’epoca.
La vittoria del cristianesimo imperiale, gerarchico, maschilista non è però totale: il fiume carsico del cristianesimo originario, organizzato in maniera leggera e flessibile, continua a scorrere sotterraneamente e a zampillare, qua e là, nei venti secoli successivi. È evidente che quanti si rifanno all’uno non riconoscono come legittimo l’altro: chi abbraccia un modello non può che rifiutare come diabolico l’alternativo. La tragedia di quanti provano, nel loro ruolo e nel loro tempo, a mediare fra le due interpretazioni teorico-pratiche opposte è inevitabile perché si tratta di due prospettive oggettivamente inconciliabili. È quanto sta accadendo, ad esempio, a papa Francesco, malvisto dai conservatori ma non per questo apprezzato dai riformatori, delusi dalla sua ‘prudenza’. Ed è quanto è accaduto, mutatis mutandis, al Francesco d’Assisi di cui Jorge Mario Bergoglio – benché gesuita – ha voluto mutuare il nome.
Un personaggio sfuggente perché poliedrico
Chi è stato davvero il Poverello umbro? Come nel caso di tanti altri protagonisti della storia, a cominciare dallo stesso Gesù, siamo condannati a ignorare per sempre le sue vicende biografiche. Dobbiamo accontentarci di un Francesco polivalente, poliedrico, come viene narrato da vari testimoni, più o meno a lui vicini cronologicamente, cercando – con l’intuito e il buon senso – di sfrondare i racconti, per quanto possibile, dalle superfetazioni leggendarie agiografiche. Ma con la consapevolezza che, alla fine, racconteremo un “nostro” Francesco.
Tale consapevolezza sostiene, sin dalle prime pagine, la recente, voluminosa e appassionata, monografia di Francesco Coniglione, L’uomo venuto da un altro mondo. Francesco d’Assisi (Bonanno Editore, Acireale-Roma 2022), tesa a privilegiare, rispetto al Francesco della storia, la storia di Francesco quale rientrerebbe, per citare Gadamer, nella “storia degli effetti” della sua persona e della sua azione. Chi cerchi una chiave di lettura, per trovare il filo conduttore delle 410 pagine, la può trovare a cavallo fra pagina 10 e pagina 11, dove l’autore dichiara di essere interessato a focalizzare «l’itinerario di perfezionamento interiore» del santo medievale, per il quale
«lo svuotamento interiore di sé e la scelta della radicale povertà costituiscono il presupposto per l’accoglimento del tutto, culminando in un nuovo sguardo verso la natura che, appunto nella misura in cui non si perde nelle nebbie di un generico e romantico sentimento di misticismo naturalistico, si converte in un positivo atteggiamento e in una concreta prassi operativa a difesa del Creato».
Coniglione, storico della filosofia di formazione “laica”, tiene a precisare che questa sua chiave interpretativa non deriva da una concessione alle mode ecologiste né, ancor meno, intende sminuire «il forte radicamento di Francesco nella tradizione cristiana». Vuole soltanto sottolineare che di tale tradizione il “povero cavaliere di Cristo” (F. Cardini) ha valorizzato
«una direzione che va in senso contrario alla fuga dal mondo e al disprezzo della corporeità dell’uomo, atteggiamenti per molto tempo assai diffusi e verso i quali ha operato una decisiva rottura»,
a ennesima conferma che – secondo l’ironica affermazione di Alano di Lilla a proposito della Bibbia e del magistero ecclesiastico – ogni «auctoritas ha un naso di cera, cioè lo si può piegare in diversi sensi». Anche se non perseguita ruffianamente, l’attualità del “mito” francescano s’impone spontaneamente: ha infatti
«molto da dire all’uomo contemporaneo, di questo mondo, assai versato nello sviluppare le proprie ‘competenze’ ma parecchio sottodimensionato per quanto riguarda la formazione della sua interiorità, lo sviluppo del suo ‘carattere’ o, per dirla in modo più laicamente moderno, nella costruzione di una mind che non sia unidimensionalmente concentrata sulle sole capacità tecniche ed operative. […] L’insegnamento di Francesco sembra essere invece a noi assai vicino, non solo per i suoi specifici contenuti legati a una determinata temperie e tradizione, ma soprattutto per aver indicato quell’iter difficilior che è alla base di ogni autentico arricchimento umano, di ogni perfezionamento e sviluppo della mente, di ogni formazione educativa che faccia dell’uomo un essere spiritualmente completo e non un composito centauro, in cui a una raffinata cultura scientifico-ingegneristica si giustappone un rachitico senso morale e umano, schematico, dogmatico, intriso di fondamentalismi fideistici».
La ‘povertà’ come appello a un nuovo paradigma economico
Presupposto di ogni altra qualità virtuosa è, per Francesco, la povertà: non quella che si subisce involontariamente dalla nascita, bensì quella che si sceglie liberamente in modo da poter condividere con i poveri involontari le proprie risorse, materiali e immateriali. La sua è stata definita da Leonardo Boff «un’autentica rivoluzione morale: dall’economia dell’elemosina e del regalo, propria della società dei signori, si passa all’economia della restituzione per diritto».
Anche di questo aspetto peculiare del messaggio francescano, Coniglione non può fare a meno di sottolineare l’attualità, citando in proposito papa Francesco:
«Se ripetessi alcuni brani delle omelie dei primi Padri della Chiesa, del II o del III secolo, su come si debbano trattare i poveri, ci sarebbe qualcuno ad accusarmi che la mia è un’omelia marxista. “Non è del tuo avere che tu fai dono al povero; tu non fai che rendergli ciò che gli appartiene. Poiché è quel che è dato in comune per l’uso di tutti, ciò che tu ti annetti. La terra è data a tutti, e non solamente ai ricchi”. Sono parole di sant’Ambrogio, servite a papa Paolo VI per affermare, nella Populorum Progressio, che la proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto, e che nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario. San Giovanni Crisostomo affermava: “Non condividere i propri beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che possediamo non sono nostri, ma loro”».
Superfluo aggiungere che sia il Francesco medievale che il Francesco del XXI secolo non hanno ricevuto il consenso che speravano. Per limitarci al primo dei due, scoraggiato per la piega ‘moderata’ che stava assumendo il suo movimento, preferì cederne ad altri la direzione e trascorse, tra ingratitudini e diffidenze, gli ultimi anni di vita. Un discepolo – Tommaso da Celano – che lo conobbe personalmente, e ne scrisse due biografie, notò che già tra i frati sopravvissuti alla morte del fondatore non pochi preferiscono «riposare prima ancora di lavorare […], lavorando più con le mascelle che con le mani» e «senza faticare, si nutrono col sudore dei poveri». È una storia nota, non solo nelle tradizioni religiose ma anche nelle esperienze politiche dell’umanità: onestà, giustizia, uguaglianza, sobrietà…sono valori affascinanti da predicare al mondo, non necessariamente da praticare in prima persona (specie se, proprio grazie alla proclamazione di quei valori, si è arrivati ai vertici del potere istituzionale).
 La doppia metamorfosi del cristianesimo originario
La doppia metamorfosi del cristianesimo originario
Coniglione dedica varie pagine anche alla diffidenza di Francesco d’Assisi verso la teologia e mette in evidenza uno dei nessi fra tale diffidenza e la sua tendenziale fedeltà ai dettami evangelici: chi fa l’intellettuale di professione è tentato dall’orgoglio, dal potere, talora dal profitto economico. Ma ci sono altri nessi, più profondi e nascosti. Anche il teologo soggettivamente più sobrio, e distaccato da ambizioni mondane, producendo teologia contribuisce – oggettivamente – a snaturare il cristianesimo (dove “snaturare” non implica alcuna valutazione di merito: può darsi che, cambiando continuamente ‘natura’, il cristianesimo si assicuri una più durevole persistenza storica). La teologia, infatti, è il prodotto più tipico della metamorfosi del cristianesimo da proposta di vita a visione-del-mondo, da atteggiamento etico-esistenziale a dottrina teoretica: insomma, una sorta di gigantesco alibi per sostituire la ricerca della virtù con la speculazione intellettuale. Francesco non è, o non è necessariamente, un “simplex et idiota”. Pur rivelando nei suoi scritti una notevole finezza espressiva, non è stato un pensatore. Non per questo, però, è stato un irrazionalista. Chiunque può ammirare la filosofia, la razionalità, la logica, a patto di non illudersi che esse possano sostituire, subdolamente, la fede come aspirazione all’unione col Tutto e alla compenetrazione empatica con i sofferenti. La sua è stata, dunque,
«una diffidenza verso quel sapere teologico che, avventurandosi in arzigogolate interpretazioni, alimenta il timore che la parola si sostituisca all’azione, che ci si senta soddisfatti nel predicare, senza a ciò far seguire l’operare, laddove invece lo ‘spirito’ della parola divina non è il ripeterla od onorarla solo nella sua dimensione verbale, ma farne lievito di azione concreta, di pratica operativa».
Non si trattava per lui di esaltare l’ignoranza o di disprezzare l’istruzione, ma di invertire il cammino della Chiesa che, a mille anni dalle origini, aveva consentito alla teo-logia di soppiantare la teo-pratica (se così si potesse chiamare l’imitazione agapica del Dio annunziato da Gesù). È, in sostanza, il (forse disperato) tentativo di papa Francesco di riavvolgere il nastro a quei secoli iniziali in cui soccorrere un malato o salvare un naufrago erano gesti più urgenti e più rilevanti che processare i teologi dubbiosi sulla “pericoresi” intra-trinitaria o sul divieto dei metodi anticoncezionali: dopo tre decenni di governo del duopolio Wojtyla- Ratzinger, nei quali si sono formati per la maggior parte i preti e i vescovi cattolici, sarà possibile senza rischiare un ennesimo scisma? E, se tale scisma non dovesse palesarsi, dopo Bergoglio tornerà qualche nuovo papa talmente concentrato – con le scarpette di Prada al piede – sul dilemma se il presbitero opera la “transustanziazione” oppure la “transignificazione” dell’ostia da non chiedersi su quali edifici della City londinese vengano investiti i miliardi donati dai fedeli alla Santa Sede?
Il “giullare di Dio” ha intuito che, nel passato, l’intellettualizzazione del messaggio cristiano aveva reso possibile, se non addirittura inevitabile, una seconda metamorfosi: da movimento “carismatico”, profetico, a istituzione gerarchica, ricca di denari e di potere. E che, dunque, la novità della sua proposta di “fratellanza” si sarebbe inaridita e sclerotizzata se fosse diventata una bella teoria, utilizzabile ideologicamente per legittimare un nuovo “Ordine” religioso da sommarsi ai tanti altri “Ordini” trasformatisi, nel tempo, in potentati politico-economici.
Pare che il Francesco della storia abbia cercato di mediare fra la radicalità della sua ispirazione originaria (condivisibile da pochi discepoli più motivati) e l’esigenza di venire incontro alla maggioranza dei “frati minori”, bisognosi di un minimo di istruzione teologica e di inquadramento disciplinare, se li si voleva mantenere nell’alveo ecclesiale cattolico: «è stata proprio la capacità di articolare, nei luoghi e nei tempi opportuni, questi due momenti indispensabili ad assicurare la stupefacente fortuna del movimento francescano» passato in dieci anni (dal 1209 al 1219) da 12 frati a circa 5.000 in tutta Europa, in Africa settentrionale e in Medio Oriente.
Ma le vicende dei secoli successivi, con i frequenti tentativi di “rifondare” il francescanesimo imborghesitosi, sono state – per riprendere la citazione da Jacques Dalarun – quasi
«la riedizione del destino della Cristianità: tra insegnamento del Vangelo e necessità di istituire una Chiesa, come tra il carisma del santo fondatore […] e la necessità, per una fondazione, per un Ordine di vivere queste esigenze giorno per giorno. Tutto sommato ciò che viene svelato in maniera frammentaria nella morte del santo fondatore, è la difficoltà, il paradosso o la sfida che costituisce l’esistenza stessa di una società cristiana».
Coniglione riporta alcuni passaggi, a mio avviso tragicomici, della gestione ecclesiastica del “paradosso” francescano in quanto riproposizione del “paradosso” gesuano. Negli anni immediatamente successivi alla morte del Poverello (1226) qualche discepolo si richiama al suo Testamento per suffragare la necessità di un severo rispetto delle regole ivi raccomandate. Il papa Gregorio IX interviene nel dibattito con una finezza argomentativa ammirevole: Francesco è stato il fondatore, ma di un Ordine di uguali. Dunque, non può essere considerato, specie da morto, superiore ai suoi frati. Se gli si vuole essere veramente fedeli, non gli si può essere troppo: ha predicato la fratellanza, dunque spetta alla comunità dei frati stabilire come vivere concretamente, senza lasciarsi condizionare dalla sua pedissequa sequela dei dettami evangelici. Il papa ha ragione, ma – aveva osservato con non minore acutezza il cardinale Giovanni di San Paolo, vescovo di Sabina – la Chiesa non può rifiutarsi di «dare almeno una accettazione verbale alla proposta di Francesco» se non vuole rischiare di «bestemmiare Cristo, autore del Vangelo». Ciò che non è avvenuto per Francesco, è però capitato a tanti suoi poveri discepoli: bruciati vivi – in seguito a sentenze di condanna emesse da altri frati minori! – perché avevano preso troppo sul serio le parole di Gesù come riportate nel Nuovo Testamento. In fondo, colpevoli – più che di un peccato – di un erroneo metodo esegetico: interpretare letteralmente quanto dev’essere inteso, a quanto pare, metaforicamente…
Vorrei qui aprire una parentesi. Considerando i protagonisti dell’epoca medievale non è difficile tifare per Francesco contro le gerarchie ecclesiastiche, ben avviate – tra Innocenzo III e Bonifacio VIII – verso il culmine dell’elefantiasi teocratica. Ma, nel XXI secolo, alla luce sia delle scienze bibliche sia delle scienze umane, è ragionevole per un cristiano condividere la radicalità evangelica nello stesso senso in cui la intendevano Francesco (per ripristinarla, difenderla, promuoverla) e il Magistero cattolico (per smussarla, limarla, riservarla a pochi eletti)? O entrambi contendevano a partire da alcuni equivoci secolari sì che, oggi, ha senso puntare sulla radicalità evangelica ma a patto di restituirla, per quanto possibile, al significato originario (proprio dei primi tre secoli dell’era volgare)? La mia risposta è quest’ultima e, per argomentarla, sintetizzo brutalmente il volume I consigli evangelici. Proposta e interpretazione (Edizioni Dehoniane, Roma 1990) di Ortensio da Spinetoli, un biblista rinomato che, tra l’altro, è stato proprio un religioso francescano (più precisamente un membro dei Frati Minori Cappuccini, ossia di un Ordine fondato nel XVI secolo per riformare l’Ordine – ritenuto decadente – dei Frati Minori) e di cui lo stesso Coniglione cita più volte la monografia Francesco: l’utopia che si fa storia (Cittadella Editrice, Assisi 1999).
Premetto un chiarimento terminologico: mentre, nel vocabolario comune, una persona ‘religiosa’ è una persona che segue una propria religione o, almeno, una propria religiosità interiore, nel lessico teologico-ecclesiale cattolico è una persona che si è “consacrata” in maniera speciale a Dio accettando di «praticare la castità nel celibato per il Regno, la povertà e l’obbedienza» (Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1992, punto 915: 249); sia che rimanga una persona solo battezzata sia che – nel caso dei maschi – abbia accesso al ministero presbiterale, cioè diventi prete. Mentre ci sono ordini religiosi, congregazioni, associazioni che chiedono altre promesse solenni e vincolanti (ad esempio la “stabilità” nel monastero di appartenenza per Benedettini e Benedettine o “l’assistenza ai malati” per i Camilliani o “l’obbedienza speciale al papa” per i Gesuiti), tutte le istituzioni ‘religiose’ cattoliche devono chiedere ai propri membri almeno i tre voti di castità (celibataria), povertà e obbedienza perché sarebbe questo il modo oggettivamente migliore per «seguire Cristo da vicino». Castità da celibe (o da nubile) significa astensione rigorosa da ogni relazione affettivo-sessuale con persone del proprio o dell’altrui sesso; povertà significa rinunzia totale ad ogni proprietà, e tendenzialmente ad ogni possesso, di beni materiali; obbedienza significa dipendenza continua dalla volontà di un’altra persona che si trovi, temporaneamente o definitivamente, a occupare un ruolo di governo della propria comunità ‘religiosa’.
Dove nasce il problema? Dalla constatazione, evidente, che dalle fonti evangeliche a nostra disposizione non risulta che Gesù fosse un celibe (poiché sarebbe stato molto strano per un rabbi trentenne non essere sposato, le fonti lo avrebbero notato) né tanto meno si astenesse da relazioni affettive con amiche (le sorelle di Lazzaro, Marta e Maria; Maria Maddalena; le molte donne che facevano parte del suo gruppo errante); che fosse un povero (a differenza di Giovanni Battista non si dice mai che vestisse pelli di animali e mangiasse locuste); che fosse obbediente a qualsiasi autorità umana, religiosa o civile, se non nei limiti di ogni altro concittadino ebreo (e solo nella misura in cui tale obbedienza non dovesse ostacolare la sua obbedienza all’unica volontà da lui ritenuta assoluta, la volontà divina). Insomma: per quel che ne possiamo sapere storicamente, Gesù non fu né un eremita solitario né un monaco di clausura né un frate mendicante né un prete celibe e diffidente d’ogni relazione con donne. Spiegare come mai dal modello gesuano si sia potuti arrivare al modello monastico-conventuale esigerebbe un volume a parte da inscrivere nella più ampia questione delle influenze greche, manichee, gnostiche sul piccolo seme del movimento spirituale palestinese del I secolo.
Ciò che importa in questa sede è chiarire che Francesco, figlio del suo tempo, rivendicava (a mio parere meritoriamente) radicalità evangelica, ma identificandola (a mio parere disastrosamente) con un modello di vita imperniato sulla mortificazione della dimensione sessuale e affettiva, dell’autonomia nella gestione dei beni materiali e soprattutto della libertà di coscienza e di scelta. Solo in parte il suo intuito spirituale gli ha fatto presentire che l’anelito alla santità è sì un cammino senza mete prestabilite, senza limiti dettati dal moderatismo bigotto, ma un cammino essenzialmente interiore non sottostante alle regole moralistiche di chi stabilisce che l’astensione da ogni pratica genitale sia preferibile ai rapporti sessuali; quanti soldi si possano spendere ogni giorno per non varcare la soglia della povertà volontaria; che farsi manovrare (“perinde ac cadaver”: come se si fosse un cadavere) da un capo-comunità, per obbedienza militare, sia più cristiano del metodo democratico-assembleare adottato nei primi secoli dopo Cristo.
 Come spiega Hans Küng a proposito di Thomas More, canonizzato dalla Chiesa cattolica, non aveva certo rinunziato ai piaceri del sesso e alle gioie della famiglia (ebbe due mogli e dalla prima, morta prematuramente, tre bambine e un maschietto); né alle ricche proprietà familiari dal momento che «aveva una casa magnifica a Londra, una a Chelsea sulla riva del Tamigi, con biblioteca, una galleria, una cappella e un parco unito ad un frutteto» (Libertà nel mondo, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2014: 18), né, tanto meno, all’esercizio del potere (fu Gran Cancelliere del Regno d’Inghilterra, dunque l’uomo più autorevole subito dopo il sovrano). Possedette, ma come se non fosse padrone di nulla (cfr. 1 Cor. 7: 29-31). E che fosse davvero libero dai vincoli affettivi, dai beni economici e dal potere politico lo dimostrò con i fatti quando gli eventi lo misero alla prova: tra obbedire a Enrico VIII, che gli chiedeva di sostenerlo pubblicamente nello scisma da Roma per banali faccende matrimoniali, e perdere – insieme alla vita – i familiari, le proprietà, l’autorità politica, non ha esitazioni. «Egli tentò di evitare il conflitto e di ritirarsi a vita privata: presentò le sue dimissioni motivare da “ragioni di salute”. Non cercava il martirio» (ivi: 47). Ma, quando si accorse che poteva evitarlo solo tradendo la sua coscienza – nella quale riteneva di percepire la volontà divina – lo accettò rassegnato e senza perdere il suo proverbiale umorismo: «rinunciò alla famiglia» prendendo «congedo dalla moglie e dai figli che non poterono più visitarlo nemmeno in prigione»; «rinunciò ai suoi possedimenti: perse i redditi, licenziò la servitù, dovette lasciare che gli confiscassero i beni»; «rinunciò alla sua posizione nello Stato: si dimette dagli incarichi e restituisce al re il Gran Sigillo. L’uomo, che era il politico più eminente d’Inghilterra, fu gettato nel carcere della Torre di Londra» (ivi: 49-50).
Come spiega Hans Küng a proposito di Thomas More, canonizzato dalla Chiesa cattolica, non aveva certo rinunziato ai piaceri del sesso e alle gioie della famiglia (ebbe due mogli e dalla prima, morta prematuramente, tre bambine e un maschietto); né alle ricche proprietà familiari dal momento che «aveva una casa magnifica a Londra, una a Chelsea sulla riva del Tamigi, con biblioteca, una galleria, una cappella e un parco unito ad un frutteto» (Libertà nel mondo, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2014: 18), né, tanto meno, all’esercizio del potere (fu Gran Cancelliere del Regno d’Inghilterra, dunque l’uomo più autorevole subito dopo il sovrano). Possedette, ma come se non fosse padrone di nulla (cfr. 1 Cor. 7: 29-31). E che fosse davvero libero dai vincoli affettivi, dai beni economici e dal potere politico lo dimostrò con i fatti quando gli eventi lo misero alla prova: tra obbedire a Enrico VIII, che gli chiedeva di sostenerlo pubblicamente nello scisma da Roma per banali faccende matrimoniali, e perdere – insieme alla vita – i familiari, le proprietà, l’autorità politica, non ha esitazioni. «Egli tentò di evitare il conflitto e di ritirarsi a vita privata: presentò le sue dimissioni motivare da “ragioni di salute”. Non cercava il martirio» (ivi: 47). Ma, quando si accorse che poteva evitarlo solo tradendo la sua coscienza – nella quale riteneva di percepire la volontà divina – lo accettò rassegnato e senza perdere il suo proverbiale umorismo: «rinunciò alla famiglia» prendendo «congedo dalla moglie e dai figli che non poterono più visitarlo nemmeno in prigione»; «rinunciò ai suoi possedimenti: perse i redditi, licenziò la servitù, dovette lasciare che gli confiscassero i beni»; «rinunciò alla sua posizione nello Stato: si dimette dagli incarichi e restituisce al re il Gran Sigillo. L’uomo, che era il politico più eminente d’Inghilterra, fu gettato nel carcere della Torre di Londra» (ivi: 49-50).
Insomma, la radicalità del cristiano non si misura con autoflagellazioni masochistiche del proprio corpo né con un pauperismo che ci consegna totalmente all’arbitrio di chi – autonominatosi o eletto a capo di una comunità ‘religiosa’ – può decidere della nostra vita, avendo, come unico limite al proprio potere, la lex naturalis (interpretata “infallibilmente” dall’autorità papale): questa “radicalità” non merita, a mio avviso, di essere difesa a oltranza. Si permetta pure ai monsignori che vogliono godersi a fondo la vita, anche grazie alle rinunzie dolorose che consigliano ai fedeli, di aggirarla con vari giochetti dialettici. La “radicalità” evangelica autentica è altra.
«La cosa più importante per un cristiano» – afferma Küng a conclusione della sua breve monografia su More – è
«compiere una scelta radicale nella fede, per Dio, il Signore e il suo regno, a dispetto di tutte le inclinazioni peccaminose, e conservarla intatta attraverso le vicende ordinarie di ogni giorno. Conservare, vivendo nel mondo, la libertà fondamentale nei confronti del mondo, in mezzo alla famiglia, ai possedimenti e alla vita politica, nel servizio di Dio e dei fratelli. Possedere la lieta prontezza ad attuare questa libertà, in ogni tempo, nella rinuncia e, quando si è chiamati a farlo, nella rinuncia totale. È solo in questa libertà dal mondo, cercata, per amore di Dio, che il cristiano, il quale vive nel mondo e la riceve come dono di grazia di Dio, trova la fortezza, la consolazione, la potenza e la gioia, che sono la sua vittoria» (ivi: 54-55).
E allora «l’ubbidienza è sempre una virtù insostituibile, ma va prestata a Dio cercato, conosciuto, amato con la sincerità de dedizione di un figlio» (O. da Spinetoli, I consigli evangelici, cit.: 63), non a un altro essere umano:
«Gesù ha liberato l’uomo dal dominio del proprio simile. Egli non si ritroverebbe in un’istituzione (religiosa) che lega, subordina i suoi membri a un sedicente delegato divino» (ivi: 64).
Anche la povertà, intesa come “spoliazione volontaria”, può essere «un messaggio per chi rischia di diventare schiavo dei beni temporali», ma
«deve soprattutto mirare ad alleviare l’indigenza, il dubbio, l’inquietudine delle moltitudini bisognose. La sua funzione può essere anche ascetica, ma è prima di tutto umanitaria. L’illusione che occorre sempre evitare è che in se stessa abbia un valore, che sia un gesto accetto a Dio, come se egli trovasse particolare compiacimento a contemplare l’uomo indigente, spoglio, privo di sussistenza, addirittura nella miseria piuttosto che chi è nella prosperità e nell’abbondanza o che egli senta più vicino a sé colui che soffre che chi gioisce. Un’affermazione o aberrazione in cui si è spesso caduti e si rischia sempre di ricadere. Quel che Dio sicuramente vuole è che gli uomini siano felici, che lo siano tutti non soltanto alcuni» (ivi: 95).
Quanto alla castità, poi, essa non implica la rinunzia alla propria dimensione affettivo-sessuale, quanto una gestione saggia della stessa: dunque rispettosa della libertà dei partner e funzionale all’integrale completamento della propria e dell’altrui personalità. Come scrive genialmente Drewermann, la “castità” autentica – testimoniata già da Gesù per primo –
«significa questo: intuire qual è l’essenza dell’altro e riportarla in superficie con la stessa attenzione che distingue un restauratore di quadri quando toglie i ritocchi operati da estranei e risana gli effetti della corrosione del tempo per rendere nuovamente visibile l’opera originaria; evidenziare le linee del carattere, in cui l’Io dell’altro manifesta di più la sua bellezza; accogliere in se stesso il ritratto del suo sorriso e l’espressione della sua tristezza così che queste immagini dell’attimo possano manifestare pienamente la verità della sua persona; attirare l’anima dell’altro che è sepolta sotto montagne di macerie, fatte di speranze distrutte, gesti nascosti, pensieri segreti, e farla ritornare alla luce del sole; far sì che l’anima faccia fiorire le zone devastate, bruciate, disseccate o gelate dall’angoscia e vi si senta a suo agio. Si tratta dello sforzo di liberare il corpo dell’altro dai vincoli di un falso pudore e di donargli la sua originaria bellezza e innocenza» (E. Drewermann, Funzionari di Dio. Psicogramma di un ideale, Edizioni Raetia, Bolzano 1995: 506).
I classici “consigli evangelici” codificati dalla tradizione cristiano-cattolica nei tre “voti” di castità, povertà, ubbidienza andrebbero interpretati in maniera ben diversa da come è avvenuto storicamente, anche da parte di Francesco e dei francescani: il che non significa in maniera più “permissiva” o “ammorbidita”, ma più ragionevole e più seria. E comunque perché ci si è fissati – e si continua a perseverare – proprio su questi tre “consigli” come se non ce ne fossero di altrettanto, anzi più, tipici e rilevanti, quali la “pazienza”, la “misericordia”, il “coraggio”, la “sollecitudine per chi soffre” e mille altri?
 Francesco e il mondo della natura
Francesco e il mondo della natura
Il secondo capitolo di questo ampio saggio di Coniglione è dedicato a Francesco e il mondo della natura. Non c’è dubbio che, se consideriamo le correnti filo-gnostiche e neo-manichee coeve, egli abbia rappresentato una silenziosa ma ferma protesta. Senza la violenza repressiva delle autorità cattoliche, tuttavia Francesco ha espresso un forte richiamo a quelle pagine bibliche che indicano la natura extra-umana, intrisa di materia, come dono del Creatore e motivo di gratitudine nei suoi confronti. Come nota Franco Cardini, dopo aver tratteggiato l’eresia catara,
«se teniamo presente tutto questo e porgiamo orecchio ai Minori che, nelle strade dell’Europa, lodano il Signore per tutte le Sue creature, il Cantico si rivela anche un efficace, serrato, appassionato manifesto anticataro».
Questa rivalutazione del mondo fisico, corporeo, non poteva non coinvolgere anche il regno animale. Egli sembra oltrepassare «l’idea che la natura debba essere soggiogata e dominata dall’uomo e che solo nella misura in cui ciò accade essa diventa un “paradiso”»: ritiene, infatti, che essa «deve essere apprezzata così com’è, ha una sua bellezza intrinseca, anche se in qualche caso deve essere addomesticata, secondo lo stereotipo agiografico del potere sugli animali come prova di santità».
«Ovviamente ciò non significa fare di Francesco un animalista nell’accezione odierna, né tanto meno sostenere un suo pur indiretto sostegno per il vegetarianismo o addirittura il veganismo: non solo manca ogni testimonianza in tal senso e anzi si possono citare numerosi episodi in cui egli consuma carne di animali , ma soprattutto perché di solito nel mondo cristiano antecedente a Francesco le pratiche vegetariane erano giustificate in termini penitenziali e non per il rispetto dovuto agli animali».
Il predicatore umbro è stato frenato, nel portare alle estreme conseguenze logiche la sua compassione con i “fratelli” animali, dalla «idea di una superiorità dell’umanità nella gerarchia della creazione» (un’idea irrinunciabile per «un uomo impregnato dei sentimenti del suo tempo»)? Coniglione sembra pensarlo, in linea per altro con la stragrande maggioranza degli studiosi. Personalmente sono convinto che la medesima convinzione della “superiorità dell’umanità” (ovviamente relativamente a molti parametri, non a tutti) rispetto alle altre specie, di per sé potrebbe condurre a conseguenze pratiche esattamente opposte: proprio se un essere è più evoluto dal punto di vista della coscienza, è anche più responsabile delle sue azioni. Il leone non può fare a meno di divorare la gazzella se ha fame: l’uomo – che ha il terribile potere di uccidere la gazzella senza necessità, per puro gioco da imbecilli – ha però anche la libertà di rinunziare a mangiare carne di altri animali e di cercarsi alternative non violente (o meno violente). La libertà potenziale lo sposta al di sopra dell’invincibile innocenza a-morale degli altri animali e lo inchioda alle sue responsabilità.
Comunque la si pensi su questo tema, più in generale l’atteggiamento di Francesco nei riguardi del mondo naturale rimane «ancora ambivalente». Infatti non c’è dubbio che, da una parte,
«tutta la sua vita è una gioiosa condivisione della natura e dei suoi animali, che fanno parte del progetto di salvezza di Cristo e quindi hanno una dignità pari all’uomo, in quanto tutte creature divine e tutti fratelli/sorelle: non si perviene a Dio fuggendo dal mondo, ma amandolo profondamente, identificandosi con esso».
Tuttavia, dall’altra parte, è altrettanto incontestabile che su Francesco e i suoi discepoli
«abbiano pesato i canoni ascetico-spirituali ed agiografici del tempo, tra gli elementi più caratteristici dei quali sono o v’erano un atteggiamento di sospetto, talvolta di disprezzo, verso il corpo […]. Questo influsso a nostro avviso ha frenato alquanto l’atteggiamento spontaneo, istintivamente positivo, dell’anima francescana verso il corpo ed ha colorato la prassi spirituale e la visione dottrinale francescana verso di esso di una certa tinta di pessimismo anticorporale, che è in oggettivo contrasto con l’affermazione di Francesco e dei suoi seguaci della positività di tutte le cose, anche di quelle materiali» (così G. Iammarrone citato da Coniglione).
Dunque – come già a proposito di quanto osservato sulla rilettura dei classici voti ‘religiosi’ (castità, povertà, obbedienza) – non possiamo vedere in Francesco un modello per la spiritualità contemporanea. Non perché siano stati registrati nel suo profilo caratteriale degli aspetti di durezza, di eccessivo rigore, di intolleranza: in questo non si è discostato molto dalla figura canonica del “fondatore” (in cui «il carisma […] appare sempre come un abuso di potere»), in genere «un tipo particolare, che potremmo definire, cum grano salis, un insoddisfatto aggiunto a un megalomane: nulla di ciò che esiste mi soddisfa (leggere il Testamento); io posso fare meglio di qualunque sino ad ora. […] Dominus ego: quanta presunzione in questa linea diretta!» (così J. Dalarun citato da Coniglione).
No, la inadeguatezza del modello-Francesco per le donne e gli uomini del XXI secolo affonda le radici ben più in profondità. Egli può essere considerato un prezioso traghettatore dal teismo –sinora dominante in tutte le principali Chiese cristiane – antropomorfo, fortemente dualistico e (per citare Matthieu Fox) “amartiocentrico” (=centrato sul peccato) verso quella teologia, ancora in fase di elaborazione, che assume con serietà l’innominabilità del Divino e la sua onnipresenza nel cosmo (senza necessariamente sfociare nel panteismo).
Sulla mistica francescana
Francesco ha lasciato tracce indelebili anche – e forse soprattutto – nella storia della mistica cristiana. A proposito delle quali vanno notati almeno due aspetti.
Il primo riguarda il nesso fra mistica e poesia. Opere liricamente significative, a cominciare dal Cantico di frate sole vanno considerate come documenti di un hobby personale, ai margini dell’attività principale – per così dire professionale – del padre fondatore di nuove famiglie spirituali? Con sguardo penetrante, l’autore di questo poderoso studio mostra che non è per nulla così. Francesco e i suoi (basti citare Jacopone da Todi) attestano che l’esperienza interiore del Divino non può essere espressa con il linguaggio ordinario; che essa è costretta, se non si rassegna al silenzio, a tutta una “strumentazione retorica” che «tende a un al di là della lingua stessa scardinandone alla radice la logica» e che è «esattamente quella della poesia»; che, insomma,
«quando la poesia affronta temi mistici o quando, anche al di fuori di ogni contesto propriamente religioso, si slancia verso il Sacro e il Trascendente, poesia e mistica sono la stessa cosa» (così F. Zambon citato da Coniglione)
Un secondo aspetto degno, fra tanti altri, di essere sottolineato è che Francesco incarna, per così dire plasticamente, un itinerario mistico il cui vertice – sino a quando si calpesta la polvere di questo pianeta – non è la beatitudine della fusione con l’Assoluto. Coniglione illustra questo aspetto parafrasando Riccardo di San Vittore che, nella descrizione ‘canonica’ dei tre gradi dell’ascesa a Dio, introduce
«una significativa novità quando al terzo grado dell’amor languens, nel quale si ha excessus mentis e il suo rapimento nell’abisso della luce divina, egli fa seguire un quarto grado di discesa, affinché l’anima possa conformarsi perfettamente a Cristo, essendone l’imitatio: è l’umiliazione di ritornare sulla terra, farsi carne e sopportare le sofferenze inflitte sino alla morte. […] Una conclusione assai importante in quanto mostra come “il rapimento mistico e l’unione con Dio non bastano, sono soltanto la premessa dell’opera che ogni uomo è chiamato a compiere tra i suoi fratelli, imitando Cristo” (F. Zambon). È l’opera che – aggiungiamo – si pose come missione della propria vita Francesco».
Siamo, come Coniglione non manca di far notare, agli antipodi dalle aporie della “mistica speculativa” su cui, in Italia, insiste da decenni Marco Vannini, con il forte rischio di ridurre l’esperienza ineffabile del Divino a
«una sorta di hegelismo di ritorno, dove il “pensiero speculativo” – che supera ed eccede l’intelletto di cui sono fatte le scienze profane ed empiriche – viene di fatto equiparato al mistico»
e al quale interessa il cristianesimo dei dogmi più cervellotici (teandricità di Cristo, unitrinità di Dio) più che l’essenzialità dell’invito evangelico originario ad amare con gratuità e operosità.
Va comunque notato che sarebbe storicamente falso fare finta che Francesco non condividesse la dogmatica cristiana – diventata l’unica ortodossa dal IV secolo in poi – e, in particolare, che non credesse che la natura umana di Gesù fosse innervata in una Persona divina (non in una persona umana): solo dal XVIII secolo a oggi – prima in ambienti ‘laici’, poi via via anche in ambienti ecclesiali – è stato possibile, con gli sviluppi delle scienze bibliche, contestare il passaggio, avvenuto lentamente ma inesorabilmente dalla morte di Gesù in poi, dalla venerazione per Gesù il Cristo (=Messia) all’adorazione di Gesù in quanto Dio. Come tutti i mistici di ogni religione, egli esprime la sua esperienza spirituale all’interno di un apparato concettuale e simbolico che eredita, senza averlo scelto. Anzi, secondo S.T. Katz (qui citato)
«le esperienze stesse sono inevitabilmente modellate da influenze linguistiche precedenti in modo tale che l’esperienza vissuta si conforma a uno schema preesistente che è stato appreso, poi inteso, e poi attualizzato nella realtà esperienziale del mistico».
Per questo non sono sicuro che Francesco abbia avvertito i dogmi cristiani (l’incarnazione o la Trinità) come “dottrine folli” o “paradossi” su cui meditare come su Köan Zen in modo da «mettere in scacco quella vigile coscienza razionale che impedisce l’apertura della mente a un altro e diverso tipo di accesso al Vero»: più semplicemente, da buon fedele medievale, egli vi ha aderito a-problematicamente, ma, da buon mistico, ha avvertito la «infinita distanza tra ciò di cui sente di avere immediata esperienza» e «l’apparato teorico cristiano» (o, per altri mistici, “giudaico, buddhista, islamico ecc.”). Da buon mistico cristiano, inoltre, ha concentrato la propria attenzione non sulla «propria vita interiore» – Francesco non scrive una sola parola su questa dimensione, sarà Bonaventura a «costruire una teologia mistica» francescana –, ma sulla prassi evangelica propria e dei suoi seguaci.
Distante dalla mistica “speculativa”, più teoretico-metafisica che esistenziale-affettiva, Francesco lo è altrettanto dalla mistica “naturalistica”, atea o agnostica o panteistica, tipica del successivo Romanticismo europeo. Va dunque rispettato nella sua identità di «uomo arcaico e neomoderno» (L. Boff qui citato), la cui “grandezza” sta in ciò:
«pensare e agire nel contesto di una proposta integralmente cristiana – a pieno titolo all’interno della sua tradizione, dei suoi dogmi, dei suoi riti – e nondimeno aver proiettato tale sua visione su uno sfondo più ampio, più comprensivo, tale da essere in grado di parlare ad ogni uomo, religioso o laico che sia. In ciò sta lo scandalo e il paradosso di Francesco, che tante interpretazioni divergenti ha suscitato».
La divergenza delle interpretazioni suscitate dalla figura e dal messaggio di Francesco si registra già lui vivente. In tutta la Parte seconda di questo volume l’autore riepiloga – in ordine cronologico – le reazioni, dentro e fuori del movimento francescano, all’originalità del Fondatore: è un intreccio di vicende drammatiche, intrighi, tradimenti, processi, condanne, roghi, rivincite…rispetto a cui le soap opere brasiliane più inverosimili appaiono romanzetti sfornati da scrittori privi di fantasia.
Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2022
____________________________________________________________________
Augusto Cavadi, già docente presso vari Licei siciliani, co-dirige insieme alla moglie Adriana Saieva la “Casa dell’equità e della bellezza” di Palermo. Collabora stabilmente con il sito http://www.zerozeronews.it/. I suoi scritti affrontano temi relativi alla filosofia, alla pedagogia, alla politica (con particolare attenzione al fenomeno mafioso), nonché alla religione, nei suoi diversi aspetti teologici e spirituali. Tra le ultime sue pubblicazioni si segnalano: Il Dio dei mafiosi (San Paolo, 2010); La bellezza della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo, 2011); Il Dio dei leghisti (San Paolo, 2012); Mosaici di saggezze – Filosofia come nuova antichissima spiritualità (Diogene Multimedia, 2015); La mafia desnuda – L’esperienza della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone” (Di Girolamo, 2017); Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia e contro i mafiosi (Di Girolamo, 2018), Dio visto da Sud. La Sicilia crocevia di religioni e agnosticismi (SCe, 2020); O religione o ateismo? La spiritualità “laica” come fondamento comune (Algra 2021).
______________________________________________________________