L’insediamento del nuovo esecutivo, espressione della coalizione uscita vincitrice dalle elezioni del 25 settembre 2022, è stato accompagnato da una decisa svolta linguistica, ancora più netta se paragonata alla comunicazione formale e un po’ ingessata degli ultimi governi tecnici. Nei loro interventi pubblici e istituzionali, così come nella decisione di cambiare nome ad alcuni dei più importanti Ministeri dello Stato [1], gli esponenti della attuale maggioranza si sono immediatamente distinti per una decisa sterzata identitaria attraverso l’impiego di alcune delle tradizionali parole d’ordine delle destre: sovranità, sicurezza, natalità, merito, autorità, disciplina, tolleranza zero. Ovviamente non c’è nulla di sorprendente in tutto ciò: la vittoria della destra rappresenta un passaggio importantissimo nella storia del nostro Paese ed è naturale che il coronamento del lungo processo di legittimazione politico-sociale [2] si accompagni al richiamo ai propri ideali.
Tuttavia sarebbe molto interessante condurre un’analisi semiotica di questo tipo di comunicazione leggendola, in particolare, alla luce delle congiunture internazionali odierne e di un’evoluzione culturale in cui i temi dell’inclusione delle minoranze non sono più rinviabili. La mia sensazione, infatti, è che, a fronte dei ristretti margini di manovra che il nuovo esecutivo sta sperimentando a livello economico-finanziario (margini stretti dovuti al posizionamento euro-atlantico dell’Italia, alle dinamiche strutturali del capitalismo transnazionale e alle contingenze emergenziali dettate dalla crisi (post-)pandemica e dall’invasione russa in Ucraina), l’impiego di un gergo muscolare e senza sfumature quando si discute di questioni sociali e civili serva essenzialmente a ostentare un’immagine di purezza e genuinità sul piano dei valori assoluti.
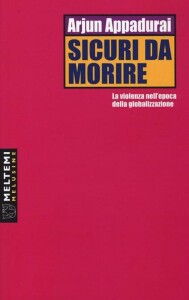 Mi spiego meglio. Arjun Appadurai ha riflettuto con grande lucidità sulla dialettica locale/globale innescata dalla globalizzazione neoliberista e sulla tendenza degli Stati-nazione a giocare la carta della cultura in senso essenzialista [3] per nascondere la crescente passività che ognuno di essi sperimenta davanti a forze economiche sempre più liquide, pervasive e sovranazionali. All’interno di uno spazio mondiale «deterritorializzato», in cui il concetto di località ha ormai «perduto i suoi ormeggi ontologici», agli Stati-nazione non è rimasto altro che ritagliarsi un ruolo da protagonisti come controllori e mediatori delle differenze culturali: in un’economia planetaria sempre meno inquadrabile all’interno delle frontiere nazionali tradizionali, gli Stati cercano allora di «legittimare la loro posizione presentandosi come garanti degli interessi di un “popolo” definito e delimitato in senso territoriale». Secondo l’antropologo indiano, insomma, l’ambito della cultura è rimasto l’unico in cui «possono ancora attecchire fantasie di purezza, autenticità, confini e sicurezza». Le riflessioni di Appadurai si riferiscono essenzialmente al ruolo degli odierni Stati-nazione e vogliono indagare la genesi della violenza di matrice etnica, ma a me pare che le sue considerazioni si attaglino particolarmente bene anche al concreto operato dei populismi che in quest’epoca di “modernità in polvere” [4] si stanno affacciando alla guida di molti Paesi.
Mi spiego meglio. Arjun Appadurai ha riflettuto con grande lucidità sulla dialettica locale/globale innescata dalla globalizzazione neoliberista e sulla tendenza degli Stati-nazione a giocare la carta della cultura in senso essenzialista [3] per nascondere la crescente passività che ognuno di essi sperimenta davanti a forze economiche sempre più liquide, pervasive e sovranazionali. All’interno di uno spazio mondiale «deterritorializzato», in cui il concetto di località ha ormai «perduto i suoi ormeggi ontologici», agli Stati-nazione non è rimasto altro che ritagliarsi un ruolo da protagonisti come controllori e mediatori delle differenze culturali: in un’economia planetaria sempre meno inquadrabile all’interno delle frontiere nazionali tradizionali, gli Stati cercano allora di «legittimare la loro posizione presentandosi come garanti degli interessi di un “popolo” definito e delimitato in senso territoriale». Secondo l’antropologo indiano, insomma, l’ambito della cultura è rimasto l’unico in cui «possono ancora attecchire fantasie di purezza, autenticità, confini e sicurezza». Le riflessioni di Appadurai si riferiscono essenzialmente al ruolo degli odierni Stati-nazione e vogliono indagare la genesi della violenza di matrice etnica, ma a me pare che le sue considerazioni si attaglino particolarmente bene anche al concreto operato dei populismi che in quest’epoca di “modernità in polvere” [4] si stanno affacciando alla guida di molti Paesi.
 Da tutt’altro versante, Furio Jesi ha scritto pagine definitive sulla relazione tra mito, linguaggio e storia, soprattutto rispetto a quella che egli ha definito «cultura di destra». Proprio di questa area politica, infatti, è il costante rinvio a una dimensione mitica fatta di valori eterni (Tradizione, Patria, Suolo, etc.), il cui nucleo originario se da una parte è inaccessibile in quanto tale, dall’altra è conoscibile esotericamente attraverso narrazioni dogmatiche, immediate e semplificate in grado di mettere in comunicazione il presente con il passato ancestrale e, contemporaneamente, spingere all’azione. Se per Jesi la realtà del mito è inattingibile, perfettamente indagabile attraverso l’analisi di pratiche e retoriche storicamente fondate è invece la «macchina mitologica» che la destra ha prodotto: «una cultura fatta di autorità e sicurezza […] circa le norme del sapere, dell’insegnare, del comandare e dell’obbedire» [5].
Da tutt’altro versante, Furio Jesi ha scritto pagine definitive sulla relazione tra mito, linguaggio e storia, soprattutto rispetto a quella che egli ha definito «cultura di destra». Proprio di questa area politica, infatti, è il costante rinvio a una dimensione mitica fatta di valori eterni (Tradizione, Patria, Suolo, etc.), il cui nucleo originario se da una parte è inaccessibile in quanto tale, dall’altra è conoscibile esotericamente attraverso narrazioni dogmatiche, immediate e semplificate in grado di mettere in comunicazione il presente con il passato ancestrale e, contemporaneamente, spingere all’azione. Se per Jesi la realtà del mito è inattingibile, perfettamente indagabile attraverso l’analisi di pratiche e retoriche storicamente fondate è invece la «macchina mitologica» che la destra ha prodotto: «una cultura fatta di autorità e sicurezza […] circa le norme del sapere, dell’insegnare, del comandare e dell’obbedire» [5].
Facendo dialogare Appadurai e Jesi, allora, non mi pare un caso che il lessico forte del nuovo governo italiano sia in qualche modo collegato agli aspetti sopra accennati: puntando su «parole spiritualizzate», che richiamano verità eterne e prepolitiche, esso mira a coinvolgere visceralmente i propri seguaci rinviando a un tipo di «idee che esigono non parole», ovvero ad archetipi astorici e auto-evidenti. La comunicazione della destra di governo, insomma, funzionerebbe come una piccola «macchina mitologica»: essa parla una lingua rassicurante, utile a disinnescare, almeno simbolicamente, un divenire storico-politico che, nonostante l’oratoria muscolare, è difficile da guidare completamente (almeno dal punto di vista finanziario). Una «macchina mitologica», infine, che produce «miti tecnicizzati» incistati nella storia: formule che non vogliono produrre nuove visioni del mondo, bensì tracciare linee in un momento storico in cui molte frontiere si fanno più fragili: noi Vs loro.
Detto così parrebbe né più né meno che la riproposizione di un vecchio trucco del pensiero reazionario; un trucco che, notava già Jesi negli anni Settanta, col tempo si è sedimentato anche nei populismi di diverso colore. Il punto è che, come riconosciuto lucidamente dallo studioso piemontese, il linguaggio non è puro simbolo, bensì atto creativo: quando nominiamo qualcosa gli diamo forma, lo produciamo. E non serve scomodare anche John Austin per vedere «quante cose riusciamo a fare con le parole»: quanti mondi possiamo inventare, quanti ne possiamo distruggere; quante possibilità possiamo schiudere, quante ne possiamo chiudere.
Si prenda allora, a mo’ d’esempio, il recente caso di cronaca che ha visto protagonista il neo Ministro dell’Istruzione e del Merito: il suo disinvolto uso del concetto di “umiliazione” a scopo educativo, a mio avviso, appare coerente con il nuovo corso perché più che cercare soluzioni usa una determinata idea come richiamo identitario.
Andiamo con ordine. Il 21 novembre il Ministro ha partecipato all’evento “Italia, direzione nord” promosso dall’associazione Amici delle Stelline e dall’istituto di ricerca Osservatorio Metropolitano di Milano. Parlando di sicurezza in classe, il titolare del Dicastero ha citato un grave episodio di violenza avvenuto in un istituto tecnico di Gallarate (Varese) e ha elogiato il Dirigente Scolastico che ha immediatamente sospeso per un anno lo studente coinvolto anziché indugiare in sofismi o contestualizzazioni inopportune. Infine ha rincarato la dose auspicando misure ancora più drastiche. Ecco le sue parole:
«[…] se ci si limita a sospendere per un anno, il rischio è che quel ragazzo vada poi a fare fuori dalla scuola altri atti di teppismo, o magari addirittura si dia allo spaccio o magari si dia alla microcriminalità. Quel ragazzo deve essere seguito, quel ragazzo deve imparare che cosa significa la responsabilità, il senso del dovere. Noi dobbiamo ripristinare non soltanto la scuola dei diritti, ma anche la scuola dei doveri. Quel ragazzo deve fare i lavori socialmente utili, perché soltanto lavorando per la collettività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche, evviva l’umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Di fronte ai suoi compagni è lui, lì, che si prende la responsabilità dei propri atti e fa lavori per la collettività. Da lì nasce il riscatto. Da lì nasce la maturazione. Da lì nasce la responsabilizzazione» [6].
 Ora, prescindendo dalla discutibile (per usare un eufemismo) mossa retorica consistente nell’instaurare un collegamento tra un bruttissimo gesto compiuto a scuola ed eventuali atti di teppismo, spaccio e microcriminalità consumati fuori, dietro queste parole si staglia una concezione rigida e autoritaria dell’educazione in cui è bandito il dialogo, in cui è messa da parte la storia dei soggetti che vivono lo spazio scolastico e in cui si lascia intendere che il docente – o comunque il rappresentante dell’Istituzione – debba assumere il ruolo di censore di comportamenti devianti. La scuola, insomma, viene dipinta come il luogo in cui il colpevole trovato con le mani nel sacco deve espiare la propria colpa. L’umiliazione pubblica gioca così una triplice funzione: è motore di crescita personale per il singolo studente; è monito per i compagni e le compagne che assistono alla mortificazione del reo; è chiamata ai valori dell’ordine e della sicurezza (law and order) per chi osserva dall’esterno.
Ora, prescindendo dalla discutibile (per usare un eufemismo) mossa retorica consistente nell’instaurare un collegamento tra un bruttissimo gesto compiuto a scuola ed eventuali atti di teppismo, spaccio e microcriminalità consumati fuori, dietro queste parole si staglia una concezione rigida e autoritaria dell’educazione in cui è bandito il dialogo, in cui è messa da parte la storia dei soggetti che vivono lo spazio scolastico e in cui si lascia intendere che il docente – o comunque il rappresentante dell’Istituzione – debba assumere il ruolo di censore di comportamenti devianti. La scuola, insomma, viene dipinta come il luogo in cui il colpevole trovato con le mani nel sacco deve espiare la propria colpa. L’umiliazione pubblica gioca così una triplice funzione: è motore di crescita personale per il singolo studente; è monito per i compagni e le compagne che assistono alla mortificazione del reo; è chiamata ai valori dell’ordine e della sicurezza (law and order) per chi osserva dall’esterno.
Se è possibile, come sovente accade in questi casi, la toppa si è dimostrata persino peggiore del buco: chiamato a chiarire il senso del suo intervento dopo le inevitabili polemiche, il Ministro ha espresso rammarico per l’uso improprio del termine “umiliazione”, che a suo dire andava sostituito con “umiltà”, e ha giustificato il proprio lapsus con la partecipazione emotiva causatagli dall’increscioso episodio che aveva preso in esame. Tuttavia la rettifica non ha minimamente intaccato il nucleo del suo ragionamento, lo ha semmai ribadito in modo più accorto e circostanziato e ha, soprattutto, introdotto ulteriori elementi di oscurità quando, a margine, ha avanzato l’ipotesi che il dispiegamento di mezzi repressivi possa essere funzionale alla restaurazione del prestigio sociale degli insegnanti.
Ecco, allora, che lo scandalo dell’umiliazione pubblica come strumento pedagogico si salda al più profondo desiderio di riproporre modelli mitici, basati su una relazione asimmetrica tra docente (chi decide) e discente (chi ubbidisce), e di traghettare la discussione dei problemi della scuola italiana sull’astratto terreno di valori non negoziabili indifferenti ad ogni contesto. Quando, infatti, all’interno di una riflessione sul futuro e la credibilità del sistema didattico nazionale, il principale esponente governativo tace sulla generalizzata precarietà degli insegnanti (contrattuale e remunerativa), sull’inadeguatezza degli spazi scolastici, sulla debolezza di reti che facilitino il dialogo tra scuola e società civile e sulle difficoltà nel concepire un’istruzione realmente inclusiva e al passo con l’evoluzione socio-demografica delle nostre città, qualcosa non torna. Le idee veicolate da questo tipo di parole-simbolo appaiono non solo vetuste e allarmanti ma paradossalmente non in linea con le stesse più avanzate riflessioni pedagogiche sui processi di apprendimento diffuse dalle reiterate circolari ministeriali; non in linea con ciò che conosciamo dalla letteratura scientifica sulle dinamiche che generano violenza, bullismo e discriminazione; non in linea con politiche che vogliano rendere la scuola un luogo libero in grado di dare a tutti uguali possibilità.
Vista la collocazione politica del Ministro, si potrebbe fare facile ironia sul gergo cameratesco da lui impiegato con tanta leggerezza – è noto, d’altra parte, come in certi ambienti segnati da gerarchia strutturale i sottoposti debbano attenersi rigidamente ai comandi dei superiori e, anzi, debbano anche passare da vere e proprie umiliazioni ritualizzate per poter alla fine essere ammessi all’interno del gruppo. Ma in realtà c’è poco da scherzare perché, come detto poc’anzi, in ballo non c’è solo un vocabolo apparentemente fuori posto, bensì il modello, l’archetipo, il mitema cui vocabolo e ragionamento complessivo rimandano. Un’idea di educazione, cioè, che si avvicina più a una specie di addestramento in cui il soggetto attivo – l’insegnante – elargisce conoscenza e regole, mentre quello passivo – l’allievo – deve limitarsi a recepire e non discutere. Non è certo questo il modo migliore per rilanciare la scuola. Né, banalmente, il lavoro giornaliero sul campo lascia intendere che: a) la pura repressione funzioni; b) insistere sul ristabilimento di un’autorità dell’insegnante calata dall’alto sia in grado di responsabilizzare chi apprende.
 Ma che cosa significa, in fondo, educare? In che cosa consiste questo compito? E che cosa significa, infine, costruire un ambiente di apprendimento? Chiunque lavori a scuola impara presto che la cosa più difficile da raggiungere è la creazione di una relazione positiva con chi sta dall’altra parte della cattedra. Questa relazione è complessa: non è data una volta per tutte, non è determinata da una norma precostituita, è sempre sul punto di rompersi o incrinarsi. La realtà quotidiana, del resto, mostra che l’educazione non consiste in una mera trasmissione di informazioni a soggetti passivi, che le identità (tanto quella del docente quanto quelle dei discenti) sono in continua formazione e che le variazioni, deviazioni, divagazioni, digressioni sono all’ordine del giorno. Le parole del Ministro tradiscono senza dubbio nostalgia per un passato idealizzato e lasciano intendere erroneamente che un proficuo rapporto educativo possa sorgere solo di fronte a una ferma devozione per i ruoli gerarchici. Non è così. E probabilmente non lo è mai stato, perché il processo formativo è per sua stessa natura dialogico: si fonda su un rapporto di fiducia che non è mai fissato a priori.
Ma che cosa significa, in fondo, educare? In che cosa consiste questo compito? E che cosa significa, infine, costruire un ambiente di apprendimento? Chiunque lavori a scuola impara presto che la cosa più difficile da raggiungere è la creazione di una relazione positiva con chi sta dall’altra parte della cattedra. Questa relazione è complessa: non è data una volta per tutte, non è determinata da una norma precostituita, è sempre sul punto di rompersi o incrinarsi. La realtà quotidiana, del resto, mostra che l’educazione non consiste in una mera trasmissione di informazioni a soggetti passivi, che le identità (tanto quella del docente quanto quelle dei discenti) sono in continua formazione e che le variazioni, deviazioni, divagazioni, digressioni sono all’ordine del giorno. Le parole del Ministro tradiscono senza dubbio nostalgia per un passato idealizzato e lasciano intendere erroneamente che un proficuo rapporto educativo possa sorgere solo di fronte a una ferma devozione per i ruoli gerarchici. Non è così. E probabilmente non lo è mai stato, perché il processo formativo è per sua stessa natura dialogico: si fonda su un rapporto di fiducia che non è mai fissato a priori.
Le più avanzate proposte pedagogiche contemporanee insistono proprio su questi aspetti: esse, pur non questionando mai l’importanza dei maestri, si oppongono all’idea di “educazione depositaria” (secondo la definizione del pedagogista Paulo Freire) basata sul mero trasferimento di dati e su una rigida asimmetria. La studiosa americana bell hooks [7], ad esempio, ha sostenuto con forza la necessità di ripensare i modelli d’insegnamento del mondo occidentale, tanto a scuola quanto all’università. L’educazione, scrive hooks, è un processo che mira essenzialmente alla costruzione di una «dimensione comunitaria» all’interno della quale, per tutti i soggetti coinvolti, possa dispiegarsi un ricco ventaglio di possibilità. Costruire comunità significa «riconoscere il valore di ogni singola voce», «accettare modi di conoscere differenti e nuove epistemologie», accogliere la possibilità del conflitto nelle sue potenzialità creative di nuove idee e punti di vista.
La studiosa americana parte da due assunti: 1) l’educazione non è mai politicamente neutra; 2) l’aula non è mai un ambiente neutro. L’obiettivo dell’insegnamento, dunque, non è quello di uniformare le diverse voci a quella di un indiscutibile potere superiore; né, d’altra parte, quello un po’ naïve di predicare una finta uguaglianza nel momento in cui si chiude la porta e inizia la lezione. Una pedagogia realmente aperta, al contrario, deve essere consapevole che ognuno di noi è portatore di una storia; deve quindi produrre uno spazio in cui l’uguaglianza è costantemente perseguita attraverso la valorizzazione delle differenze e la formazione di un clima in cui «tutti sentano la responsabilità di contribuire» senza essere consumatori passivi. Docenti e discenti, quando varcano la soglia, non lasciano mai indietro il proprio vissuto e i propri corpi, ma li portano in aula con loro. Far finta di essere soggetti neutri è solo una finzione utile, da una parte, ad assolutizzare il sapere trasmesso allontanandolo ancora di più dall’esperienza concreta e dalla vita di tutti i giorni; dall’altra, a distanziare i protagonisti della relazione educativa reiterando l’immagine di un passaggio unilaterale della conoscenza da cui non si può, pena un’immediata sanzione, deragliare.
Inutile negarlo, entriamo tutti in classe con un progetto o programma da seguire, ma come sperimentiamo quotidianamente e come sostiene hooks, l’insegnamento è sempre un «atto performativo»: esso genera cambiamento in chi insegna, in chi apprende, nel sapere cui si fa riferimento e nel processo educativo stesso. In classe, insomma, possiamo essere «tutti uguali nella misura in cui siamo ugualmente impegnati a creare un contesto di apprendimento»: la diversità e il conflitto devono essere concepiti nel loro valore generativo di possibilità e stimoli, anche quando sfidano apertamente convinzioni acquisite. E questo perché essere insegnanti, lungi dall’essere semplici addestratori con fini prestabiliti e inderogabili, significa prima di tutto «stare con le persone», con tutto il carico di difficoltà che ogni relazione porta con sé.
Tutto molto bello sulla carta, ma immagino già le obiezioni: come comportarsi di fronte a palesi insubordinazioni o a comportamenti violenti come quelli stigmatizzati dal Ministro? Contestualizzare è lecito quando uno studente colpisce un’insegnante con un pugno? Tu che avresti fatto al posto della collega di Gallarate? O al posto del Dirigente Scolastico? Beh, credo siano domande mal poste perché, esattamente come le parole del titolare del MIUR, tendono a compartimentalizzare un problema che riguarda non solo la scuola in quanto tale, ma la società tutta. Soprattutto si tratta di questioni che, puntando sull’emotività, finiscono col depoliticizzare gli spazi di deprivazione, illegalità e violenza strutturale quotidianamente agiti da molti dei nostri studenti, specialmente nei quartieri più disagiati, naturalizzandoli. Come educatori, invece, non siamo certo chiamati a inseguire atteggiamenti di rivalsa che parlano la stessa lingua della prevaricazione del più forte sul più debole che tanti alunni conoscono fin troppo bene. Noi, al contrario, quella lingua dobbiamo cercare di scardinarla: quando qualcuno sbaglia, allora, un sano intervento pedagogico può sperare di essere efficace solo se non veste i panni della ritorsione o dell’umiliazione, bensì del dialogo. Ciò non significa, ovviamente, giustificare tutto o abolire i provvedimenti disciplinari, bensì inserire questi ultimi all’interno di una meta-riflessione che coinvolga tutte le parti in causa e che apra la scuola alla più ampia realtà esterna.
Da questa prospettiva credo che le riflessioni di bell hooks possano entrare in risonanza con quelle di Tim Ingold, un antropologo che sta insistendo molto sulla necessità di abbattere i muri che dividono i contesti educativi formali dall’educazione tout court. Il progetto pedagogico di Ingold parte dall’antropologia (è anzi una particolare forma di “osservazione partecipante” di matrice antropologica), ma supera gli steccati disciplinari articolandosi sul concetto di «educazione all’attenzione». Tutti i discenti, scrive lo studioso britannico, imparano sintonizzandosi sull’ambiente ed entrando in relazione con gli altri: «la promessa dell’educazione sta nella capacità di rispondere e di ricevere risposta: senza questa abilità di risposta (response ability) […] l’educazione non sarebbe possibile».
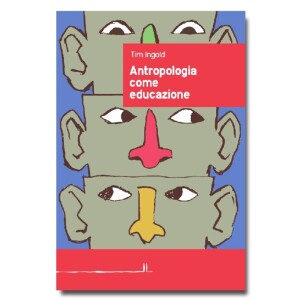 Tutti gli esseri umani, in fondo, sono dei discenti: essi non smettono mai di prestare attenzione all’ambiente, di rispondere alle sollecitazioni dei membri della comunità e di imparare secondo la formula che Ingold chiama «agire nel subire» («doing undergoing»): ovvero, fare tenendo sempre ben presente ciò che lo spazio (naturale e sociale) consente di fare. Un antropologo che spende mesi e mesi lontano da casa; uno studente che deve imparare a far di conto; un docente che deve calibrare le sue parole sulle persone che ha di fronte; un apprendista che osserva il maestro e affina progressivamente le proprie abilità: tutti studiano con gli altri, contemporaneamente osservando e facendo-subendo. L’insegnamento, allora, consiste in questa ineliminabile relazione in cui non si incontrano agencies assolute e indipendenti dal contesto, secondo un rigido «principio di volizione», bensì differenti modi di entrare in risonanza con le cose, secondo un più caritatevole «principio di attenzione».
Tutti gli esseri umani, in fondo, sono dei discenti: essi non smettono mai di prestare attenzione all’ambiente, di rispondere alle sollecitazioni dei membri della comunità e di imparare secondo la formula che Ingold chiama «agire nel subire» («doing undergoing»): ovvero, fare tenendo sempre ben presente ciò che lo spazio (naturale e sociale) consente di fare. Un antropologo che spende mesi e mesi lontano da casa; uno studente che deve imparare a far di conto; un docente che deve calibrare le sue parole sulle persone che ha di fronte; un apprendista che osserva il maestro e affina progressivamente le proprie abilità: tutti studiano con gli altri, contemporaneamente osservando e facendo-subendo. L’insegnamento, allora, consiste in questa ineliminabile relazione in cui non si incontrano agencies assolute e indipendenti dal contesto, secondo un rigido «principio di volizione», bensì differenti modi di entrare in risonanza con le cose, secondo un più caritatevole «principio di attenzione».
Come hooks, Ingold è convinto che l’educazione nel suo senso più autentico sia una pratica partecipativa e trasformativa in cui l’uguaglianza dei soggetti coinvolti non è data a monte, ma si raggiunga a valle, e solo quando ognuno si prenda veramente cura dell’altro (corrisponda responsabilmente, cioè) portando in dote la propria differente visione dell’unico mondo che abitiamo. Il fine non è replicare o imporre un sapere fisso, bensì generare una conoscenza di volta in volta nuova e aperta a nuove direzioni. Ciò, lungi dal mettere in crisi la figura dell’insegnante, la consegna a una rinnovata centralità: essere una guida, autorevole perché non autoritaria, in grado di seguire gli allievi nel loro graduale processo di sintonizzazione alle cose del mondo valorizzando la loro curiosità.
È evidente, allora, che non c’è spazio per stigma, umiliazioni o punizioni esemplari in uno scenario del genere. Da educatori dobbiamo sempre essere consapevoli del nostro posizionamento: tutto ciò che diciamo e facciamo in classe s’intreccia con ineludibili questioni di potere e ha un impatto enorme sulla società attraverso il nostro rapporto con le generazioni più giovani. “Le parole sono importanti!” – gridava un personaggio in una celebre sequenza di un vecchio film. Le parole aprono e chiudono interi universi simbolici; hanno una straordinaria presa performativa sul reale; veicolano miti, narrazioni e visioni del mondo che producono storia; includono ed escludono. Sta a tutti noi studiare con gli altri e non smettere mai di cercare il linguaggio più appropriato per esprimere e realizzare idee autenticamente libere, aperte e democratiche. Il rischio del fallimento, o che dall’altra parte ci si rifiuti di corrispondere, non rende questo compito meno urgente.
Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023
Note
[1] Alcuni dei Ministeri che hanno cambiato nome con l’insediamento della nuova Legislatura: «Famiglia, Natalità e Pari opportunità», «Agricoltura e Sovranità alimentare», «Ambiente e Sicurezza energetica», «Istruzione e Merito», «Imprese e Made in Italy». La scelta dei termini (qui riportati in corsivo) non è casuale.
[2] Ovviamente la recente vittoria elettorale della destra, con la storica nomina della sua leader alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è giunta inaspettata e ha semmai suggellato un processo di sdoganamento che si può fare iniziare almeno ai primi anni Novanta del Novecento. Da quel momento, infatti, gli eredi del Movimento Sociale Italiano hanno regolarmente sostenuto gli esecutivi di centro-destra in carica e hanno ricoperto prestigiosi incarichi governativi (alla guida di importanti Ministeri) o istituzionali (alla presidenza di uno dei due rami del Parlamento).
[3] Appadurai parla di «primordialismo», intendendo con questo termine il richiamo di certi gruppi etnici, o di interi stati-nazione, a supposti valori atavici connessi a un’idea di popolo indissolubilmente legato a un territorio.
[4] Il titolo originale del più famoso libro di Appadurai, Modernity at large, gioca sulla polisemia dell’espressione inglese at large, che può significare “nel suo insieme” o “in libertà, senza permesso”. L’autore vuole evidentemente richiamare i modi tortuosi e sempre nuovi con cui la modernità si declina localmente e per questo motivo il traduttore italiano, Piero Vereni, pur rinunciando a una resa letterale, ha coniato la felice formula “modernità in polvere”.
[5] È molto difficile condensare in poche righe una ricerca serrata e complessa come quella che Jesi ha intrapreso a partire dagli anni Sessanta del Novecento. Voglio però precisare che la riflessione dello studioso piemontese non mira certo a sbarazzarsi del mito – di narrazioni mitiche, infatti, nessuna cultura può fare veramente a meno. Piuttosto, egli ritiene che il mito venga deformato e alterato quando certe comunità si rapportano ad esso in modo non sano cercando di applicarlo acriticamente al presente o di fondare, tramite esso, i loro giudizi oltre lo storico e il sociale. Da questo punto di vista il concetto di «macchina mitologica» e la dicotomia «mito genuino» Vs «mito tecnicizzato» (ovvero politicizzato) sono decisivi per comprendere a pieno il pensiero di Jesi e l’attenzione da lui posta al rapporto storico degli esseri umani con la dimensione mitica.
[6] La dichiarazione del Ministro è tratta da un articolo de Il Post datato 24 novembre 2022: https://www.ilpost.it/2022/11/24/giuseppe-valditara-umiliazione-crescita/
[7] bell hooks, pseudonimo di Gloria Jean Watkins, è stata una delle più importanti esponenti del femminismo contemporaneo. Interessata all’intersezione tra questioni di potere, razza, genere ed educazione, ha scelto di usare un nome con le iniziali in minuscolo per porre l’accento sul suo pensiero, più che sulla sua persona.
Riferimenti bibliografici
Appadurai A., 2001, Modernità in polvere, Meltemi, Roma.
Appadurai A., 2005, Sicuri da morire. La violenza nell’epoca della globalizzazione, Meltemi, Roma.
hooks b., 2020, Insegnare a trasgredire. L’educazione come pratica della libertà, Meltemi, Milano.
hooks b., 2022, Insegnare comunità. Una pedagogia della speranza, Meltemi, Milano.
Ingold T., 2019, Antropologia come educazione, Edizioni La Linea, Bologna.
Jesi F., 2011, Cultura di destra. Con tre inediti e un’intervista (a cura di Andrea Cavalletti), Nottetempo, Roma.
_____________________________________________________________
Dario Inglese, ha conseguito la laurea triennale in Beni Demo-etnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e la laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Si è occupato di folklore siciliano, cultura materiale e cicli festivi. A Milano, dove insegna in un istituto superiore, si è interessato di antropologia delle migrazioni e ha discusso una tesi sull’esperimento di etnografia bellica Human Terrain System.
______________________________________________________________








