di Antonello Ciccozzi
Mahsa e le altre
Mahsa Amini era una ragazza di 22 anni di una provincia curda dell’Iran. Il 13 settembre 2022 si trovava a Tehran con la famiglia quando fu arrestata dalla polizia morale perché indossava l’hijab, il velo islamico, in modo non abbastanza aderente, ovvero non rispettoso dei dettami della Sharia. La ragazza è morta dopo tre giorni di coma a seguito dei pestaggi subiti in prigione. La polizia parla di un infarto, il suo corpo racconta un supplizio. Da allora Mahsa Amini è diventata il simbolo delle proteste che infiammano la Repubblica islamica dell’Iran. Ad oggi durante gli scontri sono state uccise 500 persone, 18 mila sono stati gli arresti e per due manifestanti è stata eseguita la condanna a morte (mentre altri 80 rischiano di subirla).
Queste righe sono dedicate a Mahsa Amini, a Saman Abbas e alle altre donne che, in luoghi e forme diversi, lottano contro la Sharia. Discutono del loro diritto umano – sistematicamente negato – di togliere il velo, e della nostra opportunità intellettuale – spesso trascurata – di pensare a queste vicende distinguendo tra scelte e obblighi, e quindi ragionando in modo prioritario sul rapporto e sulle differenze che intercorrono tra Islam e islamismo [1].
In TV parla una giovane donna iraniana. È girata di spalle, è in incognito. Si esprime in un buon italiano, segno che è qui da tempo. Spiega che nel suo Paese di provenienza la popolazione protesta per la libertà di scelta, contro il fatto che lo Stato usa il velo per esercitare il suo potere sul corpo delle donne. Il Governo iraniano comanda questo obbligo in modo talmente insopportabile che finanche le donne che il velo lo portano per scelta, per credo religioso, postano dei video di protesta in cui lo tagliano con delle forbici. La trasmissione in questione è la puntata del 21 ottobre 2022 del talk-show pop-progressista “Propaganda live” in onda sull’emittente La7 [2]. A un certo punto il conduttore e protagonista Diego Bianchi – un personaggio sempre platealmente engagé – sottolinea che «tanti pensano che sia una protesta contro l’obbligo di portare il velo», aggiungendo subito «invece no!». Invece no? Ma come? si è sbagliato? non ha capito nulla? o fa inconsciamente in modo di seguitare a non voler capire nulla? a non capire che, invece sì, è proprio una protesta contro l’obbligo di portare il velo.
Intendiamoci, ho apprezzato il gesto di dare finalmente voce a chi si ribella all’islamismo, tantopiù che Diego Bianchi il 4 marzo dello stesso anno aveva invitato l’attivista iraniana Masih Alinejad che da anni si batte proprio contro l’obbligo del velo. È che ritengo che questo lapsus sia sintomatico di un certo bias islamofilo, in gran parte poco consapevole. Si tratta di una postura ideologica di fondo, dove, in nome di un precetto di apertura e di difesa dell’alterità, per proteggere l’Islam dall’islamofobia si finisce a volte con il tutelare indirettamente l’islamismo dalla democrazia.
Come dicevo negli altri interventi che ho fatto su Dialoghi Mediterranei, la questione riguarda un problema diffuso nella cultura progressista, un’attenzione selettiva dove all’onere morale di non porgere mai il fianco alle destre occidentali, al fascismo nostrano, corrisponde una frequente se non sistematica distrazione opposta e complementare di rimozione del rischio di porgere il fianco al fascismo esotico (un ur-fascismo [3] che monta dai Sud del mondo e che si manifesta prevalentemente come islamismo [4] e come generico odio antioccidentale). Il tutto tocca anche il campo accademico delle scienze umane, da anni egemonizzato sotterraneamente dal paradigma dominante della critica postcoloniale che, per quanto foriero di irrinunciabili momenti di giudizio e di emancipazione del pensiero da una serie di vizi etnocentrici, sottende spesso un eccesso dogmatico che ci induce a una postura xenofila generalizzata per cui ciò che viene dall’altro non può fare altro che arricchire (e a una complementare e opposta oicofobia, un odio di sé dove in fondo l’unica forma dell’Occidente ammessa è quella del progressismo radicale espiatorio orientato ad eliminare tutto ciò che in qualche modo radicato, identitario). Da anni, quando un musulmano come persona, come gruppo o come Stato, uccide dichiaratamente in nome di Allah, la conclusione è che “l’Islam non c’entra”; ed è anche così che in Occidente entra l’islamismo. È così che la Sharia entra anche grazie alla cornice di immunità prodotta da questo mantra. Lo fa in una molteplicità di modi, beneficiando anche della protezione data dall’accusa di “islamofobia”, estesa a un livello strumentale che va ben oltre la denuncia delle discriminazioni reali contro i musulmani, usata come tribunale dell’Inquisizione contro qualsiasi dubbio che osi toccare in qualsiasi modo la semiosfera dell’Islam.
Il punto è che in un certo senso le donne e gli uomini che in questi giorni muoiono in Iran muoiono anche per noi. Si stanno immolando per difendere la libertà delle donne di togliersi il velo, e non solo: muoiono perché vorrebbero vivere in una società dove la religione non è tradotta in obbligo di legge che domina tutti gli aspetti della vita quotidiana fino agli interstizi più intimi dell’esistenza. Lo fanno anche per invitarci a toglierci certi paraocchi ideologici: hanno il coraggio che noi non abbiamo nell’affrontare il contagio islamista che ha ingabbiato la loro società, e che da anni dilaga nel mondo musulmano e nel mondo intero. Muoiono perché rifiutano la Sharia, non per islamofobia.
 Distinguere l’Islam dall’islamismo: la religione e i suoi usi sociali
Distinguere l’Islam dall’islamismo: la religione e i suoi usi sociali
L’Islam c’entra? C’entra questa religione con violenze, sopraffazioni, condanne a morte, attentati che da anni vediamo consumarsi, a partire da carnefici che sottolineano di agire proprio in nome di quello che loro ritengono sia il vero Islam? Rispetto a questa domanda il senso comune occidentale è da anni polarizzato tra una tendenza generalizzante islamofoba conservatrice e sovranista, che vede nell’Islam la religione della sottomissione, la fonte di tutti i mali (da cui “è colpa dell’Islam!”) e una tendenza islamofila progressista e immigrazionista, che vede nell’Islam la religione della pace, la religione che arriva dal Sud del mondo, il credo più rappresentato e più rappresentativo dei portatori di diversità che non farebbero altro che arricchire (da cui “l’Islam non c’entra!”). Qui va sottolineato che ‘pace’ – che nell’Occidente laico significa concordia, serenità, calma, assenza di guerra, libertà dall’oppressione – nel senso musulmano del termine significa proprio “sottomissione”, intesa come sottomissione ad Allah. Va specificato che, in funzione dell’intensità della loro fede, per i musulmani la sottomissione al loro Dio non è una mera “obbedienza”, non è una prigionia, un’assenza di libertà, ma, come avviene anche nel senso biblico del termine, la parola ‘sottomissione’ inerisce a un affidarsi alla divinità accettando il suo ordine.
Questo per chiarire che, da questo punto di vista, l’Islam è sia una religione di pace che di sottomissione; che, in questo incontro tra semiosfere, la parola ‘pace’ si carica di una polisemia caratterizzata da una forte ambivalenza (che si manifesta dal momento in cui due termini in senso laico contrapposti – pace e sottomissione – rimandano invece a una convergenza da una prospettiva religiosa). Ma il punto è che stare a discutere se l’Islam c’entri o meno con la violenza suggerisce una prospettiva interpretativa fallace, fuorviante; soprattutto dal momento in cui la domanda proietta la questione su una logica binaria e generalizzante che prevede risposte del tipo “sì/no”, “vero/falso”.
L’errore di fondo sta nel fare confusione tra le religioni e il loro uso sociale: è inutile, fuorviante e controproducente stare a discutere sui temi della violenza o della coercizione, riducendo la questione nei termini in cui queste siano o meno enunciativamente presenti nel Corano. È inutile non solo perché una certa dose di violenza emerge da vari enunciati disseminati nei testi sacri di diverse religioni. È fuorviante non solo perché, almeno da un punto di vista scientifico-umanistico, i testi sacri vanno intesi come esiti di processi mitopoietici in cui è erroneo confondere tout court il linguaggio del mito con proposizioni di pensiero razionale, per individuare falle morali desumendole a partire da contraddizioni logiche che appaiono tali proprio a partire da questa confusione epistemologica. Cercare di spiegare certe pratiche focalizzando il ragionamento sull’Islam come religione e sul Corano come testo sacro è controproducente in quanto una religione – intesa come sistema dottrinale che i credenti intendono rivelato o increato – non dovrebbe essere del tutto confusa con i modi storici in cui le autorità sociali usano questo sistema come materia prima di una procedura di costruzione di un sistema giuridico.
Intendo dire che se nelle società semplici, arcaiche, tradizionali il rito si configurava plausibilmente come prima forma di governo [5] e la religione assumeva una funzione regolativa rivolta alla società [6] (ovvero il sacro era la risposta a una primitiva necessità di ordinamento e tendeva naturalmente a configurarsi come il luogo della norma), nelle società complesse, nel mondo contemporaneo, e in una cornice diacronico-evolutiva attraversata da disincanti scientifici del mondo e razionalizzazioni dell’esistenza, non è più così. Oggi, nel caso della rivoluzione teocratica iraniana del 1979 e non solo, il recupero di un rapporto primordiale tra la religione e la legge richiede un’opera di ritessitura, di costruzione, di ingegneria sociale molto più articolato e distinguibile dal passato più o meno remoto del mondo primitivo, tradizionale, antico. La religiosità che precedeva il pensiero scientifico-razionale è diversa da quella che nel presente si oppone ad esso. Oggi l’integralismo religioso è un atto di distinzione socioculturale e geopolitico principalmente rivolto contro l’Occidente secolarizzato.
In tal senso deve essere chiaro che a presiedere l’opera attuale di costruzione giuridica delle teocrazie – che siano esse compiutamente strutturare in un’architettura statuale o implicitamente emergenti in spontaneità rizomatiche terroristiche che le propiziano – non ci sono divinità eterne o antichi profeti. Oggi più che mai dietro alla religione che si trasforma in legge c’è il lavoro culturale di uomini che, nella forma di gruppi di potere, interpretano, rielaborano e transcodificano i testi sacri in un processo selettivo che enfatizza dei punti e ne adombra degli altri per farne un habitat di significati condivisi. Ciò al fine di trasfigurare la parola di Dio in legge in funzione di esigenze presenti di identità e di opposizione rispetto a uno scenario geopolitico che è chiaro agli artefici di questa trasformazione, tanto in termini di condizioni che di finalità, come cornice esterna e come propositi rispetto ad essa.
Così la religione diventa la base per imporre unidirezionalmente un impianto normativo, che segna un confine di difesa rispetto al mondo esterno e anche una frontiera da percorrere contro di esso. Diventa un modo per calare dall’alto dei pattern coercitivi altamente pervasivi, per sancire con rigore il campo di senso comune che i singoli sono vincolati a incorporare come habitus in una relazione di sudditanza assoluta. In questo processo gli individui sono obbligati, pena finanche la morte, a reificare quell’ordine sociale che, in un determinato momento storico e in un determinato spazio geografico, ha tradotto il sacro in un sistema obbligatorio di usi, di costumi, di prescrizioni, di divieti. Così, attraverso l’uso sociale della religione, il potere mira oggi a riprendersi la sua ricorrente caratteristica arcaica di non negoziabilità dal basso delle sue istanze, di assolutezza; mira a colonizzare senza possibilità di dissenso tutti gli ambiti della cultura antropologica di un luogo, o del mondo. Il tutto in un’ossessione continua di purezza rivolta ad annientare qualsiasi elemento di contaminazione, qualsiasi fonte di diversità rispetto all’ordine politico sacro che in tal modo si è costituito.
Questa distinzione tra religioni e usi sociali delle stesse non è peregrina, soprattutto rispetto a quanto avviene nel mondo musulmano: se il Corano è un testo sacro (secondo i credenti rivelato da Dio a Maometto 1400 anni fa, o increato quale espressione stessa della divinità), selezionarne 190 versetti su 6236 passando per la Sunna (un racconto collegato a Maometto che assume già carattere normativo e si manifesta secondo diverse varianti) al fine di farne un sistema giuridico da imporre al presente è un’azione umana; è un processo di costruzione di una semiosfera giuridica che rimanda al livello dell’uso sociale di testi religiosi. In quest’atto c’è il passaggio dal piano religioso a quello giuridico, dall’Islam alla Sharia. E in tal senso essere musulmani è diverso dall’essere islamisti, dove se tutti gli islamisti sono musulmani non tutti i musulmani sono islamisti.
La religione e l’uso sociale della stessa non sono, o almeno non sono più, due lati della stessa medaglia: esse, soprattutto oggi, sono in un rapporto di derivazione. Se per i non credenti un testo sacro è un prodotto culturale umano, storico, contingente, per i credenti un testo sacro è una manifestazione della divinità o la divinità stessa, una verità rivelata che si pone in modo necessario, assiomatico, fisso a ordinare la storia [7]. Però vi è un punto che esonera da qualsiasi disputa tra ragione e fede, e riguarda la contingenza, la storicità degli usi sociali dei testi sacri, della religione, nel suo variare nello spazio e nel tempo empiricamente osservabile. Se non possiamo entrare in merito allo statuto di verità della rivelazione religiosa è innegabile che la trasformazione contemporanea della religione in diritto è un atto politico, che si manifesta in base a una varietà di forme storico-sociali. Questo dovrebbe chiarire il motivo per cui, che si tratti un apparato di Stato o di terroristi in gruppo o come singoli, chi uccide dichiaratamente in nome di Allah afferma di farlo in quanto interprete del vero Islam, e il motivo per cui per altri musulmani gli stessi atti sono reputati come contrari al vero Islam. Strategie di dissimulazione (taqiyya) a parte, quest’ambivalenza tra sostegno e condanna mostra che vi sono diversi usi sociali della religione, differenti modi culturali di trasfigurare la stessa divinità in forme, finanche inconciliabili, di agire politico. Lo sguardo sulla religione non dovrebbe distrarci dalla contingenza storico-culturale dei suoi usi sociali. Per tutto questo ripeto che il problema non è l’Islam ma l’islamismo, non è il Corano ma la Sharia.
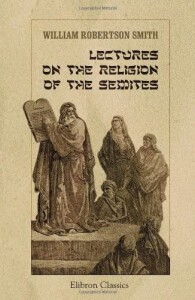 Moharebeh: quando il Governo si veste da Dio
Moharebeh: quando il Governo si veste da Dio
A questo punto ritengo che per comprendere il peso della Sharia, sulla vicenda iraniana ma anche sul presente globalizzato, sia opportuno sottolineare che oggi in Iran chi manifesta contro il Governo rischia la condanna a morte a partire dall’accusa di Moharebeh, ossia di “inimicizia contro Allah”. Questo reato, già applicato contro vari manifestanti, nel suo tradurre in modo limpidamente lineare una protesta contro un ordine di potere statuale in un atto di guerra contro Dio, mostra chiaramente come la natura assolutamente coercitiva delle teocrazie si sostiene attraverso un uso sociale della religione quale strumento per sacralizzare le istituzioni politiche, per renderle intoccabili attraverso la licenza di uccidere chi le contesta.
In tal senso ritengo che, pur avendo oltre un secolo di età, la lezione classica di Durkheim sulla funzione sociale del sacro sia oggi di grande utilità per rivelare l’essenza elementare, atemporale di certi meccanismi inerenti all’attuale presenza e affermazione di sistemi politici dispotici di tipo teocratico. Rifacendosi a Robertson-Smith, Durkheim giunge all’idea che nelle società primitive «il dio del clan, il principio totemico, non può essere dunque che il clan medesimo» [8] per desumere da ciò un principio generale di fondo secondo cui quando gli uomini adorano la divinità adorano la società stessa, trasfigurata in sembianze sacre: la divinità è la forma con cui la società ottiene consenso da parte dei suoi membri e con cui lo richiede ad essi, è la veste con cui li attrae e con cui li sottomette, con cui suscita in essi riverenza e con cui incute verso di essi timore. Nello specifico lo studioso sosteneva che:
«In generale, non c’è dubbio che una società possieda tutto ciò che occorre per risvegliare negli spiriti, con la sola azione che essa esercita nei loro confronti, la sensazione del divino; poiché essa è di fronte ai suoi membri ciò che un dio è di fronte ai suoi fedeli. Un dio, infatti, è innanzitutto un essere che l’uomo si rappresenta, per certi aspetti, superiore a lui e da cui crede di dipendere. Che si tratti di una personalità cosciente, come Zeus o Jahvè, oppure di forze astratte come quelle in gioco nel totemismo, il fedele, in un caso come nell’altro, si ritiene obbligato a certi modi di agire che gli sono imposti dalla natura del principio sacro con cui si sente in relazione. Orbene, anche la società mantiene vivo in noi il senso di una perpetua dipendenza. Essa ha infatti una natura propria, diversa dalla nostra natura di individui, e persegue scopi che le sono egualmente particolari: ma, poiché può attingerli soltanto per mezzo nostro, essa reclama imperiosamente la nostra collaborazione. Essa esige che, dimentichi dei nostri interessi, noi diveniamo i suoi servitori e ci obbliga a ogni sorta di avversità, di privazioni e di sacrifici senza i quali la vita sociale sarebbe impossibile. È così che a ogni istante siamo obbligati a sottometterci a regole di condotta e di pensiero che non abbiamo prodotto né voluto, e che anzi talvolta sono contrarie alle nostre inclinazioni e ai nostri istinti fondamentali. Tuttavia, se la società non ottenesse queste concessioni e questi sacrifici che in virtù di una costrizione materiale, essa non potrebbe risvegliare in noi che l’idea di una forza fisica a cui dobbiamo cedere per necessità, e non l’idea di una potenza morale del genere di quelle adorate dalle varie religioni. Ma in realtà, il dominio che essa esercita sulle coscienze deriva meno dalla supremazia fisica di cui ha il privilegio che dall’autorità morale di cui è investita. Se ci sottomettiamo ai suoi ordini, non è semplicemente perché essa dispone dei mezzi per vincere le nostre resistenze; è, soprattutto, perché essa è oggetto di un autentico rispetto» [9].
Nell’equazione secondo cui una società è per i suoi membri quello che è un dio per i suoi fedeli il sociologo francese intendeva sottolineare soprattutto che tutte le società tendono a sacralizzarsi e ad essere sacralizzate dai loro membri al fine di stimolare adesione, consenso, rispetto delle norme. Per Durkheim la verità della religione non risiedeva nell’esistenza di Dio ma nel sostegno della società. Se l’adorazione della divinità significa tributare consenso alla società, da ciò si evince che una società che obbliga in modo coercitivo all’adorazione della divinità sta costringendo i suoi membri al consenso assoluto verso le sue norme. Il punto è che più il potere persuasivo del sacro cede, più il sociale che usa quel sacro per persuadere le masse orienta il sacro in senso coercitivo contro di esse.
Da ciò si può affermare che il potere teocratico si sacralizza rappresentandosi come Dio che diventa Governo, e in condizioni normali questo atto di trasfigurazione lo legittima in termini di plausibilità, gli garantisce un anelito di adorazione, porta consenso. Dal lato opposto, il Governo diventa Dio, e questa direzione del potere si manifesta nel caso che il vento della storia si faccia turbolenza suscettibile a portare quel consenso a vacillare. Tale trasfigurazione nel sacro consente al Governo di legittimare in modo primordialmente efficace il ricorso all’uccisione degli uomini che contestano l’ordine sociale che esso esprime. Intendiamoci, la storia insegna che si può uccidere anche senza, ma uccidere in nome di Dio trasforma l’assassinio in sacrificio; e questo conferisce plausibilità etica assoluta all’atto (e la cosa funziona tanto a livello di Stati nazionali quanto a livello di singoli terroristi). Dio, nel suo uso sociale, è il modo più elementare per invocare un ideale superiore che suscita adorazione quale fonte di vita e impone adesione nella minaccia della morte. Oggi in Iran questo è lapalissiano, dal momento che chi contesta il governo offende Dio: il Moharebeh è una manifestazione netta e tangibile della mimesi del sociale in vesti religiose come mezzo di acquisizione di immunità assoluta del potere dalla possibilità di contestarlo, come sacralizzazione del politico quale pretesto di governo dispotico delle masse.
Questo aggrapparsi del potere politico alla divinità per rivendicare obbedienza assoluta è ancora più evidente dal momento in cui in Iran si è giunti a una situazione paradossale dove, insieme ad altri chierici, Abdolhamid Ismaeelzahi, la massima autorità religiosa del Paese, ha affermato che le uccisioni dei manifestanti da parte del Governo sarebbero contro la Sharia [10]. Questa dichiarazione di rottura è avvenuta dopo che la polizia ha sparato su un corteo di manifestanti, trucidando 80 persone. Il Governo ha cercato di delegittimare il leader religioso troppo potente per essere ucciso, ma i risultati sono stati scarsi. Un simile episodio mette in chiaro ancora di più la necessità di distinguere la religione dai suoi usi sociali, dal momento in cui perfino la Sharia può finire al centro di una tensione tra i politici e il clero che si contendono il monopolio interpretativo dei suoi contenuti normativi. Tutto questo non è affatto divino ma del tutto sociale.
Questa volontà politica di affermazione di una funzione primordialmente regolativa della religione deve scontrarsi con una realtà culturale caratterizzata da un’esasperazione crescente della popolazione dove, già da prima delle proteste, solo un iraniano su cinque dichiarava di voler ancora preservare i valori della rivoluzione religiosa tutelando la Repubblica islamica; dove, anche considerando che questi sondaggi vanno presi con beneficio d’inventario, risulta che il 60% degli iraniani non prega, dove oltre la metà della popolazione vorrebbe che i figli a scuola avessero l’opportunità di conoscere anche altre religioni; dove, soprattutto, il 58% dei cittadini non crede nel valore religioso del velo e il 72% lo rifiuta come imposizione [11].
 Il lato del velo che non vediamo
Il lato del velo che non vediamo
Il problema delle donne musulmane migranti che scelgono di indossare il velo, spesso anche come emblema di orgoglio identitario e di distinzione, e vengono discriminate in Occidente viene ampiamente trattato in ambito accademico; giustamente, in quanto si tratta di pratiche riconducibili a un razzismo culturalista che va affrontato e combattuto in nome del proposito di costruire una società che punti all’inclusione. In tal senso è opportuno mettere in evidenza i dispositivi di stigmatizzazione in base ai quali il velo delle donne migranti viene ridotto dai residenti a indice di arretratezza e pretesto di marginalizzazione a partire da uno sguardo gerarchizzante [12]. Altre volte si ha l’impressione di uno schieramento un po’ in eccesso che parte con il proposito di combattere le generalizzazioni xenofobe ma arriva a una postura xenofila in cui il velo emerge perlopiù come vessillo anticoloniale e simbolo di liberazione dal dominio straniero [13]. In questo modo ben poca attenzione è riservata al problema delle donne musulmane che, nel Sud del mondo come sempre di più nel Nord, vorrebbero togliere il velo ma sono obbligate a indossarlo da sanzioni che arrivano alla pena capitale. Insomma, sarà anche perché i veli hanno due lati, ma alla discriminazione occidentale contro le donne che vogliono indossare il velo si oppone la discriminazione islamista contro le donne che il velo vorrebbero toglierlo.
Il velo islamico, nella molteplicità di forme e pesi con cui si propone, può essere il mezzo con cui si oggettiva dal basso un’agency data da un desiderio di riconoscimento nella distinzione, ovvero uno strumento di soggettivazione decisa nell’atto della scelta individuale di quale sociale incorporare, di quali elementi di cultura materiale cristallizzare autonomamente come repertorio di sé. Oppure, all’opposto, il velo può essere strumento di un potere coercitivo che si impone dall’alto attraverso l’oggettivazione di una politica spiccatamente interstiziale, che usa pervasivamente i corpi passivizzati delle singole donne per reificarsi come ordine sociale.
La donna che decide di indossare il velo per segnare uno scarto dall’egemonia occidentale attraverso l’incorporazione di questo accessorio ornamentale è tutt’altra cosa dal dominio islamista che si realizza nell’imposizione del velo come strumento di sottrazione del corpo della donna dalla società. Scegliere individualmente il velo come habitus contro un campo egemonico è altro dal velo quale habitus imposto con la forza da un campo dominante contro un soggetto subalterno. Quando dico che il velo ha due lati intendo questo, e non si tratta solo del dovere cognitivo di non confondere un uso emancipatorio da uno coercitivo ma di quello ermeneutico di ammettere che oggi questi usi esistono entrambi nella pratica sociale, senza sminuire né la rilevanza dell’uno né quella dell’altro. Probabilmente dal punto di vista musulmano si tratta di due forme di jihad, ma questi due lati del velo rimandano alla polisemia di tale ornamento e all’ambivalente antropologia del corpo che in tal modo si delinea.
Se il velo scelto dalla migrante musulmana accende l’islamofobia dell’Occidente sovranista quello imposto è un presidio irrinunciabile su cui si appoggia l’islamismo; e lo fa con la complicità dell’Occidente progressista spesso involontaria, indiretta, derivata da questioni di simpatia intersezionale rispetto a un avversario comune: i conservatori, i sovranisti, le destre, i razzisti. Da un altro punto di vista entrambi i campi rimandano a una richiesta di conformità all’ordine costituito che si inscrive nella corporeità della donna, uno come divieto (la volontà sovranista occidentale di vietare il velo indossato come libera scelta) e l’altro come obbligo (la volontà teocratica islamista del velo imposto contro la libertà di non indossarlo). Ma il punto è che dovremmo comprendere che l’islamofobia, quella effettivamente diffusa in ambito sovranista, si combatte con un’educazione all’inclusione e in una cornice non negoziabile di diritto positivo; mentre a combatterla con l’islamofilia acritica, che grida all’islamofobia non appena si accenna a una qualsiasi critica in qualsiasi modo accostabile all’Islam, si finisce con il porgere il fianco all’islamismo, al diritto della Sharia.
E se l’avversione generalizzata contro il velo è segno d’islamofobia, la lotta all’obbligo del velo è lotta contro il fascismo islamista, per cui fare confusione su questo punto significa usare in modo inconsapevole o strumentale l’accusa di generalizzata islamofobia come cavallo di troia per veicolare l’islamismo. Se l’Islam comprende la scelta del velo come simbolo di fede, non si dà obbligo del velo senza islamismo, come pure non si dà islamismo senza obbligo del velo. In tal senso, se il velo islamico è un simbolo di fede facoltativo, libero, opzionale, il velo islamista è un simbolo politico obbligatorio, comandato, imposto. L’Islam è condizione necessaria ma non sufficiente al dispotismo islamista, rispetto al quale è sufficiente la Sharia (che è ciò che configura l’obbligo del velo, come aspetto particolare di un obbligo generalizzato del sacro).
La vicenda iraniana ha il merito di chiarire la sostanzialità della differenza tra scelta e obbligo del velo, e ad attiviste come la prima citata Masih Alinejad – in esilio dal 2009 e nel mirino dei servizi segreti iraniani – va riconosciuto il coraggio e la perseveranza di fare questa battaglia, anche contro un certo relativismo culturale occidentale che l’accusa degli stessi argomenti usati dal regime da cui scappa, ossia le imputa di riprodurre una nozione di superiorità dell’Occidente come Paese libero e democratico. L’attivista attribuisce questa mancanza di attenzione, di empatia e di solidarietà verso la sua battaglia, e quella della quasi totalità delle donne iraniane, proprio all’egemonia del paradigma della critica postcoloniale. Ci dice che l’aspetto paradossale di tale vicenda è che le femministe che giudicano queste attiviste come eterodirette dall’Occidente conservatore in fondo vorrebbero eterodirigere le donne iraniana per spiegare a loro quali lotte fare e quali no (a partire da una implicita postura di superiorità data dal loro essere occidentali progressiste). Questo comportamento delegittimante rimanda a dei pattern ricorrenti: usare sistematicamente le accuse di islamofobia e di filo-imperialismo occidentale per criticare chi lotta contro un totalitarismo teocratico che si situa in un orizzonte di imperialismo islamista [14].
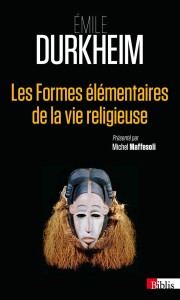 Il pericolo della tentazione della “esportazione di democrazia”
Il pericolo della tentazione della “esportazione di democrazia”
Senza dubbio le parole di Masih Alinejad vanno prese seriamente in considerazione, ma questo non può esonerarci, all’opposto, da un dovere di vigilanza verso le perenni tentazioni imperialiste che seguitiamo a riproporre anche nel Terzo Millennio, in base alle quali da anni, soprattutto in Medioriente, esportiamo disordine nella promessa di offrire soluzioni. Parlo del raggiro con cui le passate “missioni civilizzatrici” come moderno “fardello dell’uomo bianco” assumono oggi sembianze postmoderne di emancipazione attraverso la poetica delle “esportazioni di democrazia” usata come manto per veicolare politiche neoliberiste non può essere ridotto a complotto antioccidentale. All’opposto non possiamo nemmeno ridurre a complotto antimusulmano la nebulosa di segnali, di evidenze, di testimonianze di dissenso disperato e di sofferenze e violenze atroci che arrivano da quei luoghi. Dovremmo solo sperare, in Iran come altrove, in una rivolta autonoma e sempre più inarrestabile dei musulmani che vogliono togliere la Sharia dall’Islam. Possiamo sostenerli in tutti i modi, ma sempre senza pretendere di dirigere e strumentalizzare i loro desideri.
Il tutto, comunque, nella consapevolezza che la rappresentazione mono-imperialistica dell’Occidente che, unico, colonizza i suoi altrove si rivela come una nostalgia di modernità perduta e un costrutto della teoria postcoloniale: il presente postmoderno che viviamo è attraversato da intenzioni imperialistiche plurali dove, sempre più, anche gli altri, a torto o a ragione, tessono le loro trame di potere su di noi e sul mondo. In fondo, in un modo o nell’altro, oggi sono in molti a cercare di far indossare al prossimo i loro abiti culturali.
Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023
Note
[1] Preciso che in questo scritto riprendo dei temi già trattati su Dialoghi Mediterranei (Cfr.: Ciccozzi, 2021, 2022). Sono consapevole della vastità e del peso delle questioni qui in esame, per cui questo discorso non ha nessuna pretesa di essere completo e men che mai definitivo, lo propongo solo per tratteggiare una possibilità interpretativa.
[2] Il video dell’intervista è reperibile a questo link (e il lapsus del conduttore è al minuto 8:48): https://www.la7.it/propagandalive/video/il-protagonismo-delle-donne-in-iran-con-azade-lintervista-a-propaganda-live-21-10-2022-456832
[3] Eco, 2016.
[4] Se l’Islam è una religione basata principalmente sul Corano e poi sulla Sunna, l’Islamismo è un uso sociale dell’Islam in base a cui il Corano e la Sunna diventano materia prima di un’elaborazione giuridica, la Sharia. L’islamismo è un Islam politico, politicizzato, che, dato il suo carattere autoritario e tradizionalista, è denominabile anche come integralismo, fondamentalismo islamico o islamista ed è omologabile a una forma di fascismo. In tal senso si parla di islamofascismo, di fascismo islamista.
[5] Mi riferisco in senso ampio alla classica formulazione di Hocart (1936).
[6] Qui il rimando è alle tesi di Robertson-Smith (1972).
[7] Per una questione di trasparenza in merito al posizionamento, chiarisco che personalmente, da agnostico razionalista, sono scettico rispetto a tutte le religioni, così come un ateo non crede a nessun dio senza dubbio alcuno, così come un credente non ha bisogno di riscontri empirici per validare la sua fede, così come un integralista fa della religione la fonte unica di diritto.
[8] Durkheim, 1912.
[9] Ibid.
[10] https://www.iranintl.com/en/202212117200, https://www.iranintl.com/en/202212097671
[11] https://gamaan.org/
[12] Giacalone, 2021.
[13] Pepicelli, 2012.
[14] https://www.micromega.net/quando-le-femministe-sposano-il-relativismo-culturale/
Riferimenti bibliografici
Ciccozzi, A.,
2021, “Diversità che non arricchiscono: la questione dell’estraneità ostile nei reati culturalmente motivati”, Dialoghi Mediterranei, n. 51, settembre, Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/diversita-che-non-arricchiscono-la-questione-dellestraneita-ostile- nei-reati-culturalmente-motivati/.
2022, “Malintesi mediterranei: politically correct e rimozioni”, Dialoghi Mediterranei, n. 53, Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/malintesi-mediterranei-politically-correct-e-rimozioni/
Durkheim, É., 1912, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Alcan.
Eco, U., 2016, Cinque scritti morali, Milano, Rizzoli.
Giacalone, F., 2021, Tra hijab e pratiche sociali. Generazioni di donne musulmane in Italia, Milano, FrancoAngeli.
Hocart, A. M., 1936, Kings and Councillors, Il Cairo, Paul Barbey.
Pepicelli, R., 2012, Il velo nell’Islam. Storia, politica, estetica, Roma, Carocci.
Smith, W., R., 1972, Lectures on the Religion of Semites, New York, Schocken Books (ed. Or. 1889).
______________________________________________________________
Antonello Ciccozzi, è professore associato di Antropologia culturale presso Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. Si è laureato con una tesi sulla teoria ciresiana dei dislivelli di cultura. S’interessa dei processi di rappresentazione sociale della diversità culturale, di causalità culturale in ambito giuridico, di antropologia del rischio, dell’abitare, delle istituzioni, della scienza, delle migrazioni. Ha svolto ricerche etnografiche nell’Appennino rurale, in contesti di marginalità giovanile urbana, in ambito post-sismico, in luoghi di lavoro precario dei migranti.
______________________________________________________________









