di Giovanni Isgrò [*]
Per comprendere le origini dell’opera dei pupi, sarebbe molto riduttivo, come finora è avvenuto, cercare a tutti i costi il geniale inventore che per primo avrebbe messo in scena i paladini del ciclo carolingio. Piuttosto che limitarsi a ricostruire la vita artistica dei due presunti pionieri, ossia Gaetano Greco e Gaspare Canino, occorre allargare lo sguardo a quel complesso mondo del teatro festivo urbano in età sei-settecentesca a Palermo, alla evoluzione della cultura materiale e alla prassi lavorativa ad essa collegata; così come è opportuno cogliere il bisogno di ritualità e di relazione del pubblico popolare. Ma soprattutto occorre guardare alle contingenze storico-politiche nelle quali vanno collocati gli anni che videro nascere l’Opra.
Altrettanto importante è riconoscere la discendenza diretta del fenomeno “Opra” da quello del teatro delle “Vastasate” che per circa trent’anni, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, rivitalizzò fortemente la farsa popolare [1]. Affermatesi nei casotti in legno di Piazza Marina a Palermo, le vastasate avevano dato significato all’idea di un teatro che fosse espressione diretta della classe subalterna, contrapposto a quello della classe borghese e aristocratica, fino a quando gli interessi di impresari senza scrupoli spinsero le autorità locali a porre fine all’attività degli artigiani/attori protagonisti di questa stagione unica nel panorama della storia dello spettacolo in Sicilia. E fu proprio da questo mondo di performer legati alla pratica artigiana, rimasto escluso dalla scena nel corso del primo decennio dell’Ottocento che nacque l’idea di dar vita ad una nuova forma di spettacolo.
 Condivido con Meldolesi che se si vuole cercare una costante che accomuni la consuetudine espressiva nell’ambito della festa urbana in questi anni che preludono all’Opra, e la pratica dell’intrattenimento destinato al “basso” pubblico, questa costante è possibile individuarla nella logica della narrazione separata dei valori cerimoniali e tardo-feudali nei decenni in cui la Sicilia si affrancò dal rigidismo delle regole della monarchia ispanica a seguito del passaggio alla monarchia borbonica. In questa esplosione libera, fatta di trasgressione, dove la noia delle classi dominanti viveva la sua stagione di puro divertissement e di ricerca del “diverso”, la cultura popolare vigilava in attesa di trovare e configurare i termini della nuova ritualità.
Condivido con Meldolesi che se si vuole cercare una costante che accomuni la consuetudine espressiva nell’ambito della festa urbana in questi anni che preludono all’Opra, e la pratica dell’intrattenimento destinato al “basso” pubblico, questa costante è possibile individuarla nella logica della narrazione separata dei valori cerimoniali e tardo-feudali nei decenni in cui la Sicilia si affrancò dal rigidismo delle regole della monarchia ispanica a seguito del passaggio alla monarchia borbonica. In questa esplosione libera, fatta di trasgressione, dove la noia delle classi dominanti viveva la sua stagione di puro divertissement e di ricerca del “diverso”, la cultura popolare vigilava in attesa di trovare e configurare i termini della nuova ritualità.
La tecnica dei “trasparenti”, introdotta nella struttura delle macchine dei fuochi d’artificio in particolare nei primi decenni dell’Ottocento, contribuì notevolmente, come meglio si vedrà più avanti, ad alimentare la pratica della narrazione rappresentata attraverso immagini. Proveniente dall’esperienza maturata dal pittore Vincenzo Riolo durante il suo soggiorno a Roma, e condiviso da Nicolò Ranieri, l’impiego dei giganteschi trasparenti dipinti consentì una lettura scenograficamente figurata del racconto. La successione degli episodi, il narrare per immagini disposte in sequenza, come era avvenuto in età barocca nei quadroni dipinti collocati nella navata centrale della cattedrale, specialmente in occasione del Festino di Santa Rosalia, precisò la logica cinetica del racconto, sposandosi con la predisposizione popolare a farsi trascinare da intrattenimenti di lunga durata.
In un certo senso si può dire che la presenza, all’interno dello scenografismo del Festino di Santa Rosalia, di pittori operanti nel teatro fece sì che la scenotecnica urbana si intrigasse con il teatro stesso e che questo luogo dell’evasione programmata potesse diventare adesso l’elemento trainante del laboratorio della sperimentazione spettacolare della festa. Uno scambio, questo, emblematico sotto il profilo di una prassi possibile che dovette in qualche modo determinare fenomeni di discesa all’interno della genesi del teatro popolare.
In questo intrecciarsi di figurazioni si rese necessario individuare un elemento coagulatore che fosse riferimento sicuro: una sorta di identificazione di una presenza antica e di forte proiezione rituale. Questo vate nostrano, mimetizzato nella consuetudine della quotidianità, fu il “contastatorie”. Figura di secolare memoria, mai fissata nella pagina scritta, indicò naturalmente agli artisti-artigiani il percorso della nuova ritualità e della relazione che il popolo cercava. Ecco come Giuseppe Pitrè ha descritto, sia pure riferendosi ad anni successivi a quelli dell’origine dell’Opra, la performance del cantastorie.
«Armato di un bastone a forma di spada, che vuol essere quella di Rinaldo, presenta un dopo l’altro i suoi personaggi e li fa parlare come ragion comanda; ne ripete per punti e virgole i discorsi e i dialoghi; ne declama le arringhe; schiera in ordine di battaglia gli eserciti cristiani ed i turchi e li conduce agli scontri agitando energicamente le mani e piegando in ogni maniera la persona tutta. Nel fervore della mischia, dà un passo avanti, un passo indietro, levando in alto quanto può i pugni chiusi e slungando e piegando convulsamente le braccia. I suoi occhi si spalancano e schizzano fuoco, le narici si dilatano e la voce si fa concitata e rauca; i piedi pestano incessantemente il suolo, che per vuoto di sotto rintrona; alternansi i movimenti di va e vieni, e fra mozze parole e tronchi accenti muore chi ha da morire, fugge chi deve fuggire, cioè i pagani, gli infedeli, i turchi, i mori come il narratore indistintamente li chiama, e teste e braccia e scudi ed elmi rotolano attorno ad un mucchio di cadaveri, dove pur giace pietosamente qualche valoroso cavalier cristiano. Quasi per incanto, tutto torna calmo come se nulla fosse stato, mentre ducento, trecento uditori sono rimasti sorpresi, trepidanti, sull’esito della pugna piegante a favore ora dei loro cari cavalieri, ora degli odiati figli di Maometto» [2].
 Sul piano della cultura materiale, la scelta del legno in sostituzione della stoffa adoperata per i tradizionali burattini a filo fu in un certo senso determinata dalla necessità di tradurre in modo adeguato il movimento rigido, fortemente ritmato, del pupo. Del resto, la familiarità con l’uso del legno per la realizzazione di statue anche per le decorazioni delle macchine del teatro festivo era molto diffusa nelle botteghe artigiane.
Sul piano della cultura materiale, la scelta del legno in sostituzione della stoffa adoperata per i tradizionali burattini a filo fu in un certo senso determinata dalla necessità di tradurre in modo adeguato il movimento rigido, fortemente ritmato, del pupo. Del resto, la familiarità con l’uso del legno per la realizzazione di statue anche per le decorazioni delle macchine del teatro festivo era molto diffusa nelle botteghe artigiane.
Ancora nel 1847 in uno dei capitoli di appalto per la realizzazione del carro trionfale di Santa Rosalia si fa obbligo di «eseguire di legno le teste, braccia e gambe di tutte quelle figure e geni che gli saranno ordinati, [...] quali figure si dovranno unire facendo eseguire le rispettive ossature dall’appaltatore falegname, indi vestirle sopra la machina con quella tela doppia di buona qualità di diversi colori» [3].
Nella ricerca della nuova ritualità, gli ex artisti delle vastasate, fossero essi stessi artigiani o collegati indirettamente con questo mondo, dovettero trovare più consono e naturale attingere all’esperienza del teatro festivo per dare forma alla nuova idea: l’uso del legno, della stoffa vivacemente colorata, della plattina, ossia delle lamelle di rame utilizzate per la realizzazione di elmi, corazze, scudi, schinieri e attrezzeria, non era altro che una sorta di adattamento alla nuova forma di tecniche già acquisite. Allo stesso modo, effetti scenoluminotecnici e catturanti risoluzioni scenografiche, rientravano abbondantemente nella prassi del gioco scenico degli effettismi messo in atto per secoli nella consuetudine del teatro urbano.
A questo punto però è arrivato il momento di porre all’attenzione una componente tanto fondamentale, quanto finora ignorata da chi si è occupato dell’origine ma anche delle caratteristiche dell’Opra, ossia quella collegata al ruolo avuto dai padri gesuiti. Espulsi dalla Sicilia nel 1767, quando vi fecero ritorno nel 1805 la grande avventura della vastasata, come si è visto, stava per esaurirsi. Sbarcati nell’isola, i padri della Compagnia di Gesù furono accolti con grande entusiasmo dal popolo palermitano. In particolare la vecchia generazione artigiana, ma anche quella nuova erede della sapienza lavorativa antica, riconobbe l’importanza della loro presenza rassicurante e protettrice del lavoro quotidiano nel segno della loro azione evangelizzatrice. Subito infatti essa riprese ad attuarsi attraverso le missioni popolari, a contatto diretto con le classi meno agiate nei mercati, nelle case e nelle botteghe, dove si continuava ad attivare il metodo gesuitico del rappresentare.
La Casa Professa di Palermo, insieme al Collegio Massimo, diventò in questo modo nel giro di pochi anni, la cabina di regia di un programma edificante ben strutturato e pensato. Fu così che riprendendo un percorso di risignificazione storica da loro avviato alla fine del ‘500 riguardante la memoria della celebrazione del mito dei Normanni, eroi della ricristianizzazione dell’Isola, disceso a sua volta nell’immaginario della cultura popolare, i gesuiti sostennero l’idea dei re Borboni riguardo all’opportunità di identificarsi quali eredi della monarchia degli Altavilla; da qui la ripresa dell’immagine dei protagonisti della lotta vittoriosa contro gli “infedeli” e della configurazione della pace mediterranea.
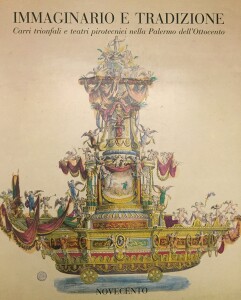 In questo modo, l’esigenza della monarchia dominante si collegava alla memoria della nobiltà siciliana, che guardava con orgoglio al tema della rifondazione del Regno di Sicilia. In questo quadro si afferma una ricca produzione di arte figurativa guidata da artisti come Patania, Riolo, Patricolo, Velasco, autori di dipinti realizzati su commissione dei Borboni per il Palazzo Reale (chiamato appunto Palazzo dei Normanni), che si incontrano anche nella pratica festiva dell’effimero con la narrazione riportata nei citati tabelloni dipinti per la Cattedrale di Palermo in occasione del Festino di Santa Rosalia. Ma era dovuto soprattutto ai “trasparenti”, cui prima si faceva cenno, facenti parte delle macchine dei fuochi d’artificio, l’attrazione visiva maggiore per le masse in festa, vero argomento di ispirazione per il teatro di figura dei nostri artigiani, oltre che per la nascente pratica della pittura sui carretti.
In questo modo, l’esigenza della monarchia dominante si collegava alla memoria della nobiltà siciliana, che guardava con orgoglio al tema della rifondazione del Regno di Sicilia. In questo quadro si afferma una ricca produzione di arte figurativa guidata da artisti come Patania, Riolo, Patricolo, Velasco, autori di dipinti realizzati su commissione dei Borboni per il Palazzo Reale (chiamato appunto Palazzo dei Normanni), che si incontrano anche nella pratica festiva dell’effimero con la narrazione riportata nei citati tabelloni dipinti per la Cattedrale di Palermo in occasione del Festino di Santa Rosalia. Ma era dovuto soprattutto ai “trasparenti”, cui prima si faceva cenno, facenti parte delle macchine dei fuochi d’artificio, l’attrazione visiva maggiore per le masse in festa, vero argomento di ispirazione per il teatro di figura dei nostri artigiani, oltre che per la nascente pratica della pittura sui carretti.
I bozzetti dei trasparenti dipinti da Vincenzo Riolo sono ancora oggi conservati presso la Galleria Regionale di Palermo dove si trovano anche disegni di Giuseppe Patania e dello stesso Vincenzo Riolo in parte su tema normanno (fondo Sgadari Lo Monaco). Per quanto riguarda i dipinti di Patricolo, Riolo e Patania che abbelliscono la Sala Gialla del Palazzo Reale di Palermo, vale la pena ricordare che furono commissionati da Leopoldo, conte di Siracusa e luogotenente generale della Sicilia, figlio di re Francesco di Borbone e fratello del nuovo re delle due Sicilie Ferdinando II. E fu lo stesso conte di Siracusa ad ispirarsi all’ingresso di Ruggero d’Altavilla a Palermo nella mascherata del 1835 quando sfilò su un carro preceduto e seguito da cavalieri con corazze ed elmi con pennacchi; una sorta di aggiornamento paladinesco che improvvisamente sembrò richiamare le nuove soluzioni costumistiche dell’Opra dei pupi e che si perpetuò in altre mascherate degli anni immediatamente successivi [4].
Sul piano della pratica artigiana la riformulazione dei meccanismi del teatro festivo, la stessa soppressione delle corporazioni e dei loro rigidi statuti avvenuta nel 1822 contribuì ad una più libera organizzazione e distribuzione del lavoro, potendo l’arte delle diverse botteghe sconfinare in specializzazioni affini. Si pensi, ad esempio, ai maestri addobbatori che ebbero la possibilità, finalmente, di occuparsi di costumistica e di provvedere essi stessi a vestire le statue delle loro decorazioni. Le stesse parate dei cortei paratattici, con la mostra dei costumi cerimoniali, l’incedere solenne dei cavalieri e delle centinaia di partecipanti, privati del loro antico senso rituale, sembrarono formulazioni sceniche disponibili per un diverso uso, cui si aggiunsero riflessi di spettacolari aggiornamenti.
La stessa ideazione dei trasparenti si legò ad un fenomeno artistico molto articolato e di ampie prospettive che coinvolse eccellenti pittori siciliani della prima metà dell’Ottocento, impegnati oltre che nell’effimero urbano, anche nella ritrattistica e nella scenografia teatrale, i cui contenuti in parte finirono per intrecciarsi con gli orientamenti politici della monarchia borbonica. Fu così che, prima ancora dei paladini di Francia, i combattimenti dei cristiani guidati dal granconte Ruggero contro i saraceni fino al gesto di omaggio all’eroe vincitore, raffigurati nel palazzo reale di Palermo come nelle macchine dei fuochi d’artificio del Festino di Santa Rosalia, entrarono nel progetto scenico del nuovo teatro di figura.
Il teatro dei pupi ispirato al mito dell’eroe normanno occupa il tempo intermedio tra la fine delle vastasate e l’entrata in scena dei paladini di Francia legati, come si suole affermare, all’avvento di Canino e Greco, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta dell’Ottocento. È in questo poco più che ventennale percorso, poi oscurato dal definitivo consolidarsi di un’arte di grande attrazione popolare animata dal protagonismo eroico di Orlando e Rinaldo, che si misura l’apporto degli artigiani della festa urbana di cui si è parlato nelle pagine precedenti, e soprattutto la lezione scenica dei padri della Compagnia di Gesù. Non a caso l’Opra dei pupi paladini continuò ad utilizzare l’idea dei gesuiti, messa in atto nel ventennio di ispirazione normanna, di associare all’azione del teatro di figura l’apporto artistico dei musici “orbi” da loro riscoperti e valorizzati.
Né si spezzò il filo rosso che legò ancora il teatro dei pupi paladini alla vastasata come testimonia fra le altre cose il fatto che furono proprio gli artigiani della farsa dialettale palermitana dei casotti ad introdurre nell’Opra il personaggio principale della loro invenzione scenica dell’ultimo Settecento, ossia Nofriu. Nel teatro dei pupi Nofriu il comico, il vastaso, l’irriverente, poteva prendere in giro Carlo Magno o criticare i personaggi più importanti dello spettacolo, e soprattutto difendere le ragioni dell’oprante durante i battibecchi fra questi e gli spettatori. Nofriu era dunque l’erede del teatro vastaso introdotto nell’invenzione dell’Opra, così come sul piano materiale l’uso del legno adoperato per realizzare il corpo dei pupi; analogamente il tessuto dei costumi dai colori accesi per essere visibili da lontano nel corso dei cortei, non poteva non uscire dalle mani degli artigiani del teatro festivo urbano. Lo stesso uso delle corazze, degli elmi, degli schinieri e delle spade non poté non nascere nelle botteghe dei vicoli specializzati nell’uso del metallo applicato anche alle figurazioni dei vari elementi della festa. E si trattò anche di trasferire “in piccolo” la pratica dei congegni applicata nei carri processionali o nelle rappresentazioni mute, fino al movimento meccanico degli automi. La stessa pratica costruttiva dei personaggi in cartapesta si prestò a sua volta ad alimentare l’esperienza artigiana poi utilizzata nella gestazione dell’Opra dei pupi.
Su un altro piano è utile dare significato e valore all’essere stati gli affreschi di Palazzo Steri raffiguranti i costumi, le corazze, gli elmi dei paladini e l’abbigliamento dei saraceni ad ispirare gli artigiani che a poca distanza dalle loro botteghe e dai casotti adattavano alla loro impresa quanto rappresentato nel tempio massimo dell’epopea cavalleresca siciliana.
Se pensiamo che tutto questo accadeva ancor prima della discesa in campo dei Canino, dei Greco e dei Crimi (a Catania), in un contesto di vera euforia artigiana scatenata su scala urbana, ci rendiamo conto dell’importanza di una gestazione già compiuta rispetto all’arrivo dei cosiddetti pionieri dell’Opra; singoli sperimentatori, provenienti in parte da realtà estranee alla tradizione dello spettacolo siciliano. Né è secondario il fatto che proprio Canino non disdegnò di esibire nel suo teatro un sipario raffigurante l’entrata del granconte Ruggero a Palermo; testimonianza importante, questa, della ricerca di una continuità rispetto alla stagione precedente a quella dei paladini, dalla quale l’Opra dei pupi, come si è visto, discendeva.
Ed eccoci di nuovo al ruolo del cantastorie. Dalla necessità di individuare una strada possibile, di fronte alla diaspora dei comici vastasi, nacque il fenomeno dell’adattamento scenico del mestiere di questo spettacolare narratore solista e, al tempo stesso, la riscoperta di quella ritualità perduta dopo il declino della cerimonialità del teatro urbano sei-settecentesco. Si approdò così a quella che Meldolesi ha definito «la più articolata invenzione regionale del teatro contemporaneo»[5] che non abbandonò mai sullo sfondo la drammaturgia embrionale del cuntu, e con essa l’espressionismo ritualizzato delle azioni festive e le forme della tradizione pre-teatrale; tutte aree di addestramento che poi avrebbero portato, come sostiene ancora Meldolesi, allo spettacolo maggiore, da Grasso a Pirandello, nel quale pure rimasero vibranti valori di preteatralità. È dalla preteatralità, dunque, che prese forma il genere dell’Opra, nata dal bisogno di sopravvivenza di artigiani-artisti, geniale in sé e foriera di virtualità favorevoli alle selezioni del futuro; una forma scenica che poggiò su basi povere, semplici ed elementari eppure orientabile verso la soglia dell’arte, capace di far recuperare alla Sicilia la sua indipendenza teatrale.
Nel mistero che ancora avvolge l’atto di nascita dell’Opra dei pupi un dato emerge con chiarezza, ossia che essa si impose intanto che la vita teatrale in Sicilia continuava a cercare di uniformarsi alle forme importate dal continente. Fu così che da quella difesa di un’identità di tradizione che rifiutava il convenzionalismo allora trionfante e che sembrava anacronistica e perdente, scaturì una forma scenica che sarebbe durata nel tempo, sostenuta peraltro da una componente fondamentale di riscatto popolare. È il valore autentico dell’eroismo prima normanno, poi paladinesco contrapposto all’indifferenza della cultura borghese per il teatro dell’opra; un genere che poté crescere finalmente senza essere condizionato da velleità di omologazione ad altre forme di teatro importato, fino a raggiungere la dimensione del mito.
 Meldolesi, in una appassionata conversazione dalla quale traggono spunto alcune di queste considerazioni che qui riporto, definì l’Opra anche come «il mitico spettacolo di un popolo lungamente colonizzato». Ci siamo chiesti allora come mai l’Opra adottò come personaggi principali i paladini di Carlo Magno. La risposta che ci sembrò più convincente fu che gli eroi della corte di Francia non furono acquisiti nella loro identità storica, ma per le caratteristiche di idoli immaginabili come patrimonio “naturale” della nostra Isola, e per questo riconosciuti dal nostro popolo, come sarebbe successo a Napoli col mito di Maradona.
Meldolesi, in una appassionata conversazione dalla quale traggono spunto alcune di queste considerazioni che qui riporto, definì l’Opra anche come «il mitico spettacolo di un popolo lungamente colonizzato». Ci siamo chiesti allora come mai l’Opra adottò come personaggi principali i paladini di Carlo Magno. La risposta che ci sembrò più convincente fu che gli eroi della corte di Francia non furono acquisiti nella loro identità storica, ma per le caratteristiche di idoli immaginabili come patrimonio “naturale” della nostra Isola, e per questo riconosciuti dal nostro popolo, come sarebbe successo a Napoli col mito di Maradona.
Da qui l’atmosfera del rito che accomuna il cuntu e l’opra. «Per un anno e mezzo, e per più ancora, il contastorie, che è quasi analfabeta, narra senza leggere le imprese dei suoi amati guerrieri», ricorda ancora il Pitré, prospettando la lunga durata dei cicli rappresentati [6]; una sorta di teatro a puntate, in cui regolarmente le serate dedicate alla rappresentazione, senza soluzione di continuità, come in un film, raccontavano ad un pubblico sempre uguale le diverse sequenze delle storie dei paladini di Francia. Fu così che alla ritualità dello spazio e del tempo (il ritrovarsi alla stessa ora, nello stesso luogo) corrispose quella dei contenuti, anch’essi necessariamente rispettosi della trama, senza possibilità alcuna di varianti, pena la rivolta collettiva degli attenti ed esigenti spettatori. Da qui la ricomposizione di un teatro di relazione e di autorispecchiamento, anche nelle vicende dei paladini, rispetto al perdurare del teatro di rappresentazione nei luoghi deputati della teatromania borghese e della nobiltà.
Fatte salve le motivazioni del profitto e della sopravvivenza attraverso l’economia della festa di cui si è detto, la comicità delle vastasate era stata, come in parte si accennava prima, una sorta di rivolta liberatoria dagli schemi tardo-feudali della cultura dominante, e in quanto tale, animata, nelle sue motivazioni implicite, dall’insofferenza, dal desiderio di conquistare nuovi spazi, dalla ricerca, comunque, di una identità. Adesso gli artisti-artigiani con l’Opra dei pupi ritrovavano la tragedia, all’interno della quale riprendevano posto, ma questa volta nelle forme direttamente gestite dell’artista popolare, le sequenze dell’“apparenza” tipica dei rituali urbani, e al tempo stesso del riscatto nell’habitus eroico e guerresco del paladino. I pupi dell’opra, dunque, si presentavano in parata come i cavalieri dei cortei paratattici.
Dopo lo svuotamento dei cerimoniali, gli opranti adattarono i simulacri ormai privi di vita del rito ufficiale alla nuova ritualità. Fu così che la forma e la materia riconobbero l’anima eroica della révanche popolare. Un gioco diverso, per certi aspetti irriverente, nei confronti di secolari dominazioni, e per questo aperto agli innesti buffi, legati alla recente memoria. A questo punto l’avventura dei pupi diventò il simbolo della cultura popolare siciliana. I teatrini, come piccoli templi del rito, ospitarono sempre più numerosi, per mesi e mesi, cicli di rappresentazioni a puntate. Il pupo paladino era ormai diventato la maschera siciliana del riscatto sociale.
Volendo poi comprendere le ragioni per le quali i paladini di Francia presero il sopravvento sugli eroi normanni, che tuttavia continuarono ad essere presenti sia pure in tono minore nel repertorio dell’Opra, bisogna guardare alle caratteristiche drammaturgiche dei cavalieri di Carlo Magno e all’interesse col quale il pubblico popolare guardò alle loro azioni in scena. Rispetto alla solennità della figura dei Normanni, vero colpo d’occhio apprezzato nei dipinti dei trasparenti e nei tabelloni festivi della Cattedrale, i pupi paladini si prestarono a varianti e adattamenti molto più vicini alla cultura degli spettatori. L’astuzia di Rinaldo, la passione di Orlando, la disonestà di Gano di Magonza traditore, rispecchiavano sentimenti di esaltazione dell’onore e della virtù eroica e il disprezzo del disonore, offrendo il campo così ad una forma di spettacolo ricco di colpi di scena e di situazioni molteplici che, diversamente dall’epopea normanna, vedevano gli spettatori fortemente coinvolti. Il che si aggiungeva all’apprezzamento della manualità artigiana della quale i pupi in legno erano espressione. E poi c’era l’incomparabile spettacolarità offerta dagli effetti sonori e visivi provocati dai rumori metallici derivanti dal contatto violento di scudi, spade e corazze uniti al movimento di colori delle vesti dei paladini, delle immagini dei corpi mutilati con un sol colpo di spada.
Siamo giunti dunque allo snodo che porta alla comparsa dei pupi armati; un evento che scaturì dall’incontro di Gaetano Greco, come pure di Lamberto Canino, con la fiorente attività degli anonimi artigiani della festa, di cui abbiamo a lungo parlato, alcuni dei quali già impegnati nel teatro di figura, in quanto discendenti dalla stirpe estinta delle vastasate. Nel tempo in cui l’immagine dei paladini soppiantò in buona parte gli eroi del mito normanno, furono loro che offrirono ai cosiddetti pionieri impegnati fino a quel momento nell’uso di marionette di stoffa e a filo, l’idea e la possibilità di procurarsi quanto avrebbe reso possibile la rappresentazione in scena della gagliardia del paladino.
I Greco e i Canino che artigiani non erano, pensarono così di sostituire le armature di cartone, gli elementi decorativi e i corpi flaccidi delle loro marionette con i materiali che una vera e propria organizzazione di botteghe del legno e del metallo poteva offrire loro. Pitrè stesso riconosce che ancora nel suo tempo «c’è persona che in Palermo si occupa di questo genere di lavori, altri scolpendo teste o mani, altri costruendo armature, altri mettendo pupi di tutto punto» [7]. Fu soltanto dopo la graduale assimilazione del mestiere artigianale, che i Greco e i Canino impararono a costruire e vestire in proprio i loro pupi secondo una conformazione sempre più omogenea e riconoscibile da parte degli spettatori.
Orlando indossa così sempre una veste rossa sotto la corazza sulla quale è raffigurata un’aquila riportata sullo scudo, sul cimiero e sull’usbergo, mentre il simbolo di Rinaldo è la figura di un leone e, a differenza di Orlando, Rinaldo porta dei baffetti neri. Gano di Magonza, il traditore, è più piccolo di statura rispetto ai due eroi paladini; ha un andamento goffo e porta il segno della “M” sullo scudo e sul petto. Carlo Magno ha due forme di abbigliamento, quello curtense consistente in una tunica riccamente adornata, corona e mantello di velluto; quella da battaglia è caratterizzata da un elmo a forma di corona, scudo esagonale con sovrapposto il giglio, simbolo della monarchia franca. I personaggi femminili si distinguono per la specificità del loro costume, se figure di rango: assimilabile alla tipologia degli eroi maschili se si tratta di eroine guerriere; in veste che richiama la moda primo-ottocentesca le altre, a cominciare da Angelica, Berta ecc. I personaggi secondari, fino a quelli di basso rango, non hanno invece una tipologia specifica di costume, essendo vestiti con fogge di epoche diverse, senza particolare ricercatezza e con il volto sommariamente abbozzato.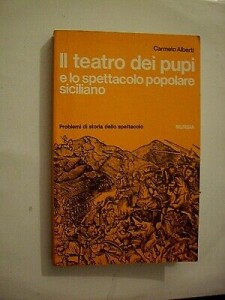
Sono, quelli qui riportati, soltanto alcuni pur significativi esempi rispetto ad un quadro più completo riscontrabile nella vasta mole di studi di settore che hanno fatto seguito al lavoro di Giuseppe Pitré. Pertanto, rimanendo nell’area palermitana, ci limiteremo a dare alcune informazioni essenziali. Per quanto riguarda la componente scenografica, ci si è soffermati in particolare su due elementi: il cartellone e i dispositivi di scena: dai fondali alle quinte, ai sipari. Relativamente a questi è stato messo in evidenza l’influsso da parte delle scenografie del teatro maggiore, in particolare del melodramma. A proposito di questa contaminazione Alberti cita opportunamente il contributo di Giovanni di Cristina «ad un tempo pittore di cartelli e scenografo al Teatro Massimo di Palermo» [8]; poi precisa ulteriormente:
«Nei teatrini dei pupi l’utilizzazione dei fondali s’incrementa proprio nel periodo e nell’area geografica in cui più stretti e continui sono i rapporti spettacolari tra il teatro popolare e quello borghese. La tipologia scenografica è alquanto ricca di argomenti figurativi: ampi scorci di accampamenti turcheschi, visioni di città cinte di mura invalicabili, giardini incantevoli con fontane e giochi d’acqua, paesaggi orientaleggianti con oasi e palmizi; gli interni mostrano ora saloni, alcove ornate di ricchi tendaggi, verande, ora ambienti tetri, prigioni, caverne».
Rispetto a questa panoramica, non bisogna tuttavia trascurare che la consuetudine pittorica riguardante i fondali è già molto significativa nella grande stagione dei casotti della Compagnia Nazionale delle vastasate. La competenza pittorica maturata nei casotti nel campo scenografico non venne meno con la fine delle vastasate e verisimilmente anche in questo campo questa pratica artigianale entrò nella gestazione dell’Opra allo stesso modo delle tecniche manuali riguardanti il configurarsi dei pupi. Fu così che successivamente gli opranti riconosciuti dalla storiografia impararono col tempo ad acquisire una loro autonomia operativa distaccata dalle diverse botteghe specializzate nella realizzazione delle diverse componenti del pupo; ed è singolare che a poco a poco le competenze pittoriche spettarono prevalentemente alle donne.
 Diversa sorte ebbero invece i cartelloni, ossia le tele che venivano esposte all’esterno dei teatrini, destinate a pubblicizzare gli spettacoli dell’opra. Essi rimasero a lungo opere più impegnative e per questa ragione affidati all’esecuzione di specialisti. Alto in genere circa tre metri per due metri di larghezza, il cartellone veniva diviso in sei o otto e più scacchi per raffigurare le scene più significative dell’Opra di riferimento. La loro tecnica di pittura ad acquarello presentava colori molto accesi, tali da attirare il pubblico: il rosso vivo dei costumi, dei pennacchi dei cimieri, delle ferite, come pure il giallo degli sfondi, l’argento e il bronzo delle corazze, il marrone delle superfici sterrate, il verde dei rami, l’azzurro del cielo, i diversi colori dei costumi dei paladini, il bianco delle nuvole.
Diversa sorte ebbero invece i cartelloni, ossia le tele che venivano esposte all’esterno dei teatrini, destinate a pubblicizzare gli spettacoli dell’opra. Essi rimasero a lungo opere più impegnative e per questa ragione affidati all’esecuzione di specialisti. Alto in genere circa tre metri per due metri di larghezza, il cartellone veniva diviso in sei o otto e più scacchi per raffigurare le scene più significative dell’Opra di riferimento. La loro tecnica di pittura ad acquarello presentava colori molto accesi, tali da attirare il pubblico: il rosso vivo dei costumi, dei pennacchi dei cimieri, delle ferite, come pure il giallo degli sfondi, l’argento e il bronzo delle corazze, il marrone delle superfici sterrate, il verde dei rami, l’azzurro del cielo, i diversi colori dei costumi dei paladini, il bianco delle nuvole.
Anche in questo caso gli studi sull’Opra non hanno prodotto riferimenti documentari al di qua della metà dell’Ottocento, mentre riguarda l’Ottocento avanzato l’affermazione della pittura sui carretti, molto vicina dal punto di vista cromatico e del disegno a quella dei cartelloni dell’Opra. Fra i primi pittori di cartelloni emerge la figura di Nicolò Rinaldi, oltre al già citato Giovanni di Cristina, delle cui opere non è rimasta che qualche piccola traccia. Tra la fine dell’800 e del ‘900, particolarmente apprezzato fu il figlio Francesco Rinaldi del quale Li Gotti dice che «con singolare rapidità e sveltezza sguizzava i contorni delle scene e delle figure col carbonello e poi li ricopriva di vivaci colori in un battibaleno» [9]. Il tempo tuttavia ha deteriorato i deperibili materiali dei cartelloni, mentre più lunga vita avrebbero avuto i disegni che gli stessi cartellonisti produssero per le xilografie pubblicate nelle dispense che, come si vedrà, verso la fine dell’’800 iniziarono a riportare le storie dell’opera.
 Prima della comparsa di questi materiali a stampa si era tuttavia già consolidato un vasto repertorio dell’epopea paladinesca raccontata dai contastorie e che costituirono materia viva delle rappresentazioni nei teatrini. Fra i maestri del cuntu emersero Manzella, maestro di Ferreri, e mastro Pasquale, particolarmente attivi negli anni Quaranta ossia all’inizio della grande stagione dell’Opra. Sarà soltanto nel 1858, tuttavia, che si arrivò alla prima pubblicazione delle imprese dei paladini. Con i quattro volumi della Storia dei Paladini di Francia cominciando da Milone conte d’Anglante fino alla morte di Rinaldo, Giusto Lo Dico diede così avvio alla diffusione a stampa dell’epopea paladinesca preceduta dalla pubblicazione a fascicoli di quaranta pagine. La pubblicazione di Lo Dico in un certo senso contribuì a regolarizzare il fenomeno dell’Opra, intanto che nuovi teatrini si posizionavano in quartieri diversi venendo a costituire un riferimento importante per il quartiere stesso.
Prima della comparsa di questi materiali a stampa si era tuttavia già consolidato un vasto repertorio dell’epopea paladinesca raccontata dai contastorie e che costituirono materia viva delle rappresentazioni nei teatrini. Fra i maestri del cuntu emersero Manzella, maestro di Ferreri, e mastro Pasquale, particolarmente attivi negli anni Quaranta ossia all’inizio della grande stagione dell’Opra. Sarà soltanto nel 1858, tuttavia, che si arrivò alla prima pubblicazione delle imprese dei paladini. Con i quattro volumi della Storia dei Paladini di Francia cominciando da Milone conte d’Anglante fino alla morte di Rinaldo, Giusto Lo Dico diede così avvio alla diffusione a stampa dell’epopea paladinesca preceduta dalla pubblicazione a fascicoli di quaranta pagine. La pubblicazione di Lo Dico in un certo senso contribuì a regolarizzare il fenomeno dell’Opra, intanto che nuovi teatrini si posizionavano in quartieri diversi venendo a costituire un riferimento importante per il quartiere stesso.
Terminato da tempo il monopolio del piano della Marina come spazio teatrale urbano a fruizione popolare con i suoi casotti, venne a prospettarsi così una estensione policentrica di una forma scenica che mantenne la configurazione di un rito laico distribuito in punti diversi della città con le stesse regole e le stesse sequenze, pur con le differenze specifiche dell’arte dei singoli opranti. La visione d’insieme del fenomeno confermò così l’idea di un vero e proprio teatro di massa. Di fronte alla perduranza a Palermo della teatromania aristocratico-borghese con i suoi tre luoghi deputati che continuarono ad ospitare repertori e compagnie di giro provenienti prevalentemente dal continente, gli spettacoli dell’Opra seppero mantenere a Palermo lo spirito di un fenomeno d’arte di tradizione. L’annuncio stesso dello spettacolo che veniva dato dal tamburinaio in prossimità del teatrino faceva parte di un rituale ormai consolidato. Il suono del tamburo, puntuale al calar del sole, sembrava corrispondere in qualche modo a quello delle campane delle chiese nunzianti ai fedeli l’inizio della Santa Messa.
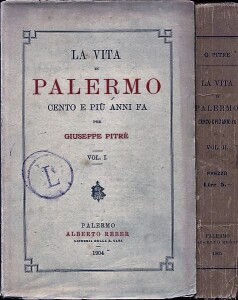 Così si presentava dunque Palermo negli anni Ottanta dell’Ottocento nel pieno dell’esplosione dell’Opra con i suoi teatrini in piazza Ballarò, porta Nuova, via Fornai, via Alloro e nei rioni Borgo, Capo e Albergheria. In questi angusti luoghi deputati dalla capienza mediamente non superiore ai cento posti, artigiani, contadini, operai diversi, gente di quartiere, tutti uniti in una configurazione di pubblico omogeneo e sempre uguale assistevano all’intero sviluppo a puntate delle storie dell’Opra rappresentate per cicli, acquisendo una competenza tale da consentire loro di entrare in un rapporto osmotico con la scena. Accadeva infatti, durante la rappresentazione, che, per le eventuali dimenticanze o imperfezioni delle quali poteva essere giudicato responsabile l’oprante, il pubblico si scatenasse in accuse molto accese contro l’oprante stesso, il quale a sua volta rispondeva con uguale energia.
Così si presentava dunque Palermo negli anni Ottanta dell’Ottocento nel pieno dell’esplosione dell’Opra con i suoi teatrini in piazza Ballarò, porta Nuova, via Fornai, via Alloro e nei rioni Borgo, Capo e Albergheria. In questi angusti luoghi deputati dalla capienza mediamente non superiore ai cento posti, artigiani, contadini, operai diversi, gente di quartiere, tutti uniti in una configurazione di pubblico omogeneo e sempre uguale assistevano all’intero sviluppo a puntate delle storie dell’Opra rappresentate per cicli, acquisendo una competenza tale da consentire loro di entrare in un rapporto osmotico con la scena. Accadeva infatti, durante la rappresentazione, che, per le eventuali dimenticanze o imperfezioni delle quali poteva essere giudicato responsabile l’oprante, il pubblico si scatenasse in accuse molto accese contro l’oprante stesso, il quale a sua volta rispondeva con uguale energia.
Questa forma di teatro di relazione costituì per diversi decenni l’originalità e l’unicità dell’Opra nel panorama generale del teatro ottocentesco non soltanto siciliano. Tutto ciò rimase sul solco del genere ormai acquisito. I pupi continuarono a mantenere l’altezza di circa cm.80 e il manovratore continuò a prestare la voce al pupo stesso, ricorrendo al falsetto quando si trattava di personaggi femminili. Allo stesso modo si mantenne sempre uguale il sistema di manovra: l’oprante collocato ai lati della scena, nascosto dalle quinte manovrava i pupi tenendo il braccio teso. La scatola magica del piccolo palcoscenico continuò a coinvolgere emotivamente per tutto il secolo e i primi decenni del Novecento i fedeli spettatori che pure si adattarono ad accogliere i riflessi dell’epopea garibaldina nel repertorio degli anni Sessanta dell’Ottocento.
Questa perduranza della tradizione “pupara” non fu tuttavia fenomeno retro, né tanto meno retrivo, come invece accadde per il teatro borghese dell’Ottocento; anzi paradossalmente e senza che gli opranti stessi e il relativo pubblico ne avessero consapevolezza, continuarono ad esprimere, ancora dopo decenni, un’ideologia rivoluzionaria contro l’ingiustizia e l’arroganza del potere; vero e proprio teatro popolare in quanto di massa, che avrebbe certamente attirato l’attenzione di alcuni dei padri della rivoluzione del teatro europeo, da Rolland a Gémier, a Meyerhold.
Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023
[*] Il testo è parte del volume dal titolo, L’opera dei pupi nella storia dello spettacolo in Sicilia, in corso di stampa presso la casa editrice del Museo Pasqualino, che si ringrazia per l’autorizzazione alla pubblicazione in anteprima.
Note
[1] Sul fenomeno delle vastasate rimando per tutti al mio Il Teatro negato, Pagina, Bari 2011
[2] G. Pitrè La famiglia, la casa, la vita del popolo siciliano, Pedone Lauriel Palermo,1913: 327-8.
[3] Archivio Storico Comunale di Palermo, Appalti, 1847, fasc. 22, s.d. 2 aprile 1847.
[4] Cfr. S. Riccobono, Carri trionfali e teatri pirotecnici nella Palermo dell’Ottocento, in Immaginario e tradizione, ed. Novecento, Palermo, 1993. In particolare si fa riferimento ad una mascherata del 1837 dal titolo Costumi di Rebecca e Ivanhoe disegnata da Giuseppe Bagnasco, nella quale Ivanhoe è chiaramente vestito in costume paladinesco.
[5] Meldolesi C. e Taviani F., Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, Laterza, Bari-Roma, 1991.
[6] G. Pitré, La famiglia, la casa, cit.: 327.
[7] G. Pitrè, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, Casa editrice del libro italiano, Roma 1939:153
[8] C. Alberti, Il Teatro dei pupi, Mursia, Milano 1977: 45.
[9] E. Li Gotti, Il teatro dei Pupi, Sansoni, Firenze 1957: 92
Riferimenti bibliografici
Aa.Vv., 1981, I pupi e il teatro, numero speciale di «Quaderni di Teatro» (13)
Alberti C., 1977, Il teatro dei pupi e lo spettacolo popolare siciliano, Milano: Mursia.
Archivio di Stato di Palermo – Reale Segreteria di Stato (A. S. Pa. R. S), incartamenti buste 5260 (teatri di Palermo), 5223 (Polizia teatri), 5317 (Spettacoli), 5551 (Teatri)
Atti del Convegno «L’opera dei pupi nel nuovo millennio», in Associazione Figli d’Arte Cuticchio (a cura di), 2002, La Macchina dei Sogni. Diciannovesima edizione – Opera dei pupi e teatro di figura, Palermo: Associazione Figli d’Arte Cuticchio: 126 -177.
Buttitta A., 1961, Cultura figurativa popolare in Sicilia, Palermo: S. F. Flaccovio.
Cocchiara G., 1926, Le vastasate. Contributo alla storia del teatro popolare, Palermo: Sandron
De Felice F., 1956, Storia del teatro siciliano, Catania: Giannotta
Di Palma G., 1991, La formazione della parola. Dalla narrazione orale al testo. I cantastorie, Roma: Bolzoni.
Giuliano S. G., Sorgi O., Vibaek J. (a cura di), 2011, Sul filo del racconto. Gaspare Canino e Natale Meli nelle collezioni del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, Palermo CRicd – Regione Siciliana.
Isgrò G., 1981, Festa Teatro Rito nella storia di Sicilia, Palermo: Cavallotto
Isgrò G., 2000, La forma siciliana del teatro, Palermo: Ila Palma
Isgrò G., 2010, Il teatro degli artigiani, in «Teatro e Storia» nuova serie 2-2010 [a. XXIV vol. 31]: 321-341
Isgrò G., 2011, Il teatro negato, Bari: Pagina
La Porta Parlato R. 1917, Note sul teatro popolare siciliano, Palermo.
Li Gotti E., 1969, Il teatro dei pupi, Firenze: Sansoni.
Lodico G., 1971, Storia dei Paladini di Francia cominciando da Milone conte d’Anglante sino alla morte di Rinaldo, Palermo Celebes
Manzanares P., 1886-1887 Storia dei Paladini di Francia da Pipino sino alla battaglia di Roncisvalle, facendo seguito la morte di Carlo Magno, Palermo: Pedone-Lauriel, 2 voll.
Meldolesi C. e Taviani F., 1991, Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, Bari-Roma: Laterza.
Napoli A., 2002, Il racconto e i colori. «Storie» e «cartelli» dell’Opera dei pupi catanese, Palermo: Sellerio.
Pasqualino A., 1977, «Ideologia dell’opera dei pupi». Medioevo romantico-borghese e Medioevo popolare, in Id. (a cura di) Opera dei pupi. Tradizioni e prospettive. Incontro di studi tenuto al Teatro Angelo Musco di Catania dal 19 al 23 gennaio 1977, Catania: Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana.
Pasqualino A., 1969, Il repertorio epico dell’opera dei pupi, in «Uomo e cultura», Palermo, an. II, 3-4.
Pasqualino A.,1989, Le vie del cavaliere dell’epica medievale alla cultura popolare, Milano: Bompiani.
Perricone R., 2013, I ferri dell’Opra. Il teatro delle marionette siciliane in «Antropologia e Teatro», (4)
Perricone R., 2018, L’Opera dei pupi in Perricone R. (a cura di), La cultura tradizionale in Sicilia, Palermo: Edizioni Museo Pasqualino, Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari.
Pitrè G., 1881, Spettacoli e feste popolari siciliane, Palermo: Pedone Lauriel.
Pitrè G., 1889, Usi, costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, vol. 1, Palermo: Pedone Lauriel
Pitrè G., 1904 – 1905, La vita in Palermo cento e più anni fa, Palermo: Pedone Lauriel
Signorelli M., 1981, “Documentazione, Pupari, pittori, scultori dell’epoca dei pupi in Sicilia”, «Quaderni di teatro» 13, agosto 1981: 128-153.
Venturini V., 2003, Dal Cunto all’Opera dei pupi. Il teatro Cuticchio, Roma: Dino Audino.
Vibaek J., 1981, “I cartelli dell’opra”, «Quaderni di teatro» 13, agosto 1981: 195 -208.
Vibaek J., 2000, Le donne dell’opera dei pupi, in Associazione Figli d’Arte Cuticchio 9 -15.
______________________________________________________________
Giovanni Isgrò, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università di Palermo, è autore e regista di teatralizzazioni urbane. Ha vinto il Premio Nazionale di Saggistica Dannunziana (1994) e il premio Pirandello per la saggistica teatrale (1997). I suoi ambiti di ricerca per i quali ha pubblicato numerosi saggi sono: Storia del Teatro e dello Spettacolo in Sicilia, lo spettacolo Barocco, la cultura materiale del teatro, la Drammatica Sacra in Europa, Il teatro e lo spettacolo in Italia nella prima metà del Novecento, il Teatro Gesuitico in Europa, nel centro e sud America e in Giappone. L’avventura scenica dei gesuiti in Giappone e Il Teatro dei gesuiti sono i titoli delle sue ultime pubblicazioni.
______________________________________________________________










