Nella premessa al suo lavoro, Eugenio Imbriani, a proposito del termine “folklore” si chiede: «Sappiamo tutti cosa significa?»; è questa una domanda retorica fatta per poter dichiarare, a conclusione del suo discorso, che «Il fine di questo libro è … fornire qualche elemento che aiuti la comprensione di quei fenomeni sociali riassunti nella parola “folklore” …».
Il libro è F. come Folklore, edito da Protegit (Bari 2022). Ci aspetteremmo forse una trattazione, anche minima, dei fenomeni, se non di tutti almeno dei più significativi, sia quelli materiali sia quelli immateriali, che la cosiddetta cultura popolare ha prodotto e produce, in modo da aiutare i lettori a colmare le loro eventuali lacune in materia. Ed invece, a parte alcuni sintetici riferimenti a qualcuna delle manifestazioni di questo settore della cultura, Imbriani dedica il suo lavoro a tutte le teorie interpretative e le metodologie di indagine che dall’Ottocento ad oggi sono state elaborate dagli studiosi che hanno riflettuto sul concetto di folklore.
Probabilmente, “la scoperta” del folklore, cioè di una cultura “altra”, stranamente complessa, è stata vista dalla cultura dominante come qualcosa di incomprensibile, da qui la necessità di studiarla per capire se si trattasse di qualcosa che ogni tanto si poteva accettare (per es.: ascoltare uno stornello oppure osservare con distacco il lavoro di un contadino) per divertirsi e passare il tempo, oppure fosse una mentalità intrisa di saperi e conoscenze con cui dover fare i conti nei rapporti di convivenza. Da qui la convinzione che per parlare di folklore sia più importante illustrare e discutere le riflessioni di coloro che l’hanno studiato, anziché specificare cosa esso sia.
Non è da meravigliarsi, pertanto, se anche Imbriani ha composto un siffatto manuale della cultura popolare, perché anche i compendi pubblicati nel passato, remoto o prossimo, sono strutturati in questo modo: una storia del lungo dibattito su cosa è il folklore e su come si deve considerare e studiare e pochi riferimenti alle sue specificità. Mi pare che soltanto Pitrè e Van Gennep si siano comportati diversamente, ma le loro opere non sono certo manuali di facile consultazione o succinte enciclopedie settoriali come vorrebbero essere certe opere di impostazione didattica o di divulgazione generale.
Ho l’impressione che per questa disciplina i manuali in circolazione siano stati ideati ad imitazione di quelli di letteratura italiana: nelle scuole medie superiori, infatti, siamo stati abituati a studiare su libri in cui si parla esclusivamente del pensiero e dello stile degli autori ma difficilmente si ricorre, anche per fare qualche esempio, alla citazione di brani di prosa e di componimenti poetici. Poi, però, si fa accompagnare il manuale di storia letteraria da un altro volume (magari, incongruamente, di autore diverso) in cui si presenta una più o meno vasta antologia delle opere. Si dovrebbe dunque accostare al manuale di folklore una breve antologia dei suoi prodotti e dei suoi aspetti? Certo che no: oggi sono possibili altre soluzioni perché nell’ultimo trentennio le cose sono cambiate, grazie anche ai progressi teorici sia della didattica, sia della linguistica la quale invita ad evincere le interpretazioni e le considerazioni della critica senza apporti filosofici esterni ma analizzando approfonditamente le strutture e lo specifico vocabolario di ogni poesia e di ogni prosa.
Ai vari Sapegno e Petronio di qualche anno fa si sono sostituiti, infatti, testi scolastici in cui contesto storico, brani ed opere di autori e interpretazioni critiche convivono insieme in modo da abituare gli studenti ad un’attività di laboratorio che faccia acquisire loro sia le nozioni necessarie, sia le capacità di analisi critica. Se si impostasse in questo modo anche un manuale di folklore si illustrerebbe contemporaneamente il pensiero degli studiosi che se ne sono occupati, e si mostrerebbe cos’è il folklore e come nascono, si formano e si evolvono quei prodotti che lo costituiscono. Ovviamente queste sono opinioni mie personali che, pur non avendo a che fare con esso, sono state sollecitate dal lavoro di Imbriani, il quale, seguendo la tradizione, ci presenta un breve manuale molto utile agli studenti universitari e a tutti quelli che volessero sapere qualcosa in più sugli studi delle tradizioni popolari in Italia.
 Il volume fa parte della collana Nuvole che si presenta come una enciclopedia monografica formata da testi, di circa 150 pagine cadauno, affidati a specialisti; fino ad ora ne sono stati pubblicati otto. Eugenio Imbriani, che prima di questo ha curato il volume sull’Antropologia, e che dirige la collana “Antropologia e Mediterraneo”, dello stesso Editore, ci espone la storia degli studi sul folklore in Italia in soli cinque densi capitoli.
Il volume fa parte della collana Nuvole che si presenta come una enciclopedia monografica formata da testi, di circa 150 pagine cadauno, affidati a specialisti; fino ad ora ne sono stati pubblicati otto. Eugenio Imbriani, che prima di questo ha curato il volume sull’Antropologia, e che dirige la collana “Antropologia e Mediterraneo”, dello stesso Editore, ci espone la storia degli studi sul folklore in Italia in soli cinque densi capitoli.
Già alla prima lettura, la cosa che subito si nota è la profonda conoscenza della storia generale in cui sono inquadrate le vicende del folklore italiano; la seconda è che l’Autore ha fatto tesoro di tutti gli studi che negli ultimi decenni hanno affrontato la storia della demologia in Italia, da Cocchiara a Bronzini e a Cirese, da Sandra Puccini a Alliegro, da Gianluigi Bravo a Pietro Clemente e a Fabio Dei. Con queste competenze gli è possibile trattare nei cinque capitoli i momenti storici caratterizzati da specifici indirizzi ideologici, come il Romanticismo, il Positivismo, il Fascismo, il crocianesimo fino a De Martino e alla antropologia dell’ultimo Novecento; nello stesso tempo può soffermarsi a lungo sugli studiosi che secondo lui hanno influito, negativamente o positivamente, nella ricerca etnografica e nell’analisi del folklore.
Dopo il primo capitolo in cui si tratta degli studiosi ritenuti capisaldi e iniziatori della ricerca demologica italiana (Berchet, Tommaseo, Rubieri, D’Ancona) e che propedeuticamente serve a chiarire il concetto di popolo, si passa al periodo positivistico i cui maggiori rappresentanti sono stati Loria, e Giuseppe Pitrè. Il primo ritenne in un primo momento, dato il suo interesse di esploratore per le popolazioni allora definite “primitive”, che il folklore fosse una cultura “diversa” e lontana dalla propria, simile a quelle di etnie non europee; successivamente scoprì, dopo una gita nel Sannio, che la diversità era presente anche in Italia presso le comunità rurali, povere ed isolate. Loria fu anche il primo a tentare una categorizzazione della cultura popolare, ma fu poi il Pitrè a elaborare una classificazione (ancora oggi funzionale) di tutti gli aspetti in cui si può suddividere «ciò che l’uomo dice e ciò che l’uomo fa»; su questa classificazione fondò la demopsicologia, da cui è derivata la più moderna demologia. Uno spazio forse troppo ampio è dedicato a Benedetto Croce e alla sua teoria estetica, che però in buona parte è utilizzato per parlare degli studiosi (Barbi, Vidossi, Santoli) che gli si opposero in nome della filologia. Il ricordo di don Benedetto dà poi all’Imbriani l’occasione di contrapporgli un vero maestro della storia sociale, il francese Marc Bloch, la cui teoria storiografica e la metodologia di ricerca avrebbero contribuito a dare al folklore la stessa importanza che si dà alle vicende storiche e a ripulirlo di quelle accuse di pittoresco, di pregiudizio e di ignoranza che la cultura dominante aveva formulato nei suoi confronti; più che la filologia, dunque, fu la storia degli Annales ad indebolire e a sconfiggere l’interpretazione del folklore che di esso dava il filosofo di Pescasseroli.
Il periodo fascista, come dimostra l’Imbriani, fu un periodo piuttosto difficile per lo studio delle tradizioni popolari e per gli studiosi che se ne occupavano; e ciò a causa del fatto che il regime si appropriò di quegli aspetti superficiali del folklore che gli servivano per creare e accrescere consenso, come le feste e le sagre, le filodrammatiche e i giochi di gruppo, i cortei “storici”: tutte attività gestite da istituti come il Dopolavoro e i circoli Enal, e che della cultura popolare conservavano solo gli aspetti ludici, pittoreschi ed appariscenti e che erano spesso affidate a persone non all’altezza del compito e che tuttavia, nonostante qualche perplessità, furono in qualche modo avallate dagli stessi studiosi. Ciò comportò una grave limitazione della ricerca che in quel periodo toccò i livelli più bassi: d’altra parte lo studio delle tradizioni popolari non interessava minimamente al regime, per il quale era importante solo la veste di ruralità che una parte del folklore conservava.
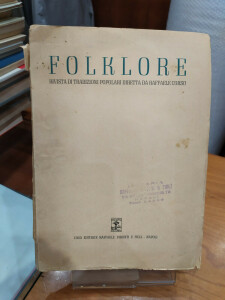 Tra gli studiosi del periodo è da annoverare Raffaele Corso che per la sua mentalità piuttosto conservatrice spesso agì in conformità alle direttive governative; con l’intenzione di nobilitarlo, avanzò l’ipotesi che il folklore fosse la “preistoria contemporanea” dell’Italia, senza accorgersi che il concetto presentava una insanabile contraddizione semantica.
Tra gli studiosi del periodo è da annoverare Raffaele Corso che per la sua mentalità piuttosto conservatrice spesso agì in conformità alle direttive governative; con l’intenzione di nobilitarlo, avanzò l’ipotesi che il folklore fosse la “preistoria contemporanea” dell’Italia, senza accorgersi che il concetto presentava una insanabile contraddizione semantica.
L’altro studioso rappresentativo del periodo è Giuseppe Cocchiara, che ebbe momenti di cedimento all’ideologia fascista ma che seppe però lentamente far dimenticare a partire da un’opera in cui si prendevano, anche se debolmente, le distanze dal famigerato manifesto della razza. Come Corso, anche Cocchiara, ma in maniera più lineare, ritenne che il folklore potesse essere identificato con la storia delle plebi rurali ed urbane, seguendo in questo un’interpretazione che già era stata del Pitrè (ne accenna l’Imbriani in una nota). Anche lui evitò di intervenire a livello teorico, per evitare forse contrasti con il regime o per la sua formazione culturale ed ideologica, accontentandosi di delineare la storia del folklore in Europa.
Da sottolineare che tra tutti quelli che hanno scritto la storia degli studi folklorici in Italia, Imbriani è tra quei pochi che ha discusso del periodo fascista, in genere rimasto misconosciuto, senza che nessuno abbia spiegato il motivo di questo silenzio [1].
Ampio spazio è dedicato alla figura e al pensiero di Antonio Gramsci, né poteva essere altrimenti per l’influenza che le pur brevi Note sul folclore hanno avuto sugli studi italiani ed esteri. Il concetto di folklore come cultura delle classi subalterne, il fatto che esso si debba studiare come una cosa seria e non pittoresca; l’aver intravisto nella cultura popolare tratti dinamici e relazionali tali da poter configurare un cambiamento e una concezione superiore della vita, hanno completamente rovesciato l’ottica con cui si era guardato a quel mondo. Non solo: l’esame gramsciano della cultura delle classi subalterne va di pari passo con un discorso più generale che riguarda la lotta di classe, il concetto di egemonia e la formazione delle classi dirigenti. Sono tutte questioni cruciali della società moderna e per questo, fin dalla loro prima edizione (1948), i suoi Quaderni hanno aperto un dibattito lungo ed ampio che è ancora in pieno svolgimento in Italia e all’estero.
Mi sembra qui opportuno segnalare le pagine del libro di Imbriani, in cui il pensiero gramsciano viene sunteggiato in maniera esemplare, come del resto avviene per altri autori il cui pensiero ha sempre un’illustrazione sintetica esauriente e chiara.
 Molto più complessa la trattazione del pensiero e dell’opera di Ernesto De Martino, tanto che Imbriani la divide in due parti: la prima, relativa al De Martino storicista ed ancora crociano, inserita nel capitolo in cui si parla di Croce, e la seconda posta dopo il paragrafo dedicato a Gramsci. L’etnologo napoletano certamente è una delle figure più interessanti e controverse degli anni ‘50/60 del ventesimo secolo. Giovane militante fascista, trasferitosi a Bari, conobbe il gruppo di intellettuali liberali che gravitava attorno a Croce e alle edizioni Laterza. I suoi studi iniziali riguardavano la storia delle religioni; dopo l’incontro con Croce si rivolse all’etnologia convinto che la storia umana non può esistere senza tener di conto di tutti quei popoli che sono stati dimenticati prima dai governi e poi dagli storici. Fu, da un lato, la scoperta di quello che sarebbe stato chiamato Terzo mondo e, dall’altro, quella della magia come strumento per opporsi alle difficoltà della vita e soprattutto per «difendere la propria presenza nel mondo».
Molto più complessa la trattazione del pensiero e dell’opera di Ernesto De Martino, tanto che Imbriani la divide in due parti: la prima, relativa al De Martino storicista ed ancora crociano, inserita nel capitolo in cui si parla di Croce, e la seconda posta dopo il paragrafo dedicato a Gramsci. L’etnologo napoletano certamente è una delle figure più interessanti e controverse degli anni ‘50/60 del ventesimo secolo. Giovane militante fascista, trasferitosi a Bari, conobbe il gruppo di intellettuali liberali che gravitava attorno a Croce e alle edizioni Laterza. I suoi studi iniziali riguardavano la storia delle religioni; dopo l’incontro con Croce si rivolse all’etnologia convinto che la storia umana non può esistere senza tener di conto di tutti quei popoli che sono stati dimenticati prima dai governi e poi dagli storici. Fu, da un lato, la scoperta di quello che sarebbe stato chiamato Terzo mondo e, dall’altro, quella della magia come strumento per opporsi alle difficoltà della vita e soprattutto per «difendere la propria presenza nel mondo».
Da qui la necessità di una lunga e complessa inchiesta etnografica, compiuta in Basilicata insieme con una équipe, per poter scrivere «un’opera che abbia l’efficacia, l’unità e il calore di Cristo si è fermato a Eboli, e che, al tempo stesso, sia opera di scienza e non di letteratura». Ma l’attività di De Martino non si fermò qui, perché va aggiunto che la sua attenzione cadde non solo sulla magia, ma anche sulla morte, sul simbolismo, sul tarantismo e infine sulle “apocalissi culturali”, delle quali ultime l’Imbriani, sorprendentemente, non si occupa. Dal quadro, tuttavia, che l’Imbriani ne fa, vengono fuori chiaramente le difficoltà, e gli sforzi per superarle, vissute da De Martino nel tentativo, irrisolto, di spiegare nella storia umana la presenza di aspetti contraddittori e apparentemente inconciliabili, come la razionalità, la magia, la paura della morte e della crisi della presenza.
 L’ultimo capitolo, intitolato Tradizione, affronta la complessa situazione degli ultimi cinquanta anni del secolo scorso. In Italia la seconda parte del secolo comincia con due spettacoli basati interamente sui canti popolari; il primo si deve a Roberto Leydi (Bella ciao) e il secondo a Dario Fo (Ci ragiono e canto), due spettacoli di grande successo ma che fecero molto scalpore presso il pubblico borghese. Da lì nacque il movimento del folk-revival che avrebbe caratterizzato il decennio successivo e che avrebbe generato appassionati dibattiti sul folklore progressivo, sul rapporto folklore/cultura, su quello tra folklore e cultura di massa. A quasi fine secolo, le discipline accademiche di Storia delle tradizioni popolari si trasformano in Antropologia culturale che, successivamente, si è moltiplicata in numerosi indirizzi di ricerca. Dalla Francia, dalla Germania e dall’America, intanto, arrivavano nuove teorie, nuovi modi di guardare alla cultura popolare e alla cultura di massa.
L’ultimo capitolo, intitolato Tradizione, affronta la complessa situazione degli ultimi cinquanta anni del secolo scorso. In Italia la seconda parte del secolo comincia con due spettacoli basati interamente sui canti popolari; il primo si deve a Roberto Leydi (Bella ciao) e il secondo a Dario Fo (Ci ragiono e canto), due spettacoli di grande successo ma che fecero molto scalpore presso il pubblico borghese. Da lì nacque il movimento del folk-revival che avrebbe caratterizzato il decennio successivo e che avrebbe generato appassionati dibattiti sul folklore progressivo, sul rapporto folklore/cultura, su quello tra folklore e cultura di massa. A quasi fine secolo, le discipline accademiche di Storia delle tradizioni popolari si trasformano in Antropologia culturale che, successivamente, si è moltiplicata in numerosi indirizzi di ricerca. Dalla Francia, dalla Germania e dall’America, intanto, arrivavano nuove teorie, nuovi modi di guardare alla cultura popolare e alla cultura di massa.
Grandi trasformazioni sociali interessavano tutto il mondo, con riflessi notevoli anche in Italia: l’arrivo di immigrati soprattutto dall’Africa e dall’Asia aprivano altre questioni, mentre i paesi e le cittadine delle zone altocollinari e montane entravano in crisi e si spopolavano. Tutto ciò avviava nuovi campi di indagine etnografica e richiedeva nuovi strumenti di ricerca e nuove ottiche di analisi. I maestri del folklore italiano in auge fino agli anni ’50, furono messi in discussione, le loro teorie abbandonate per dar spazio a quelle nate altrove. Con molto garbo e con cognizione di causa Imbriani districa questa situazione labirintica e ci guida con sicurezza tra le varie e spesso dissonanti teorie.
Questa dunque la sintesi del lavoro di Imbriani. Qui vorrei aggiungere le considerazioni che alcuni suoi passi mi hanno suggerito e che riguardano le apparenti, secondo me, aporie riscontrabili nelle opere e nei comportamenti personali di alcuni studiosi, soprattutto di quelli che hanno operato in momenti particolari della storia italiana. La mia è solo un’ipotesi, non so quanto verificabile, ma la propongo lo stesso perché le argomentazioni di altri studiosi mi convincono fino ad un certo punto.
Imbriani dichiara di non aver mai amato quelle frasi con cui Pitrè «mostra il popolo in dialogo con i monti e i corsi d’acqua, affascinato da fate e draghi», perché così il popolo …perde di concretezza…Pitrè …sembra davvero separato da quella realtà sociale, che pure ha ben conosciuto e documentato, in cui è nato e cresciuto, figlio di pescatori prima e medico poi». Altro motivo di spiacevole sorpresa è per Imbriani, e non solo per lui, la difesa della mafia da parte del demologo palermitano.
E qui c’è da dire che noi conosciamo la mafia degli ultimi settanta anni, quella dell’efferata violenza, dei sequestri, degli omicidi, dei cadaveri impastati col cemento armato o sciolti nell’acido, delle stragi. La mafia conosciuta dal Pitrè, invece, era una mafia rurale, silenziosa, non aliena dall’omicidio che però avveniva nel buio dell’omertà e di un consenso che trovava una giustificazione nel codice arcaico di una società non evoluta, ancora basata sul sistema economico del latifondo. Questa mafia aveva le sue fondamenta nei valori tradizionali come la famiglia patriarcale, il rispetto delle gerarchie, una religiosità bigotta e superstiziosa, un concetto di onore maschile piuttosto vago, una giustizia autoctona, il disconoscimento dello Stato moderno [2].
Pitrè viveva in un mondo già industrializzato o sulla via dell’industrializzazione, era un medico che credeva nella scienza e la metteva in pratica, faceva parte di uno Stato organizzato secondo i principi di Montesquieu, ma vedeva anche la vecchia società che, ancora integra, cominciava a perdere pezzi, a dissolversi, pressata da un mondo con essa inconciliabile. Un mondo moderno nel quale, forse, Pitrè intuiva esserci un groviglio di contraddizioni sociali molto drammatiche, al cospetto del quale il mondo popolare, il medesimo della mafia, gli appariva più semplice e soprattutto più organico. Tra l’altro, gli sembrava che le genti della società antica, contadina e pastorale, erano anche capaci, come dimostravano le sue fiabe e i suoi canti, di usare la fantasia (le fate e gli orchi delle fiabe), di emozionarsi davanti ad un tramonto o ad una marina, mentre quelli suoi coevi apparivano privi di tali emozioni.
E non era solo il Pitrè ad avere questi sentimenti, perché la storia letteraria ci insegna che dalla fine dell’Ottocento ai primi del Novecento ci sono stati scrittori come Verga, Capuana, Deledda (e in parte lo stesso D’Annunzio con la sua esaltazione del primitivo), i quali pure guardavano a quel mondo che stava per scomparire, caratterizzato da una condizione di vita difficile che però era affrontata con grande coraggio in nome di valori che, per dirla col Verga, la società delle Banche e delle Imprese industriali stava perdendo già in quell’inizio di corsa precipitosa verso un incerto progresso. Anch’essi, come il Pitrè, vollero narrare quella società, quei valori, quei miti arcaici, quella religione del lavoro, quella cavalleria rusticana impossibile da trasportare nel mondo moderno, insomma la idealizzarono. La critica moderna ha parlato dei veristi come se fossero persone che volessero denunciare le tristi condizioni di vita delle genti urbane e del mondo contadino, mentre, in realtà, ne facevano un monumento a futura memoria per esaltare l’eroismo con cui quelle plebi affrontavano la vita, invece di indicare un nuovo modo di vivere, cosa che non potevano fare perché incapaci politicamente, intellettualmente e umanamente, ma soprattutto perché non avevano nessuna volontà di modificare quello stato di cose.
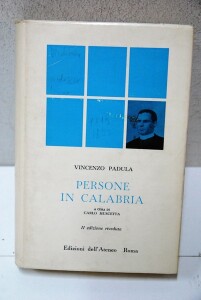 Tra tutti gli scrittori e gli studiosi che si occuparono delle condizioni di vita delle classi subalterne e della loro cultura tra Ottocento e Novecento, nessuno, infatti, mosse un dito per il riscatto delle plebi meridionali: gli storici e i critici letterari moderni hanno ascritto al pessimismo filosofico di quegli autori questa incapacità di indicare una soluzione (per trovarne qualcuno bisogna tornare indietro di qualche anno e fare il nome di Pisacane) o di contrastare in qualche modo la drammatica trasformazione sociale che avveniva sotto i loro occhi: l’unica risposta che seppero dare fu quella di rappresentare letterariamente quelle condizioni di vita perché le vedevano esistenzialmente positive rispetto a quelle che cominciavano a intravedersi, o di documentarle come facevano il Pitrè nei suoi enciclopedici volumi e Serafino Amabile Guastella nelle sue Parità morali. L’unico a prendere una vera difesa delle genti meridionali fu il calabrese Vincenzo Padula, il quale non si limitò a darci, come nell’opera Stato delle persone in Calabria, un quadro in cui i contadini non sono più primitivi, subalterni al destino e alle classi dominanti, ma uomini in possesso di ideali e valori atti a farli riscattare; inoltre, egli si fece anche interprete dei loro bisogni e promosse, da giornalista, un’azione politica riformista in loro favore.
Tra tutti gli scrittori e gli studiosi che si occuparono delle condizioni di vita delle classi subalterne e della loro cultura tra Ottocento e Novecento, nessuno, infatti, mosse un dito per il riscatto delle plebi meridionali: gli storici e i critici letterari moderni hanno ascritto al pessimismo filosofico di quegli autori questa incapacità di indicare una soluzione (per trovarne qualcuno bisogna tornare indietro di qualche anno e fare il nome di Pisacane) o di contrastare in qualche modo la drammatica trasformazione sociale che avveniva sotto i loro occhi: l’unica risposta che seppero dare fu quella di rappresentare letterariamente quelle condizioni di vita perché le vedevano esistenzialmente positive rispetto a quelle che cominciavano a intravedersi, o di documentarle come facevano il Pitrè nei suoi enciclopedici volumi e Serafino Amabile Guastella nelle sue Parità morali. L’unico a prendere una vera difesa delle genti meridionali fu il calabrese Vincenzo Padula, il quale non si limitò a darci, come nell’opera Stato delle persone in Calabria, un quadro in cui i contadini non sono più primitivi, subalterni al destino e alle classi dominanti, ma uomini in possesso di ideali e valori atti a farli riscattare; inoltre, egli si fece anche interprete dei loro bisogni e promosse, da giornalista, un’azione politica riformista in loro favore.
Con questo non voglio dire che si debbano giustificare certi comportamenti di allora, dobbiamo invece cercare di capirli guardandoli nel quadro storico complessivo del loro tempo e analizzando meglio la personalità e l’ideologia di quegli intellettuali, senza farli diventare i protagonisti di una denuncia sociale che da parte loro non ci fu. Questo giudizio, forse ancora più severo, va attribuito anche a quei politici meridionali che dal 1861 in poi furono ministri e capi di governo e che poco o niente fecero per il Meridione, lasciando che il capitalismo, presente nel Nord del Paese, sfruttasse per proprio interesse il Sud [3].
 Tornando al libro di Imbriani, devo dire che mi ha colpito positivamente l’ampiezza della documentazione che contempla gli Almanacchi e i Lunari, ma anche tanti nomi di ricercatori e studiosi minori alquanto sconosciuti. Ma c’è anche l’aspetto contrario, cioè il silenzio sotto il quale si mettono le persone di cui non si vuole parlare. Chiaro che ci sia libertà di scelta nelle citazioni, ovvio che si trattino ampiamente gli Autori che si ritengono più importanti, quelli che hanno tracciato i percorsi teorici e metodologici più fruttuosi per l’avanzamento della disciplina e della conoscenza. Ci sono stati, però anche dei personaggi che non possono essere lasciati in disparte solo perché secondo noi hanno influito poco o negativamente sugli studi demologici: la storia è fatta anche da loro. Ormai non nutro più alcuna simpatia per Frazer, né ho alcuna nostalgia del suo Ramo d’oro. Ma perché Imbriani riserva solo la citazione del suo nome accanto a quello di Tylor, che ha il privilegio di essere ricordato per la sua definizione del concetto di cultura?
Tornando al libro di Imbriani, devo dire che mi ha colpito positivamente l’ampiezza della documentazione che contempla gli Almanacchi e i Lunari, ma anche tanti nomi di ricercatori e studiosi minori alquanto sconosciuti. Ma c’è anche l’aspetto contrario, cioè il silenzio sotto il quale si mettono le persone di cui non si vuole parlare. Chiaro che ci sia libertà di scelta nelle citazioni, ovvio che si trattino ampiamente gli Autori che si ritengono più importanti, quelli che hanno tracciato i percorsi teorici e metodologici più fruttuosi per l’avanzamento della disciplina e della conoscenza. Ci sono stati, però anche dei personaggi che non possono essere lasciati in disparte solo perché secondo noi hanno influito poco o negativamente sugli studi demologici: la storia è fatta anche da loro. Ormai non nutro più alcuna simpatia per Frazer, né ho alcuna nostalgia del suo Ramo d’oro. Ma perché Imbriani riserva solo la citazione del suo nome accanto a quello di Tylor, che ha il privilegio di essere ricordato per la sua definizione del concetto di cultura?
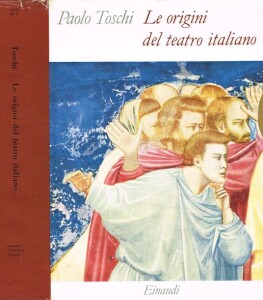 Possiamo rifiutare tutto di Frazer, ma non possiamo dimenticare che egli ha influenzato per lunghi anni la ricerca folklorica italiana e non solo negli articoli divulgativi di giornali e riviste e nei dépliant delle Pro Loco, ma anche a livello accademico: basti pensare ad un manuale di grande successo come quello di Paolo Toschi, Le origini del teatro italiano, per molti anni considerato una novità estremamente originale e fondamentale. Anche di quest’opera, che è stata alla base dei miei primi studi demologici, posso capire perché Imbriani non parli; il motivo per cui dal 1956, anno della sua pubblicazione, fino agli anni ’70 del secolo scorso, esso è stato punto di riferimento per tutti quelli che si sono occupati di folklore, fuori e dentro l’Accademia, mi sembra tuttavia un fatto notevole. Se non lo vogliamo ricordare può essere lecito, ma non possiamo dimenticare che Paolo Toschi per la sua caparbia attività (e forse una buona dose di ambizione personale) riuscì, dopo una stasi ventennale, a mettere in movimento tutto il settore del folklore, riportando all’Università la disciplina di Storia delle tradizioni popolari che ne era stata esclusa dopo la morte del Pitrè, che rimise in piedi la rivista Lares, che curò il negletto Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari di Roma: il che non mi pare impresa da poco, nonostante i suoi limiti teorici.
Possiamo rifiutare tutto di Frazer, ma non possiamo dimenticare che egli ha influenzato per lunghi anni la ricerca folklorica italiana e non solo negli articoli divulgativi di giornali e riviste e nei dépliant delle Pro Loco, ma anche a livello accademico: basti pensare ad un manuale di grande successo come quello di Paolo Toschi, Le origini del teatro italiano, per molti anni considerato una novità estremamente originale e fondamentale. Anche di quest’opera, che è stata alla base dei miei primi studi demologici, posso capire perché Imbriani non parli; il motivo per cui dal 1956, anno della sua pubblicazione, fino agli anni ’70 del secolo scorso, esso è stato punto di riferimento per tutti quelli che si sono occupati di folklore, fuori e dentro l’Accademia, mi sembra tuttavia un fatto notevole. Se non lo vogliamo ricordare può essere lecito, ma non possiamo dimenticare che Paolo Toschi per la sua caparbia attività (e forse una buona dose di ambizione personale) riuscì, dopo una stasi ventennale, a mettere in movimento tutto il settore del folklore, riportando all’Università la disciplina di Storia delle tradizioni popolari che ne era stata esclusa dopo la morte del Pitrè, che rimise in piedi la rivista Lares, che curò il negletto Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari di Roma: il che non mi pare impresa da poco, nonostante i suoi limiti teorici.
Tutto questo, comunque, non inficia il valore di un lavoro, come quello di Eugenio Imbriani, ben documentato ed esposto con somma chiarezza ed efficacia.
Dialoghi Mediterranei, n.60, marzo 2022
Note
[1] Sulle attività di studio e di ricerca della demologia italiana del ventennio fascista coloro che hanno scritto storie del folklore in Italia hanno voluto far calare una coltre di silenzio. Adesso, di questo strano oblio, se non inquietante, si è occupata la rivista «Lares» con il numero monografico 2021/2-3 (lxxxvii), «Antropologia italiana e fascismo. Ripensare la storia degli studi demo-etno-antropologici», a cura F. Dimpflmayer.
[2] Gli studi recenti condotti da B. Palumbo sulla religiosità popolare (si vedano il suo Piegare i santi, Marietti, Bologna 2020; e la mia recensione La modernità secondo Palumbo. Santi che si inchinano e sguardi che si interrogano, in «Dialoghi Mediterranei», 1 sett.2020, n. 45) riguardano una “cultura popolare” abbastanza simile a quella in vigore al tempo del Pitrè e degli scrittori veristi.
[3] Senza tener di conto le pubblicazioni finalizzate al patetico tentativo di riabilitare la monarchia borbonica da parte di alcuni presunti meridionalisti, su questo tema vasta e plurale è la letteratura storica; qui mi limito a segnalare il vecchio testo, a cura di A. Caracciolo, La formazione dell’Italia industriale, Laterza, Bari 1969.
_____________________________________________________________
Mariano Fresta, già docente di Italiano e Latino presso i Licei, ha collaborato con Pietro Clemente, presso la Cattedra di Tradizioni popolari a Siena. Si è occupato di teatro popolare tradizionale in Toscana, di espressività popolare, di alimentazione, di allestimenti museali, di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, Giovanni Pascoli e il mondo contadino, Lo stile narrativo nel Pinocchio del Collodi). Ha pubblicato sulle riviste Lares, La Ricerca Folklorica, Antropologia Museale, Archivio di Etnografia, Archivio Antropologico Mediterraneo. Ultimamente si è occupato di identità culturale, della tutela e la salvaguardia dei paesaggi (L’invenzione di un paesaggio tipico toscano, in Lares) e dei beni immateriali. Fa parte della redazione di Lares. Ha curato diversi volumi partecipandovi anche come autore: Vecchie segate ed alberi di maggio, 1983; Il “cantar maggio” delle contrade di Siena, 2000; La Val d’Orcia di Iris, 2003. Ha scritto anche sui paesi abbandonati e su altri temi antropologici.
______________________________________________________________








