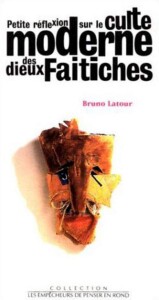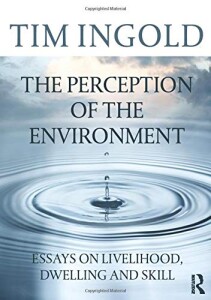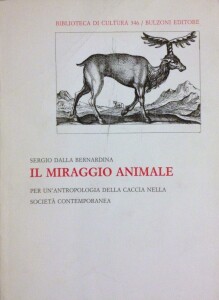Le ragioni di una similitudine
Nella sua celebre illustrazione del paradigma indiziario, Ginzburg (1986) ha richiamato l’attenzione sulla forte similitudine esistente tra l’esperienza della caccia e quella dell’inchiesta scientifica. Fin dalle prime righe lo storico mostra come gli studiosi delle discipline umanistiche fondino il loro lavoro su delle indagini di casi particolari, di spie e indizi per poter giungere – come i cacciatori che seguono le tracce di una preda – ad una verità scientifica di qualità (quantunque sempre perfettibile). L’analisi di Ginzburg è storiografica fino in fondo e, sebbene egli si mostri disposto a “prendere sul serio” le metafore venatorie, il collegamento tra l’esperienza della caccia e quella della decifrazione scientifica è spiegato dallo studioso come una maturazione semio-cognitiva che ha avuto origine nella notte dei tempi, una volta per sempre.
Il saggio di Ginzburg è dunque maggiormente concentrato a risolvere la polemica tra oggettivismo e soggettivismo e per tale ragione non mostra interesse nell’esplorazione della similitudine tra caccia e fare scienza. Rispetto a trent’anni fa, grazie agli studi sulla cultura materiale e sulle diverse ontologie, un simile confronto appare oggi meno azzardato poiché l’esigenza di sfumare i confini tra umano e antropomorfico, tra soggetto e oggetto, tra animato e inanimato è tendenza condivisa in antropologia, anche al di là delle varie contrapposizioni epistemologiche (Bird-David 1993, Latour 1996, Gell 1998, Ingold 2000, Mancuso 2020).
In questo articolo, facendo tesoro di queste ultime riflessioni, tenterò di svolgere la comparazione tra caccia e scienza archeologica e lo farò cercando di spingermi oltre la propedeutica considerazione che tali attività sono accomunate dalla presenza di un soggetto ricercante e di un soggetto ricercato. Per compiere questa inchiesta farò dialogare alcuni casi etnografici sul prelievo venatorio con i dati frutto della mia ricerca sul campo iniziata nel 2016 e che mi ha permesso, nel corso degli anni, di osservare e partecipare ad alcune campagne di scavo archeologico, sia professionali che universitarie, a Roma e nel Lazio meridionale [1] .
Data la forte similitudine retorica ed esperienziale tra attività venatoria e archeologia, l’idea è quella di adoperare le etnografie della caccia per illuminare ed inquadrare le pratiche archeologiche da un’angolatura attenta agli aspetti personali ed esistenziali del fare archeologia in Italia.
Nella comparazione tra caccia e archeologia voglio sin da subito sbarazzarmi della distinzione tra soggetti animati e inanimati non solo perché il collegamento tra morte e inattività è sempre di difficile attribuzione (Cozza 2021), ma anche perché la letteratura antropologica ha mostrato come i processi di antropomorfizzazione e quelli che conferiscono un’agency alle cose assegnano al mondo un aspetto più complesso di quello proposto dalla dicotomia soggetto/oggetto (Latour 1996, Gell 1998, Ingold 2000, Mancuso 2020).
Oltre ad essere il principale ingrediente di questa disciplina scientifica, l’indagine delle tracce del passato conferisce vividezza all’impresa archeologica. Ne è un esempio il caso di Laura – archeologa universitaria di circa trent’anni – la quale riporta alla luce un grosso frammento di marmo scanalato probabilmente facente parte di una colonna. Dopo tutti i rilievi scientifici del caso, la singolare sistemazione dell’oggetto spinge Laura a riferirsi ad esso con lo stesso tono che si usa per parlare ad un cucciolo che si è smarrito. L’antropomorfizzazione procede con l’assegnazione di un nomignolo: «ti piace il mio colonnino? È carino, l’ho chiamato Ugo Colonnino». Dalla bocca dell’archeologa il pezzo acquisisce un carattere al contempo buffo e malinconico anche per via del suo solitario rinvenimento: «poveretto Ugo, se n’è stato tutto solo per tutti questi anni». Nei giorni seguenti i componenti della squadra diretta da Laura si relazionano in maniera intima col reperto, lo si «chiama per nome», qualcuno dice di essercisi «affezionato» e il momento della sua rimozione dal cantiere si conclude con un caloroso saluto e qualche carezza: «addio Ugo, ci mancherai». «Se n’è stato buono e zitto, ogni tanto si faceva pulire il culetto» dice Laura concludendo quella joking relationship che ancora una volta rimanda al mondo della caccia e ad un certo modo diffuso di diventare intimi tra cacciatore e preda (Dalla Bernardina 2008).
Ma è il momento dell’indagine stratigrafico-ricostruttiva ad avvicinarsi di più all’esperienza venatoria in una modalità che va oltre la seppur fondamentale dimensione retorica di chi è coinvolto nello scavo. Mi riferisco ad un’immersione del soggetto in un’aumentata esperienza sensoriale del mondo e della decifrazione dei diversi elementi della realtà (Marvin 2005, Edgeworth 2006, 2012). A tal proposito salta agli occhi l’usuale ricorso alle metafore ferine con la mutazione degli operatori in «animali da scavo», «cani da tartufo» e «segugi» nonché la funzione divinatoria dei sogni e delle visioni che – proprio come nella caccia – dotano il soggetto ricercante di una consapevolezza supplementare (Nelson 1983, Hamilakis 2007, Greenland 2021). Oltre a ciò, la continua raccomandazione di usare la trowel per «pulire lo strato», «mettere in evidenza» e «vedere cosa esce» può essere intesa come la concretizzazione di un ambiente più propizio al palesamento della preda e alla sua cattura. Durante lo scavo spesso ci si riferisce ai reperti come a cose che «escono» o che «saltano fuori» quasi fossero delle bestie selvatiche (Edgeworth 2006, Greenland 2021). E come nella caccia, l’archeologa o l’archeologo deve immedesimarsi nelle intenzioni degli esseri di un passato più o meno lontano e deve provare a pensare e a muoversi come loro.
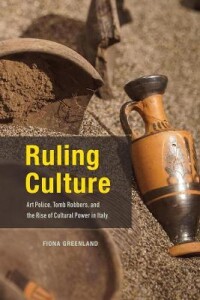 È ciò che si verifica nel caso di Livia, archeologa di circa trent’anni, la quale s’interroga sull’andamento planimetrico dell’area di scavo che dirige. In particolare, Livia si domanda la possibile destinazione d’uso di uno spazio racchiuso tra delle pareti ma che appare molto ristretto e modesto nonostante si trovi a contatto diretto con un edificio pubblico che doveva essere sfarzosamente decorato. Per provare a cogliere il senso di quell’ambiente, Livia usa il corpo muovendosi tra i resti come un antico pedone e mima il superamento di soglie o gradini. Nota che questo risulterebbe ulteriormente angusto e malagevole se fosse dotato di una porta a battente e dunque «fa delle prove» di altre possibili forme di ingresso al fine di comprendere la relazione che quello spazio poteva avere con gli edifici e le strade adiacenti. «Queste sono le chicche che ti dà l’archeologia», mi dice Livia, «è come un puzzle che finché non trovi la soluzione non dormi la notte […] quando non sai cosa stai scavando è molto stressante […] ma quando trovi la soluzione c’è il godimento».
È ciò che si verifica nel caso di Livia, archeologa di circa trent’anni, la quale s’interroga sull’andamento planimetrico dell’area di scavo che dirige. In particolare, Livia si domanda la possibile destinazione d’uso di uno spazio racchiuso tra delle pareti ma che appare molto ristretto e modesto nonostante si trovi a contatto diretto con un edificio pubblico che doveva essere sfarzosamente decorato. Per provare a cogliere il senso di quell’ambiente, Livia usa il corpo muovendosi tra i resti come un antico pedone e mima il superamento di soglie o gradini. Nota che questo risulterebbe ulteriormente angusto e malagevole se fosse dotato di una porta a battente e dunque «fa delle prove» di altre possibili forme di ingresso al fine di comprendere la relazione che quello spazio poteva avere con gli edifici e le strade adiacenti. «Queste sono le chicche che ti dà l’archeologia», mi dice Livia, «è come un puzzle che finché non trovi la soluzione non dormi la notte […] quando non sai cosa stai scavando è molto stressante […] ma quando trovi la soluzione c’è il godimento».
Questo modo di individuare nella soluzione degli enigmi la fonte del piacere dell’indagine archeologica – indipendentemente dalla specializzazione e dagli anni di esperienza – è uno dei temi più ricorrenti tra le archeologhe e gli archeologi che ho avuto modo di frequentare. La mia attiva collaborazione negli scavi mi ha permesso di assistere a numerosi episodi di questo genere; momenti spesso contraddistinti da un certo nervosismo da parte di chi opera poiché in un ambiente a forte competizione, la presenza di un soggetto che non si fa identificare e dunque non si lascia «afferrare» all’interno di uno scavo – come una preda che sfugge al suo cacciatore – rappresenta una minaccia al valore di chi dirige l’impresa ricostruttiva ma soprattutto costituisce la negazione di quella esperienza dell’essere scelti che è centrale nel fare archeologia come nella caccia.
Una volta entrati in contatto visivo con il loro cacciatore i caribù hanno l’abitudine di restare immobili a fissare la fonte della loro minaccia, giusto per guadagnare tempo prima di lanciarsi in uno scatto fulmineo che il più delle volte può sorprendere l’avversario (specialmente se questi non è attrezzato con armi a propulsione). I cacciatori Cree dell’attuale Canada sostengono che in quelle occasioni è l’animale a scegliere intenzionalmente il suo cacciatore e dunque l’incontro tra i due va inteso come un’offerta volontaria al fine della costruzione di una qualche tipologia di relazione di reciprocità (Ingold 2000).
Tale interpretazione è paradigmatica di molti altri modi di intendere le attività venatorie poiché – in maniera esplicita o implicita – il contatto tra chi caccia e chi è preda è infatti sempre raccontato come una reciproca scelta, come la costruzione di un rapporto di intimità e condivisione dell’umano con l’animale ucciso (Dalla Bernardina 1987, 2003, Bird-David 1993, Ingold 2000, Knight 2012).
Si tratta di avvertire un’intenzionalità favorevole del soggetto ricercato che presenta una notevole analogia con l’esperienza dello scavo archeologico. A giudicare dai resoconti che ho raccolto e dagli eventi a cui ho potuto partecipare, l’incontro tra chi scava e chi è scavato non si verifica mai casualmente ma sempre è possibile cogliere un legame che era attivo anche quando i due capi del filo non ne erano ancora totalmente coscienti. Anche per via della tendenza ad usare il passato per criticare e distinguersi nel presente (cosicché “chi scava” si (ri)conosce in “chi è scavato”), un determinato reperto è sempre in relazione con l’autore o l’autrice del rinvenimento o comunque la scoperta reca sempre una storia di cura e condivisione che fornisce anche la giustificazione della concretizzazione di quel ritrovamento: quell’incontro è avvenuto con quel soggetto, in quel preciso momento, durante quel dato turno di lavoro.

La moneta rinvenuta durante uno scavo archeologico che “cerca di convertire” l’etnografo in archeologo (ph. Fulvio Crozza)
È quello che succede durante il mio coinvolgimento diretto nelle attività di scavo stratigrafico allorquando ho modo di intercettare una moneta d’epoca antica. In ironico contrasto alla mia attività etnografica, l’archeologa che dirige il settore mi dice che: «questo è un segno. L’archeologia ti sta chiamando a sé […] ti sta convertendo».
Durante un’altra campagna di scavo, dopo diversi giorni d’indagini passati senza intercettare alcun elemento che catturasse il nostro interesse, dopo aver dato il cambio ad altri due colleghi, Claudio ed io finalmente rinveniamo in stratigrafia un frammento di affresco sul quale si intravede una decorazione floreale. «Te l’avevo detto», mi dice Claudio ammirando quella traccia dei tanto amati antichi romani, «questo ce stava aspetta’».
È nella stessa direzione che va la storia di Fabio, archeologo di circa cinquant’anni, il quale mi descrive l’esordio di uno scavo che nel corso degli anni – anche grazie alla collaborazione della sua squadra – avrebbe riportato alla luce reperti di grande rilievo. Fabio mi racconta tutte le indagini propedeutiche «non invasive» e quindi mi illustra il criterio utilizzato per selezionare – in una vasta area agricola – il punto esatto da cui cominciare lo scavo vero e proprio: «io avevo ricostruito la griglia urbana e quindi sapevo dove potessero passare le strade. La scelta del posto non fu casuale […] anche se non si va mai a colpo sicuro». Fabio mi racconta che tuttavia tale scavo d’esordio, di soli m 5×5, non aveva restituito che piccoli elementi attraverso i quali sarebbe stato molto difficile motivare e finanziare delle indagini più approfondite. A questo punto entra in scena ciò che egli – anche seguendo le ironiche considerazioni del suo team – definisce «fattore C», sarebbe a dire la sua capacità di intercettare “fortuitamente” dei reperti non comuni. Fabio dirige la mia attenzione verso un’area situata a qualche decina di metri dal punto dove avvenne il primo saggio:
«Lungo quella fila di alberi c’era una specie di rientranza […] allora mi sono spostato lì perché magari è una zona più riparata e troviamo cose più conservate […] ho iniziato io a mano, poi è subentrato un operaio e infine è venuto ad aiutarci l’escavatorista […], però scendi e scendi ma non succedeva niente, stavamo per rinunciare ma all’ultima passata abbiamo sentito il rumore metallico che senti quando strusci su quello che è poi risultato essere un pavimento in mosaico con una bella iscrizione […] da lì è partito tutto».
Nonostante il riferimento al fattore C, quando Fabio passa in rassegna le scoperte della sua carriera egli stesso sottolinea quanto alla base di tali successi ci debba essere una rigorosa applicazione di metodi e strumenti ma anche un «fiuto particolare», «una tigna» che l’ha premiato poiché senza tali caratteristiche non sarebbe mai esistito l’importante sito archeologico che dirige da diversi anni. «In archeologia», mi dice Fabio, «uno la fortuna se la deve anche saper creare».
Sebbene in un diverso ordine di rilevanza, i tre casi che ho presentato sono tutte esperienze accomunate dalla percezione di un rapporto privilegiato tra chi scava e chi è scavato. Ma che senso può avere questa esperienza dell’essere scelti?
Le etnografie della caccia hanno spesso descritto ecosistemi dall’occhio vigile cioè capaci di giudicare le azioni dei loro abitanti propiziandone il prelievo o sanzionando l’infrazione dei tabù attraverso malefici e cattiva sorte (De Martino 1948, 1977, Nelson 1983, Ingold 2000). In molti casi il successo nell’attività venatoria è solo in parte il riflesso dell’abilità tecnica del cacciatore poiché il segno del suo valore ha bisogno di un raffronto non unilaterale, cioè che sia il prodotto dell’approvazione di un soggetto altro da sé che è spesso collocato ad un livello superiore e che in molte occasioni dispensa il predatore dalle sue responsabilità di carnefice (Dalla Bernardina 2008).
Se nella caccia tale “favore” si concretizza nel prelievo della preda che viene a concedersi, nulla vieta l’interpretazione dei reperti archeologici come a delle prove tangibili della cura e della fiducia accordate a chi scava. Indipendentemente che tali cure amorevoli vengano classificate come frutto della fortuna, del destino o dell’intenzionalità di qualcosa o qualcuno, ciò che conta è che emerga come spia di un valore consacrato altrove – magari attraverso il supporto della materialità dei reperti – oltre i limiti dell’esperienza soggettiva e delle possibilità individuali.
Caccia e archeologia si trovano dunque a condividere un comune sistema di validazione del sé, assai malleabile, attraverso il quale ciascuno può esaminare e redimere aspetti variegati e complessi della vita quotidiana in contesti diversi come le foreste americane, i boschi europei, le steppe asiatiche e il mondo dell’archeologia romana.
A proposito dell’ultimo contesto, quello oggetto della mia indagine etnografica, l’idea di percepire la propria attività come frutto di un’investitura non unilaterale sembra riflettere anche il desiderio di adeguarsi ad un immaginario della realizzazione del sé in cui il successo professionale ha necessità di essere riconosciuto e legittimato attraverso un piano trascendentale, al di là del discorso autoreferenziale e dunque abdicando alla possibilità individuale di essere centro di un progetto d’azione e di scelta (de Martino 1977, Armano, Bove e Murgi 2017; Mollona, Papa, Redini e Siniscalchi 2021). Non basta “semplicemente” fare archeologia, bisogna che qualcosa di più grande e importante riconosca le virtù professionali delle operatrici e degli operatori consacrando le loro identità di soggetti validi che tuttavia restano dipendenti ad un potere che sta altrove.
Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023
Note
[1] Trattando un tema assai vicino al delicato universo dell’intimità professionale, anche considerando il clima piuttosto competitivo in cui si sviluppano le carriere archeologiche e non solo, ho adottato dei nomi fittizi per tutte le persone coinvolte nella mia inchiesta e ho volutamente evitato di inserire informazioni troppo specifiche riguardanti le località e gli scavi in cui ho avuto la possibilità di svolgere la mia osservazione partecipante. Con l’occasione ringrazio tutte queste persone per il tempo e la fiducia accordatami.
Riferimenti bibliografici
Armano, E. – Bove, A. – Murgi, A., a cura, (2017), Mapping Precariousness, Labour Insecurity and Uncertain Livelihoods. Subjectivities and Resistance, London-New York, Routledge.
Bird-David, N., (1993), Tribal metaphorization of human-nature relatedness: a comparative analysis, In K. Milton, a cura, Environmentalism: the view from anthropology, London, Routledge: 112-125.
Cozza, F. (2021), Al di là dello scavo. Archeologia e Pratiche del Cordoglio nell’Italia Contemporanea, “Lares”, n. 87 (1): 87-110.
Dalla Bernardina, S. (1987), Il Miraggio animale. Per un’antropologia della caccia nella società contemporanea, Bulzoni, Roma.
Dalla Bernardina, S. (2003), I doni del cacciatore. La morte dell’animale tra simulazione sacrificale e pragmatismo, in C. Tugnoli, a cura, Zooantropologia. Storia, etica e pedagogia dell’Interazione uomo-animale, Milano, Franco Angeli: 211-231.
Dalla Bernardina, S. (2008), Voglia di immortalare: polisemia del trofeo, “Lares”, n. 74 (1): 63-84.
De Martino, E. (1948), Il Mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Torino, Einaudi.
De Martino, E. (1977), La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Torino, Einaudi.
Edgeworth, M. (2012), Follow the Cut, Follow the Rhythm, Follow the Material, “Norwegian Archaeological Review”, n. 45 (1): 76-92.
Edgeworth, M. a cura, (2006), Ethnographies of Archaeological Practice. Cultural Encounters, Material Transformation, Oxford, Alta Mira Press.
Gell, A. (1998), Art and Agency: An Anthropological Theory, Oxford, Oxford University Press.
Ginzburg, C. (1986), Miti Emblemi Spie. Morfologia e storia, Torino, Einaudi.
Greenland, F. (2021), Ruling Culture. Art Police, Tomb Robbers, and the Rise of Cultural Power in Italy, Chicago, University of Chicago Press.
Hamilakis, Y. (2007), The Nation and its Ruins. Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece, Oxford, Oxford University Press.
Ingold, T. (2000), The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, London, Routledge.
Knight, J. (2012),The Anonymity of the Hunt: A Critique of Hunting as Sharing, “Current Anthropology”, n. 53 (3): 334-355.
Latour, B. (1996), Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches, Paris, Synthélabo.
Mancuso, A. (2020), La ‘svolta ontologica’ e le questioni epistemologiche in antropologia, “Rivista di Antropologia Contemporanea”, 1, 1: 55-90.
Marvin, G. (2005), Sensing Nature: Encountering the World in Hunting, “Etnofoor”, n. 18 (1): 15-26.
Mollona, M. – Papa, C. – Redini, V. – Siniscalchi, V. (2021), Antropologia delle imprese. Lavoro, reti, merci, Roma, Carocci.
Nelson, R. K. (1983), Make Prayers to the Raven: A Koyukon View of the Northern Forest, Chicago-London, University of Chicago Press.
______________________________________________________________
Flavio Cozza, Dottore di ricerca in Antropologia culturale ed Etnologia presso la Sapienza Università di Roma. I suoi studi riguardano il rapporto tra vita quotidiana, pratiche archeologiche e forme di intimità nello spazio urbano di Roma. Nel 2018, insieme a Francesco Aliberti, ha coeditato il libro “Mobilità Culturale e Spazi Ospitali”, Roma, Cisu. 2018. Nel 2021, riguardo agli usi personali e creativi dei saperi professionali, ha pubblicato una monografia frutto della sua ricerca etnografica in alcuni scavi archeologici universitari dal titolo Fare Archeologia. Etnografia delle Pratiche Ricostruttive, Roma, Cisu.
_______________________________________________________________