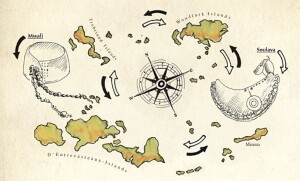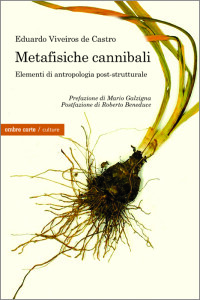di Giovanni Cordova
Nelle settimane in cui iniziavo a ragionare intorno al contenuto di questo contributo per Dialoghi Mediterranei, in circostanze del tutto casuali ho avuto modo di incontrare e interloquire con un ricercatore italo-canadese incaricato, da un’importante ONG, da diverso tempo ormai, impegnata nel salvataggio di vite nel Mar Mediterraneo, di condurre una ricerca sulle percezioni e le rappresentazioni sociali intorno alle quali ha preso forma negli ultimi anni la criminalizzazione della solidarietà e degli attori che la costruiscono. Nelle parole del ricercatore, l’organizzazione non governativa per la quale lavora è rimasta profondamente scossa dalle accuse (infondate ma piuttosto radicate nel tessuto sociale e in particolar modo nella sfera digitale) che le sono state rivolte e che hanno determinato conseguenze di non poco conto anche sul piano economico e finanziario dell’organizzazione, avendo registrato un crollo delle donazioni e del sostegno di tante e tanti simpatizzanti.
L’avvelenamento del clima politico e sociale su temi come la solidarietà e l’accoglienza ha condensato e condensa tutt’oggi risentimento sociale, teorie del complotto, razzismi di varia conformazione e strumentalizzazioni politiche, indirizzati contro un bersaglio perfetto: gli invasori e i loro complici, traditori dell’integrità della nazione – categoria politica, quest’ultima, oggi ampiamente rispolverata, com’è noto. Non si tratta di un fatto esclusivamente italiano o regionale: dinamiche analoghe si sono verificate in tutta Europa e non solo, in un gioco non del tutto sorprendente di rimandi e analogie. Del resto non ci stupiamo più nell’assistere su scala globale al prestito e allo scambio di registri di mobilitazione dispiegati contro le migrazioni e la minaccia alla purezza identitaria (registri ricondotti, forse un po’ semplicisticamente, alle categorie del populismo e del sovranismo) che condividono armamentari retorici, infrastrutture digitali, prassi organizzative, persino concezioni biologizzate del corpo sociale e, soprattutto, matrici e genealogie storico-culturali.
Si è molto scritto, negli ultimi anni, di nazionalismo, populismo, xenofobia, respingimenti, razzismi e reviviscenza delle “nuove” destre, in Europa e oltre. Al riguardo esiste ormai un ampio e aggiornato corpus di studi e ricerche nel campo delle scienze sociali, e diverse etnografie si focalizzano sulla germinazione della criminalizzazione della solidarietà in seno all’opinione pubblica dei Paesi che si sono dovuti confrontare con la gestione di flussi migratori nell’età in cui la mobilità è stata messa sotto scacco, forzata, irrigidita e sottoposta a un regime di stringente controllo sociale e repressione (Pinelli 2022). Questi studi sottolineano come l’emersione e l’evoluzione di sentimenti di ostilità contro l’altro non possano essere disgiunti dall’allestimento di regimi della frontiera e del trattamento politico-giuridico cui va incontro la figura del migrante (Giliberti 2018). In altri termini, politica e morale vanno di pari passo, alimentandosi a vicenda senza che una delle due (la sfera delle decisioni politiche e delle istituzioni da una parte; l’economia morale dall’altra) possa rivendicare una matrice primigenia nel direzionare i flussi di opinione e i processi politici nella sfera pubblica.
Ciò che in queste pagine vorrei azzardare è però una riflessione, ancora in una fase aurorale, sui significati politici e morali della solidarietà e della sua negazione, attingendo ad ambiti ed esempi della vita sociale che eccedono il campo delle migrazioni e dell’accoglienza.
Al plurale
«Ecco un’altra questione, in che modo dobbiamo comportarci con gli uomini. Cosa facciamo? Quali insegnamenti diamo? (Insegniamo) a non spargere sangue umano? Quanto è piccola cosa non nuocere a colui al quale ciò debba giovare! Grande merito davvero se l’uomo è mite verso l’(altro) uomo. Insegneremo a porgere la mano al naufrago, a mostrare la strada all’errante, a dividere il pane con l’affamato? Perché dico tutte le cose da fare o da evitare, quando posso brevemente trasmettere questa formula di tutte quelle attività umane? Tutto ciò che vedi, in cui sono contenute le cose divine e umane, è unico; siamo membra di un grande corpo. La natura ci ha creato parenti, avendoci creato dagli stessi elementi e per gli stessi fini, ci ha ispirato l’amore reciproco e il dovere della solidarietà operosa. Essa ha stabilito l’equo e il giusto; secondo il suo ordinamento è cosa più miserevole fare il male che subir(lo); secondo il suo comando, che le mani siano pronte per coloro che devono essere aiutati. Sia sempre sia nel cuore sia nella bocca quel famoso verso: “Sono un uomo; niente di umano ritengo a me estraneo”».
In una delle Epistulae Morales ad Lucilium (la n. 95), Seneca affida al genere epistolare, particolarmente congeniale ai suoi sforzi pedagogici, una riflessione tendente alla validazione retorica del dovere della solidarietà. Ho riportato questo passaggio perché l’argomentazione cui Seneca fa ricorso ricorda alcune delle tonalità con cui le scienze sociologiche e antropologiche si sarebbero soffermate, molto tempo dopo, sulla solidarietà e sul legame sociale. Infatti, Seneca sembra addurre a fondamento del suo richiamo al dovere della solidarietà quasi un’evidenza scientifica, evocata con piglio analitico e descrittivo, piuttosto che basarsi esclusivamente su un tono esortativo dalla connotazione morale. Unità del reale e delle rappresentazioni; parentela; partecipazione organica ad una totalità quasi-corporea; reciprocità: non è necessario un grande sforzo di immaginazione per cogliere alcuni dei temi che una certa trattazione socio-antropologica avrebbe fatto propria – a partire dalla metafora durkheimiana dei segmenti del lombrico, per non citare la parentela, che avrebbe attraversato gli studi antropologici da Lewis Henry Morgan fino ai nostri giorni. In ogni caso, nell’impianto retorico senechiano emerge un tratto ricorrente della riflessione senza tempo sulla solidarietà: la caratterizzazione sociale intrinseca all’essere umani.
Hannah Arendt ha sottolineato con tonalità particolarmente evocative come la condizione umana non possa che declinarsi al plurale. Del resto, una lunga tradizione di pensiero che affonda le sue radici nella filosofia classica – per limitarci a una genealogia occidentale – non fa che insistere sulla natura sociale dell’essere umano, tradizione che il ‘giro lungo’ dell’antropologia e della ricerca etnografica ha vivificato riscontrando diverse, ricche e complicate modalità attraverso le quali gruppi e società umane intessono senza sosta relazioni di scambio, mutualità, reciprocità (conflitto compreso) – dai mari solcati in canoa intorno alle isole Trobriand fino alla ragione sociologica del tabu dell’incesto, passando per la politica della molteplicità extra-locale, coagulata nella figura dell’alleato politico, che per Viveiros de Castro (2021) garantisce la circolazione delle alterità e la dispersione identitaria del socius “primitivo” su cui tanto ha scritto Pierre Clastres.
Dalla sociologia durkheimiana alle più recenti acquisizioni teorico-etnografiche del cosiddetto ethical turn sembra difficile, se non impossibile, immaginare la condizione umana al di fuori di un’osmotica interrelazione che lega il soggetto pensante-agente alle entità (non necessariamente umane) che lo attorniano, entità classificate di volta in volta nelle categorie del “vicino”, del “nemico”, dello “straniero”, dell’“affine”, dell’“alterità” par excellence data dal sacro. Per diversi studiosi (come Rudolf Otto, Mircea Eliade e tanti altri) è la dimensione della trascendenza a definire la condizione elementare e necessaria dell’esperienza religiosa (Fabietti 2015). Avvertire l’Altro-fuori-da-noi rivela la natura incorporata della condizione umana: come ha affermato l’antropologo Thomas Csordas (2004; 2009) attingendo alla prospettiva fenomenologica di Merleau-Ponty, la struttura elementare dell’esistenza incorporata risiede proprio nel predicato fenomenologico e culturalmente elaborato dell’ineliminabile senso dell’alterità che istituisce l’inevitabilità della dimensione religiosa.
Ne La divisione del lavoro sociale (1893), Émile Durkheim definisce la necessaria fibra comunitaria intessuta dai componenti di un raggruppamento sociale applicandole il termine di “solidarietà”, mediante la celebre contrapposizione tipologica della solidarietà “meccanica” e della solidarietà “organica”, che riflettono a loro volta la presenza e la consistenza dei legami sociali nella vita del singolo. Nelle società caratterizzate da una solidarietà di tipo meccanico, la coscienza e le rappresentazioni collettive plasmano l’individuo al punto dal risultargli coestensive. Le norme sociali guidano l’azione collettiva suscitando riprovazione sociale (ovvero solidarietà) di fronte a ogni trasgressione delle norme – per Durkheim, infatti, è l’anomia la patologia capace di mettere in crisi il legame sociale. Nelle società in cui invece prevale una solidarietà di tipo organico, l’appartenenza dell’individuo al collettivo è il frutto di un’adesione consapevole e volontaristica (nonché utilitaristica), dettata da più complessi e stratificati processi di segmentazione sociale esemplificati dalla divisione del lavoro.
In tempi più recenti, una proteiforme riflessione interna alle scienze sociali e all’antropologia in particolare (Keane 2016; Lambek, Das, Fassin, Keane 2015; Laidlaw 2014) ha problematizzato il concetto di etica e la sua irrinunciabile assunzione nell’agire umano all’interno di processi che sono insieme neurologici, cognitivi, psicologici, sociali, politici, culturali. Il decentramento da Sé che permette l’oggettivazione consapevole della propria esperienza sociale e l’auto-riflessività – necessarie alla coltivazione etica della soggettività – non rientrano in un percorso esclusivamente individuale o intrapsichico. Preoccuparsi di qualcosa – individuare, stabilire o aderire ai criteri che definiscono ciò per cui valga la pena preoccuparsi ed interessarsi – e determinare quali parametri di ‘giusto’ e ‘sbagliato’ concorrano alla definizione e alla coltivazione di essere umani ‘particolari’, plasmati dalla disposizione congiunta dell’esercizio di discernimento individuale così come da specifici sistemi morali (culturalmente mediati, tangibili, espliciti, socialmente condivisi e politicamente istituiti) sono processi la cui trama è intimamente intersoggettiva. La vita non diventa etica in seguito all’intraprendenza di un percorso virtuoso meramente individuale, privato. È nell’interazione con gli altri che emerge, mediante giustificazioni, giudizi, apprezzamenti e attribuzioni di colpa, la riconoscibilità stessa di preoccupazioni, atti ed espressioni che riguardano la vita “buona”. Basta un semplice esercizio di memoria: chi non ricorda conversazioni o scambi avvenuti durante l’infanzia, intrattenuti generalmente con persone aventi ruoli di carattere educativo/formativo, non necessariamente formale, e che hanno orientato o influenzato (anche solo per un periodo della vita) il nostro modo di intendere e valutare l’esistente?
“Etica” implica dedicare se stessi e le proprie azioni a determinati valori, mezzi e fini specifici e individuati rispetto ad altrettanti valori, mezzi e fini ai quali tuttavia non si aderisce: l’impegno etico – sorpreso nell’ordinaria scansione della vita quotidiana – ci porta a pensarci gli uni rispetto agli altri. E se non è la solidarietà il risultato necessario di questa proiezione ortogonale dell’uno sul molteplice, ne consegue quanto meno l’impossibilità di pensare l’essere umano, la sua individualità e la sua immanente costituzione personale al di fuori di una trama sociale intersoggettiva e collettiva.
Se la condizione umana non costituisce un predicato monadico, le conseguenze di tale assunto possono spingersi ben al di là del mero discorso accademico, giungendo a ribaltare categorie e classificazioni con cui le relazioni ordinarie tra esseri umani e non umani sono generalmente declinate. La variegata linea di ricerca maturata in seno alla “svolta ontologica” per esempio, si impegna a traslare il campo delle differenze dall’ambito delle prospettive – le world views – a quello dell’ontologia delle diverse “forme di vita” e, dunque, dalle rappresentazioni alla realtà dei mondi umani e non umani. In altri termini, i gruppi sociali possono oggettivare in modo differente la relazione tra il piano dell’interiorità e il piano della fisicità, tra individualità e ‘dividualità’, tra definizione idiosincratica ed egocentrata dell’identità e diluzione della ‘persona’ in reti ampie e diffuse di relazioni sociali.
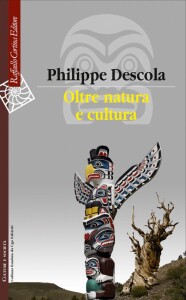 Dunque, con Philippe Descola (2021: 102) «[…]se considero un animale come una persona dotata di facoltà analoghe alle mie, come un essere intenzionale attento ai discorsi che posso tenergli, allora rivolgersi a lui con le illusioni della buona creanza non è più strano che darsi i mezzi tecnici per ucciderlo». Nient’affatto una provocazione. Siamo ben oltre la diade di natura e cultura, da intendere qui come domini ipostatizzati dalla cesura naturalistica sui cui si è fecondamente innestata la disciplina dell’antropologia culturale. Il concetto di “prospettivismo” che per l’antropologo brasiliano Viveiros De Castro caratterizza le cosmologie amerindiane esalta la reversibilità della posizionalità e dei punti di vista dei diversi “collettivi” – umani e non umani – abitanti l’ecosistema. In un passaggio che ben esemplifica la teorizzazione dell’autore, presso le comunità indigene amerindie
Dunque, con Philippe Descola (2021: 102) «[…]se considero un animale come una persona dotata di facoltà analoghe alle mie, come un essere intenzionale attento ai discorsi che posso tenergli, allora rivolgersi a lui con le illusioni della buona creanza non è più strano che darsi i mezzi tecnici per ucciderlo». Nient’affatto una provocazione. Siamo ben oltre la diade di natura e cultura, da intendere qui come domini ipostatizzati dalla cesura naturalistica sui cui si è fecondamente innestata la disciplina dell’antropologia culturale. Il concetto di “prospettivismo” che per l’antropologo brasiliano Viveiros De Castro caratterizza le cosmologie amerindiane esalta la reversibilità della posizionalità e dei punti di vista dei diversi “collettivi” – umani e non umani – abitanti l’ecosistema. In un passaggio che ben esemplifica la teorizzazione dell’autore, presso le comunità indigene amerindie
«[D]i solito, in condizioni normali, gli umani vedono gli umani come umani, gli animali come animali e gli spiriti (se li vedono) come spiriti; tuttavia, gli animali (i predatori) e gli spiriti vedono gli umani come animali (come prede), mentre gli animali (la selvaggina) vedono gli umani come spiriti o come animali (predatori). Al contrario, animali e spiriti vedono se stessi come umani: percepiscono se stessi come (o diventano) esseri antropomorfi quando sono nelle loro case o villaggi ed esperiscono le loro abitudini e caratteristiche nella forma della cultura» (Viveiros De Castro 1996: 117).

La foresta amazzonica e le popolazioni indigene che vi abitano negli ultimi anni hanno subito un vero e proprio eco-genocidio
Che non si tratti esclusivamente di un gioco di illusioni e artifici rappresentazionali è lo stesso Viveiros de Castro a chiarirlo in un altro passaggio: «tutti gli esseri vedono (“rappresentano”) il mondo allo stesso modo: ciò che cambia è il mondo che essi vedono» (2017: 57). Date queste premesse ontologiche, si ribalta completamente la configurazione dei regimi di sociabilità che legano umani, animali e spiriti, come testimoniano altri veri e propri “rompicapi” antropologici che hanno suscitato dibattito e provocato diatribe. “Noi siamo pappagalli rossi”, affermano i Bororo del Brasile, e gli esempi potrebbero continuare lungo un canovaccio che comprenderebbe, secondo la sintetica ma avvincente ricostruzione di Engelke (2018) anche la celebre uccisione rituale di capitan Cook-dio Lono alle Hawaii nel 1779.
Senza poterci addentrare nella selva di esegesi e peregrinazioni ermeneutiche tra etnografia e relativismo epistemologico, poco importa che si tratti di identificazioni rituali o di associazioni metaforiche (Crocker 1977): uomini, pappagalli, spiriti e giaguari intessono reti complesse di identificazione, relazione e alterizzazione. La solidarietà, in questi compositi scenari, non rappresenta che un pallido atomo rispetto alla ricchezza dell’architettura molecolare ontologico-cosmologica che plasma le coscienze, i corpi, le prospettive, i comportamenti individuali e collettivi. Forse un passaggio ardito, questo, rispetto alla discussione intorno alla solidarietà che era stata avviata all’inizio del contributo ma che potrebbe, almeno in potenza, rivestire una qualche utilità in una discussione sulla solidarietà, come spero di poter dimostrare più avanti.
Politica della solidarietà
Negli ultimi anni ha periodicamente destato scalpore la ricorrenza di espressioni aggressive indirizzate dai profili di social network a migranti sopravvissuti a naufragi o persino alle vittime di queste tragedie. A impressionare è la discrasia tra l’oscena e volgare crudeltà di questi commenti (da qualche anno inquadrabili nella categoria giuridica del ‘reato d’odio’) e la presentazione di Sé che gli stessi autori di queste espressioni configurano sui medesimi canali social: foto in pose dolci e tenere con figli o nipoti; attenzione e sensibilità rivolta agli esseri non umani (in particolar modo, agli animali da compagnia); l’esibizione di gusti e interessi da cui non è facile dedurre alcuna acrimonia nei confronti dei migranti. Perché allora incedere in commenti di quel tipo?
Più che tirare in ballo l’assenza o la scomparsa della solidarietà, bisognerebbe addurvi una motivazione multifattoriale. Prima di tutto l’assuefazione alle morti in mare che l’articolazione stessa dello “spettacolo della frontiera” (border spectacle), su cui ha scritto l’antropologo Nicholas De Genova (2013), ingenera, determinando una progressiva abitudine al funesto destino di ormai centinaia di migliaia di persone sepolte negli abissi del Mediterraneo. Nel border spectacle la complessità di un processo come quello migratorio viene ridotto allo sbarco (o al naufragio) mediante la spettacolarizzazione dell’intervento della frontiera e degli attori che vi operano presidiandola e proteggendola da quelli che nell’immagine e nella narrazione veicolata da media e politica sono rappresentati come indebiti intrusi. Andrebbe poi senz’altro riconosciuta l’incapacità di assumere un orientamento empatico e di risonanza affettiva nei confronti di sconosciuti che percepiamo senza nome, senza origini, senza identità, senza personalità, e che si inabissano prima ancora che uno scambio, anche solo immaginario, possa aver luogo con gli abitanti di quelle mete in cui non approderanno mai.
Un fattore di cui tener conto, quest’ultimo, ma che ci trascinerebbe in una disamina che contiene il rischio di presentarsi come endo-psichica ed eccessivamente generalizzante, dunque incapace di restituire la cifra di comportamenti assunti (consapevolmente) su scala collettiva. Infine, andrebbe tenuta in considerazione la rischiosa e seducente possibilità che i social network offrono di ‘giocare’ con le identità e con i pronunciamenti senza assumere fino in fondo le conseguenze dei propri atti – tendenza, questa, che negli ultimi anni sta tuttavia subendo una trasformazione, visto l’avvio di procedimenti di natura giudiziaria contro gli autori di crimini d’odio a mezzo digitale. Nessuna di queste motivazioni, a mio avviso, ci permette di comprendere la genesi politica di questi atti di ‘mancata solidarietà’, che molti – e immagino la maggior parte dei lettori e delle lettrici di Dialoghi Mediterranei – considerano come innaturale, dal momento che provare solidarietà assume le sembianze di un sentimento così forte e istintuale da non far scorgere le radici sociali e politiche su cui esso si incardina.
Detto in altri termini, credo che una delle chiavi di lettura attraverso cui accostarsi alla solidarietà consista nel leggere questo fenomeno come un insieme malleabile di formule verbali e non verbali, comportamenti, iniziative e disposizioni mobilitabili secondo le congiunture storiche e politiche. L’esempio delle morti in mare e della criminalizzazione della solidarietà rappresenta un caso limite in quanto ha a che fare con la morte e la vita apparentemente deprivate della loro caratterizzazione politica e morale, in realtà ben attiva dietro le rappresentazioni, le percezioni e gli orientamenti discorsivi che suscitano. Lo stesso potrebbe dirsi nei confronti di catastrofi ‘naturali’ come terremoti o inondazioni, capaci di produrre commozione e attivazione solidale in modo selettivo, in base a parametri di vicinanza, riconoscibilità e facilità di percezione rispetto alle coordinate storico-geografiche dei contesti in cui si verificano le avversità.
Un esempio forse meno drammatico e per questo più adatto ad alimentare un esercizio di riflessione sulle disavventure della solidarietà riguarda un ambito e, nello specifico, un’iniziativa esplicitamente inaugurata entro e riconducibile a un ambito politico e persino governativo. Si tratta di quella forma di sussidio rientrante nelle tipologie di reddito minimo garantito che è il reddito di cittadinanza, sul quale dopo alcuni anni di ampio dibattito, parallelamente all’implementazione della misura, pare che l’attuale governo abbia deciso di applicare la scure di tagli che conducono al pesante ridimensionamento dell’iniziativa.
Ora, interessante ai fini di questo contributo è registrare i regimi discorsivi che hanno un carattere critico rispetto alla misura del reddito. Non è possibile in questa sede entrare nei dettagli socio-economici che rendono il reddito di cittadinanza coerentemente in linea con i gravi livelli di povertà certificata da indici, agenzie e ricerche di ogni tipo, specie dopo la pandemia, e a cui rimando per un approfondimento, e alla tortuosa configurazione dei processi di ricerca del lavoro in Italia. Su quest’ultimo punto molte critiche al reddito di cittadinanza hanno argomentato che l’erogazione del reddito – peraltro in linea con analoghe misure di sostegno al reddito presenti in Europa – ostacola la ricerca del lavoro, compromettendo la salute del mercato del lavoro nazionale. L’enucleazione di questo punto, che certo astrae dalla concreta realtà del mondo del lavoro vissuta soprattutto da chi abita le periferie del lavoro salariato, riflette l’ancoramento della misura del reddito di cittadinanza alla ricerca attiva del lavoro, nodo problematico per chi scrive.
In ogni caso, l’attacco al reddito di cittadinanza (e alla non ricattabilità delle classi popolari) si nutre di una varietà di spunti e di temi, tra i quali la falsificazione dei requisiti richiesti per ottenere il sussidio; la difficoltà degli operatori economici e dei datori di lavoro di recuperare manodopera; la non brillante parabola degli strumenti di ricerca e avvio al lavoro (i navigator) previsti dalla misura. Un’immagine, tuttavia, sussume l’intera struttura retorico-politica dell’attacco al reddito di cittadinanza: quella dei giovani sul divano a oziare mentre gli altri (i non percettori del reddito) lavorano duramente. Inutile anche entrare nel merito, e dimostrare, ad esempio, che la preferenza al reddito (erogato mediamente in una fascia oscillante tra i 400 e i 500 euro) non può in alcun modo essere data per scontata di fronte a paghe e salari che si attestino su un livello più gratificante. Sì, il reddito di cittadinanza viene preferito al lavoro, ma al lavoro povero, sottopagato e ‘grigio’ (in cui la regolarità formale e contrattuale non rispecchia tuttavia l’effettività del lavoro erogato, a partire dall’incoerenza tra ore di lavoro registrate ed effettuate). Senza contare l’oggettiva e misurabile tortuosità della ricerca del lavoro anche a fronte di elevati o specializzati livelli educativi e di formazione professionale.
Se la soglia di povertà assoluta aumenta, allora, e coinvolge quasi il 10% della popolazione, con lunghe file alle mense di tutta Italia, l’attacco frontale al reddito – difficilmente indirizzabile alla misura per premesse e spirito dell’iniziativa, a differenza dell’impostazione senz’altro correggibile – riflette la mancata solidarietà con le persone e i gruppi sociali di estrazione medio-popolare che si vedono ogni giorno più impoveriti nel potere d’acquisto e sempre più esposti a vulnerabilità e marginalizzazione, soprattutto quando questo attacco proviene, come quasi sempre avviene, da gruppi o persone riconducibili a classi agiate.
Chi vorrebbe eliminare il reddito, in fondo, non apprezza l’idea che le classi sociali storicamente in sofferenza vedano lenite le loro ferite. Un ricco può stare sdraiato sul divano, ma che lo faccia un povero sembra inaccettabile. Perché avere il denaro per mangiare senza esserselo procurato con il sudore della propria fronte? La questione evidentemente si complica se includiamo nell’analisi il tema del lavoro (e l’elaborazione contestatrice del non-lavoro) su cui è fondata la nostra Costituzione e la cui matrice religiosa e culturale è evidente a chiunque. Eppure non si tratta solo di cultura, di religione, di riferimenti simbolici e disposizioni strutturanti l’agire sociale e il pensiero individuale. È in ballo una questione etica, ovviamente, rispondente alla visione di società e di relazioni tra classi sociali che definisce la legittimità stessa delle nostre cosmologie: è giusto che esistano i poveri? È legittimo che alcune persone o alcuni raggruppamenti siano collocati nelle sfere inferiori delle topologie e delle stratificazioni sociali? Va considerato fondato l’assunto secondo cui donne e uomini sono eguali tra loro o una certa dose di diseguaglianza, tanto da non compromettere gravemente l’andamento dell’economia e degli scambi, può essere tollerata? Quale immagine assegniamo alle relazioni sociali? Quella di una piramide informata di gerarchie, di un insieme nel quale a ogni individuo viene assegnato un posto secondo matrici razziali, sessuali, religiose e di lignaggio o quella circolare di una comunità definita da reciprocità e mutuo impegno nella realizzazione del bene comune? Le risposte sono molteplici e, in ogni caso, è l’ideologia a legittimare e giustificare ognuna di queste visioni (mediante narrazioni, mitologie, exempla e quant’altro possa contribuire alla ‘naturalizzazione’ dello stato di cose esistente).
Per il fatto stesso di essere impregnate di una caratterizzazione ideologica che cela la loro origine eminentemente sociale, queste prospettive sulla società raramente appaiono come terreno di mobilitazione di interessi specifici – ovvero di lotta politica. Ma la solidarietà è anzitutto conflitto per l’estensione o la limitazione di privilegi, benefici e dotazioni di capitale. L’assenza di solidarietà è parte di una decodifica delle dinamiche sociali in cui l’elaborazione di tassonomie di estraneità/mostrificazione/alterizzazione/razzializzazione mira a proteggere e preservare uno spazio non condivisibile nel mondo. Che siano migranti in cerca di un porto sicuro o giovani e meno giovani disoccupati a cui riconoscere alcune limitate porzioni di risorse pubbliche, un’economia morale conservatrice non può che trasalire alla trasgressione di confini sociali, geografici, politici, che rimettano in discussione il posto di ognuno nel mondo. La solidarietà è l’impeto teso all’abbattimento di questi confini; è la proiezione di Sé e della propria presenza/esistenza nel mondo oltre un recinto precostituito; è la partecipazione di nuove classi e di nuove categorie alla ricchezza e al benessere; è un innesco di reciprocità e riconoscimento che parla idiomi nuovi e tutti da inventare. Per questo la solidarietà spaventa e per questo la paura è il registro primo dell’assenza di solidarietà. Solidarietà è, insomma, prima di tutto l’abbattimento dello stato di cose esistente.
Ma dietro la mobilitazione politica della solidarietà l’etica non scompare del tutto. Vorrei concedermi la libertà di tornare, in conclusione, alle suggestioni offerte dalle cosmovisioni amerindiane. Non è un caso né un vezzo questo riferimento amazzonico, dato che la riflessione alimentata da queste tematiche e da questi contesti ha ispirato e ispira radicali riscritture della grammatica del rapporto reciproco tra esseri umani, animali, vegetali, all’interno di lotte sociali e politiche che stanno profondamente riformando l’impianto teorico-concettuale dell’ambientalismo e delle battaglie per un altro mondo possibile. Molte ontologie amerindiane offrono la possibilità di creare – sebbene temporaneamente – un medesimo piano di interazione tra persone umane ed entità non umane, caratterizzate da discontinuità fisiche (la diversità dei corpi) e dalla continuità delle interiorità (la soggettività che accomuna predatori e prede). Il fine della metamorfosi grazie alla quale gli uomini (a partire dagli sciamani) assumono forma animale (o vegetale) e viceversa (quando le specie animali visitano gli uomini in sogno) è istituire una comunicazione fondata su un piano di eguaglianza necessario a un’interazione autenticamente aperta all’altro. Seguendo ancora una volta Descola, la metamorfosi è «il punto culminante di una relazione dove ognuno, modificando la posizione di osservazione imposta dalla propria fisicità, si sforza di aderire alla prospettiva attraverso cui pensa che l’altro consideri se stesso» (2021: 161). E cosa rappresenta questo mettersi nei panni dell’Altro – che lo consideriamo una metafora o un dato ontologico – se non quel fenomeno transculturale, elementare e ineliminabile che siamo soliti definire con il termine di solidarietà?
Dialoghi Mediterranei, n.60, marzo 2023
Riferimenti bibliografici
Crocker, J. C. 1977, My Brother the Parrot, in J. D. Sapir e J. C. Crocker (a cura di), The Social Use of Metaphor: Essay on the Anthropology of Rhetoric, Philadelphia, University of Pennsylvania Press: 164-192.
Csordas, T. 2004, Asymptote of the ineffable: Embodiment, alterity and the theory of religion, in “Current Anthropology”, 45(2): 163-176.
Csordas, T. (a cura di) 2009, Transnational Transcendence: Essays on Religion and Globalization, Berkeley, University of California Press.
De Genova, N. 2013, Spectacles of migrant ‘illegality’: The scene of exclusion, the obscene of inclusion, “Ethnic and Racial Studies” 36: 1180–1198.
Descola, P. 2021, Oltre natura e cultura, Milano, Raffaello Cortina Editore [2005].
Durkeim, É. 1893, De la division du travail social, Paris, Félix Alcan, 1893; réimpression Paris, PUF.
Engelke, M. 2018, Pensare come un antropologo. Torino, Einaudi [2017].
Fabietti, U. 2015, Materia sacra. Corpi, oggetti, immagini, feticci nella pratica religiosa, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Gilberti, L. 2018, La criminalizzazione della solidarietà ai migranti in Val Roja: note dal campo, in “Mondi Migranti” 3: 161-181, DOI: 10.3280/MM2017-003008.
Keane, W. 2015, Varieties of ethical stances, in Lambek, M., Das, V., Fassin, D., Keane W. Four Lectures on Ethics. Anthropological Perspectives, Chicago, Hau Books: 127-173.
Keane, W. 2016, Ethical life: Its natural and social histories, Princeton, Princeton University Press.
Lambek, M., Das, V., Fassin, D., Keane W. 2015, Four Lectures on Ethics. Anthropological Perspectives, Chicago, Hau Books.
Laidlaw, J. 2014, The subject of virtue. An Anthropology of ethics and freedom, Cambridge, Cambridge University Press.
Pinelli, B. 2022, Antropologia delle migrazioni. L’età dei rifugiati, Roma, Carocci.
Viveiros De Castro, E. 1996, Os pronomes cosològicos e o perspectivismo amerìndio, in “Mana” 2(2): 115-144 (tr. It. “I pronomi cosmólogici e il prospettivismo ameríndio”, in Consigliere S. (a cura di), Mondi multipli, vol. 2, Kaiak Edizioni, Pompei, 2014.
Viveiros De Castro, E. 2017, Metafisiche cannibali. Elementi di antropologia post-strutturalista, Verona, Ombre Corte [2017].
Viveiros De Castro, E. 2021, L’intempestivo, ancora. Pierre Clastres di fronte allo Stato, Verona, Ombre Corte.
______________________________________________________________
Giovanni Cordova, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia, Antropologia, Religioni (curriculum etno-antropologico) presso l’Università ‘Sapienza’ di Roma. Ha preso parte a progetti di ricerca inerenti al Nord Africa (Tunisia, Libia) e alle migrazioni internazionali. Attualmente è docente a contratto di antropologia culturale presso l’Università Federico II di Napoli e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania, dove conduce uno studio sulla ritualità religiosa delle comunità di origine asiatica residenti in Sicilia.
______________________________________________________________