di Franca Bellucci
Mentre si trasformano, a causa delle nuove tecnologie, i mezzi d’informazione, mi rendo conto che scorro sui fatti accaduti giornalmente in modo anche troppo rapido: a meno che non incontri cronache, situazioni umane o culturali, che mi sollecitano particolari emozioni o memorie: perlopiù con confronti sul presente, talora invece ravvivando ricordi passati. La dimensione del futuro mi sfugge, prospettiva di incognite, che assume aspetto diverso a seconda dell’umore del momento. Ma chiaramente proprio questa “proiezione oltre”, evanescente, mi impegna nella percezione della responsabilità di fatto, delle involontarie omissioni.
In qualche modo più mi esonera il presente, mentre constato quanto mi è possibile incidere, individualmente o in gruppi di fiducia: così, come pure annoto i dati sui grandi spostamenti informali di individui – particolarmente, in Europa, quelli che riguardano il Mediterraneo – le cronache giornalistiche sono già tragedie irreversibili, impegnando alla responsabilità di come incidere sul cambiamento. L’emozione dei ricordi, invece, viene da cronache diverse, culturali, perlopiù mentre scorro gli inserti domenicali, ancora disponendone in carta. Allora si ravvivano percorsi, in qualche modo pagine di storia, in ulteriori paragrafi: prolungamenti ma anche verifiche che arricchiscono l’interpretazione.
Del Leone d’oro alla prossima Biennale deliberato per il regista Armando Punzo (la proclamazione avverrà il 17 giugno 2023) ho appreso dall’inserto domenicale del «Sole 24 ore» il 29 gennaio scorso. La motivazione è l’esperienza venticinquennale della Compagnia della Fortezza, costituita dai carcerati di Volterra. L’interesse suscitato dalla notizia mi si è confermato nella memoria un po’ per gradi: sapevo dell’esperienza, ma visualizzavo anche i luoghi noti, nella mia terra toscana, e in generale ne ripensavo la storia culturale, secondo una rete, di cui volentieri avrei messo a fuoco alcuni nodi. Ho attivato subito il contatto con l’amico Andrea Mancini, intellettuale esperto di teatro – oltre ad avere insegnato “Iconografia del Teatro” all’Università di Siena, è regista e curatore di libri e collane specifici – che, infatti, mi ha presto procurato un pacchetto di testi per approfondire.
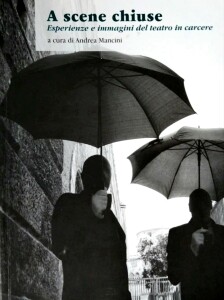 Il contatto più integro con Armando Punzo me l’offre con il libro – raccolta di documenti scenici, foto di eventi e poetiche di autori teatrali, di cui è autore lo stesso Mancini, A scene chiuse. Esperienze e immagini del teatro in carcere, dove un capitolo specifico è dedicato all’incontro (La scena sottratta, ivi: 327-335). L’intervistatore seguirebbe la linea biografica, ma Punzo si svincola presto, per precisare subito il fulcro della sua ricerca: importante «è imparare a minorarsi», dove «minor-azione della realtà» è, nel suo sentire, «universo di riferimento» (ivi: 328). Interpreto che questo pensiero denso impegni lo sguardo – in quanto fruga nella grande massa di vicende, di fatti, liberandosi dal vezzo di escludere gli ultimi – ma che, insieme, indichi un’attenzione a tutti gli umani che, collocatisi in società, creano la convivenza politica.
Il contatto più integro con Armando Punzo me l’offre con il libro – raccolta di documenti scenici, foto di eventi e poetiche di autori teatrali, di cui è autore lo stesso Mancini, A scene chiuse. Esperienze e immagini del teatro in carcere, dove un capitolo specifico è dedicato all’incontro (La scena sottratta, ivi: 327-335). L’intervistatore seguirebbe la linea biografica, ma Punzo si svincola presto, per precisare subito il fulcro della sua ricerca: importante «è imparare a minorarsi», dove «minor-azione della realtà» è, nel suo sentire, «universo di riferimento» (ivi: 328). Interpreto che questo pensiero denso impegni lo sguardo – in quanto fruga nella grande massa di vicende, di fatti, liberandosi dal vezzo di escludere gli ultimi – ma che, insieme, indichi un’attenzione a tutti gli umani che, collocatisi in società, creano la convivenza politica.
Questo piano indispensabile, se ogni essere umano è “animale politico”, Punzo lo affronta nel complesso, non nella posa voluta di chi legittima solo i vertici, così escludendo a priori i più, come non meritevoli d’attenzione: un piano inclusivo lo ritrovo nella parte finale dell’intervista, quando, narrandosi come regista nel tempo in cui ha già la responsabilità della Compagnia della Fortezza, spiega come giunga a intendere il teatro quasi “zona franca”, così da sperimentare il «“desertificarsi”» (ivi: 333): e cita Deleuze. Del resto, in varie esperienze, compreso il passaggio dall’Istituto Orientale di Napoli, in cui aveva avuto contatto con la molteplicità delle tradizioni asiatiche, si era confermata un’intuizione già ravvisata nell’infanzia: che, cioè, l’identità non è funzione del luogo.
Il suo teatro «è stato, e lo è tuttora quel non-luogo fuori del tempo ordinario dove puoi non-essere» (ivi: 329). Poi Punzo rammenta le frequentazioni di gruppi, informali e formali, intorno a Napoli e poi in Europa, fino a quando, giunto a Volterra, si aggregò al Gruppo internazionale L’Avventura, applicandosi a un «lavoro rigoroso sulla percezione che permetteva di scoprire una visione non usuale della realtà» (ivi: 329). A lungo poi la sperimentò con vari teatri cittadini, in particolare quello di S. Arcangelo di Romagna. Più tardi il percorso del regista trovò il carcere, a Volterra, e quella situazione motivante che cercava: «…persone che mi stavano aspettando…C’era tutto il Sud del mondo» (ivi: 332). L’espressione mi colpisce: evidentemente non è geografica, ma impatta una condizione umana. Ma evita di declassare il teatro, come usa, a «esercizio per il recupero e la rieducazione», quasi che il teatro sia pensabile «come una medicheria, un’astanteria … una succursale infermieristica… Il teatro deve avere come orizzonte solo l’indicibile» (ivi: 332). Il regista evita di sovrapporsi ai compiti istituzionali, di rafforzarne il ruolo riabilitativo, quasi carpendo le cartelle dei singoli: «Io non ho cercato di dare loro una possibilità, ho cercato una possibilità per il teatro» (ivi: 334).
I documenti forniti da Andrea Mancini mi permetterebbero di allargare e approfondire ancora il tema della “forma teatro” applicata ai luoghi di contenzione, disponendo di altri materiali. Nello stesso libro citato per l’intervista a Armando Punzo, per esempio, ci sono anche schede su “teatro e carcere” in Europa, censendo in questo ambito sette iniziative, mentre sulle esperienze in Italia l’apposito, ampio capitolo è ricco di interviste e verifiche. Altri percorsi ancora permetterebbero i libri fotografici, sul teatro in carcere. Ma vado in cerca di interventi espressi in parole, tali che attivino il mio pensiero, piuttosto che le emozioni.
In parallelo al libro dove ho letto l’intervista a Punzo c’è, con lo stesso titolo, ma con diverso sottotitolo (A scene chiuse. Approfondimenti), il libro degli atti istituzionali: quello infatti fu il titolo del convegno, tenuto a Firenze il 24 novembre del 2008, sulle attività di teatro in carcere, attualizzando una capacità di raccordo che ha qualificato la Toscana sulla specifica attività. Lo scorro, intercettando ancora parole illuminanti, come le considerazioni sofferte di Michelina Capato Sartore: «Non ho desiderio di illudere me quanto non ne abbia di illudere altri, e allora torno al luogo stretto del teatro, delle prove, della formazione e tutto in quel tempo di lavoro ritrova il suo senso ed è lapidario, e ci può stare» (ivi: 59). Pur ravvisandovi una specifica inquietudine, questo pensiero mi sembra molto consonante con quello di Punzo: come questi, la regista individua la prima risorsa nel teatro, nel suo costituirsi come collettivo. Questo avviene attraverso scelte, consultazioni, repertori, prove d’arte e di fisicità, con cui nel gruppo si stratificano senso e dialogo coinvolgenti. Diventa coralità il fatto che si reinventi un intreccio di sofferenza e sublimazione, un dilemma umano: visibilmente tale, accertato da memorie e modelli.
Riferimento di coralità umana, tema partecipato con totale impegno, dunque, lo stimolo che la tradizione classica ha offerto. Si delineerebbe il desiderio di tornare a letture care: di Omero, lo Scudo di Achille, nel XVIII libro dell’Iliade, con la sintesi di bene e di male che agli uomini tocca. Invece lo scatto della memoria va ad altro.
È che intanto altre cronache si sono sovrapposte a quella del premio a cui Armando Punzo è stato designato. È quotidiana discussione il tema dei migranti alla deriva nel Mediterraneo, ora che il Paese acquisisce nuovo assetto generale, con misure da sperimentare che marchino l’invalicabilità dei confini. Ora, su questo sfondo, a inizio febbraio, si intercetta una situazione di pericolo, prima dell’avvistamento: forse una imbarcazione alla deriva. Infine il 3 febbraio c’è la conferma delle autorità: recuperata imbarcazione e scortata a Lampedusa, una vicenda che ha avuto morti e dispersi. Personalmente, mi accerto su un sito siciliano (https://www.nebrodinews.it/migranti-barcone-con-otto-cadaveri-a-lampedusa-disperso-un-neonato/pubblicato il 03/02/2023). Informa di un neonato disperso in mare, piccolo di quattro mesi, e morta a ruota la madre, ora tra gli otto cadaveri. Il bollettino è succinto, ma trapela una qualche partecipazione da parte del cronista. La nuova fase politica produce già il nuovo stile dei media, molto contenuto.
La concomitanza di attenzione si riverbera anche sulle riflessioni intorno all’attività “teatro in carcere”: piuttosto che ripercorrere le messe in scena di Armando Punzo, desidero piuttosto riordinare le memorie sugli atteggiamenti diffusi che, realizzo, hanno alla fine creato le condizioni anche per quel teatro. Ci fu infatti un periodo in cui il richiamo alla Costituzione divenne quotidianità, innescando azioni nella vita civile, così che la Carta divenne linfa di un percorso collettivo. In breve, la Costituzione diventò anche misura per valutare le condizioni nei luoghi detentivi delle istituzioni: ovvero “non-luoghi”, come obiettivamente risultavano. Situazioni, edifici e conduzioni avevano canoni da primo Novecento: opacità, sopraffazione se non cancellazione dell’individualità.
In Italia, gli «Anni Settanta» furono periodo in cui le forze sociali ebbero grande ruolo, e in cui si diffuse il bisogno di rendere la Costituzione attiva nella vita quotidiana. Gli storici potrebbero inquadrare quegli anni con il metro dei cambiamenti complessivi nel mondo, in ogni ambito, materiale e culturale. Io mi limiterò a ricordare il clima specifico che si diffuse in Italia, di procedere alla ricostruzione sociale in modo partecipe. Questo avvenne, prima sotto il coordinamento dei sindacati, poi seguì un autonomo energico slancio, per un periodo sufficiente a gettare nuove basi. Ritrovo dati sulla centralità che ebbe il sindacato in Italia, con lo sforzo di agire in unità da parte delle tre principali componenti, CGIL, CISL, UIL: l’impulso unitario che ne venne riguardò temi essenziali del vivere moderno.
 Provo a verificare caratteristiche e dati, nello studio di Sergio Bologna, attivista sociologo, edito da Feltrinelli, disponibile in internet: Il lungo autunno. Le lotte operaie degli anni Settanta in Italia. Ritrovo i comparti di vita su cui intervenne il sindacato, i “problemi generali” « – la salute, la casa, i trasporti, l’ambiente –» (ivi: 9). Contesto la completezza del tema: manca il quinto, che fu «la scuola». L’impianto della scuola dialogante con l’intera società fu tema dei sindacati uniti, quinta area di quella stagione di riforme. A me sta a cuore ricordarlo: la scuola è luogo-strumento della comunità, che supera l’a-storico sistema patriarcale, refrattario alla comunità, così da accogliere e formare, nell’aspetto sociale e in quello culturale, la generazione che subentrerà a guidare. Ne cerco comunque tracce in internet: con fatica, come accade, in questo strumento, per ciò che non sollecita l’algoritmo. Ma infine ne trovo tracce, a partire dal sito di una struttura cittadina di Firenze (https://movimentoquartierefirenze.it/images/mostre_associazione/CGIL_scuola.pdf). Sì, la scuola fu il quinto tema della stagione sindacale. C’è una data citata, da ricordare: 17 maggio 1974, proclamato lo sciopero generale per i Decreti Delegati. Non fu poi fatto, perché la trattativa fu conclusa, siglandosi l’accordo il 18 maggio 1974.
Provo a verificare caratteristiche e dati, nello studio di Sergio Bologna, attivista sociologo, edito da Feltrinelli, disponibile in internet: Il lungo autunno. Le lotte operaie degli anni Settanta in Italia. Ritrovo i comparti di vita su cui intervenne il sindacato, i “problemi generali” « – la salute, la casa, i trasporti, l’ambiente –» (ivi: 9). Contesto la completezza del tema: manca il quinto, che fu «la scuola». L’impianto della scuola dialogante con l’intera società fu tema dei sindacati uniti, quinta area di quella stagione di riforme. A me sta a cuore ricordarlo: la scuola è luogo-strumento della comunità, che supera l’a-storico sistema patriarcale, refrattario alla comunità, così da accogliere e formare, nell’aspetto sociale e in quello culturale, la generazione che subentrerà a guidare. Ne cerco comunque tracce in internet: con fatica, come accade, in questo strumento, per ciò che non sollecita l’algoritmo. Ma infine ne trovo tracce, a partire dal sito di una struttura cittadina di Firenze (https://movimentoquartierefirenze.it/images/mostre_associazione/CGIL_scuola.pdf). Sì, la scuola fu il quinto tema della stagione sindacale. C’è una data citata, da ricordare: 17 maggio 1974, proclamato lo sciopero generale per i Decreti Delegati. Non fu poi fatto, perché la trattativa fu conclusa, siglandosi l’accordo il 18 maggio 1974.
 Gli «Anni Settanta», dunque. Talora, per altro, si dice «i “favolosi” Anni Settanta»: ma non furono una festa, né nel mondo né in Italia. Il clima complessivo fu tutt’altro che “favoloso”, con turbolenze a ogni livello, sociali e politiche, che accompagnarono quella stagione. In effetti il gruppo sociale dei giovani prese allora a percepirsi come “generazione”, acquisendo coscienza di autonomia, con una solidarietà interna nuova, d’aria scanzonata, rispetto al sistema della solidarietà per gruppi parentali, fino allora forma caratterizzante della società. Se ne contestavano, fin nel proporsi fisico, quelle che si ritennero le incrostature: in definitiva, il dirigismo. La generazione giovane acquisiva una autonomia sulle scelte di vita, quali le tradizioni non avevano. “Generazione” offrirebbe tuttora piuttosto l’immagine visiva, quella che hanno fissato i Beatles, le minigonne di Twiggy, il ballo angoloso del twist. Ma perderei così gli episodi che si indirizzarono agli istituti e agli stili culturali. Preferisco allora “stagione”: un termine astratto, per il collettivo delle molteplici ricadute culturali, di gruppi, singoli, di laboratori, di archivi, di discussioni e anche di ribellioni in un avvitamento che, oltre che complesso, divenne oscuro: una deriva impugnò perfino le armi. L’esito precipuo di quella stagione fu la riforma culturale che dava centralità al soggetto umano nella autodeterminazione, ma anche ammetteva tutti alla conoscenza, e spingeva ad applicare la scienza a beneficio di tutti, facendone risorsa generale.
Gli «Anni Settanta», dunque. Talora, per altro, si dice «i “favolosi” Anni Settanta»: ma non furono una festa, né nel mondo né in Italia. Il clima complessivo fu tutt’altro che “favoloso”, con turbolenze a ogni livello, sociali e politiche, che accompagnarono quella stagione. In effetti il gruppo sociale dei giovani prese allora a percepirsi come “generazione”, acquisendo coscienza di autonomia, con una solidarietà interna nuova, d’aria scanzonata, rispetto al sistema della solidarietà per gruppi parentali, fino allora forma caratterizzante della società. Se ne contestavano, fin nel proporsi fisico, quelle che si ritennero le incrostature: in definitiva, il dirigismo. La generazione giovane acquisiva una autonomia sulle scelte di vita, quali le tradizioni non avevano. “Generazione” offrirebbe tuttora piuttosto l’immagine visiva, quella che hanno fissato i Beatles, le minigonne di Twiggy, il ballo angoloso del twist. Ma perderei così gli episodi che si indirizzarono agli istituti e agli stili culturali. Preferisco allora “stagione”: un termine astratto, per il collettivo delle molteplici ricadute culturali, di gruppi, singoli, di laboratori, di archivi, di discussioni e anche di ribellioni in un avvitamento che, oltre che complesso, divenne oscuro: una deriva impugnò perfino le armi. L’esito precipuo di quella stagione fu la riforma culturale che dava centralità al soggetto umano nella autodeterminazione, ma anche ammetteva tutti alla conoscenza, e spingeva ad applicare la scienza a beneficio di tutti, facendone risorsa generale.
Che tipo di società accompagnava una visione che ebbe tanta espansione? Una società di “uguali”? L’utopia di entrare in un Eden permanente? Non così giudico. L’ideale si indirizzava all’autonomia per l’individuo di scegliere, di costruire il suo percorso anche sbagliando, contemporaneamente esigendo dalla società di realizzarsi come inclusiva. Ecco perché è stato importante recuperare il modo, l’azione con cui si affrontò finalmente la scuola per tutti. Il cammino doveva essere sgombrato dagli handicap delle discriminazioni. Ci si interessò poi di quanti erano specificamente classificati come tali, con l’apposita prassi introdotta nel 1979: perché anche i portatori di handicap entrassero nella società, uscendo dallo spazio domestico. Ripenso a quella prospettiva, perché tendenzialmente significativa in due direzioni: quella del singolo che costruisce le proprie esperienze tra le opportunità di tutti, in dialogo con la società, poi quella della relazione parentale, che usciva dall’ambito plenipotenziario, proprietario (il «padre padrone») del genitore, per privilegiare quello affettivo.
Di quel movimento il senso generale può dirsi tuttora in vigore, come acquisizione convinta. Tuttavia non è risorsa sufficiente a trarne soluzioni spontanee per i problemi attuali. Oggi, per altro, il contesto viene verificato quotidianamente su scenari ampi: quello europeo, quello della diplomazia internazionale, quello dei movimenti disorganici che, come nella cronaca letta il 3 febbraio, intrecciano istanze nel mondo. Più che una ripresa di quell’entusiasmo costituzionale che si verificò negli “Anni 70”, sarebbe auspicabile, per altro avvalendosi di conoscenze credibili, che la collettività acquisisse sia una impostazione culturale ampia, sia una corretta, pronta relazione con chi deve, e vuole, ambientarsi nel Paese.
La posizione da assumere è forse quella di una società “solidale”? “Solidale” si riferisce comunque ad un fenomeno spontaneo, informale, ma percepibile, di persone adulte che comunicando con aree sociali sprovvedute o reticenti, richiedono loro l’adeguamento. La Costituzione, per altro, cita la “solidarietà”: «doveri inderogabili di solidarietà» dice l’art. 2, indicandone tre aree vitali, l’area politica, quella economica, quella sociale. Dietro c’è la storia lunga dell’idea del “Buon governo” nelle forme dei provvedimenti paternalistici, simili a quelli che erano messi in atto anche prima dell’Unità, nei precedenti Stati. Istituzioni di solidarietà, infatti, sono state attive in vario modo, presenti sia nell’ambito dei culti religiosi, sia intrinseche alla vita pubblica: aggregazioni caratterizzate da una spiccata formalità. Verifico sul Dizionario etimologico (Deli: 1553): “solidale” è un termine formatosi, in età più recente, sul vocabolo, questo sì latino, “solidus”, che, come verifico (Conte, Pianezzola, Ranucci, Dizionario latino: 1430), aveva impiego “fisico”, come “solido, autentico”. Nel derivato più moderno il significato si è poi collocato nell’ambito economico e giuridico del “credito”: “(obbligato) in solido”, di chi dà disponibilità a fronteggiare le insolvenze.
La connotazione così formale non assomiglia all’espansione di interesse umano e civile avvertita intorno agli anni Settanta. Piuttosto che “solidarietà”, si esprimeva “sollecitudine”, inclinazione alla cura. “Sollecitudine” è una parola, transitata dal latino nelle lingue neolatine, forse un po’ desueta, ma appropriata nel significato: «Manifestazione d’impegno o di partecipazione, che si traduce in atteggiamenti di premurosa e pronta diligenza o nell’interessamento costante e affettuoso»: così Giacomo Devoto – Gian Carlo Oli, Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier-Utet 1990: 1821. La “sollecitudine” è attenzione intima, non invasiva: sobria, non cortigiana. Appropriata a valutare, così da favorire ogni miglioramento nell’altro, e da denunciare ogni abuso che contro di lui si profili. Senso simile ha il motto che si diffuse negli Anni 70, certo sentito consonante con lo spirito della Costituzione, quel «I care», cioè “Mi riguarda, m’impegna”, che nella scuola di Barbiana don Lorenzo Milani aveva stampigliato alla parete, ed era riferimento e misura delle azioni specialmente per i ragazzi, ma anche per gli ospiti, nelle loro interlocuzioni.
In definitiva, ritengo, sarebbe auspicabile, per altro non trascurando di avere informazioni credibili in relazione alle varie circostanze che costituiscono nei sopraggiunti le esperienze individuali, trarne energia per avviare esperienze di profondo confronto culturale. Una valida fonte di ispirazione, per questo, è ripensare a chi fa teatro in condizioni di disagio, affidandosi alla costruzione culturale che questa pratica induce – immersione fisica, strumentale, analisi di nodi, compatibilità e insofferenze. Tutto questo, in una disposizione positiva di interessamento: quella che indica la “sollecitudine”.
Quella stagione ebbe risonanza vasta in tutti gli ambiti della società italiana, e, al di là delle formazioni e aggregazioni sociali, attivò forze culturali che vi operavano. Si coagulavano iniziative tese ad estendere i principi della Costituzione nei vari istituti e aggregazioni sociali. Si determinarono sinergie che riesaminavano ogni intervento avendo come metro la vivibilità. In particolare si saldò una vera alleanza tra scienza e realtà socializzata, come nello sviluppo della medicina del lavoro, in cooperazione tra tecnici e operai. Si evidenziarono anche l’insalubrità del costruire, e le azioni intorno di occultamento, le responsabilità, il “progresso” spacciato per tale, invece inaffidabile. Come non ricordare Seveso, 10 luglio 1976: lo cita nel suo sito L’Istituto superiore di sanità (https://www.epicentro.iss.it/focus/seveso/seveso). Ne conseguì una riflessione collettiva, in una dialettica con mondo, individuo e società: nel 1982 l’Unione Europea varò la Normativa Seveso per prevenire gli incidenti industriali.
Vari gli aggiornamenti successivi e le estensioni: tra queste il “Principio di precauzione”, inserito nella “Dichiarazione di Rio” (Rio de Janeiro, 1992), per la salvaguardia dell’ambiente (lo riporto, in italiano, dal sito https://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1992-dichiarazione-rio.pdf): «Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale». Oggi siamo in procinto di riedificazioni radicali negli impianti che hanno fornito comodità. La comunicazione dei governanti è reticente, ma si osserva che, spesso, preparandosi interventi onerosi, si premette il riferimento alla cautela secondo la credibilità razionale. Questo è il segno di come forze potenti possano aggirare i principi, la cautela ambientale, l’impegno all’inclusione.
Alla fine del Novecento accadde che si riattualizzassero gli studi sul Rinascimento: ricordo l’autorevolezza di Eugenio Garin, profondo nella conoscenza filologica dei testi rinascimentali e illuminato studioso del pensiero contemporaneo, aggiornato, interdisciplinare. Tornò l’indagine sull’uomo nella figura e nell’essenza come lo aveva proposto Vitruvio, grande architetto imperiale, il richiamo alla relazione virtuosa secondo le sue «praescriptiones terminatas», ovvero le “precondizioni dettagliate” cui si attenne. Egli propone edifici tali che corrispondano a equilibri ideali, in proporzioni consapevoli del mistero che il cosmo detiene, cui il soggetto uomo partecipa, ma da garante.
Nel periodo cui sto ripensando, guardare ambiente e umanità con sguardo nuovo, con l’intento di rendere la scienza efficace, fu un esercizio che si espanse, con personalità sensibili e persuasive, che seppero attivare le strutture legislative e governative. Questa ondata di civiltà cambiò gli ospedali trasformando quelli che erano enti di assistenza o beneficenza in enti pubblici, e creando nel 1978 il Servizio sanitario nazionale. Finché furono coinvolti, nel moto di civilizzazione a norma di Costituzione, manicomi e, infine, carceri: quasi un’appendice complementare, sul tema dei manicomi, considerando che dal lontano 1886 erano entrati in funzione istituti penali particolari, gli “ospedali psichiatrici giudiziari”, per chi compiva infrazioni in stato di “pazzia”, come sezioni particolari per chi aveva la doppia etichetta, di “malati di mente” e “autori di reati”: ovvero “folli” e “rei”, come troviamo in uno studio del 2014, reperibile online, di Giulia Melani, giurista e sociologa specializzata nel settore criminale (Giulia Melani, 2014: http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/melani/cap1.htm).
Il superamento dei manicomi fu un capitolo di interesse collettivo nella società italiana, cresciuto fino a entrare nei livelli istituzionali: alcuni medici e operatori addetti – scienziati, ma davvero “maestri” – si intestarono una vera battaglia di civiltà. Il nome di Franco Basaglia è la sintesi del cambiamento in questo ambito: si doveva uscire dai manicomi, costruire la soluzione fuori di tali reclusori, mettere in atto il curare in quanto includere, egli sostenne in modo persuasivo. Non fu isolato: non solo per quella convergenza di interessi in ambito scientifico qui ricordata, ma anche perché ebbe sinergia importante in Franca Ongaro, sua moglie.
Porta dunque il nome di Basaglia, la Legge 180/1978 che, imponendo la revisione dei manicomi, promoveva il trattamento sul territorio dei pazienti. La morte lo spense ancora giovane, ma il tratto del cambiamento verificatosi ha mantenuto alcuni capisaldi, in particolare nelle istituzioni, dove la stagione delle riforme è continuata. Quella che verifichiamo rarefatta è l’attenzione collettiva, scambievole, aggiornata alla scienza vigile, attenta alla convivenza. Ma su altri piani, intanto, si verificarono eventi gravi e oscuri: in presenze conflittuali del tessuto sociale nella stessa Italia, e poi in eventi nell’Europa e nel mondo. Tra le riforme più recenti, che tracciano continuità con l’onda delle riforme istituzionali, cito come nel 2014 è stata disciplinata, con le “REMS”, ovvero residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, la conduzione pubblica nei confronti degli autori di reato affetti da disturbi mentali. Lo verifico nella relazione di Franco Corleone, Garante dei detenuti, al convegno 2018 organizzato dalla Regione Toscana, con un gruppo della Fondazione Michelucci, tramite un PDF reperibile (https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/GARANTE-DETENUTITOSCANA). Qui ritrovo la partecipazione di Armando Punzo, con una specifica sezione sulle “prove di teatro” nella REMS di Volterra, con appunti di «un momento molto particolare ed intenso, legato da un filo rosso al lavoro che Punzo svolge da anni con la Compagnia della Fortezza» (ivi: 69).
Ritrovare il nome di Punzo segnala il capolinea dell’excursus e insieme la sua validità, nel collegare alla sensibilità civica degli “Anni Settanta”, per lo specifico della riflessione sulla istituzionalizzazione dei cittadini, il filone “manicomi – manicomi giudiziari – carceri”. Ma la divagazione, mi accorgo, ha anche contagiato, incanalandole insieme, le due cronache segnate all’inizio come separate, quella sull’arte teatrale in carcere, quella dell’approdo ostacolato, di emigranti senza i documenti richiesti: l’accoglienza «a braccia chiuse», opposta a quella “sollecitudine” che favorirebbe la ricostruzione dei progetti, anche gli Italiani l’hanno conosciuta e conoscono, se si constata ampio il fenomeno del rientro dal lavoro all’estero.
Non voglio cedere alla banalizzazione, di assimilare fenomeni, in ragione di un singolo tratto particolare: in questo caso, come facilitare un percorso socievole, di condivisione, per chi emerge dalla conduzione cancellata. Tra tante politiche che cambiano, tra tante carte geografiche che si sono modificate e si modificano, il termine però di “confine” si mantiene come strumento formale rigido, e rigidi i regolamenti cui si associa. Eppure gli accadimenti complessivi hanno cambiato profondamente il Paese, e quel moto civile collettivo, ispirato alla Costituzione cui ho qui volto la mente, ne fu forte motore. Situazione di diversa disposizione, di più ampia cultura e commercio, è l’essere parte dell’Unione europea.
Pure, come in un clima di allarme permanente si dissolse il grande moto civile collettivo, ispirato alla Costituzione, quel clima si è confermato nel tempo. Oggi osservo che a Vinci, paese a me vicino, l’artista Mario Ceroli ha installato un uomo vitruviano che non riesce nell’accordo con il mondo, intitolandolo Squilibrio. E osservo che, con tanti mezzi che consentono oggi di comunicare, i contatti si riducono spesso a quei disegnini detti “emotikon”, così che non diventano sguardi condivisi. Credo non ci siano impostazioni culturali condivise, dopo che, accolto come atteggiamento largo e motivato la variazione continua, lo “storicismo” crociano che caratterizzava la cultura in Italia è divenuto metro non utile per comprendere i fenomeni. La variabilità dei fenomeni sembra dare ragione alla teoria di storici autorevoli, studiosi di aree varie del mondo, come E. J. Hobsbawm o Terence Ranger, che in larga misura le “nazioni” siano enti costruiti: sono documentabili, dicono, interventi che, in controtendenza con le parole-concetto della continuità – tradizione, radici –, hanno imposto alle collettività l’elemento artificioso (“invenzione”), anche con sottofondo di violenza. In questa prospettiva l’industria culturale, scritta o espressa per immagini, che sempre più si identifica con la comunicazione, e sempre più attinge al modello della biografia – narrazione morale, dunque, non di problematica storica – coopera più a suffragare le imposizioni infiltrate che a interromperne l’efficacia con impugnazioni critiche. Tra queste osservazioni, mi è occorso di notare che, tra gli intellettuali italiani che operano traduzioni degli storici citati per gli editori più autorevoli del Paese, c’è il figlio di Franco Basaglia e Franca Ongaro, Enrico Basaglia.
Del resto, non sono azioni coordinate, volute, “inventate”, che cambiano e incidono, anche quelle dei gruppi collettivi che, ho ricordato, promossero le riforme ispirate alla Costituzione, nella cui rievocazione mi sono lasciata immergere? Certo, è una ricostruzione memoriale, la mia, forse sentimentale, che ha ampliato agganci per un inseguimento che ha disegnato una linea. Avrei potuto riguardare quei punti sotto sollecitazioni diverse, e ne avrei tratto recuperi diversi. Uno, avrebbe potuto riguardare l’attrazione che quei disumani manicomi hanno avuto sugli artisti.
Non di rado sono organizzate mostre sull’argomento: nel PDF citato, del convegno 2018 della Regione Toscana si riporta un disegno dell’artista siciliano Bruno Caruso, del 1954. Un diverso, importante capitolo potevo rilevare che fa parte di quello che è stato l’ingresso della Costituzione nella società italiana intorno all’accreditamento della donna – anzi, nella pluralità degli stili e delle scelte, delle donne. È stato, questo, un terreno di percorsi, più che un unico filone, con incroci di recuperi su ogni livello: quello delle subordinazioni di fatto esistenti, tanto privata, quanto pubblica, quanto religiosa, quindi solo in parte avvicinabile al riverbero dei ceti, del costume – si ricordi la ribellione di Franca Viola, il 26 dicembre 1965, al costume del “matrimonio riparatore”, ovvero lo stupro socialmente approvato –fino a giungere al piano dell’inerzia degli addetti agli archivi delle memorie.
Me lo ha ricordato, mentre mi incentravo su Franco Basaglia, il reperimento di scritti e analisi sul manicomio di Gorizia, con scritti, non solo di Franca Ongaro, ma anche di Carla Cerati: scrittrice e fotografa di grande potenza. Ma il rilievo più particolare che desidero segnare, riguarda come fu ampia e convergente la “sollecitudine”, per spingere a rispettare l’espressione negli altri, così da incentivarne, durante e mediante la relazione, la coscienza del proprio esistere, della propria dignità. La voce, l’argomentazione individualmente condotta “dovevano” essere ascoltate. Questo, per altro, portò a rinnovare la prassi della relazione medico-paziente, in generale, ma in particolare nei luoghi di cura in reclusione, cioè i manicomi. La poeta e sociologa fiorentina Alberta Bigagli, di recente scomparsa, mise a punto un metodo efficace per rapportarsi agli ospiti, uomini o donne, reclusi, carceri, manicomi, di Firenze e della provincia, basato su interlocuzione e espressione, che definì “Tu parli, io scrivo”. È questa iniziativa diffusa che ha creato, per le verifiche positive che ha accumulato, l’offerta delle prove espressive di cui oggi usufruiscono i gruppi del “teatro in carcere”.
È di enorme disagio, oggi, tornare negli archivi dei manicomi e trovarvi sterminata documentazione, gli appelli scritti che i reclusi per tutta la vita mandavano ai familiari, senza che fossero recapitati: ammonimento, anche questo, della barbarie legale che può accadere nel mondo. Oggi sono oggetto di studio per gli storici: il deposito accumulatosi nel manicomio di Volterra, per esempio, è stato studiato dalla storica Vinzia Fiorino (Le officine della follia. Il frenocomio di Volterra (1888-1979).
Tra gli “operatori culturali” impegnati a incrementare i mezzi espressivi negli interlocutori, ritengo tuttavia che vada distinta l’area che si propone in uno sfondo nazionale e internazionale: musica, arte, in quanto il superamento di quella barriera che è il silenzio, diventa spinta alla elaborazione filosofica e alla proposizione dell’opera in circuiti ampi, economicamente notevoli. Nell’arte, cito la critica Carla Lonzi, che, acquisita la persuasione di come l’artista dovesse padroneggiare i mezzi espressivi, attuò presso molti artisti il suo progetto di “verbalizzazione della consapevolezza”, se così si può dire, attività tramite la quale forse emersero anche declinazioni di diversità, nel trattare l’arte, tra uomini e donne. Anche la critica Lea Vergine, pur con un progetto diverso, di ricostruire i percorsi e gli archivi delle donne, affermò forza e limite dell’arte, dando valore di linguaggio al corpo e mostrando come l’arte possa valere come una malattia del sé.
Ma, appunto, il linguaggio che consolida il sé, o diventa archivi, pubblicazioni, materiale per la circolazione internazionale, transita, mediante la formula della crescita del livello di qualità, nella pubblicizzazione presso “fondazioni” rilevanti, diventando evento. È in questo sfondo che dobbiamo porre appunto Armando Punzo, l’azione 25ennale della sua Compagnia, i suggerimenti e le considerazioni che possono venirne ai soggetti partecipanti. Si dice che l’arte aiuti a collegare individui e popoli. Certo altra complessità, altro sfondo, e anche permanenza di pregiudizi sono riserbati alla migrazione, aumentata esponenzialmente, e problematica in ogni sezione: trattarla nell’insieme, ai tavoli diplomatici, sarebbe opportuno. Ma è forse questo tabù avversato quello che Punzo chiama “il Sud del mondo”. È il “mondo offeso. Intanto, non si può non seguire con sollecitudine, e con ogni forma di aiuto, per la parte che, seguendo circostanze informali, giunge alle nostre coste.
Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023
Riferimenti bibliografici
A scene chiuse. Approfondimenti. Pubblicazione realizzata all’interno del progetto “Teatro in carcere” promosso e sostenuto dalla Regione Toscana, Corazzano (Pisa), Titivillus, 2011
A scene chiuse. Esperienze e immagini del teatro in carcere, a cura di Andrea Mancini, Corazzano (Pisa), Titivillus, 2008
Conte, Gian Biagio, Emilio Pianezzola, Giuliano Ranucci, Dizionario della Lingua Latina, Firenze, Le Monnier, 2004
Cortelazzo, Manlio, Paolo Zolli, Deli – Dizionario etimologico della Lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 1999
Devoto Giacomo, Gian Carlo Oli, Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier-Utet 1990.
Fiorino Vinzia, Le officine della follia. Il frenocomio di Volterra (1888-1979), Pisa, Edizioni ETS, 2012
Punzo, Armando, La scena sottratta. Conversazione di Andrea Mancini, in A scene chiuse. Esperienze, cit.; 327-335
Sitografia
Bologna, Sergio, Il lungo autunno. Le lotte operaie degli anni Settanta in Italia https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2019/06/Il-_lungo-autunno_Sergio-Bologna.pdf
https://movimentoquartierefirenze.it/images/mostre_associazione/CGIL_scuola.pdf
http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/melani/cap1.htm
https://www.epicentro.iss.it/focus/seveso/seveso
https://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1992-dichiarazione-rio.pdf
https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/GARANTE-DETENUTI-TOSCANA/eventi/Mai%20più%20Manicomi_%20Una%20ricerca%20sulla%20Rems%20di%20Volterra_
%20La%20nuova%20vita%20dell’Ambrogiana%20-%20web(1).pdf
https://www.nebrodinews.it/migranti-barcone-con-otto-cadaveri-a-lampedusa-disperso-un-neonato/pubblicato il 03/02/2023
_____________________________________________________________
Franca Bellucci, laureata in Lettere e in Storia, è dottore di ricerca in Filologia. Fra le pubblicazioni di ambito storico, si segnalano Donne e ceti fra romanticismo toscano e italiano (Pisa, 2008); La Grecia plurale del Risorgimento (1821 – 1915) (Pisa, 2012), nonché i numerosi articoli editi su riviste specializzate. Ha anche pubblicato raccolte di poesia: Bildungsroman. Professione insegnante (2002); Sodalizi. Axion to astikon. Due opere (2007); Libertà conferma estrema (2011).
______________________________________________________________














