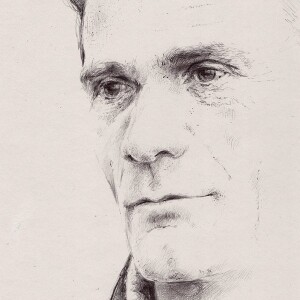di Giuseppe Pera [*]
Fine millennio et “fin d’époque” in Francia
Questo lavoro iniziato a Parigi, dove vivevo all’epoca, fu concluso nel novembre-dicembre 1996 a Lilla, nella cui università ero allora ricercatore – dunque, venticinque anni fa – e fu discusso alla Sorbona nel gennaio successivo. Uno dei quattro membri della giuria esaminatrice non ritenne di dover partecipare al rinfresco che seguì la discussione in un albergo vicino: si trattava, a sette anni dell’abbattimento del muro di Berlino, seguito due anni dopo dalla dissoluzione dell’Urss, di un irriducibile comunista francese più che mai convinto della sua fede, nonostante l’evidenza dei fatti storici, e visibilmente indisposto da ciò che aveva appena letto in questo testo e dovuto giudicare.
Il suo rifiuto di partecipare al rinfresco che segue tradizionalmente la discussione di una tesi di dottorato – con una banalità peraltro comunicatami indirettamente – fu parte integrante del suo giudizio negativo su questo lavoro. Il che non è affatto sorprendente, in effetti, come si dirà di seguito, dato che nel corso della discussione, tanto per dirne una soltanto, egli mi chiese con una serietà cui stentavo a credere, che cosa fosse mai avvenuto di così importante in Urss e in Ungheria nel 1956. Un fatto che io avevo naturalmente ben messo in rilievo, con le sue ripercussioni in Italia, nella mia tesi, la cui nuova storia letteraria dell’Otto-Novecento italiano, che emergeva attraverso la critica e gli scritti politici pasoliniani che l’accompagnavano, era ovviamente una doppia storia politica: quella di Pasolini, innanzitutto – uno degli oggetti precipui della tesi – e, in secondo piano, inevitabilmente, anche la mia: entrambe antistaliniste.
Dato che riparleremo ancora di lui, chiameremo questo tipico docente stalinista parigino di fine Novecento, aspirante se non al segretariato generale del Pcf, diciamo, a quello della Sorbonne Nouvelle (carica simbolica che effettivamente finì per ricoprire, almeno, più modestamente, nel Dipartimento d’italiano, in tutto il suo grottesco anacronismo; quando, cioè, il suo partito prese a registrare risultati simili a quelli dei Pensionati e dei Cacciatori), con lo pseudonimo sicuramente a lui gradito (echeggiando il titolo italiano di un divertente film di Mel Brooks), di Ždanov junior.
In altro campo culturale e, certo, a un ben altro livello, in quegli stessi anni, Il secolo breve di Eric Hobsbawm, pubblicato nel 1994 in Gran Bretagna, tradotto nelle principali lingue mondiali e già diffuso in una trentina di Paesi in quattro continenti – Cina comunista e Taiwan comprese, nonché in Russia e nei Paesi dell’ex blocco sovietico nei quali, in precedenza, nessun libro di Hobsbawm era stato tradotto nell’epoca comunista –, nonostante il successo mondiale dell’opera, non trovava una traduzione francese nemmeno presso l’editore che aveva già pubblicato i tre volumi di Hobsbawm dedicati alla storia del “lungo Ottocento” e di cui questo, dedicato al Novecento, chiudeva la serie.
Nel molto sensibile dibattito internazionale suscitato da questa strana e intrigante anomalia, nel tentativo di spiegarla, qualcuno ricordò che la Francia era stata (e verosimilmente, nonostante tutto, continuava ad esserlo) il Paese «più a lungo e più profondamente stalinizzato» dell’Europa occidentale (e altre e ancora più antiche e profonde ragioni sulla peculiarità storiografica francese ho aggiunto nel capitolo Sulla storia e la religione della mia ricerca successiva a questa su Pasolini intitolata Terzo millennio. Per una riscrittura onesta della storia dei rapporti fra Europa occidentale (Spagna, Francia, Italia) e mondo islamico nel medioevo). Certo, ricordare, per esempio, fra molti altri fatti storici sgradevoli alla coscienza storica del Paese, la battuta di De Gaulle sulla Resistenza francese ai nazisti, come di «un bluff che ebbe successo», nel quadro del mito, precisava Hobsbawm, «che la Francia eterna non aveva mai accettato la sconfitta», quando in verità il governo francese del 1940 non solo firmò la pace, ma collaborò con i tedeschi, non rese agevole la traduzione francese dell’opera, scontentando evidentemente non solo i comunisti, ma anche la componente di destra della cultura francese, nonché il centro; quasi tutti, insomma, ai quali si ricordava inoltre che «Le armate della Francia libera nelle parate vittoriose dopo la liberazione erano molto più ‘bianche’ di quelle che effettivamente avevano vinto le battaglie che recarono tanti onori a De Gaulle e ai suoi seguaci».
Per non parlare poi della denuncia dei crimini francesi durante la colonizzazione e la successiva decolonizzazione, che non a caso fu, quest’ultima, molto più cruenta di quella del Regno Unito o di altri Paesi europei, giungendo, come nel Congo belga, a un vero e proprio genocidio in Algeria che ancora oggi non è stato riconosciuto dalla Francia. Tanto che, nel momento in cui scriviamo, a quasi 60 anni dall’indipendenza algerina nel 1962, conquistata alla fine di quella sanguinosissima guerra durata otto anni, i rapporti fra i due Paesi non sono ancora del tutto normalizzati, nonostante gli sforzi di Macron che sono giunti fino a desecretare in anticipo documenti sulla sale guerre, come fu chiamata, in segno di buona volontà proprio alla fine del suo quinquennato.
Sicché, il fronte del rifiuto alla pubblicazione de Il secolo breve non venne soltanto dalla componente stalinista della cultura francese, ma anche da quella che vi si opponeva, caratterizzata da un astioso antimarxismo che non perdonava a Hobsbawm di essere rimasto un uomo di sinistra, benché antistalinista, che continuava a predicare il marxismo come “un ideale di libertà”: una posizione molto vicina a quella di Pasolini, come si vede, ucciso, all’epoca, vent’anni prima, nel quale però agiva anche una componente cristiana evangelica e una mitologica e altro ancora, estranee a Hobsbawm. Grazie a Le Monde diplomatique, l’opera di Hobsbawm finì comunque per essere tradotta in francese e pubblicata nel 1999 in Belgio, dato che tutti gli editori francesi, ma proprio tutti, rifiutarono di pubblicarla.
 Mi pare significativo aggiungere che nel presentare la traduzione francese di Age of Extremes – the Short Twentieth Century 1914-1991 in una conferenza alla Sorbona, il discorso di Hobsbawm fu disturbato in modo plateale (benché molto brevemente, perché furono subito espulsi dall’aula magna), non da comunisti o fascisti francesi, ma da alcuni membri italiani di Rifondazione comunista. Circolavano inoltre in quell’epoca a Parigi, fra rifugiati di altri gruppi estremisti italiani, membri anche latitanti di Autonomia operaia, il cui leader poté vantare, sempre in quegli stessi anni, un pubblico italo-francese altrettanto numeroso di quello di Hobsbawm, in un’altra presentazione di una traduzione francese di un romanzo politico italiano, allora molto contemporaneo, svoltasi alla Fnac di boulevard Saint Germain, non lontano dalla Sorbona.
Mi pare significativo aggiungere che nel presentare la traduzione francese di Age of Extremes – the Short Twentieth Century 1914-1991 in una conferenza alla Sorbona, il discorso di Hobsbawm fu disturbato in modo plateale (benché molto brevemente, perché furono subito espulsi dall’aula magna), non da comunisti o fascisti francesi, ma da alcuni membri italiani di Rifondazione comunista. Circolavano inoltre in quell’epoca a Parigi, fra rifugiati di altri gruppi estremisti italiani, membri anche latitanti di Autonomia operaia, il cui leader poté vantare, sempre in quegli stessi anni, un pubblico italo-francese altrettanto numeroso di quello di Hobsbawm, in un’altra presentazione di una traduzione francese di un romanzo politico italiano, allora molto contemporaneo, svoltasi alla Fnac di boulevard Saint Germain, non lontano dalla Sorbona.
Questi accenni di cronaca parigina di fin de siècle per dare una rapida idea del clima politico magmatico dell’epoca in Francia, che avrebbe prodotto da lì a pochi anni, nel 2002 precisamente, la grande sorpresa di un ballottaggio presidenziale fra Chirac e Le Pen, ossia, come si leggeva sui muri delle strade adiacenti alla Bastiglia dopo un’enorme manifestazione, «fra un ladro e un fascista»; e, poco più di un decennio dopo, la triplicazione, rispetto alla sua tradizionale consistenza inferiore al 10%, dei risultati elettorali del Front national, che giunse al 24,9% nelle elezioni europee del 2014 e addirittura al 27,73% nelle elezioni regionali del 2015. Un fatto estremamente inquietante, come si vede, che capovolge la situazione politica di una non lontanissima epoca nella quale era il Pcf (con il Pci, i due più importanti partiti comunisti dell’Europa occidentale) ad ottenere risultati così consistenti. Il quale Pcf, com’è noto, nonostante i grandi rivolgimenti storici in corso, per le ragioni staliniane sopra addotte, non ritenne di dover intraprendere in tempo utile una trasformazione del partito in senso democratico (come aveva fatto invece il Pci conservando gran parte del suo elettorato), giungendo così al penoso e anche patetico risultato del 2,49% nelle ultime elezioni europee del 2019.
 Si tratta, come si vede, dell’appendice o, se si vuole, del complemento naturale della nota “profezia” pasoliniana della fine del marxismo con la conseguente affermazione di un nuovo, inedito fascismo “nazisteggiante”, diciamo, ossia razzistico, oltre che tecnocratico, che Pasolini denunciò circa quarant’anni prima anche in Italia (cfr. La prima, vera rivoluzione di destra, “Tempo illustrato”, 15/7/1973, poi confluito in Scritti corsari). Un fenomeno cui io ho assistito in Francia, un Paese, con ogni evidenza, molto simile e vicino al nostro, tanto che da ambo le parti ci si considera generalmente come dei “cugini” (anche molto prima della celebre battuta di Cocteau: «un francese è un italiano di cattivo umore» e viceversa). Il che spiega, fra le altre cose, l’interesse particolare della cultura francese per Pasolini ricambiata, in qualche modo, da parte sua, con Alla Francia (in La religione del mio tempo), nonché con la sua disponibilità a rivelarsi maggiormente, nelle numerose interviste rilasciate nei suoi ultimi anni, a interlocutori francesi, tanto che Jean Duflot raccolse addirittura in un volume dal titolo Les dernières paroles d’un impie, fondamentale per la comprensione di Pasolini, quelle a lui rilasciate nel 1969 e nel 1975 («un’intervista ampia, come mai Pasolini ne aveva concesse», si legge nell’incipit della prefazione dell’edizione italiana), con l’ulteriore dono del molto notevole poemetto Coccodrillo allora inedito (volume tradotto in italiano nel 1983 con il titolo di Il sogno del centauro). Ritorneremo più avanti sulle “profezie” pasoliniane.
Si tratta, come si vede, dell’appendice o, se si vuole, del complemento naturale della nota “profezia” pasoliniana della fine del marxismo con la conseguente affermazione di un nuovo, inedito fascismo “nazisteggiante”, diciamo, ossia razzistico, oltre che tecnocratico, che Pasolini denunciò circa quarant’anni prima anche in Italia (cfr. La prima, vera rivoluzione di destra, “Tempo illustrato”, 15/7/1973, poi confluito in Scritti corsari). Un fenomeno cui io ho assistito in Francia, un Paese, con ogni evidenza, molto simile e vicino al nostro, tanto che da ambo le parti ci si considera generalmente come dei “cugini” (anche molto prima della celebre battuta di Cocteau: «un francese è un italiano di cattivo umore» e viceversa). Il che spiega, fra le altre cose, l’interesse particolare della cultura francese per Pasolini ricambiata, in qualche modo, da parte sua, con Alla Francia (in La religione del mio tempo), nonché con la sua disponibilità a rivelarsi maggiormente, nelle numerose interviste rilasciate nei suoi ultimi anni, a interlocutori francesi, tanto che Jean Duflot raccolse addirittura in un volume dal titolo Les dernières paroles d’un impie, fondamentale per la comprensione di Pasolini, quelle a lui rilasciate nel 1969 e nel 1975 («un’intervista ampia, come mai Pasolini ne aveva concesse», si legge nell’incipit della prefazione dell’edizione italiana), con l’ulteriore dono del molto notevole poemetto Coccodrillo allora inedito (volume tradotto in italiano nel 1983 con il titolo di Il sogno del centauro). Ritorneremo più avanti sulle “profezie” pasoliniane.
Anche Pasolini, l’intellettuale, come Il secolo breve di Hobsbawm, apparve in traduzione francese nel 1999 con il titolo di Pier Paolo Pasolini, l’intellectuel: critique littéraire et écrits politiques (1940-1960), pubblicato da Presses Universitaires du Septentrion, una casa editrice collegata, insieme alle altre università della regione, all’Université de Lille 3, nella quale, come già detto, insegnavo, e che se non mi oppose un rifiuto alla pubblicazione per ovvie ragioni deontologiche (ero pur sempre un ricercatore in quell’università), non ritenne però opportuno, tre anni più tardi, in occasione del 22° Salon du Livre di Parigi, del 2002, appunto, anno in cui l’Italia pur figurava come ospite d’onore, di portare nel suo stand nemmeno una sola copia del mio libro, peraltro, l’unico testo di italianistica, all’epoca, del suo catalogo.
 La città e la regione di Lilla, regione mineraria, già dai tempi di Zola era sempre stata un grande feudo della sinistra (socialista e comunista), finché i suoi elettori non decisero di votare in massa per il Front national, fra la fine del secondo millennio e l’inizio del terzo, come si è accennato sopra; un altro fatto, ripetiamo – la fascistizzazione del proletariato divenuto o desideroso di divenire piccolo-borghese –, che Pasolini aveva ugualmente “profetizzato”. Il clima dell’Université de Lille 3 non era diverso da quello della città e della regione, e nel dipartimento stesso in cui lavoravo avevo fra i miei colleghi, oltre a comunisti francesi in fin di carriera (numerosissimi nell’insegnamento di base, nel secondario e nelle università), più giovani simpatizzanti italiani di Rifondazione comunista (residenti nella notoriamente ultra proletaria Versailles, mutatis mutandis, versagliesi che oltre un secolo dopo i celebri fatti, tifavano per la Commune de Paris, solo a parole, ovviamente), nonché un membro di Autonomia operaia (il quale, tipicamente, ossia en cachette, cercò invano di invitare il suo leader latitante all’università per una conferenza su Leopardi, come se fosse stato soltanto un critico letterario o un filosofo), sposo, a sua volta, di una nobil donna della più alta aristocrazia italica, cosa che non gli impediva di credere di essere un vero proletario rivoluzionario.
La città e la regione di Lilla, regione mineraria, già dai tempi di Zola era sempre stata un grande feudo della sinistra (socialista e comunista), finché i suoi elettori non decisero di votare in massa per il Front national, fra la fine del secondo millennio e l’inizio del terzo, come si è accennato sopra; un altro fatto, ripetiamo – la fascistizzazione del proletariato divenuto o desideroso di divenire piccolo-borghese –, che Pasolini aveva ugualmente “profetizzato”. Il clima dell’Université de Lille 3 non era diverso da quello della città e della regione, e nel dipartimento stesso in cui lavoravo avevo fra i miei colleghi, oltre a comunisti francesi in fin di carriera (numerosissimi nell’insegnamento di base, nel secondario e nelle università), più giovani simpatizzanti italiani di Rifondazione comunista (residenti nella notoriamente ultra proletaria Versailles, mutatis mutandis, versagliesi che oltre un secolo dopo i celebri fatti, tifavano per la Commune de Paris, solo a parole, ovviamente), nonché un membro di Autonomia operaia (il quale, tipicamente, ossia en cachette, cercò invano di invitare il suo leader latitante all’università per una conferenza su Leopardi, come se fosse stato soltanto un critico letterario o un filosofo), sposo, a sua volta, di una nobil donna della più alta aristocrazia italica, cosa che non gli impediva di credere di essere un vero proletario rivoluzionario.
Come si vede, casi evidenti di schizofrenia che ancora una volta non avrebbero stupito affatto Pasolini, anzi, su questa schizofrenia egli aveva a lungo insistito, suscitando l’odio anche del suddetto leader di Autonomia operaia, che egli manifestò ancora, visceralmente, nella suddetta esibizione alla Fnac, accanendosi contro il Pasolini delle “lucciole” in particolare, con l’ottuso intento di dileggiarlo, quando qualche anno più tardi si sarebbe convertito anche lui all’anti-globalizzazione con l’annessa emergenza ecologica, di cui Pasolini, con il celebre articolo sulla scomparsa delle lucciole, appunto, si era occupato una trentina di anni prima. Leader autonomo operaio e latitante che ovviamente rientrava anche lui nel grottesco quadro del borghese-rivoluzionario-comunista denunciato da Pasolini già negli anni Cinquanta, riferendosi allora ai dirigenti del Pci e ai suoi intellettuali all’indomani della grande emorragia di iscritti seguita al rapporto di Krusciov sui crimini di Stalin e alla crisi ungherese del 1956: l’inizio di quella destalinizzazione, ignorata dal nostro Ždanov junior (anche lui, evidentemente, nello stesso schizofrenico caso dei suddetti), che 35 anni più tardi avrebbe tuttavia determinato la fine del comunismo sovietico e, come si è detto, l’estinzione quasi, un po’ più tardi, del suo proprio stalinista-ad-oltranza partito stesso, plus royaliste que le roi.
Insomma, per farla breve, la cultura francese, dalla scomparsa di Michel Foucault, mi appariva allora, da osservatore residente straniero in Francia qual ero da più di quindici anni, suddivisa in un ostinato, ottusissimo, tardo ždanovismo, un vuoto neo onanismo sedicente laico (la cosiddetta gauche caviar) e una neo scolastica cattoli-cocorico-giudaica, per non parlare dei neo fascisti propriamente detti in violenta crescita a partire da quegli anni. Tutto ciò era ben rappresentato fra l’altro, quasi millimetricamente, nelle varie commissions des spécialistes che decidevano sull’attribuzione o no dei gradi universitari di professore associato e ordinario. E quando, subentrando a un’anziana, neo onanista esponente della gauche caviar, divenne presidente della commission d’italiano e di altre lingue romanze il nostro Ždanov junior, non avendo amici ne Le Monde diplomatique, capii che o avrei dovuto cambiare mestiere o cambiare Paese, dato il suddetto clima politico-culturale in cui mi trovavo. E dal momento che amavo il mio mestiere decisi di cambiare Paese.
 “Pasolini: pour une anthropologie poétique” (Colloque international 7-8-9 mars 2002)
“Pasolini: pour une anthropologie poétique” (Colloque international 7-8-9 mars 2002)
Sicché il mio ultimo impegno pasoliniano in Francia fu la partecipazione al suddetto colloquio organizzato dal dipartimento d’italiano dell’Université de Montpellier 3, in cui ebbi modo di conoscere Nico Naldini e Giuseppe Zigaina, dopo che a Lilla ebbi la fortuna di imbattermi casualmente in Ninetto Davoli e sua moglie in tournée per la rappresentazione di Histoire du soldat, un’opera teatrale allora inedita di Pasolini. Quest’ultimo, e molto gentilmente, mi fu assai utile nel darmi quelle informazioni sulle abitudini e la vita personale di Pasolini che non potevano trovarsi nei libri, e che mi servirono a precisare meglio l’idea che mi ero fatto di lui. Naturalmente, a Roma, avevo già da tempo conosciuto anche Laura Betti presso la sede del “Fondo Pasolini” in piazza Cavour, dove mi ero recato più volte per raccogliere materiale per la mia ricerca, e fu lei stessa a telefonarmi per annunciarmi che al mio lavoro era stato attribuito dalla folta giuria presieduta da Tullio De Mauro la menzione onorevole nella XV edizione del “Premio Pier Paolo Pasolini 1996-1998”, un fatto che significativamente non ebbe alcuna incidenza per le varie commissions des spécialistes presiedute sia dall’anziana neo onanista e gauchiste caviar che dal nostro Ždanov junior nel loro esame della mia idoneità all’insegnamento come associato, cosa che mi fu ripetutamente rifiutata finché smisi di chiederla [1].
A Montpellier, dunque, nel mio intervento, presentai d’emblée Pasolini come un autore eccezionale, associandomi così pienamente alle affermazioni addolorate di Moravia il quale, al funerale dell’amico, in piazza Campo de’ Fiori, lo aveva definito come uno dei due o tre poeti che nascono nel Paese in un secolo [2]. E aggiungevo che egli ha rappresentato inoltre la coscienza della nazione come nel passato più vicino lo avevano fatto D’Annunzio e Foscolo e, in quello più lontano, Dante, l’iniziatore moderno del genere poeta-vate in Italia, come si dirà più oltre, e per quanto ciò possa apparire spropositato a qualcuno. Coscienza della nazione e vocazione profetica, aggiungiamo. Non ha forse “profetizzato” infatti la fine del comunismo, e il processo alla classe politica che ha governato l’Italia per mezzo secolo, e l’avvento di “uomini nuovi” come Berlusconi insieme a una nuova forma di fascismo? E altro ancora, e non solo per l’Italia, ma per il mondo occidentale intero, giunto, secondo lui, al termine della sua civiltà, una fine che sarebbe stata seguita dall’avvento di una “nuova preistoria”? Ritorneremo più avanti anche su quest’ultimo punto e sintetizzo di seguito il mio intervento a Montpellier, aggiungendovi qualche commento.
 Pasolini fu soprattutto un grande poeta, abbiamo appena detto, e anche un autore eminentemente politico: in modo diretto, attraverso i suoi scritti politici, e indirettamente attraverso la sua critica letteraria, dalla quale affiora la storia politica dell’Italia degli ultimi due secoli (oltre che, parallelamente, con altro approccio, essa ci appare con una frequenza significativa anche nella sua poesia, nel suo cinema e nel suo teatro): precisamente ciò che si è voluto mettere in rilievo in questo lavoro: la grande dimensione politica della sua opera nel suo complesso. I punti fondamentali del quale lavoro mi appaiono in primo luogo l’aver mostrato il grande impulso che Pasolini ha dato, motu proprio, per le ragioni illustrate, alla dimensione letteraria dialettale, allo scopo d’introdurre nella sua nuova storia letteraria, secondo la lezione di Gramsci, «l’esistenza di milioni di esseri anonimi» (Contini) che parlavano questi dialetti ma non l’italiano, e che erano generalmente esclusi dalla storia della letteratura, così come dalla Storia stessa del Paese. Sempre Contini aveva messo in evidenza, inoltre, il fatto specifico che l’Italia era il solo grande Paese europeo nel quale la letteratura dialettale facesse parte integrante della storia letteraria della nazione; certo, a voler dare ad essa l’attenzione che merita, il che, come si diceva sopra, dipende da una precisa scelta politica. Si tratta quindi d’aver mostrato, spero, in questa ricerca, la possibilità di una nuova storia della letteratura italiana, come quella delineata da Pasolini, ben diversa da quelle che si scrivevano prima (e anche dopo) di lui, con l’eccezione, naturalmente, di quella di Francesco De Sanctis, che fu un modello per la storiografia letteraria marxista, la quale, però, ignorò anch’essa la letteratura dialettale, come aveva fatto il fascismo e per le stesse ragioni centralizzatrici, in sostanza.
Pasolini fu soprattutto un grande poeta, abbiamo appena detto, e anche un autore eminentemente politico: in modo diretto, attraverso i suoi scritti politici, e indirettamente attraverso la sua critica letteraria, dalla quale affiora la storia politica dell’Italia degli ultimi due secoli (oltre che, parallelamente, con altro approccio, essa ci appare con una frequenza significativa anche nella sua poesia, nel suo cinema e nel suo teatro): precisamente ciò che si è voluto mettere in rilievo in questo lavoro: la grande dimensione politica della sua opera nel suo complesso. I punti fondamentali del quale lavoro mi appaiono in primo luogo l’aver mostrato il grande impulso che Pasolini ha dato, motu proprio, per le ragioni illustrate, alla dimensione letteraria dialettale, allo scopo d’introdurre nella sua nuova storia letteraria, secondo la lezione di Gramsci, «l’esistenza di milioni di esseri anonimi» (Contini) che parlavano questi dialetti ma non l’italiano, e che erano generalmente esclusi dalla storia della letteratura, così come dalla Storia stessa del Paese. Sempre Contini aveva messo in evidenza, inoltre, il fatto specifico che l’Italia era il solo grande Paese europeo nel quale la letteratura dialettale facesse parte integrante della storia letteraria della nazione; certo, a voler dare ad essa l’attenzione che merita, il che, come si diceva sopra, dipende da una precisa scelta politica. Si tratta quindi d’aver mostrato, spero, in questa ricerca, la possibilità di una nuova storia della letteratura italiana, come quella delineata da Pasolini, ben diversa da quelle che si scrivevano prima (e anche dopo) di lui, con l’eccezione, naturalmente, di quella di Francesco De Sanctis, che fu un modello per la storiografia letteraria marxista, la quale, però, ignorò anch’essa la letteratura dialettale, come aveva fatto il fascismo e per le stesse ragioni centralizzatrici, in sostanza.
E con le eccezioni, è ovvio, anche delle storie letterarie di Gramsci e di Contini. A suggellare quanto appena detto sopra, valga un appunto del 1974, un “excerptum” da una nota molto significativa a Letteratura italiana. Otto-Novecento di Contini, che troviamo proprio nelle due ultime pagine di La divina mimesis, una delle ultime opere pubblicate in vita da Pasolini, nel 1975, se non forse proprio l’ultima, nella quale reinterpretava in prosa i primi sette canti dell’Inferno di Dante.
«Tuttavia risulta chiaro ciò che è stupefacentemente vero, cioè che il solo critico italiano i cui problemi siano stati i problemi letterari di Gramsci è Contini! “Scandalo per i Giudei, stoltezza per i Gentili”, dunque».
 Dopo aver ricostruito la nuova storia letteraria dell’Otto-Novecento tracciata implicitamente da Pasolini nei suoi numerosi scritti letterari e politici, in modo non proprio sistematico, dunque, ma frammentario (perciò, una ricostruzione, ma anche una lettura, che è risultata “un po’ difficile”, come si espresse Fortini, a proposito della sola Introduzione a Poesia dialettale del Novecento, «perché le più importanti affermazioni», scriveva, si sono rivelate essere «tutte incidentali»); un secondo punto fondamentale della ricerca è l’aver mostrato la nuova metodologia critica pasoliniana che si è chiamata appunto “gramsci-continismo”, e che si opponeva sia alla critica ermetica bellettristica in auge ai suoi tempi, sia alla successiva critica marxista, entrambe, da lui demistificate mostrandone i rispettivi limiti. Un “gramsci-continismo” arricchito infine dall’apporto della psicanalisi, strumento che egli fu tra i primi (e i pochi) ad adottare e applicare in Italia (ancora oggi), producendo così una critica letteraria inedita nel nostro Paese che ha già negli anni considerati (seconda metà degli anni ’40 e anni ’50) le caratteristiche di quelle originali forme di intervento culturale e politico pasoliniane degli anni ’60 e ’70 e che ne costituiscono i prodromi evidenti.
Dopo aver ricostruito la nuova storia letteraria dell’Otto-Novecento tracciata implicitamente da Pasolini nei suoi numerosi scritti letterari e politici, in modo non proprio sistematico, dunque, ma frammentario (perciò, una ricostruzione, ma anche una lettura, che è risultata “un po’ difficile”, come si espresse Fortini, a proposito della sola Introduzione a Poesia dialettale del Novecento, «perché le più importanti affermazioni», scriveva, si sono rivelate essere «tutte incidentali»); un secondo punto fondamentale della ricerca è l’aver mostrato la nuova metodologia critica pasoliniana che si è chiamata appunto “gramsci-continismo”, e che si opponeva sia alla critica ermetica bellettristica in auge ai suoi tempi, sia alla successiva critica marxista, entrambe, da lui demistificate mostrandone i rispettivi limiti. Un “gramsci-continismo” arricchito infine dall’apporto della psicanalisi, strumento che egli fu tra i primi (e i pochi) ad adottare e applicare in Italia (ancora oggi), producendo così una critica letteraria inedita nel nostro Paese che ha già negli anni considerati (seconda metà degli anni ’40 e anni ’50) le caratteristiche di quelle originali forme di intervento culturale e politico pasoliniane degli anni ’60 e ’70 e che ne costituiscono i prodromi evidenti.
Lo scopo che ritengo di aver raggiunto e che mi pare essere ancora validamente sostenibile a venticinque anni di distanza, è quello di aver contribuito a dare non solo rilievo, ma anche autonomia e specificità al Pasolini critico letterario (un aspetto generalmente trascurato e forse anche sottovalutato degli studi pasoliniani), rendendogli, così mi pare, la giustizia che meritava. In questo non sono stato ovviamente né il solo né il primo a pensarlo: Italo Calvino, giusto per fare un solo nome, lo aveva già riconosciuto in tutta la sua importanza; ciò nonostante, questa parte dell’opera pasoliniana è continuata a rimanere da allora alquanto misconosciuta. Come Calvino, considero dunque Pasolini, per le suddette sue specificità, fra i più importanti critici letterari italiani del dopoguerra, e ritengo che lo sia ancora oggi, nel 2021, così come uno dei più profondi intellettuali italiani del suo secolo.
Quanto alla contraddizione con la quale lo si è etichettato in un senso esclusivamente negativo, come si ricordava già nell’Introduzione citando Cesare De Michelis, il quale, nello spiegare lo straordinario interesse che Pasolini suscitava in Francia, lo attribuiva al fatto che, a suo avviso, Pasolini, più di ogni altro autore italiano contemporaneo, rappresentava «la complessità, le contraddizioni e la vitalità della società italiana», ebbene, rivediamo di nuovo, brevemente, questa sorta di mise en abyme da lui incarnata nella sua persona stessa e che, a partire da un certo punto della sua vita, ha sicuramente interpretato in modo cosciente e provocatorio.
Egli rifletteva innanzitutto, lo si è già detto, la frattura del Paese fra cattolici e comunisti, e della parte comunista rifletteva poi l’ulteriore frattura fra le due anime del partito, a sua volta riflesso della frattura del marxismo stesso, a livello storico ed internazionale, fra gradualisti e massimalisti, e fra comunismo russo e cinese, insistendo forse più di qualunque altro intellettuale italiano (in virtù dei suoi trascorsi con il partito-padre, che l’aveva prima espulso e poi reintegrato), sull’evidentissima contraddizione fra l’essere marxisti e borghesi in Paesi borghesi come l’Italia e la Francia, i cui partiti comunisti, ricordiamolo ancora, sono stati i più consistenti dell’Occidente, rappresentando nei loro risultati massimi storici circa un terzo dell’elettorato.
Dall’altra parte, così come non fu un marxista ortodosso fu ancor meno un cattolico ortodosso, oltre a dichiararsi esplicitamente come non credente con intervistatori stranieri come Oswald Stack e Jean Duflot (in particolare affermando di non credere affatto nella divinità di Cristo), o dichiarandosi, testualmente, “ateo” tout court. Ed è significativo, mi pare, che questa stessa critica che egli muove, pur riflettendola, al Pci, sulla sua intrinseca contraddizione, avrebbe potuto muoverla con altrettanta e anche maggiore plausibilità (diciamolo en passant), contro le istituzioni del cristianesimo e per le stesse ragioni: lo scarto (se non vogliamo dire il “tradimento”) fra il testo “sacro” di partenza e la realtà effettiva e la prassi delle istituzioni cristiane che affermano di fondarsi su di esso, e della chiesa cattolica in primis (cfr. il poemetto A un Papa, in La religione del mio tempo), i cui membri, nella stragrande maggioranza, altrettanto visibile (a tutti coloro che vogliono vederla, ovviamente) quanto le contraddizioni del comunista-borghese, non sono affatto evangelici, né, ancora oggi, “francescani” nel vero senso storico e religioso del termine. Si tratta, come si vede chiaramente, di un’altra forma di schizofrenia, recitata anch’essa, dopo tutto, anche da Pasolini, quando poteva far credere al grosso pubblico, per esempio, di essere un cattolico con il suo Vangelo secondo Matteo o, nella corrispondenza privata, con i poeti cattolici come Betocchi.
Non criticò il cattolicesimo reale, a-evangelico così a fondo quanto criticò il comunismo-borghese, a quanto mi risulta, forse, soltanto perché era già stato condannato dai tribunali italiani per vilipendio alla religione di Stato per il suo film La ricotta, del 1962, e dunque, per questo, seriamente intimidito, perché minacciato nella sua libertà fisica stessa, nonché penalizzato, come effettivamente lo fu, nei suoi progetti artistici ulteriori a causa della condanna subita da parte dell’ordine costituito [3]. Senza contare gli altri processi già subiti da Pasolini e quelli che avrebbe subito ancora, tanto che dopo la sua morte si raccoglierà in un volume tutta la cronaca giudiziaria che lo riguardò e che giustificò nel titolo stesso del libro il termine di “persecuzione” [4]. Insomma, se il Pci aveva perdonato Pasolini e, bene o male, lo tollerava come fiancheggiatore, la Chiesa cattolica, molto più reazionaria e minacciosa attraverso l’apparato repressivo dello Stato italiano clerico-fascista di quei tempi, no. Questo, penso, possa spiegare perché a quest’ultima non toccò una critica pasoliniana altrettanto consistente quanto quella che egli mosse al Pci, pur trattandosi, in effetti, di denunciare lo stesso fenomeno, la schizofrenia del borghese-comunista, altrettanto diffusa nelle istituzioni e fra la grande maggioranza dei membri della Chiesa cattolica: la schizofrenia del cristiano a-evangelico, a cominciare da Pio XII, il dedicatario del già citato poemetto A un Papa.
Vero è, comunque, e mi pare piuttosto evidente, che globalmente sarebbe stato molto più opportuno attribuirgli una provocatoria “strategia della disorganicità”, come fece, a mia conoscenza, il solo Gianni Scalia fra i suoi critici maggiori del tempo, piuttosto che accusarlo di “inconsistenza ideologica”, come si è fatto a lungo, in modo – questo sì – inconsistente, anche dopo la sua morte. La qual cosa è come se, nell’altro versante, quello propriamente religioso, lo si fosse accusato di non essere stato un credente nella fede cristiana: non lo era, difatti, come dimostrò di non aver fede nell’ortodossia marxista, fino a giungere alle posizioni reazionarie che manifestò alla fine della sua vita, checché abbia poi scritto all’inizio dell’intervento che avrebbe dovuto pronunciare due giorni dopo la sua morte al congresso del Partito radicale. Ritorneremo su questo punto. Né credeva alle varianti marxiste più o meno rivoluzionarie: l’Africa che egli affermava di desiderare nel Frammento alla morte (in La religione del mio tempo), infatti, non era quella di Lumumba, scriveva (ossia, per essere ancora più espliciti, di Che Guevara, il quale aveva combattuto anche in Africa), ma era l’Africa di Rimbaud, ossia quella del “disimpegno decadentistico”, come lo si sarebbe potuto definire con la terminologia marxista di quei tempi.
Questo, in rapida sintesi, l’essenziale del mio ultimo intervento su Pasolini a Montpellier, circa vent’anni fa, tratto interamente dalla presente ricerca, le cui acquisizioni, lo ripeto, mi paiono restare complessivamente valide ancora oggi pur con un significativo mutamento del mio giudizio sulle varie dimensioni interpretative pasoliniane, di cui si dirà di seguito. A questa sintesi vorrei ora aggiungere un’avvertenza cui seguiranno almeno un paio di constatazioni rese oggi possibili dal quasi mezzo secolo (46 anni precisamente) trascorso dalla morte di Pasolini.
 Fra oggettività e (inconsapevole?) soggettività.
Fra oggettività e (inconsapevole?) soggettività.
Come non si può prescindere dalla dimensione politica nella vita e nell’opera di Pasolini – lo si è già detto e ripetuto –, così nemmeno dalla dimensione psicanalitica, nella quale può confluire – io credo, ora (ed è questo il mio mutamento di giudizio cui accennavo poco sopra) –, ciò che nella ricerca avevo definito come una terza dimensione interpretativa di carattere mistico-religioso-profetica, poiché ritengo, dopo un approfondimento della questione svolto nelle mie successive ricerche, che il fenomeno religioso in generale rientri nella sfera psicologica, come si dirà più oltre.
Egli conosceva profondamente la psicanalisi – anche questo lo si è detto più volte – che non ha semplicemente letto, ma studiato e adottato quale strumento di analisi alla stessa stregua del marxismo, definendola anzi come «l’atto fondamentale della mia cultura e della mia vita». Sono questi i suoi due strumenti fondamentali della sua analisi letteraria, sociale e politica, dunque, benché il secondo strumento non sia stato – e ancora non lo è – sufficientemente riconosciuto e valutato adeguatamente dagli interpreti italiani in generale, a mio avviso, perché la psicanalisi non è penetrata nella cultura italiana altrettanto profondamente come negli Stati Uniti e in Francia (e questo potrebbe spiegare perché Pasolini si aprisse molto più di quanto facesse in Italia con intervistatori francesi, avvezzi alla psicanalisi, come Jean Duflot). Non solo, egli ci parla di sé nelle sue opere e ad alcuni suoi corrispondenti delle sue lettere, anche in espliciti termini psicanalitici, se non proprio rigorosamente clinici, psichiatrici, e mi pare che sulla traccia della sua incessante autoanalisi e delle sue confessioni – molto, e a volte, estremamente personali –, anche con vari intervistatori come Dacia Maraini, Ferdinando Camon, Oswald Stack e il già ricordato Duflot, soprattutto, si sia ulteriormente approfondita e consolidata in questa ricerca la conoscenza della sua personalità molto complessa, trovando riscontri piuttosto convincenti, puntuali e, direi, probanti – così mi è parso e mi pare tuttora –, nella sua opera altrettanto complessa.
 Mi riferisco in particolare alla rappresentazione di se stesso data in Petrolio, opera postuma, che conferma – mi pare sempre, a distanza di venticinque anni – e quasi aritmeticamente, direi, l’analisi psicanalitica della sua personalità definibile fra i casi clinici classici freudiani dell’“uomo dei topi” e del “presidente Schreber”. Tanto che ritengo essere questo un terzo punto fondamentale, una nuova acquisizione emersa da questa ricerca dopo, ripetiamolo, quella sulla sua nuova storia letteraria nazionale otto-novecentesca inclusiva della dimensione dialettale, e il risalto dato al suo ibrido, efficacissimo strumento di lavoro, che dalla critica e la storiografia letteraria passerà poi all’analisi sociale e politica contemporanee. Si tratta, in fondo, di una variante italiana a forte connotazione gramsciana del freudo-marxismo iniziato da Wilhelm Reich negli anni ’30 e praticato più tardi, fra altri membri della scuola di Francoforte, anche da Theodor Adorno e Herbert Marcuse, i più conosciuti, per intenderci meglio e cominciare ad allargare un po’ più gli orizzonti, senza la parènesi socio-politica rivoluzionaria molto accentuata di quest’ultimo, però (molto dubbia, a mio avviso, con i suoi strascichi hegeliani, oltretutto, quanto erano molto dubbie tutte le altre proposte “rivoluzionarie” di quei tempi, che Pasolini osserva attentamente e poi denuncia nelle loro contraddizioni e inconsistenze sulla base di un’analisi, giustamente, esistenziale-psicanalitica e, se non più gramsciana, a quell’epoca, sicuramente non ortodossa [5].
Mi riferisco in particolare alla rappresentazione di se stesso data in Petrolio, opera postuma, che conferma – mi pare sempre, a distanza di venticinque anni – e quasi aritmeticamente, direi, l’analisi psicanalitica della sua personalità definibile fra i casi clinici classici freudiani dell’“uomo dei topi” e del “presidente Schreber”. Tanto che ritengo essere questo un terzo punto fondamentale, una nuova acquisizione emersa da questa ricerca dopo, ripetiamolo, quella sulla sua nuova storia letteraria nazionale otto-novecentesca inclusiva della dimensione dialettale, e il risalto dato al suo ibrido, efficacissimo strumento di lavoro, che dalla critica e la storiografia letteraria passerà poi all’analisi sociale e politica contemporanee. Si tratta, in fondo, di una variante italiana a forte connotazione gramsciana del freudo-marxismo iniziato da Wilhelm Reich negli anni ’30 e praticato più tardi, fra altri membri della scuola di Francoforte, anche da Theodor Adorno e Herbert Marcuse, i più conosciuti, per intenderci meglio e cominciare ad allargare un po’ più gli orizzonti, senza la parènesi socio-politica rivoluzionaria molto accentuata di quest’ultimo, però (molto dubbia, a mio avviso, con i suoi strascichi hegeliani, oltretutto, quanto erano molto dubbie tutte le altre proposte “rivoluzionarie” di quei tempi, che Pasolini osserva attentamente e poi denuncia nelle loro contraddizioni e inconsistenze sulla base di un’analisi, giustamente, esistenziale-psicanalitica e, se non più gramsciana, a quell’epoca, sicuramente non ortodossa [5].
Si diceva, dunque, alludendo più sopra a “un’avvertenza”, che occorre distinguere a questo punto fra un’analisi oggettiva e condivisibile che Pasolini sviluppa nei suoi scritti, da conclusioni soggettive che dipendono invece dalla sua personale, specifica conformazione mentale di tipo schizo-paranoide, come l’abbiamo definita sviluppando ulteriormente e precisando la definizione di Duflot che parlava soltanto di «struttura schizoide della sua personalità». A prova di ciò, si è mostrato che appoggiandosi a quei due casi clinici freudiani succitati, da lui, ripetiamolo ancora una volta, perfettamente conosciuti, Pasolini riproduce in effetti gli stessi classici meccanismi psicologici rivelati esemplarmente da Freud, nella sua narrazione delle vicende e dei pensieri del protagonista autobiografico di Petrolio, in primo luogo. Ma questi stessi meccanismi psicologici, aggiungiamo ora, non si manifestano soltanto nella sua finzione narrativa e nella sua poesia marcatamente autobiografiche, bensì, contemporaneamente, si manifestano anche in alcune sue analisi sociali e politiche che vorrebbero essere oggettive ma che risultano invece sconcertanti data la loro chiara soggettività di tipo nevrotico, se non addirittura psicotico.
Mi riferisco, per esempio, come già accennato più sopra, alla sua “profezia” dell’avvento di una “nuova preistoria”, alla fine – che egli reputava vicina, se non imminente – della civiltà occidentale tutta. Ma noi sappiamo dalla psicanalisi che l’idea di una “catastrofe universale” è un tipico delirio della paranoia, e più precisamente, che «la fine del mondo è una proiezione della catastrofe interiore» (Freud). Occorre insomma distinguere nelle analisi di Pasolini quel che avviene oggettivamente da ciò che egli vive soggettivamente: la scomparsa del suo mondo erotico, in particolare, insieme all’invecchiamento del suo corpo, aggiungiamo, che ancora una volta provocatoriamente egli, per esempio, cinquantenne, esibisce nudo in un servizio fotografico, spinto evidentemente dalla sua fissazione narcisistica, nel classico senso freudiano del termine, cosa di cui egli era peraltro da lungo tempo perfettamente cosciente, chiamandola “narcissica”. Ritorneremo su questo punto.
 A questo scopo di provare a distinguere ciò che nelle analisi di Pasolini può essere considerato come oggettivo da quello che è invece soggettivo, possiamo servirci del confronto con le analoghe analisi socio-politiche di un autore, come lui, poeta e narratore e, a suo modo, critico letterario, di soli due anni maggiore, e che osserva l’Occidente non dalla periferia provinciale, com’è l’Italia di Pasolini, ma dal suo centro e, aggiungerei, dal suo centro propagandistico dell’american way of life hollywoodiano: Charles Bukowski, le cui opere cominciano ad arrivare in traduzione in Italia dal 1975, l’anno della morte di Pasolini.
A questo scopo di provare a distinguere ciò che nelle analisi di Pasolini può essere considerato come oggettivo da quello che è invece soggettivo, possiamo servirci del confronto con le analoghe analisi socio-politiche di un autore, come lui, poeta e narratore e, a suo modo, critico letterario, di soli due anni maggiore, e che osserva l’Occidente non dalla periferia provinciale, com’è l’Italia di Pasolini, ma dal suo centro e, aggiungerei, dal suo centro propagandistico dell’american way of life hollywoodiano: Charles Bukowski, le cui opere cominciano ad arrivare in traduzione in Italia dal 1975, l’anno della morte di Pasolini.
Già prima di Pasolini, da posizioni non marxiste, tutt’altro, ma da quelle della controcultura underground americana, che Pasolini scopre entusiasticamente negli anni ’60, Bukowski aveva denunciato, come farà poi Pasolini, gli effetti mortali sullo “spirito umano”, come definisce il più alto valore umano in cui egli crede, da parte della società consumistica, capitalista americana, attraverso l’educazione impartita dallo stato e la televisione: due temi insistenti, si ricorderà, dell’ultimo Pasolini che proponeva sempre provocatoriamente l’abolizione della scuola media dell’obbligo e della televisione, scatenando un inedito dibattito sui giornali italiani. Il bambino americano, scriveva Bukowski,
«ha avuto il cervello strapazzato dall’educazione formale americana e dal genitore americano precocemente rincoglionito e dalla mostruosa pubblicità [televisiva] americana molto tempo prima che arrivi ai 12 anni» [6].
Con il risultato, in una società americana che per Bukowski e l’underground persegue complessivamente falsi valori, non solo, in particolare, di un’eccessiva sopravvalutazione della dimensione sessuale nella vita umana in funzione del matrimonio e della famiglia che, secondo Bukowski, incatena uomini e donne in rapporti profondamente sbagliati e deleteri – vero soggetto dell’articolo in questione, nonché del celebre monologo di Marlon Brando nell’Ultimo tango a Parigi, sequestrato anche per questo –; ma, fra altre conseguenze esiziali per lo spirito umano, con il risultato ancora più grave, in generale, della trasformazione dell’uomo, svuotato della propria individualità umana, diciamo, in attore. Così infatti Bukowski rappresenta i suoi compagni di viaggio americani di ritorno dalla sua tournée in Europa nel 1978:
«L’aereo pareva pieno di americani; si muovevano tutti come fossero stati su un palcoscenico: ecco come capisci che uno è un americano. Ed erano più flaccidi in faccia, più brutti. Ero di nuovo con la mia specie» [7].
Anche su quest’altro tema, si ricorderà, Pasolini insistette molto parlando e scrivendo di “omologazione” e “genocidio antropologico”, fenomeni che, più di chiunque altro in Italia, egli sembrava vedere e denunciare nel modo più chiaro essersi già realizzati nel nostro Paese a meno di vent’anni dalla celebre Tu vuo’ fa’ l’americano di Renato Carosone, che annunciava scherzosamente il fenomeno, canzone molto popolare del 1956. Ricorda Laura Betti in un’intervista a “Epoca” del 1988:
«Era nel 1974, e avevamo convocato dei giovani per i provini di Salò. Si presentarono in diverse centinaia, e dovette intervenire la polizia perché quei ragazzi, senza alcuna ragione, si erano messi a spaccare tutto davanti agli uffici della produzione. La cosa che più colpì Pier Paolo fu proprio la deformazione dei volti: l’ingenuità, la malizia, la generosità o la timidezza che avevamo conosciuto vent’anni prima al Tiburtino o al Quarticciolo, avevano lasciato il posto ad espressioni tristi, cupe, degradate. Il segno di qualcosa di irreparabile che era successo».
 Ebbene, al di là delle esagerazioni (per noi, ma non per lui) legate alla sua soggettività, occorre constatare che anche in Italia, e già da molto, la gente, come gli americani descritti da Bukowski oltre quarant’anni fa, si comporta in effetti come se recitasse, magari non su un palcoscenico, ma in un film: non si porta a spasso il cane, per esempio, ma, imitando forse il proprio attore preferito, si recita la parte di qualcuno che porta a spasso un cane. E in questo, sull’omologazione, indubbiamente, Pasolini fu “profetico”, com’era comunque non difficilmente prevedibile osservando con quale rapidità il modello trainante americano veniva esportato in tutto l’Occidente (“libero”, come la propaganda americana lo definiva in quei tempi, in contrapposizione al mondo “schiavo” del comunismo). Giacché, in effetti, dopo aver omologato rapidamente America latina e Europa occidentale e Giappone, si è poi esteso, con la fine dell’Urss, all’Europa orientale e alla stessa Russia. Ed è persino penetrato nella Cina ancora formalmente comunista, questo modello, l’ultima vasta regione terrestre “non libera”, impegnata da un paio di decenni o tre in un’inedita adozione-resistenza al modello che si vuole verosimilmente estendere in modo totale (totalitariamente?) al nostro globo terracqueo con il cavallo di Troia della democrazia: la civiltà dei consumi capitalistica.
Ebbene, al di là delle esagerazioni (per noi, ma non per lui) legate alla sua soggettività, occorre constatare che anche in Italia, e già da molto, la gente, come gli americani descritti da Bukowski oltre quarant’anni fa, si comporta in effetti come se recitasse, magari non su un palcoscenico, ma in un film: non si porta a spasso il cane, per esempio, ma, imitando forse il proprio attore preferito, si recita la parte di qualcuno che porta a spasso un cane. E in questo, sull’omologazione, indubbiamente, Pasolini fu “profetico”, com’era comunque non difficilmente prevedibile osservando con quale rapidità il modello trainante americano veniva esportato in tutto l’Occidente (“libero”, come la propaganda americana lo definiva in quei tempi, in contrapposizione al mondo “schiavo” del comunismo). Giacché, in effetti, dopo aver omologato rapidamente America latina e Europa occidentale e Giappone, si è poi esteso, con la fine dell’Urss, all’Europa orientale e alla stessa Russia. Ed è persino penetrato nella Cina ancora formalmente comunista, questo modello, l’ultima vasta regione terrestre “non libera”, impegnata da un paio di decenni o tre in un’inedita adozione-resistenza al modello che si vuole verosimilmente estendere in modo totale (totalitariamente?) al nostro globo terracqueo con il cavallo di Troia della democrazia: la civiltà dei consumi capitalistica.
Il Pasolini degli ultimi anni della sua vita, come Bukowski [8], ha indubbiamente descritto in modo oggettivo questo fenomeno, fino al tema (surrealista?) della nazificazione del mondo, presente in modi diversi nella narrativa di entrambi, ma vi ha aggiunto un’interpretazione soggettiva che attiene alla sua propria psicologia determinata dagli specifici traumi e condizionamenti della sua vita. E proprio a partire da questa interpretazione personale che sconcerta, come si diceva, possiamo avvicinarci alla comprensione della sua psicologia, la quale, ricordiamolo, era quella di un grande poeta, una persona estremamente sensibile appartenente, come Ginsberg, a una minoranza sessuale perseguitata in Paesi dalla cultura sessuale allora reazionaria che disprezzavano e reprimevano questa minoranza sia legalmente, attraverso i loro tribunali, sia in modo sommario, attraverso un’aggressione fisica anche gratuita da parte di chiunque lo desiderasse; una violenza quasi autorizzata dalla morale corrente, insomma, di cui Pasolini fece esperienza, rischiando di morire, anche a New York e chissà quante altre volte prima di quell’ultima all’idroscalo di Ostia.
 Questo pericolo può far parte, per la conformazione psicologica di qualcuno, uomo o donna che sia, del rituale erotico di cui ha bisogno, com’era molto verosimilmente il caso di Pasolini, secondo le testimonianze di Naldini e Bellezza, nonché di non pochi luoghi della sua opera sia poetica sia narrativa che lo confermerebbero. Un genere di omosessualità “degradata”, come la definì Giorgio Galli (nella prefazione di Omicidio nella persona di Pasolini Pier Paolo), anche perché “mercenaria”, e perciò in assoluta contraddizione con i valori morali per cui si lotta, e che rivedremo in Michel Foucault, il quale trovò anche lui, benché in modo diverso (l’aids), ciò che Pasolini cercava. Che era poi anche il genere di omosessualità di Rimbaud, modello non solo poetico di Pasolini. Ciò che per chi non ha questo bisogno è appunto sconcertante, come sono sconcertanti gli argomenti dell’analisi sociale che portano a “giustificare per sé” questo bisogno: quello che più sopra si definiva appunto come soggettivo e che è da riconoscere e distinguere come tale in un’analisi che si vorrebbe invece oggettiva [9].
Questo pericolo può far parte, per la conformazione psicologica di qualcuno, uomo o donna che sia, del rituale erotico di cui ha bisogno, com’era molto verosimilmente il caso di Pasolini, secondo le testimonianze di Naldini e Bellezza, nonché di non pochi luoghi della sua opera sia poetica sia narrativa che lo confermerebbero. Un genere di omosessualità “degradata”, come la definì Giorgio Galli (nella prefazione di Omicidio nella persona di Pasolini Pier Paolo), anche perché “mercenaria”, e perciò in assoluta contraddizione con i valori morali per cui si lotta, e che rivedremo in Michel Foucault, il quale trovò anche lui, benché in modo diverso (l’aids), ciò che Pasolini cercava. Che era poi anche il genere di omosessualità di Rimbaud, modello non solo poetico di Pasolini. Ciò che per chi non ha questo bisogno è appunto sconcertante, come sono sconcertanti gli argomenti dell’analisi sociale che portano a “giustificare per sé” questo bisogno: quello che più sopra si definiva appunto come soggettivo e che è da riconoscere e distinguere come tale in un’analisi che si vorrebbe invece oggettiva [9].
 Le ultime parole di Pasolini giunte a noi sono quelle della sua intervista concessa a Furio Colombo, il sabato 1° novembre 1975, soltanto qualche ora prima di essere assassinato, e il cui titolo, deciso da Pasolini stesso, è Siamo tutti in pericolo (“Tuttolibri”, sabato 8 novembre 1975). In questa intervista, fino a un certo punto, ancora, le analisi di Pasolini non si discostano sostanzialmente da quelle dell’underground americano o, anche a un livello superiore, del Bertrand Russell di Saggi scettici, o ancora dell’Eric Fromm di Avere o essere? (benché quest’ultimo testo sia del 1976, e sarà pubblicato in Italia l’anno seguente); con il quale Fromm, egli condivide peraltro altri aspetti politici come l’accento sul giovane Marx umanistico e il rifiuto dell’autoritarismo e dell’analoga disumanizzazione operata dal comunismo reale come dal capitalismo («la violenza è sempre di destra», aveva affermato qualche anno prima in un’intervista filmata). Diamogli la parola in una rapida sintesi di questa sua ultima intervista cui, con altri più brevi articoli che l’accompagnavano, “Tuttolibri” dedicava ben tre pagine.
Le ultime parole di Pasolini giunte a noi sono quelle della sua intervista concessa a Furio Colombo, il sabato 1° novembre 1975, soltanto qualche ora prima di essere assassinato, e il cui titolo, deciso da Pasolini stesso, è Siamo tutti in pericolo (“Tuttolibri”, sabato 8 novembre 1975). In questa intervista, fino a un certo punto, ancora, le analisi di Pasolini non si discostano sostanzialmente da quelle dell’underground americano o, anche a un livello superiore, del Bertrand Russell di Saggi scettici, o ancora dell’Eric Fromm di Avere o essere? (benché quest’ultimo testo sia del 1976, e sarà pubblicato in Italia l’anno seguente); con il quale Fromm, egli condivide peraltro altri aspetti politici come l’accento sul giovane Marx umanistico e il rifiuto dell’autoritarismo e dell’analoga disumanizzazione operata dal comunismo reale come dal capitalismo («la violenza è sempre di destra», aveva affermato qualche anno prima in un’intervista filmata). Diamogli la parola in una rapida sintesi di questa sua ultima intervista cui, con altri più brevi articoli che l’accompagnavano, “Tuttolibri” dedicava ben tre pagine.
«La tragedia è che non ci sono più esseri umani, ci sono strane macchine che sbattono l’una contro l’altra. Il potere è un sistema di educazione che ci divide in soggiogati e soggiogatori. Ma attento. Uno stesso sistema educativo che ci forma tutti, dalle cosiddette classi dirigenti, giù fino ai poveri. Ecco perché tutti vogliono le stesse cose e si comportano nello stesso modo. Se ho fra le mani un consiglio di amministrazione o una manovra di Borsa uso quella. Altrimenti una spranga. E quando uso una spranga faccio la mia violenza per ottenere ciò che voglio. Perché lo voglio? Perché mi hanno detto che è una virtù volerlo. Io esercito il mio diritto-virtù. Sono assassino e sono buono. Qui c’è la voglia di uccidere. È questa voglia che ci lega come fratelli sinistri di un fallimento sinistro di un intero sistema sociale. (…) Prima tragedia: una educazione comune, obbligatoria e sbagliata che ci spinge tutti dentro l’arena dell’avere tutto a tutti i costi. In questa arena siamo spinti come una strana e cupa armata in cui qualcuno ha i cannoni e qualcuno ha le spranghe. Allora una prima divisione classica è “stare con i deboli”. Ma io dico che, in un certo senso tutti sono i deboli, perché tutti sono vittime. E tutti sono i colpevoli, perché tutti sono pronti al gioco del massacro. Pur di avere. L’educazione ricevuta è stata: avere, possedere, distruggere. Questa cupa ostinazione alla violenza totale non lascia più vedere “di che segno sei”. La cosiddetta scuola dell’obbligo fabbrica per forza gladiatori disperati. La massa si fa più grande, come la disperazione, come la rabbia. Mettiamo che io abbia lanciato una boutade (eppure non credo)».
Tuttavia, su questo punto, egli precisa poco dopo:
«Chiudere [le scuole e la televisione], nel mio linguaggio vuol dire cambiare. Cambiare però in modo tanto drastico e disperato quanto drastica e disperata è la situazione. E voi siete [rivolgendosi a Furio Colombo] con la scuola, la televisione, la pacatezza dei vostri giornali, voi siete i grandi conservatori di questo ordine orrendo basato sull’idea di possedere e sull’idea di distruggere. Beati voi che siete tutti contenti quando potete mettere su un delitto la sua bella etichetta. Qui manca il chirurgo che ha il coraggio di esaminare il tessuto e di dire: signori, questo è cancro, non è un fattarello benigno. Cos’è il cancro? È una cosa che cambia tutte le cellule, che le fa crescere tutte in modo pazzesco, fuori da qualsiasi logica precedente. È un nostalgico il malato che sogna la salute che aveva prima, anche se prima era uno stupido e un disgraziato? Prima del cancro, dico».
Ma in mezzo a quest’analisi che può essere considerata tutto sommato come oggettiva, pur nella sua tendenza, diciamo, libertaria, perché condivisa dalla variegata cultura underground e dai filosofi succitati, e che si oppone, mettiamo, a un’analisi conservatrice, reazionaria, che può essere considerata altrettanto oggettiva perché anch’essa condivisa da quella parte politica – diciamo meglio, allora: analisi, entrambe, “oggettive di parte” – ecco che brevemente affiora di tanto in tanto, fra un’analisi e una definizione e l’altra, il Pasolini privato, soggettivo:
«[...] con la vita che faccio io pago un prezzo. È come uno che scende all’inferno. Ma quando torno – se torno – ho visto altre cose. Non dico che dovete credermi. Dico che dovete sempre cambiare discorso per non affrontare la verità».
Ed è precisamente quell’inciso, “se torno”, che sconcerta, così come, poco prima, quest’altra riflessione che potrebbe dirsi altrettanto premonitrice:
«Che bello se mentre siamo qui a parlare, qualcuno in cantina sta facendo i piani per farci fuori. È facile, è semplice, è la resistenza. Noi perderemo alcuni compagni e poi ci organizzeremo e faremo fuori loro, o un po’ per uno, ti pare? Il fascista di Salò, il nazista delle SS, l’uomo normale, con l’aiuto del coraggio e della nevrosi coscienza, riesce a respingerlo, anche dalla sua vita interiore (dove la rivoluzione sempre comincia). Ma adesso no. Uno ti viene incontro vestito da amico, è gentile, garbato, e “collabora” (mettiamo alla televisione) sia per campare sia perché non è mica un delitto. L’altro – o gli altri, i gruppi – ti vengono incontro o addosso – con i loro ricatti ideologici, con le loro ammonizioni, le loro prediche, i loro anatemi e tu senti che sono minacce. Sfilano con bandiere e con slogan, ma che cosa li separa dal “potere”?»
 E qui seguiva la sua definizione di “potere” già citata più sopra e che si invita a rileggere per chiudere questo cerchio sintetico. Dunque, per sintetizzare ulteriormente: siamo tutti in pericolo perché c’è una voglia generalizzata di uccidere indotta dalla stessa educazione che abbiamo ricevuto tutti allo stesso modo in un sistema sociale sbagliato perché fondato sul possesso materiale e sulla violenza da esercitare per ottenerlo. E questa possiamo considerarla, bene o male, come la parte oggettiva.
E qui seguiva la sua definizione di “potere” già citata più sopra e che si invita a rileggere per chiudere questo cerchio sintetico. Dunque, per sintetizzare ulteriormente: siamo tutti in pericolo perché c’è una voglia generalizzata di uccidere indotta dalla stessa educazione che abbiamo ricevuto tutti allo stesso modo in un sistema sociale sbagliato perché fondato sul possesso materiale e sulla violenza da esercitare per ottenerlo. E questa possiamo considerarla, bene o male, come la parte oggettiva.
Ma appare evidente, dalla citazione delle parti soggettive del discorso di Pasolini, che egli si sentiva minacciato: difatti era già stato aggredito fisicamente più volte e non solo in Italia, si è detto, per ragioni non solo politiche, dunque. Ma si sentiva perseguitato anche per ragioni politiche e morali: dai tribunali, da altre istituzioni, da alcuni giornali, da alcuni partiti, da alcuni movimenti extraparlamentari anche di opposte tendenze, di estrema destra come di estrema sinistra: aveva insomma, verosimilmente, molti nemici – e primi fra tutti, secondo Giorgio Galli, i democristiani al potere da trent’anni di cui egli chiedeva insistentemente il processo dalle pagine dei maggiori giornali del Paese – oltre ad avere la pericolosa abitudine di “scendere all’inferno”, come egli stesso si esprime. Ed è un punto, quest’ultimo, sul quale sintomaticamente, direi, torna ancora una volta verso la fine dell’intervista:
«Voglio dire fuori dai denti: io scendo all’inferno e so cose che non disturbano la pace di altri. Ma state attenti. L’inferno sta salendo da voi. È vero che viene con maschere diverse. È vero che sogna la sua uniforme e la sua giustificazione (qualche volta). Ma è anche vero che la sua voglia, il suo bisogno di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere, è forte ed è generale. Non resterà per tanto tempo l’esperienza privata e rischiosa di chi ha, come dire, toccato “la vita violenta”. Non vi illudete».
Ed è questo, mi pare, un altro ed ultimo esempio della tendenza di Pasolini a estendere al mondo, al di là di analisi oggettive, ciò che egli provava personalmente, come in precedenza s’era parlato della soggettività del suo sentimento di “catastrofe universale”, tanto da rifletterlo stavolta anche nel titolo stesso dell’intervista da lui scelto: Siamo tutti in pericolo. Mi pare utile riportare anche le ultime domande di Colombo e l’ultima risposta di quest’ultima intervista.
«D. – Perché pensi che per te certe cose siano talmente più chiare?
R. – Non vorrei parlare più di me, forse ho detto fin troppo. Lo sanno tutti che io le mie esperienze le pago di persona. Ma ci sono anche i miei libri e i miei film. Forse sono io che sbaglio. Ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo.
D. – Pasolini se tu vedi la vita così – non so se accetti questa domanda – come pensi di evitare il pericolo e il rischio?»
Pasolini non rispose a quest’ultima domanda. S’era fatto tardi, scrive Furio Colombo, e congedandolo egli chiese di lasciargli le domande dell’intervista per poter precisare meglio le sue risposte, così dicendo:
«Ci sono punti che mi sembrano un po’ troppo assoluti. Fammi pensare, fammeli rivedere. E poi dammi il tempo di trovare una conclusione. Ho una cosa in mente per rispondere alla tua domanda. Per me è più facile scrivere che parlare. Ti lascio le note che aggiungo per domani mattina».
Quelle note non poté più scriverle perché fu assassinato qualche ora dopo. Si noti comunque la stranezza di non essere riuscito a esprimere in modo per lui soddisfacente – nelle due ore dell’intervista, precisava Colombo – ciò che egli andava ripetendo e scrivendo già da anni: un segno, potrebbe essere, anche del suo stato mentale confuso di quel momento, o anche di quell’ultimo periodo della sua vita, in balìa forse dell’irrazionalità che non sarebbe più riuscito a razionalizzare stavolta come in passato, risultando il suo discorso, in effetti, alquanto sbilanciato e perentorio, ciò che egli peraltro ammette. E con l’ultima sua domanda, Colombo sembrerebbe inoltre avere messo infine il dito nella piaga sanguinante dell’intervistato: «come pensi di evitare il pericolo e il rischio?»
Personalmente, come ho sostenuto nella ricerca e continuo a ritenere, penso che poco dopo questa intervista Pasolini trovò finalmente quel che da molto tempo una parte di sé andava cercando inconsciamente, e di cui a volte aveva dato anche prova di essere consapevole, esattamente come avverrà anche con Foucault, si è detto, che morirà nove anni dopo, nell’altrettanto evidente ricerca della morte. Ne abbiamo parlato abbastanza estesamente nella nostra ricerca, e mi pare ancora, dicevo, rileggendo quelle pagine, in modo alquanto plausibile.
 Se non ha più risposto a quell’ultima domanda dell’intervista di Colombo, infatti, Pasolini si era già aperto a sufficienza su questo punto, fra altri luoghi della sua poesia e della sua narrativa, anche con Duflot, sei anni prima, nel capitolo successivo a quello in cui si era accennato alla “struttura schizoide della sua personalità”. Riportiamo anche stavolta le risposte e le domande significative che non a caso seguono la precisazione da parte di Pasolini, in termini freudiani, dell’immagine (il sogno, appunto) del centauro nel suo Edipo re (1967), tratto da Sofocle, questione cardine, com’è noto, della teoria psicanalitica, e che darà significativamente il titolo della traduzione italiana di Les dernières paroles d’un impie: Il sogno del centauro. Spiega Pasolini:
Se non ha più risposto a quell’ultima domanda dell’intervista di Colombo, infatti, Pasolini si era già aperto a sufficienza su questo punto, fra altri luoghi della sua poesia e della sua narrativa, anche con Duflot, sei anni prima, nel capitolo successivo a quello in cui si era accennato alla “struttura schizoide della sua personalità”. Riportiamo anche stavolta le risposte e le domande significative che non a caso seguono la precisazione da parte di Pasolini, in termini freudiani, dell’immagine (il sogno, appunto) del centauro nel suo Edipo re (1967), tratto da Sofocle, questione cardine, com’è noto, della teoria psicanalitica, e che darà significativamente il titolo della traduzione italiana di Les dernières paroles d’un impie: Il sogno del centauro. Spiega Pasolini:
«È un’immagine onirica relativamente chiara, nella simbolica freudiana: il simbolo del blocco parentale, padre e madre. Il cavallo raffigura sia il padre che la madre. È il simbolo dell’androgino: della potenza paterna e della maternità (nel senso in cui viene intesa la coppia madre-figlio, dato che la madre antica porta il bambino sulla schiena.)
D. – Ma questo “smarrimento” deriva da ragioni più intime, da particolarismi psicologici, dovuti alla sua posizione nei confronti di sua madre e di suo padre?
R. – Sì sicuramente. I più dei miei fastidi, la maggior parte dell’odio che mi si dedica, vengono dal fatto che sono diverso. Lo sento, questo odio, è “razziale”. È il razzismo che viene esercitato contro tutte le minoranze del mondo».
E fra la spiegazione dell’immagine del centauro e quest’ultima domanda/risposta, troviamo ciò che Pasolini non ha potuto/voluto rispondere nell’ultima domanda di Furio Colombo.
«D. – L’ossessione dell’esclusione, della marginalità, corrisponde a una esperienza dolorosamente vissuta da Lei?
R. – Indubbiamente. Quando Le dico che la mia è la mentalità dell’animale ferito, al traino della banda, dico la verità».
Con quest’immagine di sé come di un ”animale ferito”, Pasolini si riferisce evidentemente ai versi di Poesia in forma di rosa, e che avrebbero spiegato a Colombo, se li avesse letti o ricordati, il fatto che egli non poteva/voleva evitare il pericolo perché – e lo scriveva chiaramente – era «succube degli impeti di morte», e perciò aveva il bisogno incontrollabile del rischio, non solo: «Reduce dai cessi di Messina, dalle casbah di Catania», raccontava sempre in versi, «così, trascino con me la morte nella vita» e «riprendo a Roma le mie abitudini / di bestia ferita, che guarda negli occhi, / godendo del morire, i suoi feritori…». Può essere più chiaro? Vogliamo aggiungere la stessa spiegazione espressa anche nella prosa del coevo L’odore dell’India? «… io non so dominare la bestia assetata chiusa dentro di me, come in una gabbia». Certo, si tratta di sconcertanti meccanismi psicologici che non possono essere compresi e spiegati senza Freud.
Nell’ultima parte del libro-dialogo con Duflot, una nuova lunga intervista concessa nel 1975 che completava quella del 1969, come si è detto, Pasolini ritornava sull’argomento affrontando il problema fondamentale della sua vita come, a mia conoscenza, non aveva mai fatto prima così apertamente, nel capitolo intitolato Diverso come gli altri, il quale era introdotto non da una domanda, ma dalla seguente constatazione di Duflot: « È da tempo che Lei si sente, secondo la sua definizione, votato al linciaggio». Senza nominarlo, nel corso della sua successiva analisi, Pasolini citava da una parte il noto assioma freudiano secondo cui «la bisessualità è naturalmente la legge strutturale di qualunque essere sessuato», dall’altra, ricordava al suo intervistatore la situazione nella quale, in quanto omosessuale, si ritrovava:
«Non c’è nulla di più terribile che il cacciatore di “finocchi”, reso dalla rimozione o dai pregiudizi particolarmente fobico e persino pericoloso… Ogni mattina, nelle periferie romane, due o tre vittime del razzismo antiomosessuale pagano il prezzo della loro anormalità alla società in via di normalizzazione».
E nel capitolo successivo intitolato Paradiso perduto, precisava che nell’attuale razzista e totalitaria civiltà dei consumi «le masse non sono mai state così intolleranti e violente nei confronti degli emarginati sessuali, mai così disposte al linciaggio». Infine, in Coccodrillo, poemetto composto nel 1968, riaffioravano il “masochismo” e «il desiderio di essere ucciso»(di cui, stavolta, rivelava anche l’origine nelle “liti tra i genitori” quand’egli era bambino), il “narcisismo”, la struttura schizoide della sua personalità, e constatava: «i miei Himmler potevano essere tutti / indistintamente».
Tutto ciò non esclude, comunque, che il suo assassinio sia molto probabilmente anche politico, come fra molti altri sosteneva Giorgio Galli: una “punizione” democristiana, precisamente, secondo lui, e non soltanto “un incidente di lavoro”, come s’era espresso Dario Bellezza. Altri, invece dei democristiani, pensavano ai fascisti che non gli avevano perdonato il suo ultimo film, Salò o le 120 giornate di Sodoma, apparso in quello stesso 1975. Ricordando la turbolenza politica e sociale di quegli “anni di piombo” e di “stragi di Stato” in Italia, l’ipotesi dell’assassinio politico non può che essere molto probabile: quella era l’aria dei tempi.
Tuttavia, come non si possono considerare oggettive e condivisibili le razionalizzazioni linguistico-religiose di Dante citate in nota – (ricordando ora che anche la fede religiosa è stata considerata, piuttosto autorevolmente, direi, come una “nevrosi dell’umanità”, fra gli altri, da Nietzsche e Freud, un giudizio che qui si condivide pienamente e che mi ha indotto ad assimilare la dimensione interpretativa mistico-religiosa-profetica pasoliniana a quella psicanalitica) –, così non possono che essere considerate come soggettive quelle parti delle analisi sociali e politiche di Pasolini che corrispondono al suo desiderio (non sempre inconscio, come abbiamo visto) di morte. Da qui l’importanza, si diceva, come si è appena mostrato più sopra, nella sua ultima intervista con Furio Colombo, di distinguere queste parti soggettive, peraltro ben riconoscibili perché sono sconcertanti, dalla sua analisi socio-politica generale, “oggettiva di parte”, come l’abbiamo definita.
 Del resto, Pasolini stesso riconosceva la sua incapacità a una rappresentazione oggettiva della realtà, proprio per la sua specifica conformazione mentale, nella lettera particolarmente importante indirizzata a Vittorio Sereni nel 1953, nella quale definiva “clinicamente” il suo caso come una “fissazione narcissica”, gli spiegava, che lo legava al suo “sdoppiamento”, che ugualmente ammetteva stavolta, dunque, e concludendo: «Niente capacità oggettivo-realistica, quindi: il mondo era inconoscibile se non in una sua figura leggendaria e poetica»; mondo che nei suoi ultimi anni, possiamo aggiungere, assunse invece la figura di un “universo orrendo” per le molteplici ragioni che conosciamo. Tutto ciò risulta ancora più chiaro nel giudizio molto sintetico sul realismo di Umberto Saba dato in Passione e ideologia, giudizio attribuibile con ogni evidenza e per le stesse ragioni anche a se stesso: un “profondo trauma”, scriveva Pasolini, gli ha impedito una visione oggettiva della realtà; e una «certa ricercata ‘bassezza’ di tono poetico» si spiega, diceva, «attraverso argomenti freudiani che Saba tanto ama». Come li amava anche lui, aggiungiamo, nella cui poesia la stessa “’bassezza’ di tono” attribuita a Saba corrispondeva inoltre a una forma molto patologica di sessualità sado-masochistica, obbiettivamente piuttosto pericolosa, praticata verosimilmente da una ristretta minoranza che risulta emarginata anche nella sfera omosessuale stessa, dopo tutto. Inoltre, si tratta di una patologia che possiamo trovare anche nella sfera eterosessuale, ovviamente; basti pensare all’Impero dei sensi di Nagisa Oshima, per esempio, film tratto da un reale fatto di cronaca, o anche, in una forma meno grave, a D’Annunzio.
Del resto, Pasolini stesso riconosceva la sua incapacità a una rappresentazione oggettiva della realtà, proprio per la sua specifica conformazione mentale, nella lettera particolarmente importante indirizzata a Vittorio Sereni nel 1953, nella quale definiva “clinicamente” il suo caso come una “fissazione narcissica”, gli spiegava, che lo legava al suo “sdoppiamento”, che ugualmente ammetteva stavolta, dunque, e concludendo: «Niente capacità oggettivo-realistica, quindi: il mondo era inconoscibile se non in una sua figura leggendaria e poetica»; mondo che nei suoi ultimi anni, possiamo aggiungere, assunse invece la figura di un “universo orrendo” per le molteplici ragioni che conosciamo. Tutto ciò risulta ancora più chiaro nel giudizio molto sintetico sul realismo di Umberto Saba dato in Passione e ideologia, giudizio attribuibile con ogni evidenza e per le stesse ragioni anche a se stesso: un “profondo trauma”, scriveva Pasolini, gli ha impedito una visione oggettiva della realtà; e una «certa ricercata ‘bassezza’ di tono poetico» si spiega, diceva, «attraverso argomenti freudiani che Saba tanto ama». Come li amava anche lui, aggiungiamo, nella cui poesia la stessa “’bassezza’ di tono” attribuita a Saba corrispondeva inoltre a una forma molto patologica di sessualità sado-masochistica, obbiettivamente piuttosto pericolosa, praticata verosimilmente da una ristretta minoranza che risulta emarginata anche nella sfera omosessuale stessa, dopo tutto. Inoltre, si tratta di una patologia che possiamo trovare anche nella sfera eterosessuale, ovviamente; basti pensare all’Impero dei sensi di Nagisa Oshima, per esempio, film tratto da un reale fatto di cronaca, o anche, in una forma meno grave, a D’Annunzio.
Come Dante denunciò tutti i mali del suo tempo essere derivati dall’usurpazione del potere temporale da parte della corrotta Chiesa romana che si era sostituita all’impero, tradendo l’evangelico “Da’ a Cesare…”; non solo, ma essere derivati anche dall’adozione dell’incontrollata ricerca capitalistica della ricchezza propria della classe mercantile urbana in rapidissima ascesa ai suoi tempi, con i suoi valori altrettanto anticristiani; e auspicava la restaurazione dell’impero e il ritorno alla lettera del Vangelo – sostanzialmente, un improbabile ritorno all’epoca feudale-cavalleresca in opposizione a una borghesia sempre più potente e trainante; così Pasolini (come Bukowski e la controcultura americana) denunciava il capitalismo del suo tempo (che nella convincente analisi neomarxista di Walter Benjamin di un secolo fa, aveva peraltro già da tempo fagocitato il cristianesimo costituendosi nella nuova, effettiva, vera religione dei nostri tempi). E denunciando anche il contemporaneo comunismo reale autoritario, auspicava anche lui come Dante l’improbabile ritorno ai valori di una società arcaica, preindustriale, povera, nella quale, scriveva, beni essenziali e non superflui avrebbero reso non superflua ed essenziale la vita, e che non era certamente la società comunista che aveva visto con i propri occhi.
La vita umana ridotta a cosa e mercificata nell’universo capitalistico – la “civiltà dei consumi”, per lui, è il vero fascismo moderno tendente al nazismo perché assolutamente “intollerante” e molto più “totalitaria” – avrebbe ritrovato in questa regressione, a suo avviso, quella sacralità originaria che aveva perduto e che egli vedeva ancora nei Paesi del Terzo mondo precapitalisti: approssimativamente, lo “spirito umano” su cui insisteva Bukowski. Ciò non toglie, al di là dell’impraticabilità delle esortazioni di Dante e Pasolini, considerati entrambi come “profeti” eretici dal potere, e la cui eresia era consistita nell’aver detto la verità sulle massime istituzioni dei loro tempi e sugli uomini che ne erano a capo; ciò non toglie, dicevamo, che la loro analisi politica e la forma stessa dell’analisi nella loro rispettiva opera, siano grandi valori non solo letterari, ma anche storici e morali per i posteri: grandi testimonianze, insomma, di grandi poeti.
 Concludiamo dandone un esempio, nel quale, peraltro, Pasolini definisce la funzione dell’intellettuale e la specificità del suo mestiere, ben distinto da quello del politico: ciò che si è voluto mettere in risalto nel nostro studio. Giorgio Galli, nella prefazione dell’opera citata, a tre lustri dalla morte di Pasolini, riconosce che egli «aveva perfettamente capito il processo di apparente destabilizzazione in atto» in quegli anni in Italia, e l’«autentica stabilizzazione politica» che ne seguì, precorrendo così, scrive, «una interpretazione che oggi [1992] ha trovato sostanziale conferma». E cita due luoghi “cruciali” dell’articolato discorso pasoliniano al Paese attraverso i suoi organi di stampa più diffusi, quotidiani o settimanali, discorso che prenderà il titolo, com’è noto, di “Romanzo delle stragi”: appassionati interventi politici (com’erano appassionati quelli del “ghibellino fuggiasco” Dante rivolti alla sua Firenze e non solo), e che confluiranno poi in Scritti corsari, da cui si cita.
Concludiamo dandone un esempio, nel quale, peraltro, Pasolini definisce la funzione dell’intellettuale e la specificità del suo mestiere, ben distinto da quello del politico: ciò che si è voluto mettere in risalto nel nostro studio. Giorgio Galli, nella prefazione dell’opera citata, a tre lustri dalla morte di Pasolini, riconosce che egli «aveva perfettamente capito il processo di apparente destabilizzazione in atto» in quegli anni in Italia, e l’«autentica stabilizzazione politica» che ne seguì, precorrendo così, scrive, «una interpretazione che oggi [1992] ha trovato sostanziale conferma». E cita due luoghi “cruciali” dell’articolato discorso pasoliniano al Paese attraverso i suoi organi di stampa più diffusi, quotidiani o settimanali, discorso che prenderà il titolo, com’è noto, di “Romanzo delle stragi”: appassionati interventi politici (com’erano appassionati quelli del “ghibellino fuggiasco” Dante rivolti alla sua Firenze e non solo), e che confluiranno poi in Scritti corsari, da cui si cita.
«Prendiamo le piste nere. Io ho un’idea, magari un po’ romanzesca ma credo giusta, della cosa. Il romanzo è questo. Gli uomini di potere, e potrei forse fare addirittura dei nomi senza paura di sbagliarmi tanto – comunque alcuni degli uomini che ci governano da trent’anni – hanno prima gestito la strategia della tensione anticomunista, poi, passata la preoccupazione dell’eversione del ’68 e del pericolo comunista immediato, le stesse, identiche persone hanno gestito la strategia della tensione antifascista. Le stragi quindi sono state compiute sempre dalle stesse persone. Prima hanno fatto la strage di Piazza Fontana accusando gli estremisti di sinistra, poi hanno fatto le stragi di Brescia e di Bologna accusando i fascisti e cercando di rifarsi in fretta e furia quella verginità antifascista di cui avevano bisogno, dopo la campagna del referendum e dopo il referendum [sul divorzio, 12-13 maggio 1974], per continuare a gestire il potere come se nulla fosse accaduto».
(Fascista, in “L’Europeo”, 26 dicembre 1974).
«Io so. (…) Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe (e che in realtà è una serie di golpes istituitasi a sistema di protezione del potere). (…) Io so nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. (…) Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. (…) Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. (…) Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero. (…) Tutto ciò fa parte del mio mestiere e dell’istinto del mio mestiere. Credo che sia difficile che il mio “progetto di romanzo” sia sbagliato, che non abbia cioè attinenza con la realtà, e che i suoi riferimenti a fatti e persone reali siano inesatti. Credo inoltre che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che so io in quanto intellettuale e romanziere. Perché la ricostruzione della verità a proposito di ciò che è successo in Italia dopo il 1968 non è poi così difficile. (…) Tale verità, lo si sente con assoluta precisione, sta dietro una grande quantità di interventi anche giornalistici e politici: cioè non di immaginazione o di finzione come è per sua natura il mio. Ultimo esempio: è chiaro che la verità urgeva, con tutti i suoi nomi, dietro all’editoriale del Corriere della Sera, del 1° novembre 1974. (…) Probabilmente i giornalisti e i politici hanno anche delle prove o, almeno, degli indizi. (…) Ora il problema è questo: i giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. (…) A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente a chi non solo ha il necessario coraggio, ma, insieme, non è compromesso nella pratica col potere, e, inoltre, non ha, per definizione, niente da perdere: cioè un intellettuale. (…) Un intellettuale dunque potrebbe benissimo fare pubblicamente quei nomi: ma egli non ha né prove né indizi. (…) Il potere e il mondo che, pur non essendo del potere, tiene rapporti pratici col potere, ha escluso gli intellettuali liberi – proprio per il modo in cui è fatto – dalla possibilità di avere prove e indizi. (…) Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia».
(Il romanzo delle stragi, “Corriere della Sera”, 14 novembre 1974).
E purtroppo, quest’ultima affermazione succitata è ancora oggi valida in modo sconsolante. Galli ritiene che Pasolini rimase vittima proprio della falsa destabilizzazione che denunciava, dopo averla perfettamente capita, così come ne fu vittima Aldo Moro, assassinato due anni e mezzo più tardi, il 9 maggio 1978 e che ne L’articolo delle lucciole era stato definito non a caso come «colui che appare come il meno implicato di tutti nelle cose orribili che sono state organizzate dal ’69 a oggi» (in “Corriere della Sera”, 1° febbraio 1975). Non solo, ma egli aveva precorso anche “l’ulteriore sviluppo”, secondo Galli, «della successiva evoluzione degli ‘anni di piombo’, di nuovo in chiave anticomunista contro il pericolo dell’accesso del Pci al governo», il quale, nelle elezioni regionali del 15 giugno 1975, ricordiamo, ottenne il 33,46% dei voti. Sicché, sentendosi “assediata” – come ammise uno dei suoi leader, Flaminio Piccoli – la Dc, sempre secondo l’analisi di Galli, fece «tacere una delle voci più forti dei supposti assedianti». E ciò, ripeto, mi pare molto probabile, benché non invalidi affatto la nostra analisi precedente, che ha trovato un’ulteriore conferma nell’analoga vicenda di Michel Foucault, (segnalata peraltro da Galli stesso, ma senza affrontare, né accennare a un’analisi delle profonde motivazioni psicologiche comuni a entrambi, limitandosi – come fece Fortini, quando Pasolini era ancora vivo – a rilevare che ciò era in flagrante contraddizione con il loro discorso morale. Il che, come molto spesso avviene a proposito di Pasolini, non spiega nemmeno la metà della sua figura globale, come si è riscontrato sia nella critica marxista che in quella cattolica, refrattarie entrambe et pour cause alla chiave interpretativa psicanalitica, che è l’unica chiave per comprenderlo, come si ripeterà ancora una volta di seguito. E non parliamo nemmeno dell’altrettanto abbondante critica neo onanistica [10].
Ora, al di là della polemica, il punto è, ripetiamolo: senza la psicanalisi Pasolini non può essere compreso, e anche se non la si accetta, essa è comunque necessaria per la comprensione di un autore che se ne serve molto per spiegare se stesso, che se ne serve anche nelle sue analisi letterarie e sociali e, ovviamente, nella sua multiforme produzione artistica. Ignorarla significa dunque ignorare una componente essenziale dello specifico linguaggio dell’autore. Questo atteggiamento è condannabile, evidentemente, anche dal punto di vista di una elementare metodologia della ricerca letteraria, poiché si rifiuta di seguire gli effettivi passi della traiettoria umana, artistica e intellettuale dell’oggetto di studio, sottoponendolo invece a dei parametri aprioristici e dogmatici che gli sono estranei.
 Altro celebre caso di patologia in ambito letterario-filosofico: come non si può capire lo Zarathustra di Nietzsche e nemmeno il successivo Al di là del bene e del male e quel che ne è seguito senza le Gatha, per esempio, così Petrolio, in particolare, ma anche tutto quello che lo precede, non può essere capito senza una minima conoscenza di ciò che Pasolini stesso definì come «l’atto fondamentale della mia cultura e della mia vita», la psicanalisi, appunto. Mi pare ovvio. E come leggendo le Gatha non significhi diventare necessariamente zoroastriani, così leggendo un minimo di psicanalisi, e in particolare quel testo segnalato dallo stesso Pasolini in Petrolio, e tenendone dovutamente conto, non significherebbe fare propria la teoria freudiana intaccando così la propria fede totalitaria con le sue “certezze”, e si capirebbe meglio Pasolini e la sua opera. Lo provò Fortini, molto più intellettualmente “temerario” in questo, diciamo, del nostro povero e molto limitato Ždanov junior – (non che ci volesse granché, in effetti) –; il quale Fortini però, e anche questo è sintomatico della chiusura mentale del dogmatico totalitario, anche di quelli più “temerari”, come si è mostrato nella ricerca, dovette attendere la morte dell’amico, e proprio quella morte lì, per capirlo del tutto finalmente.
Altro celebre caso di patologia in ambito letterario-filosofico: come non si può capire lo Zarathustra di Nietzsche e nemmeno il successivo Al di là del bene e del male e quel che ne è seguito senza le Gatha, per esempio, così Petrolio, in particolare, ma anche tutto quello che lo precede, non può essere capito senza una minima conoscenza di ciò che Pasolini stesso definì come «l’atto fondamentale della mia cultura e della mia vita», la psicanalisi, appunto. Mi pare ovvio. E come leggendo le Gatha non significhi diventare necessariamente zoroastriani, così leggendo un minimo di psicanalisi, e in particolare quel testo segnalato dallo stesso Pasolini in Petrolio, e tenendone dovutamente conto, non significherebbe fare propria la teoria freudiana intaccando così la propria fede totalitaria con le sue “certezze”, e si capirebbe meglio Pasolini e la sua opera. Lo provò Fortini, molto più intellettualmente “temerario” in questo, diciamo, del nostro povero e molto limitato Ždanov junior – (non che ci volesse granché, in effetti) –; il quale Fortini però, e anche questo è sintomatico della chiusura mentale del dogmatico totalitario, anche di quelli più “temerari”, come si è mostrato nella ricerca, dovette attendere la morte dell’amico, e proprio quella morte lì, per capirlo del tutto finalmente.
Dopo aver citato quei due celebri articoli che precedono quest’ultima digressione sulla necessità del ricorso alla psicanalisi per la comprensione di Pasolini, luoghi “cruciali”, si diceva, del “Romanzo delle stragi”, come li definì Galli, e che corrispondono molto chiaramente a una posizione antifascista (aggiungendo però che Pasolini distingueva fra un fascismo “archeologico”, che reputava inoffensivo, e un nuovo fascismo tendente al nazismo, il “vero fascismo”, che identificava, come si è detto, con la “civiltà dei consumi”), possiamo infine affermare ora, per quanto ciò possa sorprendere, che egli termina la sua carriera e la sua vita da reazionario, come Dante. Lo provano gli elogi dei fascisti “archeologici” del “Secolo d’Italia”, organo del Msi di allora guidato da Giorgio Almirante, nonché egli stesso in quella misteriosa ammissione scritta nel 1970 che già notammo nella nostra ricerca – «io pronuncio da tanto tempo proposizioni reazionarie» – e di cui, sintomaticamente, Naldini, sempre filologicamente preciso e onesto nella sua biografia del cugino, non ha ritenuto questa volta, forse l’unica, di dover indicare la fonte: questa affermazione importante, rivelatrice, la vedremo incarnarsi estesamente, ad ogni modo, nel protagonista autobiografico del suo ultimo romanzo, benché incompiuto, Petrolio.
Ciò non impedì a Pasolini di esordire nel discorso che avrebbe dovuto pronunciare al congresso del Partito radicale il 4 novembre 1975, se non fosse stato assassinato due giorni prima, con: «Sono qui come marxista che vota per il Pci, e spera molto nella nuova generazione di comunisti» (in Lettere luterane, opera postuma). E, a complicare ancora di più le cose, aggiungiamo che sulla questione della depenalizzazione dell’aborto, grande battaglia combattuta dal Partito radicale in quegli anni, la posizione di Pasolini coincideva con quella della Chiesa cattolica.
Ricordiamo ancora una volta, per concludere, l’interpretazione che abbiamo dato di questo fenomeno sconcertante con le parole di Freud relative al caso dell’“uomo dei topi”, uno dei suoi cinque classici saggi esemplificativi che tratta della nevrosi ossessiva: «egli poteva farsi sostenitore di due diverse concezioni e di due diverse visioni del mondo». S’intende: poteva sostenere qualcosa e anche il suo contrario contemporaneamente in modo alterno. E ricordiamo anche quei due versi alla fine di uno dei suoi ultimi lunghi poemetti, Coccodrillo, di cui abbiamo già parlato, pubblicato in calce all’intervista di Jean Duflot, versi molto rivelatori, divenuti l’epigrafe del nostro lavoro: «egli passò l’esistenza/ diviso esattamente a metà (fu cioè ambiguo)».
 Oltre Freud, contribuisce senza dubbio alla comprensione del caso piuttosto complesso rappresentato dalla vita e l’opera di Pasolini, anche L’io diviso di Ronald David Laing, un magnifico saggio che riuscì a decifrare la schizofrenia come Champollion aveva decifrato i geroglifici egizi, e poi a interpretarla come Freud riuscì a interpretare i sogni. Ma non si dimentichi che si tratta delle stesse argomentazioni che possono essere applicate per spiegare anche la schizofrenia del borghese-comunista, una specie umana praticamente estinta in Italia e in Francia, o quasi; così come la schizofrenia del cattolico a-evangelico, una specie molto più tenace, verosimilmente, e ancora molto diffusa, sicuramente in virtù della longevità ultra millenaria delle sue ricche e potenti istituzioni che la perpetuano, si potrebbe forse dire, ormai, filogeneticamente. Fenomeni di cui, nella sua analisi della società italiana, come abbiamo visto, Pasolini, che li conosceva entrambi perfettamente, si è occupato molto, e li ha mostrati anche interpretandoli in prima persona e quindi riflettendoli nella sua mise en abyme esistenziale. Nonché, più in generale, si tratta di quella stessa schizofrenia umana dello “sviluppo senza progresso”, nel suo “folle volo” dantesco di perseguire «l’industrializzazione totale del pianeta», com’egli diceva ancora a Duflot, e che a circa mezzo secolo da questa formula “profetica” pasoliniana, essa potrebbe essere oggi aggiornata con, diciamo, «sviluppo disastroso e mortale», dato che questo sviluppo sta portando in effetti alla distruzione del nostro pianeta, cosa che è ormai sotto gli occhi di tutti con il segno inequivocabile del cambiamento climatico, da quel lontano Articolo delle lucciole, pubblicato sul “Corriere della Sera” del 1° febbraio 1975, e che proverebbe che l’umanità stessa – se non tutta, una buona parte di essa –, come Pasolini e Foucault, è manifestamente alla ricerca della propria morte. E in questo senso, sì, in effetti: Siamo tutti in pericolo, e soprattutto le generazioni future.
Oltre Freud, contribuisce senza dubbio alla comprensione del caso piuttosto complesso rappresentato dalla vita e l’opera di Pasolini, anche L’io diviso di Ronald David Laing, un magnifico saggio che riuscì a decifrare la schizofrenia come Champollion aveva decifrato i geroglifici egizi, e poi a interpretarla come Freud riuscì a interpretare i sogni. Ma non si dimentichi che si tratta delle stesse argomentazioni che possono essere applicate per spiegare anche la schizofrenia del borghese-comunista, una specie umana praticamente estinta in Italia e in Francia, o quasi; così come la schizofrenia del cattolico a-evangelico, una specie molto più tenace, verosimilmente, e ancora molto diffusa, sicuramente in virtù della longevità ultra millenaria delle sue ricche e potenti istituzioni che la perpetuano, si potrebbe forse dire, ormai, filogeneticamente. Fenomeni di cui, nella sua analisi della società italiana, come abbiamo visto, Pasolini, che li conosceva entrambi perfettamente, si è occupato molto, e li ha mostrati anche interpretandoli in prima persona e quindi riflettendoli nella sua mise en abyme esistenziale. Nonché, più in generale, si tratta di quella stessa schizofrenia umana dello “sviluppo senza progresso”, nel suo “folle volo” dantesco di perseguire «l’industrializzazione totale del pianeta», com’egli diceva ancora a Duflot, e che a circa mezzo secolo da questa formula “profetica” pasoliniana, essa potrebbe essere oggi aggiornata con, diciamo, «sviluppo disastroso e mortale», dato che questo sviluppo sta portando in effetti alla distruzione del nostro pianeta, cosa che è ormai sotto gli occhi di tutti con il segno inequivocabile del cambiamento climatico, da quel lontano Articolo delle lucciole, pubblicato sul “Corriere della Sera” del 1° febbraio 1975, e che proverebbe che l’umanità stessa – se non tutta, una buona parte di essa –, come Pasolini e Foucault, è manifestamente alla ricerca della propria morte. E in questo senso, sì, in effetti: Siamo tutti in pericolo, e soprattutto le generazioni future.
Anche senza quest’ulteriore approfondimento del saggio di Laing o di altri studi psicanalitici, tuttavia, mi pare, come ho già ripetuto più volte, che l’insieme dei casi sconcertanti della biografia e dell’opera di Pasolini sia stato spiegato a sufficienza, per l’essenziale e nelle loro linee generali, nella nostra analisi. La quale, passo dopo passo, ha ripercorso il cammino, oltre che della sua biografia e delle sue letture freudiane e gramsciane e di altri testi fondamentali nella sua formazione, anche quello dei suoi ultimi tumultuosi anni, cogliendo le tracce più significative e utili alla nostra interpretazione da lui disseminate nelle sue opere – soprattutto nell’ultima, Petrolio. In effetti, a patto che si fossero davvero seguiti i suoi passi – e questo è stato il nostro metodo di lavoro che ha escluso ogni volo pindarico in cui si tratta alla fine più del critico stesso o della sua ideologia, come si è detto, che del suo oggetto di ricerca, come spesso è avvenuto e avviene –, si sono raccolte quelle tracce concrete che ci potevano fornire la più profonda chiave di lettura possibile. Una chiave di lettura che è parsa, a volte, quasi pedagogicamente guidata, direi, per le solite ragioni narcisistiche, o, diciamo, “autorizzata” da Pasolini stesso: sia della sua personalità (di cui egli parlava e scriveva molto frequentemente e mai in modo superficiale per, ripetiamolo ancora, l’evidente e incontrollabile bisogno narcisistico che lo caratterizzava, come ne è stato dato ancora un ennesimo esempio poco sopra), sia della sua opera, la cui straordinarietà nell’ambito del suo secolo, e non solo, sarà, io credo, sempre più evidente col passare del tempo.
Dialoghi Mediterranei, n. 61, maggio 2023
[*] Il testo è stato scritto come postfazione alla edizione italiana di Pasolini, l’intellectuel: critique littéraire etécrits politiques, mai pubblicata (Mazraya, 31 dicembre 2021).
Note
[1] Sempre tenendo conto delle giuste proporzioni con Hobsbawm, il rifiuto della mia ricerca da parte dell’ambiente accademico francese fu allo stesso modo totale, come lo era stato per Il secolo breve, sia da parte della destra che della variegata, sedicente sinistra, come potei leggere nei numerosi rapporti negativi degli esaminatori che giustificavano il loro rifiuto. Devo aggiungere che nemmeno in Italia, nonostante il riconoscimento del “Premio Pasolini”, (con una giuria composta da Mino Argenteri, Alberto Asor Rosa, Fernando Bandini, Giovanni Berlinguer, Mario Lavagetto, Giacomo Marramao, Lino Micciché, Stefano Rodotà, Walter Siti, Giovanni Spagnoletti, Paolo Terni; e presieduta, come si è detto, da Tullio De Mauro), il mio lavoro ebbe una considerazione maggiore finché, recentemente, non è stato segnalato dalla Biblioteca digitale dell’Archiginnasio di Bologna nella bibliografia della sua mostra dedicata al giovane Pasolini bolognese, per la qual cosa ringrazio qui la Direzione, che ha inoltre facilitato questa pubblicazione.
[2] Un episodio, per chi vuol vederlo, ripreso nel film di Marco Tullio Giordana, Pasolini, un delitto italiano, del 1995, che nella versione francese era diventato appunto Pasolini, mort d’un poète.
[3] Come avverrà ancora, per esempio (giusto per ricordare il clima politico-morale dei tempi in Italia), dieci anni più tardi, nel 1972, a Bertolucci per Ultimo tango a Parigi: film, com’è noto, condannato, sequestrato e distrutto in Italia, mentre all’estero era possibile vederlo liberamente, quando in seguito a quest’altra nuova condanna di un regista cinematografico italiano di fama internazionale, Bertolucci fu privato per anni persino del diritto di voto.
[4] Cfr. Aa. Vv., Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte
[5] cfr. per esempio, Il Pci ai giovani!.
[6] In Notes of a Dirty Old Man, pubblicato nel 1969 dalla City Lights Books di Lawrence Ferlinghetti, volume che raccoglieva articoli e racconti già pubblicati in varie riviste underground americane.
[7] in Shakespeare Never Did This, opera ancora edita da Ferlinghetti nel 1979.
[8] E molti altri prima di lui; ricordiamo velocemente: Henry Miller, Jack Kerouac e la beat generation, Allen Ginsberg, il cui Howl and Other Poems, che si apriva con “Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia”, sempre pubblicato da Ferlinghetti nel 1956, nell’America fascista di Joseph McCarthy, valse la prigione anche all’editore, oltre a una detenzione in manicomio all’autore.
[9] Si tratta di quel che in psicanalisi è definito come “razionalizzazione” di fatti irrazionali: argomentazioni logiche a premesse non-logiche. Per esempio, in un tutt’altro contesto: Dante che ci spiega nel De vulgari eloquentia, razionalmente e con sicurezza assoluta, quale fu la prima parola pronunciata da Adamo, nonché, con la stessa perentorietà, la natura specifica della comunicazione degli angeli e dei demoni, e molti altri fatti linguistico-religiosi di questo genere: dal discorso del serpente che tentò Eva e a quelli dell’asina di Balaam, fino a quelli della torre di Babele dopo la punizione divina, eccetera, come se egli avesse sperimentato personalmente tutto questo e ciò avesse una realtà oggettiva indiscutibile, non solo per lui, ma per tutti coloro che lo leggono. È ovvio che queste razionalizzazioni possono essere condivise invece soltanto da chi ha la stessa conformazione mentale dell’autore e non da chi non ce l’ha, che le ritiene per questo, diciamo, soggettive (peggio, in realtà).
[10] Difatti, un’altra perla del nostro Ždanov junior, anzi, la primissima, nella suddetta discussione della tesi, fu di dichiarare immediatamente, in modo sintomatico, la sua totale estraneità alla psicanalisi, come se averne avuto anche soltanto minime nozioni sarebbe stato per lui qualcosa di molto vergognoso, con la tipica ottusità dello stalinista che, come Pasolini non si stancava di denunciare, scambiava l’irrazionalità umana con il decadentismo, rimanendo oltretutto vittima della propria irrazionalità. Né più né meno di come avrebbe potuto fare una bigotta zitella cattolica. E si capisce: marxismo, fascismo e cattolicesimo, cui Michel David aggiungeva l’idealismo liberale, ossia il crocianesimo, come egli dimostrò in La psicanalisi nella cultura italiana (Bollati Boringhieri 1990), furono – e ancora sono, di quel che resta – i principali fattori di resistenza alla diffusione della psicanalisi in Italia. Credendo fermamente ai dogmi delle loro fedi rispettive, stalinisti, fascisti e cattolici pensano, senza alcun sospetto di ridicolo, di essere veramente in grado di spiegare tutta la realtà; e i cattolici arrivano addirittura a spiegare e persino a descrivere anche l’al di là: ils ont tout compris, insomma, una volta per tutte. E beati i dogmatici che credono davvero di aver capito tutto… Da cui però – con il loro rifiuto della psicanalisi e dunque, per il nostro caso, il precludersi la possibilità di una profonda comprensione di Pasolini, limitandosi a constatare la sua distanza dalle rispettive fedi – una critica da bollettini di sezione di partito o di parrocchia, ossia molto provincialmente ideologica e ingenua, superficiale, rozza, che non dice granché sull’autore e la sua opera come realmente sono nella loro complessità, qualcosa che risulta essere estraneo e troppo “imbarazzante” per i loro dogmi rassicuranti.
________________________________________________________
Giuseppe Pera, ha insegnato lingua, letteratura e civiltà italiana in varie università francesi e tunisine, nonché all’Università e all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Ha pubblicato in francese Pier Paolo Pasolini, l’intellectuel: critique littéraire et écrits politiques (1940-1960), Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq 1999. Altri saggi: Terzo millennio; Dantes noster est!. Si è occupato anche di letteratura nordamericana con un saggio su Charles Bukowski.
______________________________________________________________