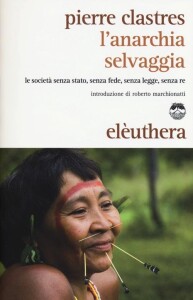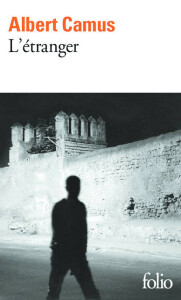di Alberto Giovanni Biuso
In questo testo tenterò una lettura anarchica del principio monarchico. A questo scopo inserirò l’incoronazione di Carlo III Windsor, avvenuta il 6 maggio 2023, all’interno della dialettica tra potentia e potestas. La tradizione dinastica è infatti espressione di tre degli elementi che innervano tale dialettica nel XXI secolo: la forza dei costumi, la natura gregaria delle società, il Nomos della Terra nato nel 1945 dalla vittoria anglosassone e che sta mostrando con sempre maggiore chiarezza la propria crisi.
Una premessa cinematografico-imperiale
Il film di Stephen Frears The Queen (GB, 2006) consiste anche in un triangolo che ha ai suoi vertici Elisabetta II, Diana Spencer, Tony Blair. Tre vertici che sono tre forme del potere.
Elisabetta è la tradizione, la storia, la freddezza e la misura.
Diana Spencer è la pura finzione di un’icona creata dalla macchina stritolatrice della comunicazione di massa.
Tony Blair è il cinismo di chi in nulla crede se non al narcisismo del proprio ombelico.
Il film fa interagire queste forme nel momento in cui la quarta modalità del potere – la folla che grida “santo subito” a ogni personaggio finto e celebre che muore – reclama per sé la scena, nel bisogno di consegnare la propria identità a un vip, il proprio tempo alla televisione e il proprio pensiero al nulla.
A questa rappresentazione si può da qualche mese aggiungere Carlo III Windsor, che nella sua attempata giovinezza di erede al trono del Regno Unito rappresenta una forma d’autorità che può apparire ed è malinconica e declinante ma che mostra anche e ancora una volta la tenacia dei simboli, la costanza della servitude volontaire analizzata da Étienne de La Boétie.
Se la servitù appare così spesso “volontaria” è anche perché essa si radica nella necessità della salvaguardia dei corpi individuali e collettivi. Salvaguardia certo apparente, visto che il potere è per sua natura una macchina violenta il cui obiettivo non è la salute del corpo sociale ma la perpetuazione degli organi di dominio. Proprio per questo la riflessione politica e filosofica sui dispositivi sociali ha il compito di individuare la struttura storica del potere come potestas separandola dalla inevitabilità biologica – e quindi naturale e non volontaristica – del potere come potentia.
Un sovrano poco malinconico e per nulla patetico fu Federico II di Svevia, Stupor Mundi e mito ancora operante nella storia d’Europa. E tuttavia la dimensione innovatrice del regno di Federico rimane inseparabile dalla parola fondamentale dell’istituzione monarchica in Europa: la tradizione.
E infatti David Abulafia identifica le cose migliori del governo di Federico in ciò che esso seppe assimilare dalla tradizione, in particolare normanna. Precisamente, furono eredità degli Altavilla «il fiscalismo e la concezione del re come erede del princeps romano» [1]. Lo storico sintetizza il senso della politica di Federico nell’aggettivo «dinastica» [2], vale a dire l’orgoglio del potere pervenuto tramite i nonni Barbarossa e Ruggero II e la preoccupazione di trasmetterlo intatto e accresciuto agli eredi Hohenstaufen. Un’intenzione coerentemente medioevale.
Sono comunque evidenti anche le differenze fra la concezione e la pratica del potere monarchico nel Medioevo e quella dei secoli successivi, sino alla contemporaneità di Carlo III Windsor. E questo non a favore dell’autorità di Federico ma di quella più solida dei sovrani costituzionali.
Rispetto a qualunque sovrano nazionale e territoriale dell’Europa moderna e contemporanea, e anche rispetto al potere di controllo degli esecutivi repubblicani e democratici, l’autorità di un Imperatore pur ricchissimo di carisma – quale Federico fu – si riduce infatti a poca cosa. Essa è teoreticamente vastissima, di fatto limitata, esautorata, annullata da una miriade di poteri locali a volte collaboranti in vista di esenzioni e privilegi, più spesso operanti al fine di ottenere la più ampia autonomia amministrativa e indipendenza politica.
Vige per Federico II e vige per tutti i sovrani – anche per colei che si è rivelata alla fine sorprendentemente mortale, la madre di Carlo III – la necessità di allontanarsi dal mito di un sovrano quale «non vi è stato né vi sarà» [3] e cogliere invece la monarchia nella sua forza simbolica e nella sua fragilità dinastica. Nulla infatti può garantire che dal corpo del Re non scaturisca un erede del tutto alieno rispetto alla funzione che la nascita gli avrebbe assegnato. Per meglio comprendere questa forza e questa fragilità possiamo appunto ricordare la distinzione tra potentia e potestas, elemento centrale anche in una prospettiva libertaria.
In tutte le società si manifesta la lotta per il potere poiché esso consiste semplicemente nella potentia, vale a dire nella capacità di ottenere ciò che si desidera dai comportamenti altrui, capacità non soltanto inestirpabile ma anche portatrice di dinamismo e cambiamenti. E quindi «persino l’anarchico riconosce che esistono ambiti per un’autorità legittima» [4], un’autorità condivisa, orizzontale, provvisoria, limitata.
Il potere è inevitabile, il conflitto è inevitabile. Non esistono società senza potere né società senza guerra. Meno che mai le società primitive sono senza potere e senza guerra. E tuttavia ‘i selvaggi’ vivono senza Stato, senza fedi trascendenti e assolute, senza legge, senza re. Com’è possibile? Il contributo etnologico di Pierre Clastres è fondamentale perché spiega con chiarezza la Differenza: la differenza tra il potere e lo Stato, la differenza tra la guerra e il dominio, la differenza tra le società indivise e le società costruite sull’Uno.
Nelle società indivise (‘primitive’) chi e che cosa è il capo? Il capo è qualcuno che anzitutto deve possedere talento oratorio e generosità. La prima qualità gli serve per fare da portavoce della comunità. La seconda qualità è necessaria poiché «il big man lavora, letteralmente, per la gloria, e la società gliela concede volentieri occupata com’è ad assaporare i frutti del lavoro del capo. Gli adulatori vivono a spese degli adulati» [5]. Vige qui un dispositivo inverso rispetto alla società dello Stato, nella quale il capo raccoglie e utilizza il frutto del lavoro dei sottoposti, un dispositivo che Clastres definisce del debito.
Se il capo è in debito con la società, quella è una società indivisa – senza Stato –, se invece la società è in debito con il capo, vuol dire che si è prodotta la scissione tra dominanti e dominati ed è quindi nata la società dello Stato. Per comprendere la struttura delle società primitive è quindi indispensabile non confondere il potere con il prestigio, errore in cui incorrono molti studi etnologici, e non essi soltanto.
Le società tribali possiedono antidoti efficaci contro la nascita dello Stato e cioè della divisione all’interno della struttura sociale tra chi comanda e chi obbedisce. Uno dei più universali e costanti è appunto la guerra, con la quale viene garantita la permanenza e la conservazione di una molteplicità di comunità che al loro interno sono indivise anche perché sono nettamente separate dalle altre.
Lo Stato come Identità, la società come Differenza. La società primitiva cerca e vuole, infatti, la frammentazione, la differenza, la dispersione in una varietà di gruppi tra di loro separati e autonomi, viventi su un territorio del quale utilizzano e consumano in modo egualitario le risorse, riconoscendo soltanto il prestigio di un capo lavoratore e donatore, negandogli invece qualunque potere separato dal corpo sociale. La logica della società primitiva è una logica della Differenza, avversa all’Uno e al suo dominio.
Le tradizionali definizioni dell’uomo come animale razionale e sociale vanno integrate da un lato con il riconoscimento della centralità del corpo, dall’altro attribuendogli una più comprensiva e peculiare natura simbolica. Animal symbolicum è l’umano per la sua capacità di rispondere alle sollecitazioni dell’ambiente non solo in forma ricettiva o reattiva; per la possibilità che ha di elaborare un linguaggio non soltanto emotivo ma anche proposizionale; per l’utilizzo dei significati e dei simboli; per la capacità, soprattutto, di costruire qualcosa di irriducibile alla percezione – a ciò che dai sensi è possibile trarre – e che si fonda invece sulla peculiarità umana di creare forme: mito, religione, linguaggio, arte, storia, scienza. La cultura è l’insieme di questi elementi, l’insieme di tali rapporti.
L’essere umano è corpo, azione, esperienza, formazione, cultura. E questo fa sì che un potere esercitato tramite la semplice forza fisica non duri di solito a lungo. Il potere vero è una forma del dominio che si edifica lentamente, a partire da capacità più specifiche quali una particolare conoscenza, l’abilità nel conseguimento degli obiettivi o il carisma personale.
Il potere è nato dall’alveo del sacro e di esso, al di là delle apparenze, ancora si nutre in quasi tutte le società. Le interazioni fra gli individui, le famiglie, i gruppi, le etnie, le corporazioni avvengono infatti all’interno di un campo simbolico che costituisce lo sfondo comune alle fasi di continuità istituzionale come a quelle di rottura e trasformazione.
È chiaro quindi che il potere non si limita alle forme del governo o al solo dominio economico, militare, politico ma pervade di sé ogni relazione umana, nella forma del possesso. La difesa di ciò che si possiede – in primo luogo di ciò che si è, del proprio corpo – caratterizza i viventi in ogni fase, aspetto, momento della scala evolutiva. Ciò che è vivo farà sempre di tutto per vivere ancora, anche al costo di gravi danni inferti ad altri esseri. Il problema politico nasce nel momento in cui a tale ferocia della vita si aggiunge quella propria degli apparati di potere, istituiti non per garantire i propri membri ma per sottometterli.
La società si fonda infatti sui corpi e sul loro bisogno di nutrirsi e di difendersi. Il corpo è sempre sottoposto al rischio di diventare vittima della violenza altrui ma può trasformarsi esso stesso in un’arma tesa a distruggere gli altri. L’insieme dei corpi uniti alla difesa forma la società. Essa nasce insieme ai tabù, ai divieti, alle leggi tese a salvaguardare la comunità umana, a impedire la violenza della condizione di natura. E tuttavia la società genera un ordine che implica anch’esso l’utilizzo sistematico della violenza: «La violenza crea caos e l’ordine crea violenza. Questo dilemma è irrisolvibile» [6]. Il potere, creato per limitare la violenza, a sua volta la moltiplica. Sta anche qui il vicolo cieco della storia umana, per uscire dal quale l’anarchismo è nato.
L’insieme delle tecnologie giuridiche, etiche, religiose, sociali volte a mantenere la violenza sotto controllo è ciò che chiamiamo cultura/civiltà. E tuttavia in nome dei valori – lo Stato, la sicurezza, il dio – la violenza si moltiplica, si radicalizza, giustifica se stessa come strumento del Bene, dell’Unità, della Giustizia.
Il potere è anzitutto il potere di fare, è agire. È un’azione diretta a indurre altri umani a compiere qualcosa o a impedire il loro agire. Intrinseco allo scopo è l’uso della coercizione nei suoi vari gradi, sino alla violenza esplicita. Le sue tre forme principali sono la riduzione dell’integrità sociale, il danneggiamento materiale, l’offesa fisica. Ne vengono dunque coinvolti i simboli relazionali, il possesso dei beni, la corporeità. Essere privati della partecipazione sociale, della sicurezza economica, dell’integrità corporale significa anticipare in forma simbolica la morte. È la paura del morire che sta a fondamento della pervasività del potere.
Ma se questa fosse la sua unica ragione, il potere sarebbe sempre e soltanto espressione del negativo. Sarebbe dunque debole. L’altra sua fonte è la predisposizione degli umani a obbedire, è la natura gregaria della specie. L’autorità si fonda anche e soprattutto sul bisogno del soggetto di essere accettato per il fatto di esistere e di esistere in un certo modo, per il fatto di essere ciò che è. Siamo ai nostri occhi anche quello che pensiamo di essere allo sguardo altrui; allo sguardo soprattutto di quei soggetti e di quelle strutture alle quali riconosciamo – per le ragioni più diverse – prestigio, valore, autorevolezza e forza. Detiene dunque autorità colui che possiede la capacità di indurre altri a determinate azioni poiché essi aspettano da lui il riconoscimento del loro valore.
Al potere/autorità così inteso si affianca il potere/dominio la cui caratteristica prevalente è l’istituzionalizzazione dell’autorità, il ‘monopolio dell’uso della violenza’ all’interno di una comunità. La definizione weberiana dello Stato può dunque essere ampliata a strutture diverse, anche più circoscritte e non soltanto territoriali. Inseparabile dal potere come dominio (e, in parte, anche dal potere come autorità), la violenza costituisce la filigrana dei rapporti umani e, in generale, delle relazioni tra i viventi. Lo sviluppo delle più differenti tecnologie è reso possibile dalla natura tecnica – plasmatrice di forme – dell’umano ed è causa e insieme effetto delle relazioni di potere.
Bisogno di riconoscimento e di autoriconoscimento, esercizio della violenza, strumentazione tecnologica, costituiscono tutte insieme le ragioni e la struttura del potere fra gli esseri umani. Il circolo è inevitabile e vizioso. Sta qui gran parte della tragedia che il potere è: le istituzioni nascono per contenere la violenza ma la violenza è parte essenziale dell’agire istituzionale. La spirale conduce a un susseguirsi della violenza del potere e della violenza dell’opposizione al potere. In ogni caso il significato di questa violenza sta nella struttura semantica del potere, nel «senso grazie all’assenso» delle sue vittime [7]. Il potere non si limita a costituire uno strumento di convivenza tra interessi differenti ma è anche una struttura al servizio di alcuni gruppi contro altri.
Le società umane costituiscono un tutto organico e nello stesso tempo distinto in una molteplicità di forme identitarie che garantiscono la persona sia nel suo bisogno di appartenenza sia nel suo desiderio di autonomia da poteri troppo vasti e forniti di un’eccessiva capacità di controllo.
La difesa della differenza aiuta a evitare sia l’errore globalista/imperialista che vorrebbe erodere le diverse culture e omogeneizzare le comunità sia l’errore nazionalista che respinge pregiudizialmente l’alterità. In ogni caso gli esseri umani non costituiscono soltanto degli astratti citoyens ma sono i rappresentanti di luoghi, tempi, culture e comunità. La continuità nella specie umana fra natura e cultura è profonda. L’evidente specificità di ciò che siamo sgorga dal nostro essere dei viventi che hanno bisogni in gran parte identici o analoghi a quelli di altre entità.
Al di là quindi dei paradigmi novecenteschi, l’ecologia libertaria tenta uno sguardo nuovo sull’abitare la Terra, uno sguardo che rifiuta ogni progressismo ingenuo, liberale o socialista che sia, per affondare nella ricchezza delle tante tradizioni cosmiche, delle millenarie culture che precedono la modernità e sono ancora presenti in molte regioni del pianeta. Quanto tutto questo sia necessario per ogni vero movimento di liberazione è mostrato dal fatto che anche i diritti civili sono diventati un’ideologia al servizio degli eserciti crociati con i quali l’Occidente porta devastazione nelle altre culture e lo fa in nome, appunto, dell’individuo affrancato dagli arcaismi. Chiamano “democrazia” questa rovinosa operazione di distruzione delle comunità e dei corpi. Bisogna quindi liberarsi dal gorgo antico del desiderio gregario, sulla cui natura enigmatica, irrazionale e criminale si sono interrogati, tra gli altri, La Boétie, Spinoza, Reich.
L’opzione anarchica può meglio scaturire da questo pessimismo antropologico piuttosto che dall’ottimismo rousseauiano o di altra natura. Proprio perché la specie Homo sapiens è tra le più violente che si diano in natura, e questo al di là delle variabili e dei caratteri dei singoli, bisogna evitare in tutti i modi che un potere nasca e si consolidi come gestione individuale, familistica, partitica, della struttura sociale collettiva. Soprattutto evitare che si consolidi come struttura dinastica. Meno potere possibile per ciascuno; distribuzione quanto più diffusa, orizzontale e collettiva; eguaglianza dei componenti del corpo sociale nella gestione degli interessi comuni. Questi elementi libertari si giustificano assai meglio se gli umani sono visti come degli organismi pronti al bellum omnium contra omnes che se fondati sull’illusione di una cooperazione tra chi detiene un potere separato e coloro sui quali si esercita il dominio.
L’al di là del bene e del male degli anarchici è stato ben espresso da un libertario come Albert Camus, dal suo essere antinomico, étranger alla Legge, perennemente in rivolta contro di essa, una rivolta che può essere tessuta di suprema indifferenza, come quella di Mersault. Al di là della disperazione, della morte e del nulla, al di là dunque dei modi nei quali l’esistenza è gettata nel mondo, il monologo di Camus si consuma e si chiude con un grido di rivolta tipicamente anarchico, nel quale l’ultima parola – odio – disegna in modo geometrico che cosa la vita sia, che cosa la vita meriti per chi intuisce l’altrove da cui proviene e il nulla nel quale si dissolve:
«Comme si cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuite chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et qui je l’étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine» [8].
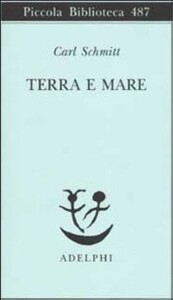 Un Impero marino, una corona usurata
Un Impero marino, una corona usurata
La chiusa de L’étranger racconta di un rito durante il quale un uomo libero conferma la propria differenza anche a costo della vita, mentre sta per essere giustiziato. Un uomo dunque vivo sino all’ultimo. Un altro rito assai più solenne e spettacolare ha designato un maturo signore quale simbolico Dominus della memoria di un Impero che è stato universale ma che in questa sua pretesa ha cercato di nascondere la propria natura di Leviatano marino.
A partire dalle civiltà del Mediterraneo orientale sino a Lepanto (1571), le battaglie navali non furono altro che scontri di fanteria trasferiti sulle tolde delle navi, ma già dalla sconfitta della Armada spagnola nella Manica (1588), con le bocche di fuoco dei cannoni e con i nuovi agili velieri inventati dagli olandesi, lo scontro di mare assunse le sue caratteristiche specifiche, che contribuirono a trasformare gli inglesi, un popolo di allevatori di pecore, nei dominatori del globo.
I pirati, i corsari, gli schiumatori del mare furono tra i protagonisti di una trasformazione radicale con la quale l’Inghilterra trasferì completamente la propria esistenza dall’elemento terrestre a quello marittimo. Un mutamento che fu contemporaneo, e strettamente intrecciato, non solo alle grandi scoperte geografiche, non soltanto alle nuove tecnologie belliche e navali, non solo allo scontro fra cattolicesimo e protestantesimo ma anche alla lotta che oppose il calvinismo “marittimo” al gesuitismo “terrestre”. Integrando e rendendo più plausibile il quadro già delineato da Max Weber, Carl Schmitt scrive che «se invece ci volgiamo al mare, vediamo immediatamente la coincidenza o, se così posso dire, la fratellanza che, nella storia del mondo, unisce il calvinismo politico alle nascenti energie marittime europee» [9].
Con la comparsa dell’Impero marino muta radicalmente il modo di combattersi degli europei (e poi di ogni altro popolo) tra di loro. Nella guerra terrestre a fronteggiarsi in campo aperto sono quasi sempre soltanto le truppe, i soldati, gli armigeri. La guerra marittima, invece, tende a colpire le risorse dell’avversario, a strozzare la sua economia, a cannoneggiare le sue coste e le città, a coinvolgere l’intera popolazione diventata tutta e inevitabilmente ‘nemica’. È la guerra totale, inventata dalla potenza marittima e calvinista inglese. Il suo dominio durò per più di due secoli sino a quando, trasformandosi da “pesce” in “macchina”, con la Rivoluzione industriale la Gran Bretagna sembrò attingere a una potenza incontrastata che invece di fatto rappresentò l’inizio della sua crisi. Con la meccanizzazione vennero meno lo slancio iniziale e il dominio sulle tecniche della navigazione a vela; da allora un’altra e più potente “isola” calvinista si sostituì progressivamente all’antica madrepatria, tanto che agli inizi del Novecento l’ammiraglio americano Mahan poté proporre la riunificazione fra l’Inghilterra e gli Stati Uniti, allo scopo di garantire la perpetuazione del dominio anglo-americano sul mondo.
 La potenza secolare dell’elemento marino – il Leviatano – ha contribuito allo sviluppo dell’aviazione e del fuoco che distrugge dall’alto. I due nuovi elementi, l’aria e il fuoco, delineano un’ulteriore trasformazione tesa al controllo dell’antico elemento terrestre. Il grande uccello mitologico, il Grifo Ziz, combatte per la sottomissione della Terra Behemoth. Nella prima metà del Novecento nacque così, attraverso scontri e distruzioni immani, un nuovo Nomos der Erde, Nomos della Terra, quello che dal 1945 al tempo presente ha controllato il pianeta, sconfiggendo l’Europa continentale, lanciando un fuoco immane e distruttore sul Giappone, imponendo all’intera umanità la globalizzazione dei suoi modelli di vita.
La potenza secolare dell’elemento marino – il Leviatano – ha contribuito allo sviluppo dell’aviazione e del fuoco che distrugge dall’alto. I due nuovi elementi, l’aria e il fuoco, delineano un’ulteriore trasformazione tesa al controllo dell’antico elemento terrestre. Il grande uccello mitologico, il Grifo Ziz, combatte per la sottomissione della Terra Behemoth. Nella prima metà del Novecento nacque così, attraverso scontri e distruzioni immani, un nuovo Nomos der Erde, Nomos della Terra, quello che dal 1945 al tempo presente ha controllato il pianeta, sconfiggendo l’Europa continentale, lanciando un fuoco immane e distruttore sul Giappone, imponendo all’intera umanità la globalizzazione dei suoi modelli di vita.
E tuttavia non sono pochi i segnali che indicano l’esaurirsi anche di questo Nomos. Uno di essi è costituito dalla fastosa e tuttavia malinconica ritualità con la quale una dinastia tormentata da tradimenti, denunce di pedofilia, incidenti mortali di principesse di Galles, conflitti e ostracismi familiari, ha ripetuto la propria incoronazione senza mai un sorriso o un grido come quello di vera gloria dello Straniero.
Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023
Note
[1] D. Abulafia, Federico II. Un imperatore medievale (Frederick II. A medieval emperor, Allen Lane The Penguin Press, London 1988), trad. di G. Mainardi, Einaudi, Torino 2006: 34.
[2] Ivi: 365.
[3] Ivi: 361.
[4] H.B. Barclay, Lo Stato. Breve storia del Leviatano (The State, Freedom Press, 2003), trad. di A. Aureli, Elèuthera, Milano 2013: 20.
[5] P. Clastres, L’anarchia selvaggia. Le società senza Stato, senza fede, senza legge, senza re (Editions du Seuil, 1980), trad. di G. Lagomarsino, Elèuthera, Milano 2013: 106.
[6] W. Sofsky, Saggio sulla violenza (Traktat über die Gewalt, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1996), trad di B. Trapani e L. Lamberti, Einaudi, Torino 1998: 193.
[7] H. Popitz, Fenomenologia del potere (Phänomene der Macht. Autorität – Herrschaft – Gewalt – Technik, J.C.B.Mohr, 1986 – Prozesse der Machtbilding, J. C. B. Mohr, 1968), trad. di P. Volonté, a cura di S. Cremaschi Il Mulino, Bologna 2001: 105.
[8] A. Camus, L’étranger, Gallimard, Paris 2011: 184.
[9] C. Schmitt, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo (Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Klett-Cotta, Stuttgart 1954), trad. di G. Gurisatti, con un saggio di F. Volpi, Adelphi, Milano 2002: 86-87.
_____________________________________________________________
Alberto Giovanni Biuso, professore ordinario di Filosofia teoretica nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, dove insegna Filosofia teoretica, Filosofia delle menti artificiali e Epistemologia. È collaboratore, redattore e membro del Comitato scientifico di numerose riviste italiane ed europee. È direttore scientifico della rivista Vita pensata. Tema privilegiato della sua ricerca è il tempo, in particolare la relazione tra temporalità e metafisica. Si occupa inoltre della mente come dispositivo semantico; della vitalità delle filosofie e delle religioni pagane; delle strutture ontologiche e dei fondamenti politici di Internet; della questione animale come luogo di superamento del paradigma umanistico. Il suo libro più recente è Chronos. Scritti di storia della filosofia (Mimesis, 2023).
______________________________________________________________