Delle poesie di Wisława Szymborska, leggendole, gustandole, meditandole, ci si accorge subito di un importante pondus filosofico. I richiami alla filosofia antica e contemporanea sono evidenti, e basta toccare questo nervo scoperto per far emergere tutta la carica teoretica di questa poetessa. Una produzione abbastanza modesta in termini quantitativi, ma è quanto richiesto al poeta, il quale ha il compito di dire il mondo nelle poche parole che servono a coglierlo e a esprimerlo, senza lungaggini o orpelli di sorta.
Le poesie colpiscono anche per il loro andare oltre i luoghi comuni del sentimento e della storia: si schierano dalla parte del disincanto, di quell’intuizione che sventa i pericoli del moralismo per esprimere con coraggio la realtà dei fatti, anche a costo del doloroso smarrimento. Anche per questo motivo la poetessa si conferma una grande pensatrice, poiché la radicalità dell’atteggiamento filosofico consiste anche nel raggiungere le cose laddove sono cose e assegnare loro l’esatta parola che le comunichi. In questo senso non c’è differenza tra il rigoroso sistema logico e la poesia, poiché entrambe, se indirizzate dall’idea, colgono lo stesso punto nella sua essenza. La poesia, dando la parola al fenomeno, nell’atto di coglierlo al contempo lo rivela nel suo quid più profondo, perché gli fornisce il medium in cui potersi manifestare e venire compreso. La poesia, se è poesia dell’idea, cattura l’essenza e nella stessa circostanza la esprime, in una doppia dinamica di fondazione/scoprimento e di esibizione/rivelazione.
Tra le tante idee oggetto della filosofia scegliamo una delle più potenti e decisive, se vogliamo anche abbastanza scontata considerando che da sempre è anche una delle principali della poesia nel suo senso, per così dire, tradizionale: l’amore. Ma lo facciamo prendendo in esame la parola della poetessa polacca che alla luce di quanto detto finora rappresenta sia la sua messa in discussione sia la sua netta negazione, in funzione di un sentimento amoroso assai lontano dai proclami dell’odierna società dei consumi, della bella apparenza e del buonismo delle emozioni, specie quelle affettive.
Cercheremo quindi di proporre una lettura di Un amore felice (Miłość Szczęśliwa) [1], in cui gran parte di ciò che la cultura occidentale, in uno dei suoi filoni più autorevoli e frequentati, ha suggerito sul tema viene quasi interamente superata, una riflessione radicalmente filosofica che mostra la verità sia dell’amore in quanto tale sia dell’impatto esistenziale che esso comporta nelle nostre vite.
Un amore felice. È normale?
È serio? È utile?
Che se ne fa il mondo di due esseri
che non vedono il mondo?
La prima strofa, come la dichiarazione di un problema e la sua trattazione, inizia con la formulazione delle ipotesi, una serie incalzante di domande che suggeriscono la sua difficoltà e uno spiccato tono contestatore. Il tema è se può esserci un amore felice, che può voler dire molte cose. La prima parte del verso è solo la riscrittura del titolo interrotto bruscamente da un punto, che, senza andare a capo, prosegue con un secco interrogativo: è normale? Il fatto che un amore felice possa esistere sembra non essere argomento di discussione, esso c’è, ed è proprio per il fatto d’esserci che ne possiamo parlare. Semmai, la cosa su cui dobbiamo interrogarci è come esista, in quale ambito, dimensione oggettuale, sfera di pensiero, piano esistenziale. Di quale esistenza si sta parlando? L’amore felice avviene realmente nella vita di due umani, è un oggetto analizzabile? O dobbiamo collocarlo come una pura ipotesi di ragione, un ideale regolativo à la Kant, come idea sulla quale si può discettare, un po’ come quando in matematica si ragiona per assurdo ponendo l’esistenza di un problema impossibile e se ne dimostra appunto l’impossibilità, affermando con ciò la tesi del suo contrario?
È infatti sul piano ideale, dell’essenza, che la Szymborska pone gli interrogativi che danno gli strumenti per poter proseguire con i versi successivi. L’amore felice è un’ipotesi di vita. E se ci affidiamo a cosa il pensiero comune reputa dell’amore felice, dirà che non c’è niente di più grande e più bello che possa mai capitare nella vita, una sorta di argomento ontologico per cui, assodato che l’amore felice esiste realmente e che bisogna perseguirlo per avere una vita piena e vissuta al massimo delle sue possibilità, questa stessa vita come eventualità di felicità esiste assolutamente.
Come il Dio di Anselmo, poiché non può pensarsi una vita più degna di quella caratterizzata dall’amore felice, altrimenti monca e difettosa, tale amore felice deve esistere. La prima strofa mette dunque in questione questa ipotesi, l’esistenza di un’idea rispetto a cui la Szymborska si incarica, e ci incarica in quanto lettori, di riflettere con il rigore tipico della domanda filosofica. Anche se ciascun lettore, nello scrigno più segreto del proprio cuore, sa per sé cosa sia fattualmente un amore felice, a cosa egli vorrebbe che assomigliasse o quale forma desidererebbe che assumesse, non importa in cosa esso consista per la vita individuale.
L’amore felice, qui sta il punto, importa solo ed esclusivamente proprio in quanto idea, ovvero possibilità della massima realizzazione del sé individuale, la disposizione nella quale l’esserci si pone talmente profonda ed essenziale da essere in grado di sollevare la vita dal gravame della sua esistenza e concedere la lievità, la dissoluzione di ogni male: una sensazione di pienezza, espansione e assoluzione capace di far dimenticare il fatto stesso di esistere in quanto avvisaglia della salvezza. L’amore felice è l’idea per cui la morte diviene indifferente e sia l’amore che la felicità, incontrandosi e sciogliendosi l’uno nell’altra, raggiungono un livello di intensità tale da indurre ad affermare che la morte dovrebbe cogliermi in questo momento in cui mai più la felicità potrà essere massima come adesso. Questo riteniamo che sia il tipo ideale di amore contro il quale la contestazione della Szymborska si scaglia duramente.
Difatti, la triade di domande della seconda metà del primo verso e del successivo diventa più semplice. È normale? È serio? È utile? Ammesso dunque che questa idea esista, ci si chiede se sia realmente come la concepiamo, se la sua legge interna sia nel modo in cui l’abbiamo spiegata, o, per meglio dire, se sia da ammettere, come norma o prassi di comportamento esistenziale, nella prospettiva di vita di ciascuno. Ci si chiede se sia serio, cioè, potremmo dire leopardianamente, se realizzi quanto promette [2], se non illuda o menta. E soprattutto ci si chiede se sia utile per la felicità stessa, per l’appagamento esistenziale di cui tutti andiamo alla ricerca costante: se non sia in altri termini, leggendo all’inverso quest’ultimo concetto, dannoso.
 Con una struttura sintattica tipica della sua poesia, quasi uno stilema, la Szymborska introduce il mondo, il massimo contesto in cui l’amore felice e i suoi protagonisti compaiono, il quale figura da punto medio dei versi terzo e quarto in cui prima funge da soggetto e poi da complemento. Riformulando l’ultima domanda con cui la poetessa espone il problema, possiamo dire che due innamorati di un amore felice sono estranei al mondo come il mondo lo è per loro. Il mondo è scenario di scoperta, accade lì dove c’è una coscienza alla quale esso possa accorrere e manifestarsi, in una dinamica fenomenologica in cui il mondo sussiste ma noi ne cogliamo solo il suo darsi a noi come ente di coscienza. Da un punto di vista teoretico, a partire da questi versi densissimi desumiamo che il mondo esiste proprio in ragione del fatto che ci sono le coscienze in cui esso può darsi a conoscere. E dunque, alla lettera, cosa se ne fa il mondo di due esserci che del mondo non hanno interesse, non è intenzione del loro esistere e dunque loro contenuto di pensiero?
Con una struttura sintattica tipica della sua poesia, quasi uno stilema, la Szymborska introduce il mondo, il massimo contesto in cui l’amore felice e i suoi protagonisti compaiono, il quale figura da punto medio dei versi terzo e quarto in cui prima funge da soggetto e poi da complemento. Riformulando l’ultima domanda con cui la poetessa espone il problema, possiamo dire che due innamorati di un amore felice sono estranei al mondo come il mondo lo è per loro. Il mondo è scenario di scoperta, accade lì dove c’è una coscienza alla quale esso possa accorrere e manifestarsi, in una dinamica fenomenologica in cui il mondo sussiste ma noi ne cogliamo solo il suo darsi a noi come ente di coscienza. Da un punto di vista teoretico, a partire da questi versi densissimi desumiamo che il mondo esiste proprio in ragione del fatto che ci sono le coscienze in cui esso può darsi a conoscere. E dunque, alla lettera, cosa se ne fa il mondo di due esserci che del mondo non hanno interesse, non è intenzione del loro esistere e dunque loro contenuto di pensiero?
Traducendo la questione in termini meno teoretici e più quotidiani, l’interrogativo dei versi finali della prima strofa descrive l’incanto in cui vivono due innamorati e la successiva indifferenza verso il mondo circostante poiché il loro mondo, a seguito dell’innamoramento, è diventato per l’uno l’altra, e viceversa. Quando ci si imbatte in qualcuno innamorato è molto comune che si dica che il mondo per lui non esista all’infuori di colui o colei che egli ama. Il mondo esterno smette d’esserci, diventa l’oggetto di una epoché, di una sospensione, per cui il solo mondo a essere interessante, l’unico a continuare a sussistere, è il mondo coincidente con l’innamorato, talché è verso di lui che il mondo esterno converge al punto da far svanire tutto il resto.
È questa dinamica dell’innamoramento, sin dai suoi albori e in uno dei suoi aspetti più radicali, a essere contestata con estrema energia dalla poetessa. Implicitamente, si può cogliere una traccia ulteriore, per la quale il mondo, con le sue bellezze, i suoi enigmi e le sue meraviglie, non merita d’essere accantonato per un solo essere umano. Questo gesto rappresenta infatti anche un crimine di natura ontologica contro il reale, rispetto al quale si abdica e ci si vota totalmente a un essere tutt’altro che esistente, bensì aleatorio e fittizio. L’accadere del mondo nel suo essere più proprio non si compie quando due innamorati giungono al cosiddetto amore felice, essi anzi ne deformano l’essenza per curvarla al raggio infinito e insaziabile del loro desiderio, che ha un’energia smisurata poiché scaturisce dall’immaginazione, che come si sa è fonte inesauribile.
Immaginazione è difatti il concetto-chiave per comprendere alla radice il tenore delle domande della seconda strofa, il loro sostrato comune, la parola che manca per scardinare l’amore felice e che la poetessa lascia al lettore di trovare per convincersi della sua realtà.
Innalzati l’uno verso l’altro senza alcun merito,
i primi qualunque tra un milione, ma convinti
che doveva andare così – in premio di che? Di nulla;
la luce giunge da nessun luogo –
perché proprio su questi, e non su altri?
Ciò offende la giustizia? Sì.
Ciò infrange i princìpi accumulati con cura?
Butta giù la morale dal piedistallo? Sì, infrange e butta giù.
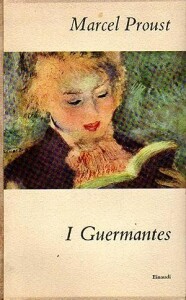 Diciamo immaginazione in riferimento alla poetica proustiana dell’amore, rispetto alla quale la Szymborska non doveva di certo essere insensibile. Il nome di Proust ricorre nel corpus della poetessa, un nome ovviamente troppo celebre per non supporre che non ne conoscesse l’opera o che non l’avesse letta. In una poesia tra le sue ultime, la Szymborska lo cita scopertamente denunciando la futilità dei tempi attuali che non si sognerebbero per niente al mondo di concedersi la lettura del capolavoro proustiano, come si sa un’impresa non facile per un presente sempre più accelerato e sempre meno incline a esperienze di lettura lunghe e faticose. Con dei versi straordinari, sigla la cifra del nostro tempo con la stessa esattezza che noi, uomini del presente, abbiamo perso forse in modo irreversibile: «Viviamo più a lungo, / ma con minor esattezza / e con frasi più brevi» [3]. L’aspettativa di vita è aumentata notevolmente dai tempi in cui Proust è morto, considerando che anche la sua malattia, l’asma, con i sollievi scoperti dalla medicina, la stessa di cui egli in realtà diffidava mortalmente, è ormai divenuta non più tale. Viviamo di più, certo, ma lo facciamo meno esattamente, come se la vita fosse vittima di una fatale sfocatura, una resistente opacità, nei casi più gravi una cecità di principio. Come se insomma mancassero gli strumenti per cogliere e descrivere le cose, che tra l’altro sono i termini con cui abbiamo iniziato questo percorso accanto alla poesia.
Diciamo immaginazione in riferimento alla poetica proustiana dell’amore, rispetto alla quale la Szymborska non doveva di certo essere insensibile. Il nome di Proust ricorre nel corpus della poetessa, un nome ovviamente troppo celebre per non supporre che non ne conoscesse l’opera o che non l’avesse letta. In una poesia tra le sue ultime, la Szymborska lo cita scopertamente denunciando la futilità dei tempi attuali che non si sognerebbero per niente al mondo di concedersi la lettura del capolavoro proustiano, come si sa un’impresa non facile per un presente sempre più accelerato e sempre meno incline a esperienze di lettura lunghe e faticose. Con dei versi straordinari, sigla la cifra del nostro tempo con la stessa esattezza che noi, uomini del presente, abbiamo perso forse in modo irreversibile: «Viviamo più a lungo, / ma con minor esattezza / e con frasi più brevi» [3]. L’aspettativa di vita è aumentata notevolmente dai tempi in cui Proust è morto, considerando che anche la sua malattia, l’asma, con i sollievi scoperti dalla medicina, la stessa di cui egli in realtà diffidava mortalmente, è ormai divenuta non più tale. Viviamo di più, certo, ma lo facciamo meno esattamente, come se la vita fosse vittima di una fatale sfocatura, una resistente opacità, nei casi più gravi una cecità di principio. Come se insomma mancassero gli strumenti per cogliere e descrivere le cose, che tra l’altro sono i termini con cui abbiamo iniziato questo percorso accanto alla poesia.
È a un vuoto di parole che la Szymborska si riferisce, al loro venire meno nel corso della vita e del pensiero, giacché, come afferma, la vita si è allungata ma le frasi si sono ristrette. Le frasi in cui Proust aveva riposto la sua intera arte, frasi vertiginosamente lunghe, talmente estese da farci dimenticare persino come sono iniziate, ma che nel loro esser-così, nella loro meravigliosa cesellatura e sinuosità, riescono a offrirci le lenti giuste, appunto le lenti esatte con cui vedere rettamente in noi stessi e il mondo.
Ebbene, se la letteratura è questa operazione di chiarità e l’ermeneutica è un’interrogazione dell’opacità (del resto in claris non fit interpretatio), lo stesso principio può applicarsi al tema specifico di questa poesia. L’immaginazione infatti, nell’ottica proustiana, non soltanto offusca il soggetto il cui desiderio si indirizza verso una persona più o meno qualunque, ma crea il suo oggetto. Sono tante le metafore che potremmo utilizzare per spiegare questo concetto: dal ramoscello stendhaliano delle miniere di Salisburgo che si abbellisce di cristalli [4], divenendo da cosa qualunque un oggetto esteticamente migliore e prezioso, all’immagine proustiana della bambola che noi stessi ci costruiamo quando ci innamoriamo [5]. In sintesi, l’innamoramento consiste nella proiezione dei desideri del soggetto su un oggetto bruto che gli fornisce in modo totalmente accidentale e involontario il sostrato su cui impiantarsi, desideri che non sono altro che espressioni del volere individuale e riflessi di quanto può rendere felici e sollevare, come detto, sia dal gravame dell’esistenza sia dalla paura della morte. Se si ama la lingua francese, sarà più probabile che ci si innamorerà di qualcuno che la conosca, se si ama l’arte si farà lo stesso con qualcuno che la ami a sua volta, se si ama la musica classica ugualmente. Nella variabilità estrema delle condizioni, come afferma Proust, basta che si ascolti un racconto di lode sul conto di qualcuno che non abbiamo mai visto per mettere in moto l’immaginazione, che sicuramente lo renderà migliore di quanto egli non sia.
 È su questo sfondo che suggerisco di leggere la strofa, intrisa di concezione proustiana del sentimento amoroso. I due innamorati, senza avere alcun merito, qualità, bravura o talento, sono entrambi innalzati dalla superficie per via del sentimento che essi nutrono a vicenda, sorretto come indicato dal costrutto immaginazione/desiderio/idealizzazione. Oggetti qualunque su cui il sentimento quindi si posa, tuttavia nell’errata convinzione che così doveva andare, che ciò che essi provano l’un l’altra è genuino, il frutto di un incanto divino e per questa ragione assolutamente intangibile. Si chiede allora la Szymborska, con una tagliente ironia: perché proprio loro? Perché ci si innamora di quelle persone invece che di altre, possibilmente più meritevoli di quelle di cui invece ci si accontenta in ragione del sentimento falso e menzognero che si prova per loro? La poetessa solleva le domande e rimette a noi la risposta, che qui abbiamo cercato di strutturare a partire dalla fenomenologia di Proust sull’amore, al punto che tali quesiti avrebbero potuto benissimo trovare posto nella Recherche. La dinamica dell’amore felice offende persino la giustizia, e anche qui potremmo suggerire una risposta proustiana, perché quando si è innamorati in modo inspiegabile di una persona specifica, si commette il grave errore, nonché il gran peccato, di diventare indifferenti a tutte le altre più belle, capaci, intelligenti e interessanti in cui potremmo imbatterci se non fosse per la cecità di cui ci si ammala quando ci si ammala d’amore.
È su questo sfondo che suggerisco di leggere la strofa, intrisa di concezione proustiana del sentimento amoroso. I due innamorati, senza avere alcun merito, qualità, bravura o talento, sono entrambi innalzati dalla superficie per via del sentimento che essi nutrono a vicenda, sorretto come indicato dal costrutto immaginazione/desiderio/idealizzazione. Oggetti qualunque su cui il sentimento quindi si posa, tuttavia nell’errata convinzione che così doveva andare, che ciò che essi provano l’un l’altra è genuino, il frutto di un incanto divino e per questa ragione assolutamente intangibile. Si chiede allora la Szymborska, con una tagliente ironia: perché proprio loro? Perché ci si innamora di quelle persone invece che di altre, possibilmente più meritevoli di quelle di cui invece ci si accontenta in ragione del sentimento falso e menzognero che si prova per loro? La poetessa solleva le domande e rimette a noi la risposta, che qui abbiamo cercato di strutturare a partire dalla fenomenologia di Proust sull’amore, al punto che tali quesiti avrebbero potuto benissimo trovare posto nella Recherche. La dinamica dell’amore felice offende persino la giustizia, e anche qui potremmo suggerire una risposta proustiana, perché quando si è innamorati in modo inspiegabile di una persona specifica, si commette il grave errore, nonché il gran peccato, di diventare indifferenti a tutte le altre più belle, capaci, intelligenti e interessanti in cui potremmo imbatterci se non fosse per la cecità di cui ci si ammala quando ci si ammala d’amore.
Guardate i due felici:
se almeno dissimulassero un po’,
si fingessero depressi, confortando così gli amici!
Sentite come ridono – è un insulto.
In che lingua parlano – comprensibile all’apparenza.
E tutte quelle loro cerimonie, smancerie,
quei bizzarri doveri reciproci che s’inventano –
sembra un complotto contro l’umanità!
La terza strofa è invece la descrizione più chiara di un abominio. L’abominio ontologico, sentimentale e umano che rappresenta l’amore felice quando ingabbia due umani. La poetessa induce a osservarli con attenzione. L’essere innamorati felici è, nei confronti di coloro che non lo sono, una mancanza di rispetto, essere irriguardosi fino allo sprezzo. Accecati come sono dal sentimento che provano, che li ha inghiottiti fino a divorarli completamente, insensibili e indifferenti al mondo, non si curano di ciò che la loro felicità presunta determina in chi li guarda. La poetessa non legge lo sguardo altrui in quanto invidioso, come ha ben spiegato Spinoza nell’Etica [6] la tristezza data per una letizia che si riferisce a un bene che altri possiedono. Essendo uno stato miracoloso dell’esserci, talmente raro da apparire come la concessione di un Dio, il male compiuto non risiede in coloro che ne sono privi, bensì in chi è innamorato, un atto assolutamente intollerabile. Gli innamorati dell’amore felice sono infatti l’emblema del più completo egoismo. E questo è perfettamente in linea con quanto si diceva all’inizio riguardo al non esser più del mondo per gli innamorati, poiché da questo mondo smettono d’essere anche gli amici, le persone più fidate che piombano nell’oblio sentimentale, essendo infatti pieni soltanto del sentimento che provano verso il loro oggetto di elezione casuale. La loro felicità, insomma, è un torto schiaffato in faccia alla tristezza generale in cui vivono gli umani, allo stesso modo di qualcuno che divora il suo lauto pasto al cospetto di una giuria di affamati.
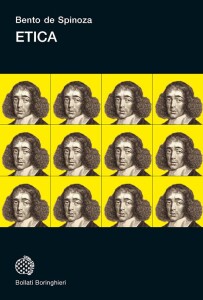 Capiamo allora che non è soltanto la prassi del comportamento amoroso a essere insopportabile, ma l’amore in sé, tant’è che la poetessa, senza usare mezzi termini, lo definisce un complotto contro l’umanità. È questa una delle parole che colgono e rivelano essenzialmente a proposito di quanto si diceva sul potere definitorio ed espressivo che detiene la poesia: è il λόγος esatto che cercavamo affinché l’idea di amore infelice si dotasse di un corrispettivo che la rendesse manifesta e chiara alla comprensione. L’amore in generale, e quello felice in particolare, è quindi un complotto architettato ai danni della vita stessa, l’illusione di una felicità che accresce in maniera criminosa l’attaccamento a qualcosa che non merita nessuna cura, bensì soltanto biasimo e calunnia. La visione di un amore felice è allora insostenibile allo sguardo. Ed è una congiura così in piena regola che pur consapevoli della sua irrealtà non ci si priverà mai della possibilità di credere in esso come acme della vita.
Capiamo allora che non è soltanto la prassi del comportamento amoroso a essere insopportabile, ma l’amore in sé, tant’è che la poetessa, senza usare mezzi termini, lo definisce un complotto contro l’umanità. È questa una delle parole che colgono e rivelano essenzialmente a proposito di quanto si diceva sul potere definitorio ed espressivo che detiene la poesia: è il λόγος esatto che cercavamo affinché l’idea di amore infelice si dotasse di un corrispettivo che la rendesse manifesta e chiara alla comprensione. L’amore in generale, e quello felice in particolare, è quindi un complotto architettato ai danni della vita stessa, l’illusione di una felicità che accresce in maniera criminosa l’attaccamento a qualcosa che non merita nessuna cura, bensì soltanto biasimo e calunnia. La visione di un amore felice è allora insostenibile allo sguardo. Ed è una congiura così in piena regola che pur consapevoli della sua irrealtà non ci si priverà mai della possibilità di credere in esso come acme della vita.
La contro-domanda più facile da formulare, giunti a questo punto, è delle più ovvie, e il solo fatto di porla ne conferma la natura: e se fossi anch’io così miracolato che un amore felice possa accadermi? Al cuore di questa domanda, a nostro parere, si trovano le ragioni del cuore stesso, delle sue speranze, dei suoi desideri e infine dei suoi malanni. È una domanda certamente legittima data l’impostazione del nostro discorso, ma naturalmente non è quella posta dalla poesia o a cui cerca di rispondere.
È difficile immaginare dove si finirebbe
se il loro esempio fosse imitabile.
Su cosa potrebbero contare religioni, poesie,
di che ci si ricorderebbe, a che si rinuncerebbe,
chi vorrebbe restare più nel cerchio?
 Quello che è certo, leggendo la quarta strofa, è che nonostante il contenuto della domanda sia suadente e fascinoso, e gli innamorati si mostrino, pensando anche al Rilke delle Duinesi [7], come paradigma di felicità assoluta e quindi di salvezza, l’idea dell’amore felice è quanto di più distante bisogna tenere nell’esistenza. La poetessa ne fa addirittura una questione di salute, un problema dell’intera umanità. Cosa accadrebbe se tutti fossero devoti all’amore felice? Ancorché nella palese impossibilità che possa realizzarsi per tutti, c’è da dubitare seriamente che la felicità farà il proprio ingresso definitivo nel mondo. Ma se anche dovesse accadere, sparirebbero sur le champ le attese e le speranze per l’aldilà di cui le religioni sono custodi, sparirebbe la poesia in quanto atteggiamento dell’umano verso la verità e l’emozione, sparirebbero i ricordi e le civiltà. Sparirebbe infine l’idea di umanità in quanto tale. L’amore felice riempirebbe ogni essere riducendolo a uno stato di ebetudine perenne, di inguaribile ottusità. Per non parlare, cosa più importante, di coloro che posseduti dalla smania di volerli imitare dovessero fallire nel tentativo, facendo con ciò dell’amore felice una cosa infelice. Perché se si guarda all’amore nel modo in cui la poetessa suggerisce di fare, con l’invito molto saggio a diffidarne e a restarne lontani, se invece testardamente ci si accosta a esso credendo nella sua bontà, il rischio, anziché di elevarsi, è quello di affondare, con tutte le disperate conseguenze che si conoscono, molto di più rispetto all’illusione della sua riuscita, illusione che non è altro che l’ennesimo parto mostruoso di immaginazione e desiderio.
Quello che è certo, leggendo la quarta strofa, è che nonostante il contenuto della domanda sia suadente e fascinoso, e gli innamorati si mostrino, pensando anche al Rilke delle Duinesi [7], come paradigma di felicità assoluta e quindi di salvezza, l’idea dell’amore felice è quanto di più distante bisogna tenere nell’esistenza. La poetessa ne fa addirittura una questione di salute, un problema dell’intera umanità. Cosa accadrebbe se tutti fossero devoti all’amore felice? Ancorché nella palese impossibilità che possa realizzarsi per tutti, c’è da dubitare seriamente che la felicità farà il proprio ingresso definitivo nel mondo. Ma se anche dovesse accadere, sparirebbero sur le champ le attese e le speranze per l’aldilà di cui le religioni sono custodi, sparirebbe la poesia in quanto atteggiamento dell’umano verso la verità e l’emozione, sparirebbero i ricordi e le civiltà. Sparirebbe infine l’idea di umanità in quanto tale. L’amore felice riempirebbe ogni essere riducendolo a uno stato di ebetudine perenne, di inguaribile ottusità. Per non parlare, cosa più importante, di coloro che posseduti dalla smania di volerli imitare dovessero fallire nel tentativo, facendo con ciò dell’amore felice una cosa infelice. Perché se si guarda all’amore nel modo in cui la poetessa suggerisce di fare, con l’invito molto saggio a diffidarne e a restarne lontani, se invece testardamente ci si accosta a esso credendo nella sua bontà, il rischio, anziché di elevarsi, è quello di affondare, con tutte le disperate conseguenze che si conoscono, molto di più rispetto all’illusione della sua riuscita, illusione che non è altro che l’ennesimo parto mostruoso di immaginazione e desiderio.
Un amore felice. Ma è necessario?
Il tatto e la ragione impongono di tacerne
come d’uno scandalo nelle alte sfere della Vita.
Magnifici pargoli nascono senza il suo aiuto.
Mai e poi mai riuscirebbe a popolare la terra,
capita, in fondo, di rado.
Chi non conosce l’amore felice
dica pure che in nessun luogo esiste l’amore felice.
Il carattere argomentativo della poesia riprende in prossimità della conclusione, nella penultima strofa. La struttura del primo verso è uguale all’incipit. Insieme alla normalità, serietà e utilità, la poetessa aggiunge la necessità, se un amore felice sia necessario alla vita, al raggiungimento di quanto si è detto riguardo alla salvezza e all’assoluzione dell’esistenza nella realizzazione della sua pienezza. I sensi e l’intelletto, la cura verso se stessi e la ragione impongono di non parlarne, di non farne argomento e di non includerlo tra le occupazioni esistenziali. L’amore felice, come un Dio che si sia fatto uomo per la redenzione dell’umanità che aveva peccato contro di lui scegliendo la conoscenza, con un’altra parola densissima è definito dalla poetessa scandaloso. È uno scandalo, qualcosa che eccede la natura delle cose, le loro leggi interne e la pietà verso gli umani e il loro dolore. Qualcosa che pur appartenendo alla Vita la Vita non sopporta, lì dove la Vita è se stessa, nelle sue alte sfere, nelle sue ragioni più essenziali e profonde, nella compassione che le si deve per continuare a essere, in altre parole per continuare a vivere. La ratio biologica degli enti viventi, quella meramente procreativa, avviene ugualmente anche senza che l’amore felice intervenga a porre il suo falso sigillo su una coppia di amanti.
E infatti è anche scandaloso poiché è difficile, se non proprio impossibile, che da una coppia posseduta dall’amore felice nascano dei figli, che essi in generale siano il coronamento, come spesso si dice, di una relazione tenuta insieme dal sentimento che entrambi provano l’uno per l’altra. L’ironia della Szymborska nel verso successivo diviene come non mai tagliente, reale: se dovesse essere l’amore felice la condizione di possibilità di ogni procreazione, la Terra resterebbe spopolata, essendo, dopotutto, assai raro che qualcosa di simile accada.
Eppure non è questa un’ottima ragione per continuare a insistere nel contrario che la poetessa afferma, inseguire questo sogno chimerico di quanto meravigliosa debba divenire l’esistenza e quelle che ancora verranno se l’amore felice accade? Non è anzi la ragione decisiva che si cercava per mettersi in cammino verso questa condizione esistenziale? È possibile, come del resto sapeva anche Proust, che questo ideale sia talmente radicato nell’indole umana da essere inestirpabile, che si tratta invero di un percorso di verità il quale, benché grandi maestri e conoscitori della vita avvertano con rigore e precisione concettuale, deve percorrersi per conoscere il fondo di se stessi, dell’esistenza e dell’enigma generale che è l’essere venuti al mondo. È curioso che a queste stesse conclusioni siano giunti filosofi, scrittori e poeti che reputavano l’amore felice nel suo aspetto erroneo, credendo che fosse realmente quanto prometteva, e che poi sono migrati verso l’opinione esattamente opposta avendo conosciuto il suo lato veritiero, quello appunto del dolore, della menzogna e della pena.
Si trascorre un’intera vita nella speranza che un simile amore possa accadere e travolgerci, che la persona che si ama, proprio quella, risponda al sentimento che si prova per lei con la sola parola che può dare grazia e benedizione, il suo dir di sì alla domanda di senso per cui ci si illude che in lei possa risolversi totalmente. Si può anche conoscerlo per la durata di un unico istante, uno sfuggente e tuttavia pienissimo καιρός mistico, e poi sprofondare nelle latomie del dolore più tenebrose per aver miseramente fallito nel credere che ciò fosse possibile, godendo più di un attimo di illusione che di una vita di verità.
 In ogni caso, gli ultimi due versi della strofa sono di uno straordinario coraggio, hanno il sapore della liberazione, come quando ci si libera appunto da una pena indicibile e si prova un enorme sollievo per il male da cui finalmente ci si è depurati: chi non sa che cosa sia l’amore felice e non l’ha mai incontrato – fortunatamente per via dei grandi dolori che si provano, sfortunatamente poiché forse non esiste occasione di conoscenza più grande di questa – affermi pure a cuor leggero che questa idea non esiste, poiché essa, del resto, non esiste realmente. Si passa una vita intera a supporre che questa pienezza possa esistere, e anche quando ci si avvicina o si pensa di essercisi avvicinati con qualcuno, l’aspettativa che si ha è scioccamente troppo elevata, o realizzata dall’immaginazione sì da essere concretamente impossibile da adeguare a quanto la persona reale invece può offrire.
In ogni caso, gli ultimi due versi della strofa sono di uno straordinario coraggio, hanno il sapore della liberazione, come quando ci si libera appunto da una pena indicibile e si prova un enorme sollievo per il male da cui finalmente ci si è depurati: chi non sa che cosa sia l’amore felice e non l’ha mai incontrato – fortunatamente per via dei grandi dolori che si provano, sfortunatamente poiché forse non esiste occasione di conoscenza più grande di questa – affermi pure a cuor leggero che questa idea non esiste, poiché essa, del resto, non esiste realmente. Si passa una vita intera a supporre che questa pienezza possa esistere, e anche quando ci si avvicina o si pensa di essercisi avvicinati con qualcuno, l’aspettativa che si ha è scioccamente troppo elevata, o realizzata dall’immaginazione sì da essere concretamente impossibile da adeguare a quanto la persona reale invece può offrire.
La Szymborska auspica allora, come già detto, una forma di assoluzione che pur transitando dall’idea di amore felice non se ne viene minimamente coinvolti: un’indagine razionale che ha proprio questi ultimi due versi come esito, in cui l’ultimo della poesia, un verso-strofa nel quale si raggruma il senso del componimento e dell’argomentazione che abbiamo qui tentato, funge da congedo.
Con tale fede gli sarà più lieve vivere e morire.
La miscredenza dell’amore felice è in verità una fede, ma non infondata poiché, come si è visto, strutturata dall’immaginazione e dal desiderio, che hanno l’infinità come processo e l’impeccabilità come fine. È una fede razionale, supportata dal dolore della non riuscita, dalla conoscenza anch’essa dolorosa dovuta al fatto di comprendere di essere stati vittime di un gioco teso da non altri che noi stessi, e dal coraggio filosofico di analizzare un fenomeno tra i più sacri e intangibili per quello che è.
Vengono in mente alcuni grandi pensatori della sensibilità e della disillusione come Dickinson, che affermava: «Che l’amore sia tutto quel che c’è / è ciò che noi sappiamo dell’amore» [8], Wilde, che ribadiva nel carcere di Reading: «Bisogna che oggi l’Amore rimanga nel mio cuore; come farò altrimenti a vivere fino a stasera?» [9], o lo stesso Proust, ai quali si aggiunge Luzi, che in un verso ormai famoso aveva scritto che «l’amore aiuta a vivere, a durare» [10]: cosa in fondo vera, perché dell’amore in quanto tale non si può fare a meno, essendo realmente un aiuto a vivere e a durare di più nel tempo che ci è concesso.
Tuttavia, dopo la lettura di questa poesia e aver discusso uno dei possibili sensi con cui può intendersi il suo contenuto, si è appreso un altro punto di vista, forse da ritenersi quello più alto e più esteso. Con la disillusione compiuta sull’amore felice in quanto chimera dell’immaginazione e del desiderio, l’esistenza diviene più leggera, meno ponderosa da portare, più piacevole da attraversare e anche un po’ meno ingiusta, perché si durerà in essa liberati finalmente dall’idea di spreco di vivere senza quella pienezza da dover ottenere con un’altra persona e di morire senza averla mai realizzata. In questi termini, tale assoluta pienezza non esiste. Quella della Szymborska è allora veramente una grande lezione di saggezza filosofica.
Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023
Note
[1] W. Szymborska, Un amore felice, in La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009), trad. di P. Marchesani, Adelphi, Milano 2009: 331-333.
[2] Cfr. naturalmente G. Leopardi, A Silvia, in Canti, a cura di G. Ficara, Mondadori, Milano 1987, vv. 36-39: 154.
[3] W. Szymborska, Del non leggere, in Tutte le poesie (1945-2009), cit., vv. 6-8: 717.
[4] «Lasciate lavorare la testa di un amante per ventiquattr’ore, ed ecco cosa troverete. Alle miniere di sale di Salisburgo, si getta, nelle profondità abbandonate della miniera, un rametto d’albero spoglio a causa dell’inverno; due o tre mesi dopo si ritrae coperto di cristallizzazioni brillanti: i rami più piccoli, quelli che non sono più grossi della zampina di una cinciallegra, sono guarniti d’una infinità di diamanti, mobili e abbaglianti; è impossibile riconoscere il rametto primitivo», Stendhal, Dell’amore (De l’amour), trad. di M. Bertelà, Garzanti, Milano 2015: 8.
[5] «Una bambola creata dal nostro cervello, la sola d’altronde che sia sempre a nostra disposizione, la sola che possiederemo, che l’arbitrio del nostro ricordo, quasi assoluto quanto quello dell’immaginazione, può aver fatto tanto diversa dalla donna reale come diversa dalla Balbec reale era stata per me la Balbec sognata; una creazione artificiosa alla quale, a poco a poco, per la nostra sofferenza, obbligheremo la donna reale ad assomigliare», M. Proust, I Guermantes (Le Côté de Guermantes), in Alla ricerca del tempo perduto (À la recherche du temps perdu, 1913-1927), trad. di M.T. Nessi Somaini, a cura di G. Bogliolo, Rizzoli, Milano 2012: 416. Ragionando su questi temi proustiani, ho tentato di suggerire questa dinamica anche ricorrendo a una metafora devozionale, descrivendo il processo dell’innamoramento alla stessa stregua di un’elevazione, in cui l’oggetto amoroso viene innalzato come una madonna su una pala d’altare. Mi permetto allora di rimandare a E. Palma, L’elevazione dell’amore. Un’analogia in Proust e Caravaggio tra immaginazione e filosofia, in «Illuminazioni», 63, gennaio-marzo 2023: 148-171.
[6] Cfr. B. Spinoza, Etica (1677), III, prop. XXIV, in Etica e Trattato teologico-politico, a cura di R. Cantoni e F. Fergnani, Utet, Torino 1997: 210.
[7] Cfr. R.M. Rilke, Elegie duinesi, trad. di M. Ranchetti e J. Leskien, Feltrinelli, Milano 2017: 13-15.
[8] E. Dickinson, Tutte le poesie, a cura di M. Bulgheroni, «I Meridiani», Mondadori, Milano 1997, 1765, vv. 1-2: 1633.
[9] O. Wilde, De Profundis (1905), trad. di C. Salvago Raggi, Feltrinelli, Milano 2021: 42.
[10] M. Luzi, Aprile-amore, in Le poesie, Garzanti, Milano, 2020, v. 25: 205.
_____________________________________________________________
Enrico Palma è dottore di ricerca di ricerca in Scienze dell’interpretazione, con una tesi dal titolo De Scriptura. Dolore e salvezza in Proust. Ha pubblicato saggi, articoli e recensioni in numerose riviste di filosofia, estetica, ermeneutica, critica letteraria e fotografia. Nel 2022 ha curato il volume L’anima della collana del «Corriere della Sera» Greco. Lingua, storia e cultura di una grande civiltà a cura dei Proff. M. Centanni e P. B. Cipolla. Collabora con Il Pensiero Storico ed è fondatore e co-direttore de Il Pequod.
______________________________________________________________









