di Leo Di Simone
Siamo consapevoli che “non c’è nulla di nuovo sotto il sole” e che intorno al culto liturgico cristiano è stato ribadito, in questo lungo tempo di post-concilio, ciò che è stato l’impegno di più d’un secolo di studi. Siamo infatti eredi di quell’ingente patrimonio lasciatoci dal Movimento liturgico [1] che ci ha fornito le piste sulle quali rintracciare la dimensione teologica e antropologica della liturgia, la riflessione intorno al mistero celebrato: il Movimento liturgico le ha fornite, anzi, a Sacrosanctum Concilium che sta lì, come un insigne monumento che ancora non è stato completamente esplorato.
Questo lascito è talmente ingente che non riusciamo a metterlo in ordine nei nostri depositi ecclesiali, nella nostra prassi liturgica che è il vero banco di prova della teoria teologica; la urgia con le sue esigenze, le sue leggi interne, la sua struttura antropologica che sembra infischiarsene delle nostre belle teorie nonostante le quali la liturgia patisce violenza. Si ha il sospetto, non che ci sia stato, in questi lunghi anni, qualcosa di non detto, quanto piuttosto di non compreso fino in fondo, e forse c’è da pensare che sessant’anni sono troppo pochi per il percorso di metanoia liturgica che il Concilio ha tracciato per il popolo cristiano, con molta determinazione, pur tenendo in conto che qualcuno rimpiange sempre le “cipolle d’Egitto” guardando al passato come ad epoca mitica di esemplarità.
Stesso discorso vale per le componenti sonore della liturgia, ciò che banalmente, genericamente e ostinatamente si continua a denominare “musica sacra”, avendo nella mente e nelle corde culturali ancora schemi di separazione e di alienazione metafisica. Il discorso sul canto e sulla musica è intrinseco al discorso sulla liturgia in quanto antropologicamente è intrinseco a quello rituale. Fiumi di inchiostro sono stati versati dalle fazioni che si sono schierate, e ancora oggi si schierano, l’una contro l’altra, a volte in maniera poco edificante dal punto di vista della carità cristiana, ciascuna ritenendo di essere la depositaria dell’autentica comprensione del cantare e del suonare all’interno del rito cristiano, nella misura di maggiore o minore aderenza agli schemi mentali e quindi culturali della sacralità. Non è il caso di riassumerne le variegate posizioni in questo breve saggio, votato più alla riflessione e alla cognizione culturalmente costruttiva del ruolo che canto e musica giocano nel rito cristiano, sia per gli “interni” a tale ritualità in quanto attanti abituali e financo magistrali, sia per gli “estranei” non interni alle sue dinamiche, “occasionali clienti” che magari gridano allo scandalo quando gli viene negata l’Ave Maria di Schubert al rito del matrimonio.
Bisogna anzitutto capire che ruolo giocano canto e musica nelle celebrazioni liturgiche ecclesiali, se sono strettamente indispensabili, se sono soltanto un accessorio, se catalizzano, in qualche modo, “partecipazione”, termine usato ed abusato, molte volte travisato ma indicativo della natura “popolare” della liturgia cristiana insita nel suo stesso etimo [2]. Riferendoci al canto e alla musica ci riferiamo allo stesso mistero che è l’uomo. Gli studiosi di estetica collocano la musica all’interno della variegata gamma delle arti, ma a ben riflettere, tra le arti essa è la più eterea, la più evanescente e la più immediata in quanto è prodotta in regime di autarchia. Sto parlando, con molta evidenza e in prima battuta del canto, di quella forma espressiva dell’uomo che trascende il linguaggio verbale pur essendo linguaggio che si articola anche in assenza di parole. In realtà dovremmo dire “canto e musica”, perché la musica, come téchne è successiva e consequenziale all’immediatezza dell’espressione canora con cui l’uomo primitivo faceva il verso alla natura e all’universo, imitandone i rumori per via di una sintonia interiore, illogica quanto naturale. Aristotele, in ogni caso, negava alla musica anche la fisionomia di téchne in senso proprio in quanto inutile alla messa in opera di qualcosa di oggettivo ed esterno al suo stesso farsi. Le riconosceva, invece, un certo legame con l’éthos in quanto i suoi moduli eterei si incontrano o si scontrano con gli stati d’animo degli esecutori e degli ascoltatori [3]. Non è difficile pensare a come l’uomo primitivo associò immediatamente la sua facoltà canora, la scoperta di una facoltà in-utile, con l’altra realtà non immediatamente utile come la trascendenza: una realtà che c’è pur nella sua immaterialità e nella sua stranezza epifanica, quella che Rudolph Otto ha sintetizzato descrivendo il fenomeno del sacro. E tuttavia né la natura né l’arte sono, per chi intuisce un mondo invisibile, un luogo di riposo definitivo dello spirito; ciò che la natura e l’arte lasciano presagire non possono, in nessun modo, donarlo. Solo Dio comunica il divino!
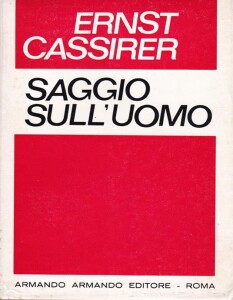 Il canto come sequenza di suoni inarticolati e non immediatamente utili alla comunicazione orizzontale si fa veicolo di quella verticale. Il canto, come dato espressivo immediato, è poiesi autonoma dell’antropo che coincide con lo stesso stupore del possesso di una dimensione trascendente che lo inabita, che si coagula in linguaggio simbolico: arte, mito, religione ne sono le risultanti [4]. Per Cassirer «sono i fili che costruiscono il tessuto simbolico, l’aggrovigliata trama dell’umana esperienza». Nasce in tal modo «il linguaggio del sentimento e delle emozioni; oltre al linguaggio logico e scientifico esiste quello dell’immaginazione poetica» [5]. Un margine di possibilità di comparazione fenomenica ce lo fornisce, però, il rito. Possediamo amplissima documentazione antropologica dell’azione sinergica di canto e musica nel rituale antropico. Qui basta rammentare la consistenza ritmica del canto e della musica; il farsi pura durata, scansione temporale, pausa, silenzio e suono, tono, timbro, ritmo che in sé ha lo stesso etimo di rito, dal sanscrito rtá. Espressività puramente ritmica dell’esistere «liberato dal peso pietrificante del concetto, melos ordinatore e cosmogonico» [6]. Per questa qualità quasi demiurgica canto e musica hanno intessuto un rapporto strettissimo anche col mito che insieme alla sua forma di drammatizzazione rituale ha cercato di elaborare modelli di chiarificazione simbolica della vita e della morte in senso religioso [7]. Dell’homo naturaliter religiosus, legato alla sfera sacrale dell’inconoscibile tremendum et fascinans, del totalmente altro pur avvertito presente e determinante il misterioso processo dell’esistenza.
Il canto come sequenza di suoni inarticolati e non immediatamente utili alla comunicazione orizzontale si fa veicolo di quella verticale. Il canto, come dato espressivo immediato, è poiesi autonoma dell’antropo che coincide con lo stesso stupore del possesso di una dimensione trascendente che lo inabita, che si coagula in linguaggio simbolico: arte, mito, religione ne sono le risultanti [4]. Per Cassirer «sono i fili che costruiscono il tessuto simbolico, l’aggrovigliata trama dell’umana esperienza». Nasce in tal modo «il linguaggio del sentimento e delle emozioni; oltre al linguaggio logico e scientifico esiste quello dell’immaginazione poetica» [5]. Un margine di possibilità di comparazione fenomenica ce lo fornisce, però, il rito. Possediamo amplissima documentazione antropologica dell’azione sinergica di canto e musica nel rituale antropico. Qui basta rammentare la consistenza ritmica del canto e della musica; il farsi pura durata, scansione temporale, pausa, silenzio e suono, tono, timbro, ritmo che in sé ha lo stesso etimo di rito, dal sanscrito rtá. Espressività puramente ritmica dell’esistere «liberato dal peso pietrificante del concetto, melos ordinatore e cosmogonico» [6]. Per questa qualità quasi demiurgica canto e musica hanno intessuto un rapporto strettissimo anche col mito che insieme alla sua forma di drammatizzazione rituale ha cercato di elaborare modelli di chiarificazione simbolica della vita e della morte in senso religioso [7]. Dell’homo naturaliter religiosus, legato alla sfera sacrale dell’inconoscibile tremendum et fascinans, del totalmente altro pur avvertito presente e determinante il misterioso processo dell’esistenza.
La musica, a partire «dalla sua più elementare forma di canto melodico, è l’unica arte di cui anche l’uomo più incolto sa valersi sin dagli albori della civiltà» [8] e pertanto sembra custodire il segreto di ogni arcano, di ogni naturale espressione sacrale, sacra oltre la nostra viziata comprensione culturale di questo termine, nella sua più intima essenza. Sacra è la musica nel suo utilizzo in direzione della trascendenza, nella dinamica di ogni mediazione rituale. Occorre dunque mettere in evidenza che sacro, stanti le componenti di indistinzione e di primordialità che lo connotano, è aggettivo che male si adatta alla qualificazione cristiana in genere e alle arti cristiane in specie, semplicemente per via della novità estetica cristiana [9], per la diversa percepibilità di Dio mostrata da Gesù di Nazareth. La sacralità è punto di partenza e non di arrivo della dimensione religiosa; canto e musica, pertanto, all’interno della ritualità cristiana, non esprimono l’indistinto ma il dialogo teandrico col Dio Uno e Trino rivelatosi in Gesù Cristo. Il canto cristiano che anela anch’esso, antropologicamente, all’affrancamento dal concetto, non articola più la sua natura melica in suoni insignificanti ma plasma la melodia sul ritmo del Verbo che è tutta la dicibilità di Dio, la possibilità di un dialogo prima impensabile, di una conoscenza interpersonale prima preclusa.
I Padri della Chiesa, cito per tutti Clemente Alessandrino e Basilio, erano concordi nel ritenere il canto cristiano, per la catalizzazione della fede, una possente azione dello Spirito Santo, e per Giovanni Crisostomo è stato Dio stesso ad aver consegnato alla musica il suo straordinario potere [10]: per cui Tommaso d’Aquino avrà una chiara visione del valore psicagogico della musica, cioè della sua straordinaria potenza emotiva, della possibilità di contemplazione disinteressata del fatto musicale in chiave cristiana, distinguibile dall’arte musicale “profana”, di tipo puramente estetico, da non condannare perché utile iuxta propria principia [11] e comunque autoreferenziale, carente di quel quid capace di farle fare il salto di qualità consistente nella relazione sacramentale. Già Agostino aveva considerato i rischi della assolutizzazione della sacralità nell’ambito della musica cristiana. Non usa il termine perché non lo conosceva culturalmente, ma ha cognizione di quella debolezza umana che considera fine il mezzo; siccome per lui una scientia bene modulandi, che ci consente di percepire il ritmo eterno ed immutabile, può venire solo da Dio, nelle Confessioni denuncia il rischio che ci si possa abbandonare alla malìa delle modulazioni e dice che vorrebbe rimuovere «ogni melodia di quelle dolci cantilene con le quali si accompagna la recita dei Salmi di Davide» [12].
 La musica è sacra quando riposa compiaciuta di sé nelle sue qualità ancestrali; quando si supera e si fa apposizione al Verbo diviene, in senso tomista, strumento dell’ammaestramento dell’anima alla rivelazione divina. Oltre la lettera essa si fa spirito nella persuasione della necessità di una trasfigurazione che solo in Cristo trova la sua forma piena. La sua strumentalità pedagogica in senso trasfigurante le deriva dalla sua stessa inconsistenza materiale che non consente rappresentazioni idoliche ma solo pungoli all’anima chiamata ad ascoltare il logos melodico del Verbo che le proferisce la verità dell’amore salvifico. Sto parlando di strumentalità come sussidio efficace del rito, non di un assoluto estetico. Dio può far intendere come vuole la melodia del suo Verbo, anche in maniera straordinaria; ordinariamente, però, ha scelto la realtà divina ed umana che è la liturgia, in cui confluiscono le arti che col loro peculiare linguaggio parlano, oltre la ragione, all’anima umana, alla sensibilità dell’uomo globalmente presa e costituente lo strumento percettivo di tale messaggio, un polo sovrannaturale di recezione inscritto nella struttura antropologica cristiana che è originalmente “iconica” perché descrittiva dell’antropo come «immagine e somiglianza» di Dio.
La musica è sacra quando riposa compiaciuta di sé nelle sue qualità ancestrali; quando si supera e si fa apposizione al Verbo diviene, in senso tomista, strumento dell’ammaestramento dell’anima alla rivelazione divina. Oltre la lettera essa si fa spirito nella persuasione della necessità di una trasfigurazione che solo in Cristo trova la sua forma piena. La sua strumentalità pedagogica in senso trasfigurante le deriva dalla sua stessa inconsistenza materiale che non consente rappresentazioni idoliche ma solo pungoli all’anima chiamata ad ascoltare il logos melodico del Verbo che le proferisce la verità dell’amore salvifico. Sto parlando di strumentalità come sussidio efficace del rito, non di un assoluto estetico. Dio può far intendere come vuole la melodia del suo Verbo, anche in maniera straordinaria; ordinariamente, però, ha scelto la realtà divina ed umana che è la liturgia, in cui confluiscono le arti che col loro peculiare linguaggio parlano, oltre la ragione, all’anima umana, alla sensibilità dell’uomo globalmente presa e costituente lo strumento percettivo di tale messaggio, un polo sovrannaturale di recezione inscritto nella struttura antropologica cristiana che è originalmente “iconica” perché descrittiva dell’antropo come «immagine e somiglianza» di Dio.
Ed è il recupero della «somiglianza» che accade nella liturgia cristiana, stante il permanere dell’«immagine» indelebile, anche se offuscata. È l’azione trasformante e indiante del Verbo che ama la sua sposa, la Chiesa, rendendola pura e santa unendola intimamente a sé. La liturgia, nel suo farsi, è il monte della Trasfigurazione su cui avviene l’epifania dello Spirito Santo come luce increata. Non si dà trasformazione dell’uomo se egli non percepisce, nella parte migliore della sua sensibilità, la proposta salvifica sussurratagli dallo Spirito, la paternità divina che non è nel cosmo, nella natura, nelle cose create primariamente o nelle stesse arti, ma in Gesù, il Signore, manifestazione suprema della bellezza e della bontà della paternità di Dio. A questo scopo le arti trovano luogo nella liturgia: non per sfilare su una passerella estetica mostrando la propria bellezza, ma per farsi canali in cui scorre la Bellezza assoluta, increata. Solo se ostendono, riflettendola docilmente, la bellezza che è Dio Padre, la bellezza amorosa del Figlio continuamente operante nell’azione del Consolatore, riescono a farsi evento: Dio che è ancora all’opera, nel tempo e nello spazio.
Si sa che i materiali della poesia sono le parole e che queste parole sono il linguaggio per eccellenza della vita. Ora, le parole per la vita non sono mai astratte, ma concrete e aspirano sempre a risalire verso la loro fonte originaria. Anche la musica conosce un percorso simile. I suoni non possono essere scissi da un contenuto che si trova nell’anima: i suoi aneliti, i suoi desideri, i suoi slanci o le sue cadute. In questo senso, nella musica, il suono è un evento, non già un puro fenomeno acustico che ci lascia là dove ci ha trovati. L’affermazione è vera nella sua pienezza significativa soprattutto se traslata in senso salvifico, laddove consideriamo Dio come “fonte originaria” dell’anima, Gesù Cristo risposta ai desideri più sublimi dell’antropo, lo Spirito santo artefice degli slanci e aiuto nelle cadute. Di questo mistero ci rende partecipi la liturgia della Chiesa, luogo pensato per il coinvolgimento salvifico dell’uomo e per la trasfigurazione dei suoi sensi, momento propizio per partecipare alla salvezza. E ciò è molto di più di una appercezione sacrale genericamente religiosa. È la poesia di Dio che spacca il sacro, nel linguaggio umano di cui ha voluto servirsi per parlare a noi e farsi capire da noi.
La caratteristica che si è attribuita e ancora da più parti si attribuisce a ciò che si denomina musica sacra, è quella di essere la musica praticata dalla Chiesa nel culto pubblico. Il suo linguaggio, stile e tecniche però, in passato erano identici a quelli praticati nella società civile del tempo culturale, un tempo che per noi è culturalmente molto lontano. Si danno linguaggi identici perciò in un madrigale o in un mottetto di Palestrina, in una frottola e in una messa di Josquin Desprez, o in una cantata liturgica o profana di J. S. Bach. E si potrebbe continuare passando attraverso Mozart e Beethoven, il Requiem tedesco di Brahms e la Petite messe solennelle di Rossini. Solo che, passata la smania romantica, si guardò unicamente al passato più passato e ci si concentrò su Palestrina come unico emblematico artefice di musica sacra, e sul canto “gregoriano” per via delle sue ascendenze di cantillazione ebraica e alla mitica paternità di Gregorio magno. Mi hanno sorpreso non poco, anche se il termine vero sarebbe indignato, le affermazioni di un illustre musicista ecclesiastico, un prete, comparse qualche anno fa, ohimè, sull’Osservatore Romano! Rispondendo all’intervistatore che gli chiedeva lo stato di salute della “musica sacra” diceva senza mezzi termini che bisogna ritornare al latino, alla “polifonia sacra”, a Palestrina! E poi la frase ad effetto: “Chi canta – solo in latino – prega due volte”.
Non sappiamo con precisione come Gesù di Nazareth abbia cantato con i suoi discepoli gli inni e i salmi della cena festiva, del suo irrituale Seder di Pesach, quella notte in cui creò il capolavoro tra le opere di salvezza che è la liturgia [13]. Sicuramente non in latino e “a cappella”; non c’erano i mezzi per pagare l’organista perché Giuda era andato via con la cassa. Eppure gli effetti della partecipazione liturgica si fecero sentire, dopo la Risurrezione! Consistettero nella testimonianza dei suoi, fino all’effusione del sangue, perché si ostinarono a perpetuare quel rito in memoria di lui, quello strano culto che tanto disorientava e intimoriva i pagani, perché aveva connotazioni agapiche piuttosto che sacrali e idoliche, fuori dagli schemi della religione. Il concetto di sacralità, pertanto, applicato all’arte e alla musica cristiani, appare alquanto tarato da una componente ideologica tutta occidentale, segnata pesantemente dal dualismo astratto coniato dalla filosofia greca che ha diviso ciò che è indivisibile, come corpo e spirito, particolare e universale, sacro e profano… Quando invece «la vita regge gli opposti; gli opposti si realizzano nella vita; sono i modi in cui la vita è viva» scriveva in antitesi Romano Guardini [14].
Bisogna allora uscire dalla gabbia culturale dell’Occidente cristiano ormai estenuato e disilluso. Ci si deve confrontare con un universo sonoro che si estende dal “bisbiglio” al “fragore di grandi acque”, in una cromia sonora che coinvolge gli usi e i costumi, ormai, di tutti i popoli della terra, in quella dimensione transculturale che necessariamente contempla processi di ac/in/de/ri-culturazione. Processi che riguardano anzitutto la liturgia nel suo costruirsi e nel suo necessario ri-farsi ad ogni passaggio epocale ed inculturativo, e con la liturgia la musica che non è, né nella struttura del rito, né nella sua strumentale funzione semiotica, un orpello della celebrazione liturgica ma un «elemento necessario e integrante» di essa [15].
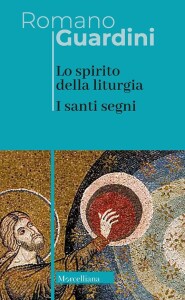 Bisogna prestare attenzione, a tale riguardo a ciò che accade nella culturazione, processo quanto mai dinamico della cultura umana, fatto necessario del suo muoversi nella storia, anche nella nostra storia contemporanea, liquida, fluida, postmoderna, aggettivabile come si voglia, ma fattualità dalla quale non si può fuggire, pena l’irrealtà, l’anacronismo, l’artificio, l’astuzia, la menzogna, ai limiti della schizofrenia intellettuale. E ciò vale per tutte le realtà culturali messe in atto dall’antropo. Anche la religione, il culto afferente, le arti e la musica inerenti sono registrabili, “riprendibili” (al modo di una ripresa cinematografica) in questo lungo e movimentato film che si chiama culturazione, ove ogni movimento come fotogramma può essere registrato e comparato, vivendo ciascuno di relazionalità: conseguenza di ciò che precede, premessa di ciò che seguirà, progetto antropologico mai completamente in atto ma in continua potenza, pro-teso, orientato escatologicamente verso un compimento pieno ed eterno: per i cristiani “la vita del mondo che verrà”!
Bisogna prestare attenzione, a tale riguardo a ciò che accade nella culturazione, processo quanto mai dinamico della cultura umana, fatto necessario del suo muoversi nella storia, anche nella nostra storia contemporanea, liquida, fluida, postmoderna, aggettivabile come si voglia, ma fattualità dalla quale non si può fuggire, pena l’irrealtà, l’anacronismo, l’artificio, l’astuzia, la menzogna, ai limiti della schizofrenia intellettuale. E ciò vale per tutte le realtà culturali messe in atto dall’antropo. Anche la religione, il culto afferente, le arti e la musica inerenti sono registrabili, “riprendibili” (al modo di una ripresa cinematografica) in questo lungo e movimentato film che si chiama culturazione, ove ogni movimento come fotogramma può essere registrato e comparato, vivendo ciascuno di relazionalità: conseguenza di ciò che precede, premessa di ciò che seguirà, progetto antropologico mai completamente in atto ma in continua potenza, pro-teso, orientato escatologicamente verso un compimento pieno ed eterno: per i cristiani “la vita del mondo che verrà”!
Finora, nelle analisi “anatomiche” della liturgia e delle sue manifestazioni sonore effettuate nel lungo tempo del postconcilio sono stati visionati i fotogrammi del film, le belle fotografie delle componenti della musica liturgica e del suo canto radicate nel rito con le sue leggi, codificate in un ordo da intendersi come regola cognitiva e percettiva del Mistero di Cristo; ma ci si è limitati ad analizzare il paradigma culturale nel quale siamo immersi: il territorio piuttosto omogeneo – pur con le sue non poche e scontate sfaccettature singolari – su cui insistono le Chiese occidentali, portandoci appresso, nelle riprese, i filtri delle diatribe e delle contese che hanno avvelenato, dalla fine del Concilio ad oggi, il campo fertile ma ancora inesplorato della riforma liturgica. Portandoci appresso il nostro bagaglio troppo “romano”, ingombrante, che pesa come un macigno e che ha rallentato di non poco il passo nella frequentazione degli ambiti della riforma stessa che è stata pensata pneumaticamente dal Concilio per l’intera ecumene, in maniera veramente cattolica, e approntata culturalmente, almeno in teoria, per il genio delle culture antropologiche dove l’evento cristiano si è inculturato, e in molti luoghi ormai da lungo tempo.
E dico “in teoria” perché la cappa della “romanità” ha gravato e ancora grava sulla Chiesa universale nella quale il “Rito romano”, pur non essendo maggioritario statisticamente lo è ancora, di fatto colonialisticamente. E sappiamo che il colonialismo è inculturazione forzata, innaturale, artificiale, che com-porta l’in-portazione di arti (temi e modelli) che non possono esprimere al meglio i temi e i modelli di una determinata cultura costretta, metu seu vi, a sop-portarli. Le arti che pur esprimono valori e grandezza di altre culture, passate o presenti, significano poco o niente in luoghi altri da quelli di origine e in tempi diversi da quelli di emissione. E se qualcosa significano vuol dire che appartengono al patrimonio comune dell’umanità ed esprimono valori che sono transculturali e universali; verosimilmente, nella visione cristiana, cattolici. E quando esprimono, nella sintesi artistica, il più alto concentrato di valori possibili, sono capolavori frutto di una risoluzione meta culturale. Lo spettro interreligioso va da un comune substrato sacrale ad un ethos universale teleologicamente salvifico.
Guardando fuori dalla nostra aiuola italiana, per esempio, ci accorgiamo che si protrae il retaggio delle acculturazioni che per tutto il medioevo, nel bene e nel male, hanno costruito la liturgia euro-occidentale, poi arbitrariamente e unilateralmente qualificata come “romana” [16]. Processi che hanno riguardato il rito, le sue arti e i suoi canti, specie quelli che sono nati dalla tradizione popolare, dal basso, dalla sensibilità del popolo di Dio. Ed anzi, alcuni elementi canori, residui qualificati di un significativo passato, rappresentano tacite osmosi ecumeniche, travasi rituali mutuati anche, incredibile a dirsi, scandaloso per i “puristi”, dal mondo protestante; quest’ultimo però non li ha inventati ex novo, ma li ha attinti ad una fonte comune. Tutta una serie di inni che cantiamo tranquillamente, e i cui testi, tradotti nelle lingue nazionali europee o coniati ex novo sull’ordo metrico del ritmo musicale, sono ormai inscindibilmente amalgamati con melodie nate in area riformata e dall’intuizione geniale di Lutero che pensò al canto, e all’inno in particolare, come forma autonoma di culto. Dopo il Concilio, ricercando canti nuovi per la liturgia riformata, si pescò, con grave scandalo dei “puristi romani”, proprio in quell’area culturale; per questo si disse che la liturgia cattolica era diventata “riformata” nel senso di “protestante”. Ma da allora l’inno Noi canteremo gloria a te, che proviene musicalmente dal Salterio di Ginevra, che è una riduzione metrica dei salmi per l’uso canoro, funziona ancora oggi e si canta in tutta Europa [17]. Ricordo che con tale inno iniziai il mio ministero di organista liturgico.
Invece che fissarsi sulla sterile diatriba sulla “musica sacra”, risulterebbe più utile perseguire studi comparativi delle forme musicali comuni alle Chiese europee, a partire dal nostro repertorio italiano; per rilevare costanti e varianti, per osservare e percepire con cognizione di causa il gusto culturale, ciò che permane ad onta delle variazioni e delle innovazioni forzate, nate in via sperimentale e morte qualche tempo dopo perché senz’anima. Rivisitare il lavoro di altri laboratori musicali che nel lungo arco del post-concilio hanno visto prodursi canti semplici, di tipo modale, in forma più o meno responsoriale, accanto a canti ritmati, magari accompagnati dalla chitarra e salutati, al loro apparire come segno di rinnovamento e di modernità. E poi i canti dei Movimenti ecclesiali, che non sempre si rivelano adeguati perla liturgia essendo nati per scopi aggregativi o anche per momenti di preghiera ma non integrabili nell’ordo, ed anzi senza alcun radicamento nella liturgia, nei suoi riti, nei suoi tempi, nei suoi luoghi, nei suoi ritmi celebrativi.
Giusto per avere qualche indicazione in più sulla fisionomia della “sintonia culturale” con la quale imbastire un progetto per una nuova stagione del canto liturgico che tenga conto del clima culturale in cui abitiamo e della tradizione di cui siamo eredi: seguire il processo di culturazione dei canti liturgici può aprire gli occhi su ciò che si è sbagliato, gli orecchi a ciò che musicalmente non ha funzionato; ma anche trovare qua e là qualche felice emergenza dettata da recezione pneumatica, nell’ambito della vita monastica, di qualche comunità dall’orecchio veramente aperto alla voce dello Spirito. Raccogliere ogni informazione utile per rinfocolare lo scopo dell’elaborazione dei canti liturgici che non è mettere in risalto la maestria dei singoli compositori; semmai convincerli a piegare la loro arte ai criteri culturali utili a far cantare il popolo di Dio, vero soggetto della celebrazione liturgica! In ciò viene implicitamente superata la questione della sacralità, in quanto è superata la dimensione individuale o/e individualistica della religiosità, nel riacquisto di una ecclesialità “corale” che nell’azione liturgica si rinviene «un cuore solo e un’anima sola». Il canto corale fa apparire la comunità e la costituisce: regola i passi mentre si avanza in corteo verso la festa del banchetto nuziale, e rende più salda l’amicizia dei convitati: non si può cantare insieme e ignorarsi o, peggio, odiarsi.
La forma ideale di partecipazione comunitaria al culto liturgico cristiano dunque è il canto: momento dell’azione liturgica in cui tutto il popolo adunato esprime, nel segno del canto, il suo sacerdozio comune. Lo si può osservare anche in tante altre liturgie cristiane non cattoliche: momenti di silenzio, tra un rito e l’altro, poi si riprende mettendosi in piedi e tutti cantano un inno. Anche la postura è importante, lo stare tutti in piedi per dichiarare a Dio l’adsumus, e indirizzargli la lode. Un popolo ministro della lode nel canto della gloria di Dio. Quale altra scuola può insegnare al nostro popolo l’essenza della dignità sacerdotale, del grande valore ecclesiologico dell’assemblea, della necessità del fare (urgia) non tutto, ma qualcosa di importante come il cantare nella liturgia? Sono cose che sappiamo solo in teoria, di fatto siamo molto in ritardo nel praticarle. Ecco perché occorre sbirciare sul fare dei vicini di casa, di altre Chiese, di altre confessioni, caso mai avessero escogitato qualcosa di interessante in proposito. L’acculturazione nasce dalla necessità. La necessità di camminare insieme, per i cristiani, è urgenza in tempi postcristiani come i nostri. Canto e musica si rivelano indici rilevatori di assetto sinodale: non si cammina insieme se non si canta insieme. Se non c’è con-sonanza c’è dis-accordo e la musica produce dis-sonanze! È il Verbo che dà l’in-tonazione; se non ci si entra dentro, non vi si presta orecchio, si stona!
Per quanto s’è detto, molto sinteticamente, la partecipazione all’azione liturgica non ha nulla a che vedere con l’efficientismo che la nostra cultura sottintende al termine “partecipare”; non si tratta di un apporto personale ad una situazione da supportare o da modificare o di un atto di presenza sociologico o culturale. La partecipazione liturgica, al contrario, è l’ingresso in un clima esistenziale in cui siamo noi ad essere supportati, aiutati, modificati, arricchiti e non come individui ma come comunità di salvati. La liturgia è un atto comunitario, non si partecipa individualmente; la partecipazione, anzi, è tanto più vera nella misura in cui si condivide con gli altri l’umanità e si sperimenta con gli altri la divinità, per via dell’unico amore di Dio e del prossimo evangelicamente simbolizzato nei riti. Nella liturgia, pertanto, non si canta da soli né c’è spazio per solisti o protagonisti teatrali, per esibizioni spettacolari, per l’esecuzione di “pezzi di bravura”, stante la sua natura di azione comunitaria, ecclesiale, partecipante al mistero pasquale di Cristo.
 C’è stato un tempo in cui si è data più importanza agli accessori del rito che al rito stesso, e gli accessori hanno prevalso oscurando l’azione rituale. Una gran parte di mottetti come Ave verum, Ave Maria, Panis angelicum, Salve regina e simili si presentano oggi nella letteratura musicale come pezzi autonomi, senza un legame diretto con la liturgia e vengono eseguiti nei concerti [18]. Tante celebri Messe di autori famosi, pur restando splendide composizioni musicali di carattere religioso in senso cristiano, sono inutilizzabili oggi per la liturgia, vuoi per l’eccessiva lunghezza, vuoi per la loro tessitura polifonica che non prevedeva nessuno spazio per il canto assembleare, tanto più che per lungo tempo il rito cristiano fu considerato occasione per esibizioni concertistiche, e frequentato come spettacolo nelle corti dei nobili e nelle cappelle dei vescovi-principi.
C’è stato un tempo in cui si è data più importanza agli accessori del rito che al rito stesso, e gli accessori hanno prevalso oscurando l’azione rituale. Una gran parte di mottetti come Ave verum, Ave Maria, Panis angelicum, Salve regina e simili si presentano oggi nella letteratura musicale come pezzi autonomi, senza un legame diretto con la liturgia e vengono eseguiti nei concerti [18]. Tante celebri Messe di autori famosi, pur restando splendide composizioni musicali di carattere religioso in senso cristiano, sono inutilizzabili oggi per la liturgia, vuoi per l’eccessiva lunghezza, vuoi per la loro tessitura polifonica che non prevedeva nessuno spazio per il canto assembleare, tanto più che per lungo tempo il rito cristiano fu considerato occasione per esibizioni concertistiche, e frequentato come spettacolo nelle corti dei nobili e nelle cappelle dei vescovi-principi.
La liturgia invece è un evento. Non commemorazione del passato ma attualissimo presente dove si manifesta la vita dell’eterno vivente, il Crocifisso Risorto; ed è in virtù di tale attualità che tutte le forme di accoglienza festosa di tale manifestazione di vita eterna, quelle che Guardini chiama «le forme naturali spontanee, nella liturgia vengono trasformate in forme riflesse di cultura» [19]. Liturgia come evento è luogo di inculturazione, del Verbo eterno anzitutto, che continua ad assumere carne, forme culturali senza esclusioni e senza distinzioni; poiché la salvezza è per tutti, non per un solo gruppo eletto, una sola cultura. Se il Verbo non parlasse secondo le forme culturali nessuno potrebbe intenderlo! Dio ha voluto parlare la nostra lingua per insegnarci la sua. Se non ci si intendesse non si capisce in che modo la “partecipazione” alla liturgia potrebbe essere «consapevole, attiva, fruttuosa, piena» [20].
Questa è la via tracciata dal Concilio per ritrovare la liturgia oltre la sacralità senza tempo. Per ciò che attiene più strettamente la musica trovo un inciso fondamentale e programmatico in SC 112 che di per sé dirime ogni possibile controversia sulla “musica sacra”. Ciò che si richiede alla musica per l’uso cultuale è che sia «più strettamente unita all’azione liturgica, esprimendo più dolcemente la preghiera e favorendo l’unanimità». Credo che in questa frase ci sia davvero tutto. Suavius exprimens traduce l’intenzione di fare del canto, della musica e della preghiera una vera unica euloghia, una preghiera dolce, soave, in dimensione simbolica, dove cioè tutti possano riconoscersi ritrovandosi nell’unità dei cuori e degli intenti e dove tutti possano riconoscere e incontrare Cristo. Il testo conciliare utilizza la metafora della santità per aggettivare tale musica: «sarà tanto più santa quanto più strettamente unita all’azione liturgica». Si badi: «santa» e non “sacra”. Noi prendiamo la metafora come tale, nella convinzione che è della santità degli uomini che si tratta, da attingere alla fonte del Santo di Dio che la liturgia celebra.
È solo questo lo scopo dell’azione liturgica, forgiare santi, utilizzando tutti i mezzi della natura e tutte le sorprese della Grazia; il testo prosegue dicendo che «la Chiesa poi approva e ammette al culto tutte le forme della vera arte, dotate delle dovute qualità», qualità che rinveniamo nello stesso testo sintetizzate nella dimensione “ministeriale”. Musica della liturgia che aiuti l’assemblea celebrante a entrare nel clima esistenziale [21] dell’unanimità cristica accompagnando dolcemente la preghiera liturgica, l’incedere rituale nei percorsi celebrativi, esprimendo con soavità le formule eucologiche, le invocazioni litaniche, le acclamazioni, le dossologie. In maniera semplice, non teatrale, non artificiosa ma orecchiabile, sobria, elegante, culturalmente vicina alla sensibilità di ogni Chiesa, di quella data comunità. Si tratta così della «nobile semplicità» dei riti di SC 34 e della «communitatis propria celebratione» di SC 21.
Lo abbiamo detto fino alla nausea che il canto e la musica hanno un ruolo ministeriale nel servizio liturgico, ma non ne abbiamo tratto ancora le adeguate conseguenze. Forse, ma sono sicuro che è così, perché abbiamo una visione ancora clericale del “ministero” e della liturgia. Ministerialità, sì, ma appannaggio dei pochi, degli eletti, dei perfetti. Non potrebbe o dovrebbe, invece, esprimersi col canto la ministerialità del popolo sacerdotale che ancora indugia nell’esercitarla adagiato sulla pigrizia della delega? La delega ai chierici? Il canto deve essere visto nella liturgia non più, né tantomeno, come mero segno della bellezza che è indubbiamente, per via della capacità di elevazione e sublimazione dei singoli che ne traggono effettivo godimento, quando è fatto con arte, rispondendo cioè alla sua interna armonia! Deve essere inteso, inoltre, e trattato anzitutto come gesto umano di partecipazione e persino come rito necessario insito nella dinamica liturgica dell’armonia teandrica celebrata, intendendo il “celebrare” oltre il rituale in sé compiuto, e nel senso kerygmatico di “rendere celebre”, annunciare, diffondere tale armonia tra gli esseri umani; qui si coglie un altro punto nevralgico di una ministerialità più ampia, non clericale, universale, appannaggio di un cattolicesimo aperto per il suo stesso etimo – come potrebbe essere chiuso e universale? – che parta dalla relazione culto-cultura – dalla stessa radice del colere – per la riconciliazione tra l’uomo contemporaneo e i segni del mistero cristiano. E questo non è lavoro per i pochi “chierici” sopravvissuti, ma attiene alla “laicità” del popolo cristiano.
Ora però dobbiamo fare un’altra considerazione: siamo al punto epocale in cui dobbiamo confrontarci, volenti o nolenti, con la cosiddetta “globalizzazione” nella contemporaneità. Anche il processo attuale di globalizzazione è un processo di colonialismo culturale ma per fortuna, secondo la nostra prospettiva, e per grande sfortuna per tutti gli altri punti di vista, le sue connotazioni sono in prevalenza di carattere economico e commerciale, frutto di una ideologia capitalistica che mentendo scientemente s’è appellata eufemisticamente “liberalismo”. La Coca cola la si beve in tutto il mondo, deve essere bevuta in tutto il mondo, e sembra essere il simbolo di una pacificazione planetaria, un trait d’union culturale a detta dei produttori. Poi magari si scopre che ci sono delle imitazioni, ma sempre di quel modello e sempre a scopo commerciale. Anche noi, confessiamolo, siamo entrati in questa smania commerciale nello smercio di prodotti inutili che gonfiano solo lo stomaco dell’anima senza fornirle nessun nutrimento. Basta entrare nelle nostre librerie “cattoliche” e vedere quanti librini inutili, fascicoletti devozionali, pubblicazioni sull’onda del momento… adesso su tutto si appiccica l’aggettivo “sinodale” e l’etichetta “in uscita”, sino a quando il papa non pronuncerà un’altra parola ad effetto. Commercialmente è una manna!
Che cosa vogliamo globalizzare noi cristiani, il Vangelo? Benissimo, ma dobbiamo inculturarlo col metodo del Verbo incarnato: calarlo nelle culture senza violenza, senza far pesare il modello culturale di partenza che è nostro e solo nostro, di occidentali europei razionalisti e borghesi pur affermando il contrario. In passato abbiamo creduto di averlo fatto, con esiti catastrofici, da colonizzatori. Poi, dopo aver superato mille scrupoli dell’inconscio culturale abbiamo legittimato culturalmente il pionierismo inculturativo che ha iniziato timidamente nei Paesi del Terzo mondo a servirsi dei modelli di quei popoli per operare il famoso “adattamento liturgico”, pensato dal Concilio e sollecitato fortemente dai vescovi autoctoni e sognato da una serie di profeti culturali inascoltati, da Matteo Ricci a Thomas Merton almeno [22]. A ben vedere, ci dovremmo accorgere, che le nostre rigide posture culturali non sono contemplate nel Vangelo se non nei ritratti delle posture ieratiche ed ipocrite dei Farisei e dei ministri del culto giudaico. E che Paolo è stato fustigato a sangue perché era imperterrito nel perseguire lo scopo di evangelizzare anche i pagani, uscendo fuori dal cerchio di elezione nel quale da Fariseo aveva preteso di rinchiudere Dio e il suo messaggio. Poi si è accorto che Dio lo mandava sempre oltre, sempre più lontano… e ha corrisposto con la vita, perdendo la testa!
Il dibattito sulla cosiddetta “musica sacra” è stato ed è un dibattito occidentale, forse esclusivamente europeo, ma probabilmente soltanto italiano essendo l’Italia, da sempre, la prima nazione ecclesiale esposta all’onda d’urto della romanità, e l’etnia che ancora, a differenza di altre limitrofe, è linguisticamente più sintonizzata sulla latinitas che si studia meglio in altre nazioni ma si canta meglio in Italia – sentite un tedesco che canta “Agnus Dei” o “suscipe” –. Solo cantare però! Capire è altra cosa. E non solo linguisticamente ma liturgicamente. Dobbiamo ammettere che inconsciamente continuiamo a interpretare i documenti conciliari e pastorali sulla musica liturgica con i parametri dell’Enciclica di Pio XII, del 1955, Musicae sacrae disciplina anziché con l’Istruzione postconciliare Musicam sacram del 1967. La prima è una apologia della “musica sacra”, la seconda una lezione di pastorale liturgica rivolta ai musicisti, perché lavorino in sintonia culturale, per l’orecchio liturgico-musicale dei loro contemporanei. Coscientemente abbiamo ripudiato il concetto di “musica sacra” ma di fatto abbiamo mantenuto la posizione nel recinto, nel sacro recinto di cui le nostre liturgie sono ancora lo specchio, trasudanti sacralità religiosa e ammiccamenti impliciti ad un uso liturgico che ci ha segnato profondamente come cultura occidentale, europea, romana per un millennio almeno. Mille anni come un solo giorno.
Non ci si sveste facilmente di un abito prezioso anche se logoro. Le nostre vecchie pianete sono lise, il carico dei ricami d’oro ha strappato il tessuto togliendogli la funzionalità di indumento, anzi di corazza. E se ci convinciamo che il mondo ha preso culturalmente altra direzione, perché facciamo fatica ad approntare liturgia, riti, canti pret à porter? Che non vuol dire maniera sciatta e di poco gusto e qualità! È semmai la sfida per un’eleganza contemporanea che nel campo delle arti ha cercato con fatica altri modelli più intelligibili e più vicini alla sensibilità antropica postmoderna, emergendo sulle brutture che inevitabilmente cercano di farsi strada in tempi di crisi. In architettura, per tentare omologazione, abbiamo compreso che il modello templare dell’edificio chiesa era da deculturare senza rimpianti, perché in distonia, in dis-accordo col Vangelo. Anche l’architettura liturgica è in ricerca, ma la nozione templare è ancora nel dna degli architetti, e dei committenti che dirigono il tiro sempre in quella direzione … e che dire dei vescovi italiani che hanno approntato norme per l’edificazione degli edifici di culto e gli adattamenti liturgici dei vecchi impianti che sono teologicamente ineccepibili, e poi, singolarmente, nelle loro Diocesi, fanno come possono o come gli pare…
Cosa accadrà con la globalizzazione in un prossimo futuro? Le culture saranno davvero superate? gli spazi vitali dei popoli potranno essere livellati? La lingua inglese diventerà l’unica lingua planetaria? E le altre, i dialetti, gli infiniti dialetti culturali e sub-culturali? E le arti? … Fantascienza! Più d’un’opera cinematografica, recentemente, si è cimentata in esemplificazioni di fanta-antropologia culturale, mostrando come imboccare la strada del modello unico è operazione quanto mai disumanizzante e catastrofica nei suoi esiti. Tutti i modelli esclusivi, la storia è là a dimostrarlo, sono stati deleteri e criminali, dispotici e disumanizzanti. Adesso, con molto ritardo, ci ricordiamo degli Armeni che hanno rischiato di scomparire e che nonostante le pesanti prove hanno conservato il loro bellissimo Rito sopravvissuto in virtù della risorsa della lingua e degli usi di quel popolo. Comprendiamo, dunque, che questo discorso livellante non potrà valere per le arti, né tanto meno per la musica liturgica col suo canto. Credo che l’apice della follia consista nel pensare di poter progettare una religione universale, aconfessionale, con liturgia unica. Molti blaterano in questo senso, facendo anche riferimento ad un mitico umanesimo, altro tema col quale da parecchio tempo ci riempiremo la bocca; ma per parlare di umanesimo bisogna davvero conoscere l’uomo, e non in astratto, nel suo fare culturale e cultuale … e capire che si tratta soltanto di sogni … contro la realtà. Sarebbe la restaurazione del sacro cui tanti intellettuali d’avanguardia e atei devoti sembrano affezionati.
Resta il fatto che il popolo cristiano non canta più e se canta e quando canta, canta male. Dis-accordo? Dis-armonia? È difficile cantare in regime di diaspora, in assenza di libertà! Ricordiamo la situazione degli Israeliti a Babilonia illustrata dal salmo 136 (137): sui fiumi di Babilonia avevano perso l’entusiasmo e appesero le cetre ai salici. Non vollero più cantare. Il salmo descrive un’esperienza antropologica limite ma reale e concreta. Esperienza culturalmente ripresa e genialmente rappresentata da Giuseppe Verdi nel suo Va pensiero, un canto che simboleggiò per la cultura italiana del suo tempo, col Nabucco, l’anelito alla liberazione dall’oppressione straniera; non tanto per la sola bellezza della musica ma per l’unione ipostatica di essa con il testo, unione che ancora oggi si può leggere come simbolo dell’identità italiana, molto più che nell’inno di Mameli musicato da Novaro il cui testo è linguisticamente poco comprensibile essendo culturalmente inattuale.
E con questo esempio si introduce il discorso della forza ipostatica, plasmatrice di persona e personalità, che corrobora l’unione tra logos e melos: in ordine all’autonomia culturale delle Chiese cristiane nell’esprimere la loro fede in sintonia culturale. È un tema difficile, che necessita di essere approfondito per uscire non tanto dall’impasse delle polemiche stupide che ancora stridono sui siti web di liturgia dei cattolici fondamentalisti; questo sarebbe il meno, sapendo – o forse non sapendo – che la cultura, che ha a che fare col coltivare la terra, è umile, nasce dall’humus, dalla terra stessa, dal basso, e non dalle teorie studiate a tavolino da inconsapevoli – che è un eufemismo per dire ignoranti – paladini che si ritengono unici custodi dell’ortodossia. Ed è proprio l’ortodossia, che significa “retta lode”, la discriminante: retta lode come retta dottrina, non viceversa. La lode come fatto immediato, che esplode come rendimento di grazie a Dio nella propria lingua, con la propria musica, con gli strumenti culturali che si padroneggiano in quanto usuali, comuni, pronti all’uso, senza artifici, senza necessità di mediazioni linguistiche e allosemiotiche. E anche il canto e la musica sono segni e simboli germinati dall’humus culturale, per i cristiani ecclesiale-comunitario.
Più importante è uscire dall’impasse del silenzio del popolo di Dio che sembra vivere una sorta di condizione di esilio babilonese, per cui non canta, ha deciso di non cantare. Si sente forse in terra straniera? O il suo simbolo è stato infranto, tanto che il logos cristiano non trova il melos che gli dia voce? Che dia voce profonda alla sua significazione, perché la musica tocca le profondità dell’animo e arriva in zone di sensibilità dove nessun altro può arrivare. Ma può anche darsi che a questo popolo manchi tout court il logos come Parola di Dio, educato com’è stato a preghierine devozionali e pie, introspettive e isolanti. Isolanti da Dio, in quanto risposte insufficienti alle domande fondamentali della vita poste in essere con forza dalla sua Parola. Isolanti dai fratelli ritenuti non necessari all’esercizio di una comune interazione nella carità che il Vangelo, invece, mette fortemente in luce. Al posto della Bibbia, dei Salmi, abbiamo dato al popolo di Dio Massime eterne, che a quanto pare hanno un momento di revival editoriale.
Ripeto le domande alla luce di queste mie inattuali provocazioni: Ma quale musica, quale universo sonoro in cui sentirsi a casa, quale nost-algia, quale entusiasmo, quale tradizione? Non è che non si canta per il banale motivo che non si ha niente da cantare, che le Massime eterne non si possono cantare? E non mi riferisco alla mancanza di repertorio; mi riferisco all’oscurità del cuore, al suo silenzio, all’assenza di “entusiasmo” che vuol dire, in duplice accezione etimologica: en Thèos, Dio dentro, o/e en thusia, sacrificio da dentro, sacrificio interiore, il sacrificio di lode di cui parla la Bibbia, da cui il canto. La gioia di sentirsi dentro un evento – sia soggettivamente che oggettivamente – fa esplodere il canto per la gioia di una situazione nuova e favorevole, un kairòs irripetibile da condividere con altri. Un momento che diventa la vera casa in cui abitare, la vera patria di cui avere nostalgia: ricordo doloroso quando manca. E quando non c’è non si può cantare.
È mancata senz’altro, al popolo cristiano, al cattolico almeno, l’esperienza di forte coinvolgimento del cantare insieme la gioia dell’essere popolo di Dio redento, liberato, rinnovato. Un sentimento soffocato dall’intimismo sacrale e dall’iper-ritualismo che non cessa nonostante la riforma, e che non ha lasciato spazio al canto come forma autonoma di culto. Non cominciò forse così il culto cristiano? Un minimo rituale e poi «salmi, inni e cantici spirituali» [23]. La riforma protestante ha recuperato tale paradigma, e si sente. L’acculturazione liturgica, già stabilizzata in Germania per motivi geografico-culturali, tira fuori i cattolici dalla congiura del silenzio e instaura un ecumenismo dal basso, provocando benefici effetti anche sulle Chiese della Riforma che vanno rivalutando la celebrazione eucaristica e il senso della liturgia con intelligenza teologica e maturità ecclesiale. Che tutto possa ripartire dalla musica, dal canto? Dall’armonico e variegato universo sonoro dell’unica Chiesa? Per l’effetto sinfonico di profezia escatologica?
Che l’universo sonoro cristiano si costituisca dell’amalgama indistricabile di logos e melos non occorre più dimostrarlo. Nel culto cristiano l’annuncio della Parola di salvezza occupa senz’altro il posto essenziale; e si modula seguendo una variegata iride di poetiche sonore e verbali. Il rapporto tra le parole e i loro toni trova continuamente sfumature nuove, tanto che queste si fanno musicali. Pensiamo a come dovettero essere proclamati, o cantillati, secondo i moduli della religiosità ebraica, il Benedictus, il Magnificat, il Nunc dimittis, solo per citare i cantici lucani. Quei cantici sgorgarono dal cuore di Zaccaria, di Maria, di Simeone perché Dio aveva riempito, finalmente, la loro vita. In quella tradizione non c’è, ancora oggi, soluzione di continuità tra parole e musica. Così la liturgia cristiana percorre tutta la gamma delle possibilità umane di parola e di musica, per offrire a coloro che celebrano una grande variegazione di atteggiamenti spirituali davanti al mistero, dicibile per quanto si può col dire umano.
Si comincia dal sussurro che nasce dal profondo dell’essere come gemito di benessere, di gioco, di preghiera; la preghiera che si realizza e si interiorizza esprimendosi. Un esempio rituale è il Padre nostro della messa sussurrato a mezza voce da tutta l’assemblea; l’appropriazione individuale delle parole si fa corale e diviene azione liturgica esemplare, di popolo che proclama l’unica preghiera insegnataci da Gesù il Salvatore. Si entra così nei moduli delle recitazioni collettive (gloria, credo, etc.) che per essere dignitose devono necessariamente trovare un ritmo e una nota stabile nella scala sonora, altrimenti non solo diventano insignificanti ma nuotano nel caos babelico degli individualismi. Le parole sono sempre “a toni”, utili a esprimere sensazioni! pensiamo a quando leviamo un gemito (ahi!) o facciamo un’esclamazione gioiosa (evviva!) o leviamo un lamento (povero me!) o esprimiamo un’ovazione (bravo!) … non esiste per queste espressioni il retto tono, il tono mono-tono; viene fuori una serie di suoni ad altezze diverse, un ritmo, un impegno del fiato; a volte si aggiunge una carica affettiva con ripetizione ritmica, specie in raduni di massa o nelle liturgie sportive: Bra-vo! bra-vo! Parole decise, forti, non bisbigliate e talvolta gridate o cantate (aleeee-ho-ho) [24].
La musica, dunque, nasce dalla parola per renderne più efficace l’espressione emotiva. Nella liturgia abbiamo Amen, Alleluia, Maranathà, parole chiave del culto cristiano che non sono state neanche tradotte dall’ebraico. Ricordiamo come vengono proclamate stando all’Apocalisse? Il grido dei redenti è «come il fragore di grandi acque» (Ap 19, 6), perché è la stessa voce di Cristo che Giovanni, nella visione iniziale, che descrive l’apertura della grande liturgia, percepisce proprio «come il fragore di grandi acque» (Ap 1,15). L’approccio all’esperienza di Dio può iniziare in maniera sacrale, individuale, come nel caso di Elia che lo percepisce, nella solitudine del monte, come «il sussurro di una brezza leggera» (1 Re 19, 12), anche se l’originale ebraico è più pregnante: qôl demāmāh daqqāh che Lévinas traduce «une voix de fin silence», ossia una voce di silenzio sottile [25]. Ed è l’esperienza sacrale, che induce a prostrarsi coprendosi il volto, ma è soltanto l’inizio di un esodo da sé che conduce alla liturgia corale apocalittica e salvifica il cui suono è paragonabile al «fragore di grandi acque». Con ciò stesso viene descritto il lungo cammino, un lungo esodo dalla sacralità alla santità.
La liturgia non è dunque il luogo della preghiera personale, che si può fare, chiusa la porta, nel segreto della propria camera o nell’incavo della caverna di Elia. Non è il luogo della riservatezza, è luogo parusaico, luogo di popolo acclamante e festante che risponde al suo Dio, che è il Dio di Gesù Cristo, con la stessa voce di Gesù Cristo. È difficile riscoprire questa dimensione dopo secoli di messe “private” e “ascoltate” in ginocchio e col capo chino in una cappella semideserta dove il contatto col proximus era da evitare il più possibile in ordine al “raccoglimento” individuale. Temi e atteggiamenti retaggio della Devotio moderna che cresciuta nel clima del nascente umanesimo privilegiava una spiritualità individualistica a scapito di quella comunitaria. Il grido liturgico invece scaturisce da una situazione cultuale che guarda all’uomo come essere culturale, ogni uomo e ogni donna capaci di esprimere ritualmente il loro rinnovamento antropologico e quindi spirituale hic et nunc, nell’hodie salvifico tanto caro a Leone Magno. Se siamo in grado di gridare ad un uomo qualsiasi “bravo, bravo”, perché non sappiamo gridare a Dio “alleluia, alleluia”? Per pudore, per paura di essere giudicati? E quando gli chiediamo perdono che intensità sonora ha l’espressione greca Kyrie eleison? Che intensità hanno le risposte ai saluti liturgici o alle intenzioni di preghiera, o il semplice amen prima di ricevere l’eucaristia?
Ci si dirige, così, nell’ambito di ciò che la musicologia liturgica ha chiamato verbo-melodismo, la simbiosi più profonda tra logos e melos, tra parola e melodia: in un accostamento per cui la melodia non è più separabile dalle parole. Ogni sillaba riceve dal melos il timbro, la durata, l’altezza, l’intensità. La musica non utilizza le sillabe del testo per sfruttarle a proprio vantaggio: si fa tutt’uno con le parole della preghiera dando origine alla lode, all’invocazione, alla supplica. Ma il primato deve spettare sempre alla parola. Questo è peculiare del culto cristiano, dove alla musica si chiede solo di rivestire la parola per preservarla da equivoci di ferialità e caratterizzarla in tutta la sua significazione, col ritmo o “numero” che tenta di rallentare la sua esistenza fuggevole e col “melos” che imprime nelle menti e negli animi i sentimenti che ne sprigionano. Il funzionale linguaggio comune, strettamente “informatico”, è aborrito dal rito cristiano che chiede alla musica di commentare appositivamente la Parola elevandosi alla “dominante” del mistero celebrato, per sviluppare «una diatonia che è il suo spazio di libertà e di giubilo» [26]. Difatti il dire della parola nella liturgia è più che enunciare una nozione; è semmai enunciare la Sapienza che il mashal della letteratura biblica fa consistere in un proverbio ritmico-melodico. Si tratta dell’annuncio che proviene da una sapienza operativa, in quanto nell’ebraico «dabar» (parola) significa ora «dire» e ora «fare», insieme ad uno stuolo di significati collaterali, come «cosa, oggetto, evento, comandamento, rivelazione».
Il grande liturgista, musicista e musicologo, il gesuita Joseph Gelineau che ho avuto la fortuna di avere come maestro, lo dice chiaramente, nell’ancora insuperata opera analitica Canto e musica nel culto cristiano che uscì quasi a ridosso della conclusione del Concilio: che il connubio logos-melos è peculiare del culto cristiano e che
«in ciò si distingue nettamente dalle altre religioni. I riti magici fanno volentieri uso, negli incantesimi, del suono di strumenti soli; si conoscono anche i lunghi vocalizzi sulle vocali mistiche in uso presso gli gnostici del III secolo. La liturgia cristiana contrasta con tali pratiche cariche di tutta l’ambiguità implicata nei segni naturali del sacro: è infatti religione rivelata e culto spirituale» [27].
E mi soffermo ancora su «i segni naturali del sacro» che con tutta la carica di ambiguità implicita trasformano la liturgia cristiana in “bella cerimonia”, con apparati scenici e musiche d’autore. Cosa impedisce si possano eseguire le classiche marce nuziali di Wagner, Mendelssohn, Elgar anche nei matrimoni civili celebrati in Comune? Nulla! Di fatto non hanno nessuna connotazione cristiana, essendo carenti di Parola. Forniscono aura di sacralità al matrimonio come atto naturale dell’antropo, lo solennizzano come “cerimonia” pur importante del convivere civile, rito di passaggio carico di una religiosità naturale, laico nell’accezione più ampia del termine. Eppure, guai a negare l’esecuzione di tali ormai “immortali” marce per la liturgia del matrimonio cristiano, dove di solito di canti non se ne eseguono e se qualcuno se ne esegue è affidato a qualche soprano o a qualche tenore in esecuzione solistica, come l’Ave Maria di Schubert, un pezzo che faceva parte di sette lieder su testi di Walter Scott tratti dal suo poema The Lady of the Lake e che il musicista dedicò alla contessa Sophie Weissenwolff. Al testo tedesco è stato sostituito, con un certo impaccio, quello latino dell’Ave Maria le cui sillabe non collimano con l’andamento melodico che ne supportava uno dalla fonìa e lunghezza del tutto differenti. La musica è indubbiamente sublime e affascinante, ma la liturgia patisce violenza, anche perché l’esecuzione dell’Ave Maria in canto è ammessa solo per una liturgia mariana e non può costituire orpello “devozionale” di ogni azione liturgica. Bisognerebbe ricordare – a chierici e laici – l’assioma che la liturgia, quando è vera, si regge da sé e non ha bisogno di stampelle devozionali. E comunque lo specificava ancora padre Gelineau che nella liturgia cristiana «non si trova mai che un rito propriamente detto sia musica pura, vocalizzo senza parole, o semplice suono di una strumento». Si salva il suono delle campane che però «è più un segnale d’avviso che un fatto musicale» [28].
Accenno adesso soltanto ad un altro fattore che mortifica la relazione teologica logos-melos e che risiede nei testi dei canti approntati nel postconcilio sulla scorta di quelli della tradizione popolare che esistevano anche prima e che traducevano la devozione religiosa del popolo cristiano che essendo stato esiliato da una liturgia tutta clericale si “vendicò” creando i suoi riti e i suoi canti rimasti paralleli a quelli liturgici e con testi di dubbia ortodossia, più espressione di individuali sentimenti religiosi del “poeta” che dell’appartenenza ecclesiale dei fedeli. Il discorso potrebbe diventare troppo lungo e richiamo, in questa sede, soltanto la questione complessa che si chiama “repertorio”, ove si esige consonanza tra il mistero celebrato nei tempi liturgici e i canti che alla Parola proclamata in quei tempi devono fare riferimento. Canti che devono farsi sempre illustrazione dei temi che la Parola propone e sviluppa, in coerenza significativa e didattica, perché tutto sia orientato all’intelligenza dei fedeli e alla loro edificazione spirituale. Non è un lavoro semplice, ma sono passati ben sessant’anni dall’inizio della riforma liturgica e siamo ancora all’alba. Per tentare di rimediare alla lacuna utilizziamo ancora canti passepartout, in onda da decenni, la cui inconsistenza letteraria è pari soltanto alla banalità della musica. Ciò che pur è stato prodotto di significativo e di esteticamente soddisfacente in questi lunghi anni è segnato però da un certo accademismo: musica colta, di spessore qualitativo, con testi pregevoli attinenti alla funzionalità liturgica, ma impraticabili ai più perché richiedenti competenze tecniche specifiche dei cori e degli esecutori musicali, col risultato che le Scholae cantorum, laddove ci sono e degne di questo nome, usurpano totalmente i ruoli del ministero del canto dell’assemblea, dando luogo a esemplari spettacoli canori nella liturgia. E il popolo di Dio muto! Se ne ha un’idea assistendo alle celebrazioni del papa in san Pietro animate dal celebre Coro della Sistina.
Si può ridar voce a questo popolo che ha appeso le cetre ai salici dell’esilio? La riforma liturgica è stata promossa all’insegna della partecipazione attiva dei fedeli all’azione rituale, e perciò al canto. «Se si tratta non soltanto di ascoltare, ma di prendere parte al canto come “attori” ed esecutori, ne segue che la musica deve essere “praticabile” per la media dei fedeli radunati» sentenzia padre Gelineau, ponendo poi in campo un’altra questione complementare:
«In linea di principio è chiaro che la Chiesa debba oggi esprimersi musicalmente con il linguaggio musicale del nostro tempo. Non è forse vero che costruiamo oggi delle chiese con i mezzi dell’architettura moderna? Rimane però da precisare qual è il “linguaggio musicale del nostro tempo”, e c’è poi da chiedersi se il punto di vista dei compositori contemporanei è compatibile con le esigenze interne della celebrazione liturgica odierna» [29].
La risposta a questi nodali interrogativi formulati circa cinquant’anni fa ha ricevuto solo parziali risposte: per un verso dalla musica liturgica aulica, colta, di difficile esecuzione e che gli stessi autori esibiscono in ben remunerati concerti; dall’altro dalle canzonette popolari, povere nei testi e impacciate in qualche giro di accordi grattati sulla chitarra. Tra le due posizioni estreme se ne impone una media che comporti una bella praticabilità melodica per i fedeli con linguaggio musicale che si sappia adagiare sulla musicalità del logos senza violentarla, consentendogli di incarnarsi nell’oggi. Se consideriamo che le grandi tradizioni liturgiche cristiane, nel loro insieme, sul nascere hanno utilizzato stilemi della loro contemporaneità, formule che poi, sacralizzate, sono rimaste immutate per secoli, è davvero impensabile oggi proporne di nuovi, dal momento che le lingue nazionali hanno soppiantato le lingue liturgiche antiche – sacralizzate anch’esse in Oriente come in Occidente – col risultato di sonorità diverse anche del parlato, della modulazione musicale del parlato, come abbiamo su accennato, della sua cantillazione e della sua melodizzazione? In casa nostra, lo sappiamo, il gregoriano fu il frutto della fusione del melos con la lingua latina; sappiamo anche per esperienza che utilizzare i moduli gregoriani con le lingue nazionali non funziona.
Penso al canto dei salmi in italiano con i toni gregoriani che non conosciamo o conosciamo poco o non conosciamo per niente nella loro flessibilità e varietà degli explicit di ogni tono da applicare al genere letterario del salmo e alla composizione sillabica delle sue strofe. Tra i moduli salmodici nuovi in circolazione ce ne sono veramente pochi che si salvano. Intervalli strani e banali li caratterizzano per la maggior parte; problemi con le flexae; gli autori padroneggiano poco il salterio e le sue profondità spirituali e letterarie, e approntare tre o quattro moduli non vuol dire nulla per coprire la ricchezza dei generi letterari del salterio. Qualcosa di interessante, dignitoso, moderno, si può ascoltare a Bose, dove però hanno prima provveduto alla redazione di una versione poetica del salterio, nella piena consapevolezza della relazione osmotica logos-melos; relazione che nella traduzione ultima della CEI secondo i criteri di Liturgiam autenticam [30] non si coglie, col risultato di salmi incantabili. Per Bose si tratta del raro esempio di una comunità cristiana che ha fondato la propria esperienza di fede sulla Parola celebrata nella liturgia e nella vita. Stessa cosa si potrebbe dire della Comunità ecumenica di Taizè la cui liturgia è la sintesi di diverse tradizioni liturgiche e confessionali offerta con un linguaggio nuovo e semplice per liturgie che hanno sempre carattere internazionale e sovraeuropeo.
Scrivendo La liturgia domani padre Gelineau si interrogava cinquant’anni fa sul futuro, quando aveva già individuato le piste su cui canto e musica avrebbero dovuto viaggiare fino al presente. Tanti imprevisti culturali hanno scompaginato quegli itinerari, tutti dipendenti da un fenomeno che sembrava allora di portata impensabile: l’esistenza della cultura cristiana, col suo culto, «in una società secolarizzata dove Dio è assente» [31]. Negli ultimi scorsi anni alcuni hanno pensato di fronteggiare il fenomeno – e forse si sono illusi di arginarlo – risacralizzando la liturgia, rimettendo in gioco reperti archeologici e forme di ritualità che il Concilio aveva giudicato culturalmente inefficaci alla confessione e all’espressione della fede di cui la liturgia è fonte. Credo che per il futuro liturgico di questa Chiesa in subbuglio, squassata da scandali e divisioni la liturgia, che è il cuore pulsante della Chiesa, dovrà perdere le sue false sicurezze di natura sacrale e avviarsi sulla via dell’incarnazione e dell’umanizzazione, così come il Concilio aveva profetizzato. «La santità della liturgia si mostrerà nella sua umanità, così come la divinità di Cristo si è rivelata nella sua umanità». Solo così potrà «rendere presente Dio in una società senza Dio», quando una piccola comunità radunata in un luogo si raccoglierà in preghiera nel giorno del Signore per cantare le sue lodi [32].
C’è speranza di poter integrare la musica contemporanea nel progetto liturgico non sacrale? Chi saprà comporre musica che proietti verso nuovi spazi spirituali con segnali sonori non ancora uditi per far risuonare inaudita la Parola? O rivisitare musica non necessariamente inedita come linguaggio, né troppo difficile da eseguire, che possa assumere valore simbolico dove tutti possano riconoscersi? Una musica non piena di sé, ma capace di accogliere la fecondità silenziosa dello Spirito mettendosi come Maria in atteggiamento ancillare per l’accoglienza del Verbo e prorompere poi nel Magnificat?
Non sarà sicuramente il rock a poterci aiutare, in quanto troppo pieno dei suoi rumori per aprirsi al silenzio cui la musica dello spirito orienta ed anela; né, credo, potremo trovare le caratteristiche giuste nel rap che farebbe un po’ singhiozzare il testo da cantillare… dovremo chiamare in causa il genere leggero, il folk o il pop? Non azzardo una risposta! Dovrò chiedere consiglio al mio ex compagno di seminario, il vescovo Tonino Staglianò, da qualche tempo impegnato in quell’impresa che lui ha chiamato «Pop-Theology», per avvicinare il messaggio cristiano alle nuove sensibilità umane e alle nuove generazioni. Non sarebbe male, e le premesse ci sono tutte, pensare ad una «Pop-Liturgy»; non solo le premesse culturali, ma anche quelle teologiche: non è forse la lex orandi a fondamento della lex credendi?
Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023
Note
[1] Testo fondamentale, per chi volesse conoscerne nei dettagli la storia, è il “diario” di dom Bernard Botte (1893-1980), benedettino belga del monastero di Mont César, che fu uno dei protagonisti: Il Movimento liturgico, Effata’ editrice, Cantalupa (TO) 2009.
[2] Dal greco λειτουργία, (leito-urgìa), servizio pubblico; composta da λήιτον (léiton), popolare (da laós, popolo) e da ἔργον (èrgon), opera (verbo ergà-zomai, opero, faccio). Letteralmente: opera in favore del popolo.
[3] Aristotele, Politica, VIII, 7, 134 b 30 sgg.
[4] Ho affrontato l’argomento nell’articolo Può dirsi “sacra” l’arte cristiana? sul n. 57 di «Dialoghi Mediterranei».
[5] E. Cassirer, Saggio sull’uomo. Una introduzione alla filosofia della cultura umana, Armando Editore, Milano 2004: 80-81.
[6] M. Donà, Filosofia della musica, Bompiani, Milano 2006: 63.
[7] Cf. A. N. Terrin, Rito e musica nel mondo delle religioni, in Aldo Natale Terrin (a cura di), Musica per la liturgia. Presupposti per una fruttuosa interazione, Messaggero ed., Padova 1996: 44.
[8] G. Dorfles, Il divenire delle arti. Ricognizione nei linguaggi artistici, Bompiani, Milano 1996: 169.
[9] Novità estetica esplicitata nel mio stesso articolo citato qui alla nota [4].
[10] Cf. M. Donà, cit.: 55.
[11] Cf. U. Eco, Il problema estetico in Tommaso d’ Aquino, Bompiani, Milano 1982: 121 sgg.
[12] A. Agostino, Confessiones X, 33.
[13] Per questo si rimanda allo studio di Gerd Theissen, La dinamica rituale dei sacramenti nel cristianesimo primitivo. Da azioni simboliche a riti misterici, Cittadella Editrice, Assisi/Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Roma, 2013.
[14] R. Guardini, Persona e personalità, Morcelliana, Brescia 2006, cit. in C. Giaccardi e M. Magatti, La scommessa cattolica, Il Mulino, Bologna 2019: 189.
[15] Cf. La Costituzione apostolica Sacrosanctum Concilium sulla sacra liturgia del Concilio Ecumenico Vaticano II, n. 112. D’ora in poi SC.
[16] Ho trattato l’argomento nel IV capitolo del mio libro Liturgia medievale per la chiesa postmoderna? La questione del “rito antico” nel racconto del “rito romano”, Feeria, Panzano in Chianti (FI), 2013: 133-196.
[17] L’inno All people that on earth do dwell scritto da William Kethe († 1594), basato sul Salmo 100, è impostato sulla melodia Old Hundredt del Salterio ginevrino (1551) arrangiato da Ralph Vaughan Williams (1872-1958). È nel repertorio del coro dell’Abbazia di Westminster: https://www.youtube.com/watch?v=X-1dQ8t03mE
[18] Cf. J. Gelineau, Canto e musica nel culto cristiano, LDC, Torino 1963: 339.
[19] R. Guardini, Lo spirito della liturgia, Morcelliana, Brescia 1980: 72.
[20] SC 18. 23.
[21] Il tema del “clima esistenziale” l’ho sviluppato nel mio libro, Liturgia secondo Gesù. Originalità e specificità del culto cristiano, Feeria, Panzano in Chianti (FI) 2003: 223-229.
[22] Cf. L. Di Simone, Liturgia medievale per la chiesa postmoderna?, cit.:176-182, ove si tratta la questione dei “riti cinesi” in cui Matteo Ricci fu protagonista.
[23] Cf. Ef 5,19; Col 3,16: ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς πνευματικαῖς
[24] Cf. J. Gelineau, Canto e musica nel culto cristiano, cit.: 23-33.
[25] E. Lévinas, L’au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques, Éd. de Minuit, Paris 1982, 209-220 (qui 211).
[26] Cf. F. Cassingena-Trévedy, La liturgia. Arte e mestiere, Ed Qiqajon Comunità di Bose, Magnano (BI) 2011: 115.
[27] J. Gelineau, Canto e musica nel culto cristiano, cit.: 62-63
[28] Ivi: 62.
[29] J. Gelineau, La liturgia domani, Queriniana, Brescia 1976: 80.
[30] Liturgiam authenticam è la quinta istruzione che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha promulgato il 28 marzo 2001. L’ istruzione si occupa essenzialmente di una questione: stabilire i “criteri” per una traduzione dal latino alle diverse lingue parlate nella Chiesa cattolica. Il grosso limite dell’istruzione consiste nell’imporre ai traduttori una traduzione pressoché letterale dei testi liturgici, sia scritturistici che eucologici, ciò che li rende ostici, involuti e a volte incomprensibili nelle lingue parlate. È difficile tradurre dal latino parole e concetti senza l’uso di sinonimi e di perifrasi. I testi liturgici devono anche possedere lo stesso cursus musicale che hanno in latino e che una traduzione letterale prosaicizza. Da più parti si sono levate proteste contro la criteriologia molto discutibile del documento.
[31] G. Boselli, Celebrare da cristiani nell’età secolare, in E. Bianchi – G. Boselli, Il vangelo celebrato, San Paolo, Milano 2017: 265.
[32] Ivi: 169. 265.
__________________________________________________________________________________
Leo Di Simone, teologo, scrittore, esperto di musica liturgica e di arte sacra, ha insegnato Antropologia culturale e Liturgia presso la Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo), l’Istituto di Scienze Religiose di Mazara del Vallo e l’Istituto Teologico di Scutari (Albania). È presbitero della Diocesi di Mazara del Vallo e docente stabile di teologia presso la Scuola Diocesana di Teologia. Nella stessa Diocesi coordina il progetto “Operatori di pace” e dirige l’Ufficio Diocesano per i Migranti. Attualmente è Referente diocesano per il Sinodo dei Vescovi. Tra le sue pubblicazioni, si segnalano i seguenti volumi, editi da Feeria (Panzano in Chianti – Firenze): Liturgia secondo Gesù. Originalità e specificità del culto cristiano. Per il ritorno a una liturgia più evangelica (2003); Vexilla Regis. La croce dipinta di Mazara del Vallo. Icona pasquale della liturgia (2004); Beato Angelico. L’estetica del Verbo incarnato (2004); Le rotte dei Misteri. La cultura mediterranea da Dioniso al Crocifisso (2008); Liturgia medievale per la Chiesa postmoderna? La questione del “rito antico” nel racconto del “rito romano” (2013). Ha curato, per i tipi de Il Colombre, il volume Trasfigurazione. La Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo. Culto Arte e Storia (2006). L’ultimo suo volume è un saggio biografico su Thomas Merton: Il romanzo di Thomas Merton. Un umanista cristiano nell’era postcristiana, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani (2018).
______________________________________________________________


















