«Codardo è chi ha paura della morte».
«No, chi ha paura della vita».
Sul sottilissimo filo tra vita e morte, realtà e sogno, danza con grazia e armonia il film Humma al-bahr al-mutawassit (“Febbre mediterranea”, 2022) [1]. Se la prima affermazione dell’intestazione sembrerebbe un implicito inno al martirio, un immolarsi al servizio di un ideale patriottico, la replica ad essa evocherebbe invece una forma di resistenza diversa dalla tentazione dell’autoannientamento. Il primo interrogativo che sorge spontaneo è dunque: quale di queste due soluzioni emerge dal film?
Nel secondo lungometraggio della palestinese Maha Hajj [2], che ne cura anche la geniale sceneggiatura, vincitrice del premio “Un certain regard” al festival di Cannes dell’anno scorso, il conflitto che dal 1948 infiamma in Palestina viaggia ad un’apparente bassa, anzi bassissima intensità, e la febbre del titolo rimanda metaforicamente ad una reazione del corpo (palestinese) che si starebbe difendendo da un’“infezione” [3].
Febbre mediterranea è ambientato in Palestina, quasi interamente a Hayfa, città che ha pagato a caro prezzo la prima guerra arabo-israeliana, con l’esodo massiccio di centinaia di migliaia di palestinesi nella primavera del 1948, la cosiddetta nakba. Dopo tale catastrofe e la conseguente annessione allo Stato sionista, la città continua ad esser abitata da migliaia di palestinesi, ma a distanza di decenni le nuove generazioni di arabi sono attualmente combattute tra la difesa dei valori della Resistenza e l’assimilazione ai modelli di vita dello Stato sionista, compresa l’adozione, anche volontaria, della lingua ebraica.
La bravura della regista consiste nell’affrontare il tema vita/morte, trascendendo, ma solo in apparenza, la questione palestinese, e creando in ogni caso un dramma universale ed esistenzialista sull’insostenibile pesantezza dello stare al mondo, in qualsiasi parte del mondo, e sulla disperata resistenza alla cancellazione dalla storia. Hajj costruisce la solida impalcatura della sua opera sulle dinamiche di un discorso sull’amicizia, declinato attraverso i due protagonisti del film, Walid e Jalal, per poi riapprodare al summenzionato tema centrale.
Walid è un placido marito casalingo che sogna di diventare uno scrittore famoso ma non trova alcuna fonte d’ispirazione per il suo primo romanzo. È afflitto da una cronica forma di depressione che lo rende schivo dei rapporti umani, anche all’interno della sua famiglia di origine. È comunque un fedele marito nonché padre affettuoso dei suoi due figli. La maggiore è un’adolescente che spesso si esprime a casa in ebraico invece che in arabo, e viene per questo da lui rimbrottata. Il più piccolo è affetto da ricorrenti attacchi di una strana febbre che è costante fonte di preoccupazioni per lui e la moglie, una moderna infermiera, l’unica a portare il pane a casa.
La vita di Walid viene scossa dall’arrivo nella palazzina di un esuberante vicino, Jalal, con moglie e figli. Anche lui passa sovente le giornate a casa, tra la musica assordante e le faccende domestiche, o esce fuori a portare i due cani a spasso per i viali del quartiere, oppure si trova coinvolto in loschi affari.
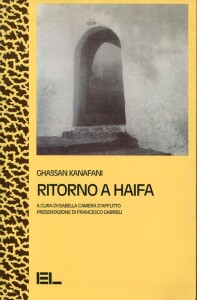 Quello che all’inizio si annuncia come un rapporto conflittuale tra i due si evolve, in maniera inaspettata – considerata la differenza abissale tra gli stili di vita di Walid e Jalal – verso un’amicizia forte. La regista scolpisce i due protagonisti a tutto tondo, anzi si adopera perché uno scolpisca l’altro, in modo speculare. I miti di Walid sono Edward Sa’id, Ghassan Kanafani, proprio l’autore del bestseller ‘A’id ilà Hayfa [4] (“Ritorno a Hayfa”, 1969), il poeta Samih al-Qasim, le cui icone sono appese alla parete della sua scrivania, possibili “numi tutelari” della sua ancora sterile penna. Jalal è invece un patito di poesia araba classica.
Quello che all’inizio si annuncia come un rapporto conflittuale tra i due si evolve, in maniera inaspettata – considerata la differenza abissale tra gli stili di vita di Walid e Jalal – verso un’amicizia forte. La regista scolpisce i due protagonisti a tutto tondo, anzi si adopera perché uno scolpisca l’altro, in modo speculare. I miti di Walid sono Edward Sa’id, Ghassan Kanafani, proprio l’autore del bestseller ‘A’id ilà Hayfa [4] (“Ritorno a Hayfa”, 1969), il poeta Samih al-Qasim, le cui icone sono appese alla parete della sua scrivania, possibili “numi tutelari” della sua ancora sterile penna. Jalal è invece un patito di poesia araba classica.
Il conflitto israelo-palestinese rimane sempre off-screen, oppure è mostrato sugli schermi della tv che Walid segue, tra un sonnellino e qualche faccenda domestica. Egli rivendica con forza un’identità culturale araba che si sforza di inculcare nei suoi figli. Addirittura ha qualche battibecco con Jalal sulla necessità di mantenere la memoria dei toponimi arabi nel territorio.
Memorabile a questo proposito è lo scambio di battute in ebraico nell’ambulatorio medico per far visitare il figlio affetto dalla strana febbre, che potrebbe essere “mediterranea”. Nella scena in cui la dottoressa gli fa riempire un questionario on-line, alla domanda sulla nazionalità lui risponde “araba”, e il sistema del computer accetta “pacificamente” la risposta. Alla successiva, sulla religione, lui si rifiuta di rispondere asserendo che si tratta di una domanda razzista, ma il questionario la ritiene necessaria per andare avanti. A quel punto, come da un cilindro magico, gli esce una risposta palesemente spiazzante: “palestinese”.
L’insostenibile pesantezza dell’esistenza di Walid, compresa l’incapacità di scrivere il suo romanzo, la sua versione della storia, potrebbe essere considerata una reazione all’impotenza nel contrastare la sistematica cancellazione della memoria palestinese? Ne L’essere e il nulla [5], Sartre affermava che l’uomo è quell’essere che «non è che ciò che è ed è ciò che non è» [6], nel senso che egli non è mai immediatamente identico a se stesso, come lo è un oggetto. Per via della sua coscienza deve infatti progettarsi in quanto possibilità, in un’esistenza sempre volta alla propria realizzazione futura, «tentando costantemente di raggiungere i suoi scopi e di identificarsi con essi» [7].
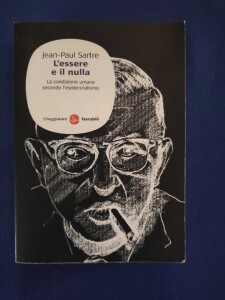 Se si applica il modello sartriano al personaggio di Walid, si direbbe che egli ha perso il senso della sua esistenza proprio in virtù del fatto che vorrebbe identificarsi, nella sua coscienza, con la causa palestinese. Ma basta tale desiderio a fornirgli la legittimità di una tale impegnativa pretesa? Ecco che allora emergono le contraddizioni di un personaggio che appare quietamente disperato e si dichiara quasi fiero della sua decisione di togliersi la vita, perché, a suo avviso, «codardo è chi ha paura della morte». Jalal, che rischia seriamente la pelle nel mondo dei loschi affari e non sembra minimamente coinvolto dalla causa palestinese, gli risponde che è «codardo chi ha paura della vita».
Se si applica il modello sartriano al personaggio di Walid, si direbbe che egli ha perso il senso della sua esistenza proprio in virtù del fatto che vorrebbe identificarsi, nella sua coscienza, con la causa palestinese. Ma basta tale desiderio a fornirgli la legittimità di una tale impegnativa pretesa? Ecco che allora emergono le contraddizioni di un personaggio che appare quietamente disperato e si dichiara quasi fiero della sua decisione di togliersi la vita, perché, a suo avviso, «codardo è chi ha paura della morte». Jalal, che rischia seriamente la pelle nel mondo dei loschi affari e non sembra minimamente coinvolto dalla causa palestinese, gli risponde che è «codardo chi ha paura della vita».
Walid, che era persino arrivato a tessere gli elogi dei Paesi europei dove si pratica l’eutanasia, chiacchierando con un paraplegico che fa difficoltà anche a respirare, è alla disperata ricerca di un killer prezzolato. Chiede a Jalal di procurarglielo, lui che è del mestiere. Quest’ultimo, ancora ignaro del fatto che Walid sia la vittima designata, sbotta spontaneamente: «Perché lo odi così tanto? Perché?».
Il rapporto che si instaura tra i due è costellato di tensioni. Le loro vite, che sembrano correre su due binari paralleli, trovano comunque dei punti d’intersezione, voluti o casuali. Quando Walid rivela a Jalal che si tratta di uccidere lui, la reazione del secondo non è affatto pacifica. Addirittura è convinto che pagando Jalal per togliergli la vita, gli farebbe un grosso favore, visto che lui è pieno di debiti.
Una battuta notturna di caccia insieme all’amico rappresenta la sua ancora di salvezza, la speranza di realizzare il sogno di annientarsi: sarà poi un obiettivo reale o frutto della sua fantasia, magari il testo del romanzo che non riesce a scrivere? Il montaggio delle scene che precedono la battuta di caccia suggerisce due reazioni simili (entrambi piangono), ma partendo da due realtà totalmente opposte: Jalal è troppo invischiato nella vita, compresa quella extramatrimoniale, oltre che nella mala-vita; Walid sembra ormai aver preso le distanze dalla vita e si prepara a dispensare gli addii finali, ovviamente senza destare alcun sospetto. È fin troppo evidente che egli è in balia del suo amico, di cui ha disperato bisogno. Forse perché codardo – è il caso di aggiungere – è chi non ha neanche il coraggio di suicidarsi, sicuramente per evitare il pesante giudizio di condanna che la società infliggerebbe a lui e alla sua famiglia.
 Febbre mediterranea si caratterizza come un dramma sottilmente noir, onirico ed ironico, puntellato da qualche scena surreale che ricorda il cinema di Elia Suleiman, sempre sul tema della morte. Pur trattando in profondità argomenti seri, a tratti riesce anche a strappare qualche sorriso. Se il ritmo della prima parte, almeno fino alla comparsa di Jalal, appare pacifico e soporifero, diventa a poco a poco sempre più incalzante quando più ci si avvicina alla fine.
Febbre mediterranea si caratterizza come un dramma sottilmente noir, onirico ed ironico, puntellato da qualche scena surreale che ricorda il cinema di Elia Suleiman, sempre sul tema della morte. Pur trattando in profondità argomenti seri, a tratti riesce anche a strappare qualche sorriso. Se il ritmo della prima parte, almeno fino alla comparsa di Jalal, appare pacifico e soporifero, diventa a poco a poco sempre più incalzante quando più ci si avvicina alla fine.
Oltre alla posizione della classe media palestinese, colta e non, sui temi dell’identità e della memoria in un’atmosfera apparentemente normale, ma molto alienante, sembra che quello che preme di più alla regista sia l’atteggiamento delle nuove generazioni sugli stessi temi.
Walid viene a scoprire che la febbre del figlio si acuisce ogniqualvolta entra nella classe di geografia. Il colmo è che l’insegnante, addirittura palestinese, aveva affermato che al-Quds (Gerusalemme) è la capitale d’Israele e arriva anche a rimbrottare il figlio che l’aveva considerata capitale della Palestina. Un punto veramente dolente che farebbe esacerbare qualsiasi infiammazione, già latente.
L’auspicio che suscita tale film è che errori del genere e volute distorsioni della storia e geografia mediorientale, presenti anche in numerosi libri di testo in Europa e in Occidente, dalle elementari in poi, possano scatenare una ‘febbre’, magari in tutto il bacino mediterraneo. D’altronde essa dovrebbe essere vista positivamente come reazione dell’apparato cerebrale umano, contro le imposture dettate dall’opprimente propaganda filo-sionista nelle arene culturali europee.
Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023
Note
[1] Coproduzione Francia, Germania, Cipro e Palestina.
[2] Le fonti anglofone riportano la grafia Haj. La regista ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema, lavorando come arredatrice di scena ne al-Zaman al-baqi (“Il tempo che ci rimane”, 2009) di Elia Suleiman. Ha esordito come regista di un lungometraggio nel 2016 con Inyanim ishayim (“Fatti personali”), vincitore del premio come miglior film al Festival internazionale del cinema di Haifa. Dopo che la regista e il produttore hanno accettato di distribuire il film come lungometraggio israeliano, l’Israeli Film Fund ha sostenuto il progetto (notizie estrapolate da Maha Hay- Wikipedia).
[3] La medicina considera la febbre mediterranea una rara sindrome che colpisce i bambini e gli adolescenti, in particolare nei Paesi arabi e della sponda sud del Mediterraneo.
[4] Per capire i risvolti risvolti psicologici della nakba, , oltre a tanti saggi storici, basta leggere il romanzo breve Ritorno a Hayfa di Ghassan Kanafani, tradotto da I. Camera D’afflitto, Roma, Edizioni Lavoro, 2003
[5] Jean Paul Sartre, L’essere e il nulla, Milano, Mondadori, 1958.
[6] Cit. da Simone Brocardo “Morior ergo sum: Sartre al cospetto della morte”, in www.arena.philosophika.it” (consultato in agosto 2023)
[7] Ibidem.
______________________________________________________________
Aldo Nicosia, ricercatore di Lingua e Letteratura Araba all’Università di Bari, è autore de Il cinema arabo (Carocci, 2007) e Il romanzo arabo al cinema (Carocci, 2014). Oltre che sulla settima arte, ha pubblicato articoli su autori della letteratura araba contemporanea (Haydar Haydar, Abulqasim al-Shabbi, Béchir Khraief), sociolinguistica e dialettologia (traduzioni de Le petit prince in arabo algerino, tunisino e marocchino), dinamiche socio-politiche nella Tunisia, Libia ed Egitto pre e post 2011. Nel 2018 ha tradotto per Edizioni Q il romanzo Il concorso di Salwa Bakr, curandone anche la postfazione. Ha curato per Progedit la raccolta Kòshari. Racconti arabi e maltesi (2021).
______________________________________________________________









