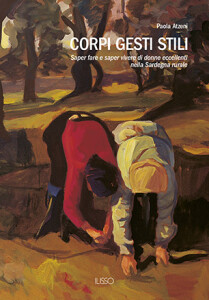Corpi, gesti e stili di Paola Atzeni (Nuoro, Ilisso 2022) è un libro molto bello, anche come oggetto, ma è bello soprattutto nel senso in cui questo aggettivo viene usato a proposito del risultato del proprio lavoro dalle donne intervistate dall’autrice. Bello è per loro un lavoro ben fatto e le sue artefici ne diventano giustamente fiere. E Paola Atzeni deve giustamente essere orgogliosa di questo suo libro, pubblicato in una splendida e lussuosa edizione, che ripropone in modo aggiornato alcune delle sue ricerche realizzate negli anni Ottanta del secolo scorso.
La descrizione etnografica investe in questo volume tipi diversi di lavori rurali di donne che, sfruttando i propri saperi tradizionali, si proiettano verso il futuro in una progettualità consapevole di un loro generale “prendersi cura”: di se stesse, dei propri familiari, degli animali, della natura, dell’ambiente e insieme della società tutta. Era una società che negli anni ’80 era già profondamente cambiata, nel quadro di una economia neoliberista dove saperi tradizionali e residuali convivevano sapientemente con le innovazioni del mondo industriale [1]. Quest’ultimo però ormai, oggi, specialmente in Sardegna, è tanto in crisi da permetterci forse di apprezzare meglio i lavori di queste donne, tipici di un’economia di sussistenza, ma che si rivelano – potremmo dire con espressioni attualmente correnti – “ecologicamente sostenibili”.
Mettendo, fin dal titolo, l’accento sui loro corpi, gesti e stili individuali, il volume presenta dunque il lavoro di «donne eccellenti nella Sardegna rurale», colte nel loro «saper fare e saper vivere», come leggiamo nel sottotitolo. Queste donne, in particolare Angelina e cia Giuannica, intervistate da Atzeni, sono peraltro consapevoli di essere più brave di tante altre nel fare i medesimi lavori. La sulcitana Angelina illustra il ciclo del grano dalla sua preparazione per la molitura (che lei continua a fare in casa, servendosi dell’antica mola sarda mossa da un asino), fino alla produzione dei vari tipi di semola e di farina, compresa la farina più fine e bianca da usare per i dolci delle feste. Solo da alcune delle foto che corredano il volume cogliamo poi anche vari momenti della lavorazione, ovviamente successiva, della pasta per il pane e della confezione dei dolci, senza che però se ne parli in dettaglio. Cia (cioè ‘zia’, come suona nel Sulcis [2] questo appellativo di rispetto) Giuannica è invece dedita a produrre scope a partire dalle palme nane, mentre un gruppo di raccoglitrici di Sènnori (località della Sardegna nordoccidentale, dove si parla una varietà di sardo logudorese settentrionale) lavora alla raccolta stagionale delle olive.
La seconda parte del volume (Poetiche visuali. Evocazioni), è interamente occupata dalle bellissime foto di Marcello Stefanini, autore anche di quelle che, numerose, punteggiano la parte iniziale (Ricerche), in cui Paola Atzeni illustra dettagliatamente il lavoro delle varie donne osservate e intervistate, tornando poi su tali ricerche, con numerosi approfondimenti teorici, nella parte finale (Riflessioni), dove leggiamo anche due brevi ma importanti contributi di Cristina Marras e di Felice Tiragallo. E si può dire che le parti di questo volume si illuminano a vicenda, integrandosi perfettamente nella sua multimodalità. Ci troviamo di fronte, cioè, a un testo compatto fatto della perfetta integrazione di linguaggi diversi entro un medesimo prodotto: c’è il linguaggio verbale e scritto di Paola Atzeni, che fa risuonare il linguaggio orale delle donne studiate, ma che evoca e descrive anche i loro gesti e la loro corporeità, posture e movimenti (a loro volta linguaggi). Il lavoro di queste donne viene descritto a parole, funzionali a farlo quasi vedere passo passo, e queste parole si integrano benissimo sia con schede illustrative e tecniche (come quella che mostra per esempio le diverse parti di una mola), sia con il linguaggio fotografico di Stefanini, che non solo è disseminato nella prima parte, con foto corredate di didascalie, ma che occupa (senza didascalie) le più di settanta pagine della parte centrale del volume, dove l’assenza di didascalie sembra sollecitare il lettore a sfruttare al meglio il loro particolare valore evocativo e non semplicemente documentario.
Queste foto, in sequenze di straordinaria efficacia, mostrano ora le diverse fasi del lavoro, ora la convivenza di strumenti tradizionali e di strumenti nuovi e tecnologicamente avanzati (la mola asinaria e la mototrebbiatrice per esempio), ora ad essere ripresi sono l’ambiente, le abitazioni, la preparazione dei cibi, l’allevamento di animali, la cura dell’orto, il contesto complessivo dunque, dove compaiono anche uomini al lavoro, oltre ad altre donne. Sono foto da guardare attentamente, magari seguendo le piste e il metodo che Felice Tiragallo suggerisce nel suo contributo, dopo avere fatto una breve storia dell’antropologia visiva. E si capisce bene, osservando le foto, come Stefanini fosse tanto partecipe della ricerca di Paola Atzeni da riuscire, con le sue foto, a mettere in evidenza persino il tempo (e i tempi impiegati) e lo spazio occupato dai lavori studiati, permettendo talvolta di far inferire gli intervalli di tempo intercorsi tra uno scatto e l’altro: spesso queste foto possono essere viste in sequenza, se tese a documentare fasi diverse dello stesso lavoro. Vediamo così, per loro tramite, non solo i relativi spazi, ma anche il tempo del lavoro e il tempo del riposo e il tutto è in grande sintonia con quanto durante la ricerca Paola Atzeni rilevava per poi darne conto nella scrittura.
Inoltre, queste foto fanno scoprire anche molte cose che integrano e arricchiscono quanto a parole dice Paola Atzeni, riprendendo e illustrando a sua volta le parole e i discorsi delle sue donne eccellenti, fiere di esserlo, fiere del proprio valore nel lavorare bene e con competenza, sia che controllino la molitura, sia che preparino e setaccino i vari tipi di farina e facciano farra bella (‘farina bella’), sia che costruiscano, anzi ‘tessano’ scope con la palma nana (dopo averla raccolta/selezionata esplorando e percorrendo i campi), sia che raccolgano, in gruppo, le olive.
Quella di queste donne è una competenza tecnica che loro per prime illustrano tecnicamente, dato che a loro, evidentemente dialettofone, sono da ascrivere le tante parole dialettali, veri e propri tecnicismi, che affiorano dalle pagine del volume e che rivelano, a chi non ci avesse mai pensato, che anche le parlate locali sono attraversate dalla variazione, cioè da quel plurilinguismo interno di cui si può legittimamente parlare a proposito dell’insieme delle varietà individuabili entro un medesimo sistema linguistico, per quanto dialettale. E tra questo cumulo di varietà ci sono quelle, selezionate dall’argomento di cui si parli, che chiamiamo “lingue speciali”, legate ai diversi ambiti speciali o specialistici di produzione e lavoro.
Potrebbe essere piuttosto lungo l’elenco di questi tecnicismi, da sistemare in un piccolo glossario per spiegarne i significati. Voglio qui solo citare alcuni dei termini che io stessa in gran parte non conoscevo, pur avendo una elevata competenza del sardo, campidanese in particolare. Espressioni o termini non di uso comune e quotidiano, non facenti parte del vocabolario di base dello stesso dialetto [3], sono dunque quelli che sotto evidenzio, corredandoli di informazioni supplementari:
- quarra sono ‘venti chili di grano’, equivalenti a 8 imbuti, mentre 4 imbuti sono una misura;
- cerri su trigu è la “cernita del grano” fatta con un cirìu (una specie di crivello) di giunco; e ci sono i vari tipi di corbe e canestri, diversi anche nominalmente a seconda della loro funzione (canistus, canisteddus, crobi po su trigu postu a molli, ecc.);
- is temperas spiccano tra le varie parti della mola per la loro funzione centrale e fondamentale. Sono i fermi e le cordicelle che regolano la tramoggia sollevandola quando si vuole ottenere un macinato più grosso o abbassandola per uno più fine. E temperai sa moa, molli beni (‘regolare la mola, macinare bene’) sono azioni fondamentali e centrali, rispetto alle quali ogni donna ha il proprio stile che si coglie sullo sfondo di azioni e saperi comuni;
- la tentua è una specie di semola per friggere il pesce;
- l’azione dello spoddinai è quella per fare le semole (e semole e farine possono essere belle, prodotti di un’etica del lavoro e della cura che si intreccia con l’estetica: non si tratta di un bello gratuito, dato che non si fanno le cose tanto per farle, ma per farle bene, belle e buone, anche per il gusto). In un corpo attento e in tensione, tutti i sensi sono impegnati in questa produzione: la vista per controllare che l’asino proceda bene durante la molitura, l’udito per capire, dal rumore che la mola fa girando, se i fermi vanno sollevati o abbassati, il tatto per controllare la qualità del macinato, eventualmente da ripassare macinandolo ancora, fino al gusto pensando ai dolci delle feste, fatti con il fior di farina: farra bella è su scetti biancu biancu ‘la farina bianchissima’.
Ci sono poi, passando alla produzione di scope:
-su cracchi, la macchia esaminata e percorsa con sguardo acuto da cia Giuannica, che lavora usando su fiettu (una corda legata alla caviglia, che muove con il piede, facendosi quasi telaio lei stessa). In una fierezza che va ben aldilà dei luoghi comuni della stessa comunità cui appartiene, la donna sfida la svalutazione di questo lavoro molto povero e umile (chi torriri a fai scovas! ‘che torni a fare scope!’ è un’imprecazione corrente nel suo stesso ambiente);
- sa prenaccia è la roncola che si usa per tagliare le palme;
- su tamaxu è il gambo delle palme, da raschiare e incidere usando su scarru (un pettine di ferro) o su scarinu (un coltello lungo). E c’è su caramistu, l’insieme dei nodi (e caramistai è legare i gambi con dei nodi) E anche qui la scopa beni bestia (ben lavorata) è bella, bianca e tostara (‘compatta’).
Nel caso della raccolta delle olive,
- ritroviamo su scarru, il pettine, ma questa volta di legno, per la loro abbacchiatura;
- sa raglia è il nome del cantiere della raccolta;
- s’olivariu è l’oliveto, le cui parti possono essere parisi (pianeggianti), palinca (collinari) o addiggiu (vallive) e intorno ai suoi filari (filus) le raccoglitrici si distribuiscono in perras (sezioni e gruppi da una parte e dall’altra rispetto al tronco dell’albero) e poi procedono lungo un’andàina (da intendersi come spazio di lavoro di ciascuna). Sa muzzaglia è la saccoccia che ciascuna lega in vita.
Potrei continuare a lungo ma, a ben vedere, questo del lessico specialistico non è l’aspetto più interessante, anche dal punto di vista linguistico, di questa ricerca. Infatti, molto più rilevante è mettere a fuoco come queste donne parlano del proprio lavoro, producendo i discorsi che si percepiscono a monte degli ampi commenti di Paola Atzeni che ne dà conto, tanto che, quando a un certo punto (a p. 255) compare un lungo elenco di espressioni particolarmente significative, chi legge capisce bene i valori impliciti di cui sono impregnate, ampiamente illustrati in precedenza. Vi troviamo per esempio temperare, tenni bona tempera (‘avere una buona regolatura dei fermi’), molli beni (macinare bene’), bella a fai sa farra (‘è bella da fare la farina’), s’azzuare (aiutarsi), cambiare pressa (‘cambiare parte’) e vi spicca, con la sua centralità, la seguente considerazione: su traballu ‘e sa femmina no est’avvalorau (‘il lavoro della donna non è valorizzato’), ma invece, in una grande rivendicazione di autonomia, esso è importante po si fai mer’ e sa persona sua (‘per diventare padrona della propria persona’).
Queste donne sono spesso parche di parole, consapevoli di fare per scelta autonoma i lavori che Paola Atzeni documenta. Le abilità acquisite lavorando e l’impegno intellettuale per esercitarle al meglio sembrano poi riverberarsi su pratiche sociali e, direi, concezioni del mondo ben più ampie, che finiscono per regolare il loro stesso modo di vivere, in una relazione consapevole tra sé e gli altri. Per esempio, il tenni bona tempera di cui parla Angelina si trasferisce, da qualcosa di necessario per un lavoro che riesca bene, anche a qualcosa che serve a giudicare altri ambiti del comportamento e della vita (sua e altrui), oppure l’essere domesticara e imparara (ben addestrata e capace, ‘sapiente’), come si sente cia Giuannica, è raccomandato più in generale.
Del linguaggio di queste donne fanno parte anche i linguaggi non verbali che accompagnano le loro parole e che coinvolgono il corpo intero. Ci sono cioè, come già detto, i loro gesti, magari ostensivi nel far vedere come si fa, ci sono le loro posture, la loro mimica e direzione degli sguardi, e intuiamo la loro voce con altezza, ritmo e timbro, le loro pause e i loro silenzi. Il loro pragmatico agire con le parole (per leggere tutto ciò Paola Atzeni ricorre alla teoria degli atti linguistici di Austin e di Searle) è un più ampio agire comunicativo [4] le cui mosse possono essere anche non verbali, silenzi compresi, dato che l’agire lavorativo di queste donne è fatto anche di mute performance, o meglio di un «muto teatro performativo», e sono le domande della ricercatrice a spingerle a verbalizzare le loro azioni di lavoro, traducendole in parole.
Paola Atzeni coglie tutti questi aspetti, li evidenzia e sottolinea. Con grande empatia, ha osservato partecipe la fatica e l’attenzione di queste donne e documentato le varie fasi di questi lavori che, ripeto, mobilitano i loro corpi, i vari sensi, la loro pazienza e la loro forza anche fisica, il loro stesso abbigliamento. E ha fatto parlare queste donne, entrando con loro in confidenza, tanto da diventare partecipe anche di ‘attrezzi’ segreti, come il fucile che Angelina le mostra: uno strumento utile per una donna che vive sola con la madre in campagna e che farebbe da deterrente per eventuali malintenzionati.
Certo, sarebbe stato interessante avere una trascrizione fedele di sequenze più estese dei discorsi di queste donne o, meglio ancora, dell’interazione complessiva con la ricercatrice, fatta sicuramente di momenti alternati di osservazione e domande da parte sua, di discorsi esplicativi, sollecitati o meno, silenzi e movimenti ostensivi delle donne intervistate, parlando e, nello stesso tempo, mostrando “come si fa” a un’osservatrice che vuol capire, interroga e fa scaturire così ulteriori sviluppi discorsivi.
Paola Atzeni, consapevole che la realtà è più complessa delle parole che si usano per descriverla, ha infatti fatto precedere o ha accompagnato con la propria osservazione diretta le spiegazioni sul proprio lavoro fornite dalle donne e ha seguito quello che definisce il «lavoro vivo nel suo farsi», arricchendo così i dati ricavati dalle informazioni fornitele oralmente. La sua non è però solo una osservazione partecipante, in cui la relazione con l’altro è fondamentale. Del resto, sappiamo bene quanto, nel corso e a causa dell’osservazione partecipante, possa cambiare, almeno un po’, lo stesso oggetto osservato, in un inevitabile paradosso dell’osservatore. In questo caso, mi sembra che la stessa presenza della ricercatrice, tanto più quando faceva domande, possa aver fatto affiorare alla consapevolezza quanto in precedenza poteva non essere poi tanto consapevole per le donne intervistate, ma appreso per semplice irriflessa impregnazione, in un apprendimento incorporato e automatizzato rispetto al quale possono non esserci le parole per dirlo o è difficile trovarle (come quando proviamo a descrivere i saperi automatizzati che si traducono in movimenti se dobbiamo descrivere come, guidando, scalare di marcia o giocare tra freno e frizione per tenere l’auto ferma in salita ecc.; oppure quando proviamo a descrivere le operazioni che riesce a fare anche un bambino semplicemente smanettando velocemente su uno smartphone). Così, si ha l’impressione che spesso queste donne riescano a verbalizzare il proprio codice di regole e comportamenti per arrivare a un lavoro ben fatto solo su sollecitazione di chi ha già osservato/rilevato le loro pratiche motorie e chiede spiegazioni.
 Peraltro, da anni si parla di un sapere che può essere solo incorporato senza essere verbalizzato, mettendo anche un po’ in discussione la supremazia del linguaggio verbale attraverso cui passerebbe tutto il pensiero e la conoscenza, come faceva spesso Giulio Angioni. Non a caso lo cita al riguardo anche Gabriella Da Re, la quale però, nella sua presentazione al volume Dialoghi con la natura in Sardegna, con cui per molti versi dialoga questo di Paola Atzeni, si chiede se la particolare capacità di verbalizzare da parte degli intervistati rivelata nei lavori etnografici raccolti nel volume non sia indice di capacità verbali sviluppate da livelli di scolarizzazione mediamente più alti che in passato. Oppure, forse, indice di una maturata (rispetto a un tempo) «maggiore disponibilità degli antropologi a una ascolto paziente» [5]. E, aggiungo, tale indubbiamente è stato quello esercitato anche da Paola Atzeni nella sua ricerca.
Peraltro, da anni si parla di un sapere che può essere solo incorporato senza essere verbalizzato, mettendo anche un po’ in discussione la supremazia del linguaggio verbale attraverso cui passerebbe tutto il pensiero e la conoscenza, come faceva spesso Giulio Angioni. Non a caso lo cita al riguardo anche Gabriella Da Re, la quale però, nella sua presentazione al volume Dialoghi con la natura in Sardegna, con cui per molti versi dialoga questo di Paola Atzeni, si chiede se la particolare capacità di verbalizzare da parte degli intervistati rivelata nei lavori etnografici raccolti nel volume non sia indice di capacità verbali sviluppate da livelli di scolarizzazione mediamente più alti che in passato. Oppure, forse, indice di una maturata (rispetto a un tempo) «maggiore disponibilità degli antropologi a una ascolto paziente» [5]. E, aggiungo, tale indubbiamente è stato quello esercitato anche da Paola Atzeni nella sua ricerca.
Ma la cosa forse ancora più interessante è che in realtà, in questa ricerca, a cambiare nella direzione – se possibile – di una maggiore consapevolezza, non sono state solo le donne intervistate, ma la stessa intervistatrice. A modificarsi durante il processo di ricerca che viene descritto è stata anche lei nella sua relazione (discorsiva e non) con le donne osservate e il loro lavoro. È qui che mi sembra si inneschi una differenza notevole e molto interessante rispetto ai modi tradizionali della ricerca anche antropologica, che peraltro Atzeni sottolinea in modo convincente tornando, nel corposo capitolo finale di Riflessioni, a leggere e rileggere anche teoricamente quanto ha fatto.
In altre parole, Paola Atzeni, nell’osservare, intervistare e seguire l’operato di queste donne, osserva e modifica anche se stessa, in relazioni cangianti e in un processo che la aiuta a scoprire l’androcentrismo di molte teorie (anche antropologiche) di riferimento e a costruire un altro modello interpretativo originale, che non solo non dimentica le questioni di genere, ma che la porta a valorizzare al massimo l’eccellenza di queste donne. Insieme, evidenzia la loro consapevolezza intellettuale del collegamento tra le proprie pratiche di lavoro ben fatto e altre pratiche di relazione con gli altri, andando alla ricerca di un mondo più giusto, paritario e solidale, come si capisce benissimo nell’organizzazione che le raccoglitrici di olive si danno, badando a s’azzare, cioè ad aiutarsi a vicenda (nella solidarietà) e a cambiare spesso posizione e perra (cioè segmento di terreno in cui lavorare nella raccolta), alla ricerca di giustizia e dunque distribuendosi così paritariamente la fatica e le eventuali difficoltà maggiori o minori, dovute alla configurazione diversa del terreno stesso.
Il lavoro di ricerca di Atzeni assume ai suoi stessi occhi un rilievo e una caratterizzazione inedita rispetto agli studi antropologici che pure riguardino lo stesso tipo di lavori tradizionali, visti finora solo nella loro tradizionalità statica. Qui ad essere colti, ripeto, sono il processo e il cambiamento nello stesso procedere della relazione e dell’interazione tra le donne e la ricercatrice, e ci si può chiedere inoltre quanto possa avere inciso in positivo il fatto che questa relazione fosse tutta tra donne. Donne (la ricercatrice e l’intervistata o le intervistate) tra cui si era stabilito un rapporto di fiducia e di confidenza tale da permettere a una di loro di mostrare anche il proprio attrezzo più segreto, il fucile di cui ho già detto.
Da questa ricerca, insomma, emerge una descrizione interessante e affascinante del percorso di ricerca scientifica e del suo farsi, arricchirsi e mutare durante il percorso stesso. Risultano evidenziati così caratteri che si possono considerare inerenti a qualunque percorso di ricerca e che restano in genere in ombra quando e se l’attenzione si dirige solo sui risultati e non anche sul modo con cui li si è conseguiti.
Ai problemi legati al farsi della ricerca guarda anche Cristina Marras quando sottolinea che da questa di Paola Atzeni emergono tre elementi (oggetti di studio, pratiche e linguaggio) che interagiscono, dato il modo dinamico in cui vengono trattati: la scrittura inscrive nel suo libro le forme di vita e la profondità concettuale degli stessi oggetti ‘detti’.
Inoltre, badando a una ricerca colta nel suo fare e mutarsi, a me è venuto da pensare a quanto sia sbagliato se non assurdo (l’ho sempre considerato tale) il modo burocratico-accademico di concepire la ricerca scientifica, con moduli da compilare per presentare progetti di cui chiedere il finanziamento e in cui specificare che cosa si vuole scoprire con quella ricerca, quali risultati si vogliono ottenere e in quali modi e tempi (e vogliamo parlare dei mesi-uomo?). Risultano così aprioristicamente e del tutto esclusi la serendipità dei percorsi di ricerca, che invece spesso comportano l’aprirsi di prospettive nuove e non previste né prevedibili, il diramarsi di direzioni diverse, il cambiamento di prospettive e interessi degli stessi ricercatori, lungo un tempo che non può essere definito apriori ma che, come ben sappiamo, può continuare in modo indeterminato e dipanarsi lungo un’intera vita.
Dialoghi Mediterranei, n. 65, gennaio 2024
Note
[1] Per questi aspetti cfr. la recensione di N. Atzori, “Bella a fai”. Donne oltre se stesse nell’antropologia di Paola Atzeni, “Dialoghi Mediterranei”, n. 59, 2023.
[2] Zona molto povera della Sardegna sudoccidentale, dove un tempo si svolgeva una intensa attività mineraria. Vi si parla la varietà campidanese di sardo.
[3] Non a caso questi termini non sono sempre reperibili nei vari dizionari di sardo esistenti.
[4] Mi piace qui citare al riguardo anche i lavori di Marina Sbisà, una delle massime studiose italiane di pragmatica linguistica: Linguaggio, ragione, interazione. Per una teoria pragmatica degli atti linguistici (il Mulino, 1989) e Essays on Speech Acts and other Topics on Pragmatics (Oxford, 2023).
[5] M. G. Da Re (a cura di), Dialoghi con la natura in Sardegna. Per un’antropologia delle pratiche e dei saperi, Olschki, Firenze, 2015: XIX.
________________________________________________________
Cristina Lavinio, già ordinaria di Linguistica educativa all’Università di Cagliari, ora in pensione, è responsabile per l’italiano del polo della Sardegna, nell’ambito del progetto nazionale promosso dall’Accademia dei Lincei “I Lincei per una nuova didattica nella scuola”. Fa parte della giuria del Premio Tullio De Mauro (sezione del Premio nazionale “Salva la tua lingua locale”). È stata segretaria nazionale del GISCEL (Gruppo di Intervento e di Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica) e si è sempre occupata anche di formazione degli insegnanti e di educazione linguistica, curandone la trasversalità tra le discipline. Le sue numerose pubblicazioni vertono su temi di linguistica del testo, di linguistica italiana e sociolinguistica, riguardano le varietà della lingua, la comunicazione orale e scritta, generi narrativi di tradizione orale e popolare, lingua e stile di numerosi scrittori sardi. Si ricordano qui solo i volumi La magia della fiaba tra oralità e scrittura (La Nuova Italia 1993), Testi a scuola. Tra lingua e letteratura (Cesati 2021), Comunicazione e linguaggi disciplinari. Nuova edizione (Carocci 2022), oltre alla cura del volume Oralità narrativa, cultura popolare e arte. Grazia Deledda e Dario Fo (ISRE-AIPSA 2019).
______________________________________________________________