Georg Simmel riesce a cogliere un valore conoscitivo anche in fatti del vivere quotidiano a prima vista insignificanti. Ciò è il risultato della sua capacità di ‘scavare’, del saper «collegare gli aspetti di dettaglio e superficiali della vita alle loro dinamiche più profonde e più essenziali», e portare così alla luce un’imprevedibile ricchezza di intrecci [1]. Tale modo di procedere spiega il carattere interdisciplinare delle sue analisi, quello sconfinamento in ambiti scientifici diversi che una concezione autoreferenziale del sapere e del potere accademico tuttora avversa. Il confine è un dato che non esiste nella realtà, ma solo nel pensiero, giacché ogni fenomeno è parte di un tutto interdipendente, è in relazione con altri fenomeni che sembrano molto distanti. Il punto di vista di una scienza, afferma Simmel, «non è mai in grado di esaurire la totalità di una realtà qualsiasi» [2].
Tale approccio consente di afferrare risvolti impensabili in un fatto apparentemente banale quale l’abbigliamento. Andando oltre la vernice dell’apparenza, questo disvela la sua complessità, la necessità quindi di considerarlo da più punti di vista, quello antropologico, storico, artistico, religioso, economico, psicologico, sociologico, filosofico e persino etico, ciascuno dei quali ne arricchisce la comprensione.
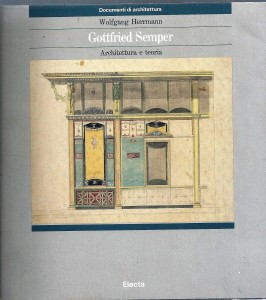 Inizi della decorazione corporea
Inizi della decorazione corporea
La parola ‘abbigliamento’ indica tutto ciò che viene adoperato per decorare e rivestire il corpo umano. Comprende gli indumenti, gli accessori, gli ornamenti e le varie modalità di trattamento dell’epidermide. La sua storia, a differenza di quella della moda, coincide con la storia dell’essere umano. Il suo bisogno innato, immutabile nel tempo e nello spazio, di modificare e abbellire il proprio aspetto naturale può essere definito una costante antropologica.
Precisamente la possibilità di adoperare le mani ha permesso, già all’uomo primitivo, di trasformare l’ambiente in cui viveva, di creare da sé le condizioni della propria esistenza, di costruirsi oggetti utili per la vita di ogni giorno, e di abbellire il rivestimento naturale del proprio corpo con sostanze coloranti, il tatuaggio e altre decorazioni. L’homo faber diede dunque inizio alla storia della cultura materiale e trasformò il corpo biologico, percepito come un’opera incompiuta, in una figura culturalmente significativa. Ancora oggi tale coscienza, esclusivamente umana, di essere carente costituisce il movente fondamentale della cura dell’apparire, della ricerca di una perfezione, essenzialmente insoddisfacente, oggettivamente sempre precaria proprio perché essa appartiene alla sfera dell’idealità e non a quella della realtà.
Richiamandosi alle ricerche in campo etnologico, Gottfried Semper nei suoi scritti di ‘estetica pratica’ accenna all’utilizzazione già presso i popoli primitivi di elementi ricavati dalla natura circostante per decorare il proprio aspetto, ad esempio le variopinte piume di uccelli e i colori estratti dalle piante adoperati nella pittura e nel tatuaggio del corpo. Questa consuetudine espresse la sensibilità tipicamente umana per il bello, costituì «la prima sollecitazione all’attività estetica» [3], un’esperienza che gradualmente venne estesa a vari ambiti dell’attività umana nei quali furono operanti gli stessi princìpi del bello. In proposito Semper dichiara: «L’adornare è in realtà un fenomeno fondamentale della storia della cultura. È uno dei privilegi dell’essere umano, forse il più antico. Nessun animale abbellisce sé stesso … È il primo e più importante passo verso l’arte; nell’ornamento e nelle sue leggi è contenuto l’intero codice dell’estetica formale» [4].
I fregi disegnati sul corpo dell’uomo primitivo ebbero non solo una funzione estetica, magico-religiosa, iniziatica. Attraverso la qualità e quantità dei motivi ornamentali, mediante un codice di forme e colori scritto sul corpo, egli intese soprattutto comunicare visivamente ben precise informazioni su sé stesso e sul proprio ruolo sociale. L’esigenza di distinguersi, evidenziando la propria individualità, così come quella di segnalare l’appartenenza a un determinato gruppo hanno sempre rappresentato le due motivazioni psicosociali che gli studi sull’abbigliamento considerano essenziali per la comprensione di tale fenomeno. Sin dall’antichità, si pensi ai poemi omerici, la presenza di elementi ornamentali e vestimentari sul corpo, oltre che stimolare l’attrazione sessuale, conferiva all’individuo personalità, sicurezza in sé stesso e dignità nella percezione altrui. Privare qualcuno delle proprie vesti, vale a dire di ciò che differenzia l’essere umano dal mondo animale, significava umiliarlo, sottometterlo, ridurlo in condizione di schiavitù. Simbolicamente si veniva spogliati della propria identità, della propria esistenza individuale e sociale, e si era ricacciati in una livellante condizione naturale, extraculturale, animale.
La cura dell’aspetto esteriore è senza dubbio il segnale non verbale che più influisce nella costruzione dell’immagine del sé fisico, garantisce l’autostima e anche il successo nell’interazione sociale. I segnali relativi all’io, consapevoli o no, manipolati o meno, non necessariamente sono veritieri. Mirano di solito a esprimere ciò che l’individuo desidera che gli altri pensino di lui e a determinare reazioni corrispondenti. L’esperienza comune dimostra che le persone di bella presenza piacciono, e gli esperti di mass media confermano che nella nostra società lo charme costituisce un fattore chiave del comportamento e della comunicazione. Il bell’aspetto suscita in genere «una risposta automatica e non ragionata» che la psicologia sociale descrive come «effetto alone» [5]. Chi è dotato di fascino è percepito tendenzialmente a un livello più alto di credibilità e stimola perciò, senza alcuna prova, un ampio raggio di reazioni favorevoli. Il linguaggio del corpo, il power look, diviene in genere un fattore di appeal più determinante dello status socioeconomico. Agisce come potere sugli altri, offre più opportunità di carriera, di successo e in vari casi, con troppa leggerezza, viene scisso da altre qualità non appariscenti ma più importanti.
È comunque la vitalità comunicativa propria dell’architettura anatomica del corpo, e quindi l’espressione del volto, dello sguardo, dei gesti, dei movimenti, della postura, ad animare i diversi elementi dell’abbigliamento. Solo così questi diventano parte di un linguaggio visivo articolato, un passaggio di segnali da un emittente a un ricevente, latori di una molteplicità di informazioni sull’individuo e sulla sua realtà socioculturale. Queste trasmettono infatti importanti indicazioni relative all’età, al sesso, al gruppo etnico, religioso e politico di appartenenza, alla classe sociale, all’attività professionale e pure ai tratti di personalità, ad esempio al grado di indipendenza, originalità, eccentricità dell’individuo, alla sua concezione della corporalità e della sessualità. Ciò spiega perché l’aspetto esteriore sia un elemento essenziale per la caratterizzazione dei personaggi della narrativa, del teatro e del cinema.
Sul messaggio di ribellione dell’iniziale moda dei ‘capelloni’ degli anni ’70 Pier Paolo Pasolini scriveva:
«Ciò che sostituiva il tradizionale linguaggio verbale, rendendolo superfluo […] era il linguaggio dei loro capelli. […] quel linguaggio privo di lessico, di grammatica e di sintassi, poteva essere appreso immediatamente, anche perché, semiologicamente parlando, altro non era che una forma di quel “linguaggio della presenza fisica” che da sempre gli esseri umani sono in grado di usare» [6].
In un processo, non sempre del tutto consapevole, di codificazione e decodificazione dei segnali non verbali gli interagenti cercano reciprocamente di catalogarsi. I criteri della loro decodificazione sono però ricavabili dal particolare contesto comportamentale e dalle tradizioni proprie di un determinato paese. Ad esempio, sulla spiaggia e in un locale notturno il bikini, come significante, assume significati ben differenti. Del tutto discordante è poi il valore simbolico assegnatogli nel mondo occidentale e in quello islamico. Tale capacità di decodificare è oggi ancor più richiesta a motivo della crescente presenza di immigrati da Paesi con tradizioni vestimentari molto diverse rispetto ai nostri canoni estetici. Queste, in quanto traduzioni di significati in significanti, costituiscono un tipo di linguaggio segnico che tocca inizialmente agli abitanti del Paese in cui tali persone vengono accolte tentare di interpretare nella loro specificità culturale.
 Indicatore di processi culturali
Indicatore di processi culturali
Le modalità abbigliamentari sono testimonianze storiche della necessità prettamente umana di crearsi una ’seconda pelle’, di conferire al corpo biologico un’apparenza individualmente e socialmente espressiva. Tutta la loro storia prova che i processi culturali immateriali e le manifestazioni materiali sono strettamente collegati. In tal senso le forme essenziali dei vestiti non sono affatto arbitrarie, ma appaiono e scompaiono insieme a precisi periodi storici. Tale corrispondenza risulta abbastanza chiara, ad esempio, nell’abbigliamento del Rinascimento. Come in campo artistico, architettonico in particolare, l’enfasi si spostò dalla linea verticale a quella orizzontale. L’ideale gotico di bellezza femminile dell’Alto Medioevo, longilinea ed esile, eterea, dai fianchi stretti e dal seno piccolo, gradualmente si modificò in un tipo di bellezza, quella rinascimentale, più rotondeggiante, con fianchi larghi e seno procace. Tali caratteri vennero ben evidenziati dai vari accorgimenti sartoriali, quali l’ampiezza della gonna, la scollatura. Anche i costumi maschili espressero il grande flusso di energia che definiva tale epoca. Furono aderentissimi e dai colori vivaci, posero in risalto la forza e lo sviluppo muscolare, e accentuarono il richiamo alla virilità attraverso la barba folta e in particolare mediante la braghetta, il cui rigonfiamento sull’inguine era un palese richiamo fallico.
Nel XVI secolo la Riforma protestante incise pure sul comportamento abbigliamentare. L’abito riformatore religioso e civile fu contraddistinto dal colore nero su cui apparivano tocchi dell’altro estremo acromatico, il bianco. Allo sfarzo sfrenato e alla pompa cromatica degli ecclesiastici romani venne contrapposto il richiamo alla sobrietà, un’estetica aniconica. Questa si tradusse in una rimozione della vitalità dei sontuosi colori rinascimentali, in una semplificazione cromatica e formale del modo di vestire, e si estese al campo architettonico e artistico. La Chiesa protestante riscoprì la pietra nuda, l’assenza di affreschi, di decorazioni e più in generale di immagini e di colore. Alla puritana concezione della Riforma, la Chiesa cattolica contrappose la glorificazione del papato con profusione di mezzi e di opere. L’arte, in tutte le sue espressioni, venne intesa come strumento scenografico di una propaganda che mirava a stupire e a conquistare i fedeli. Li educò tuttavia al gusto per il bello, all’importante valore comunicativo dell’aspetto esteriore, al potere seduttivo e manipolativo della propria messinscena.
È sempre un ben preciso principio strutturale, una comune matrice culturale che definisce l’organizzazione degli elementi formali e quindi l’unità profonda del gusto di un’epoca, osservabile tanto nelle cosiddette arti minori quanto in quelle dette maggiori. Si pensi alle linee allungate del Gotico o alla ricercatezza del Rococò. Considerando un ampio arco di tempo, l’abbigliamento e le altre espressioni del bello documentano dunque la sostanziale affinità stilistica di una ben precisa fase storica. Riflettono il cammino della cultura e sono tanto più elaborate quanto più alto è il livello da questa raggiunto. In proposito Semper, da convinto assertore del fondamentale valore delle tecniche artigianali per l’ambito artistico, sostiene che «i mutamenti radicali negli stili architettonici vennero sempre preparati da innovazioni precedentemente introdotte nella pratica artigianale» [7]. Parla persino di «analogia» tra l’ornamentazione della struttura del corpo umano e la decorazione della struttura del corpo architettonico [8].
La parola ‘moda’ fa riferimento al gusto o al capriccio del momento che, soprattutto in campo abbigliamentare, cambia a motivo di una continua, oggi sempre più frenetica, ricerca del nuovo. Il termine è adoperato anche per l’ambito comportamentale, ideologico, artistico-letterario, musicale, sportivo, gastronomico e, più in generale, dei consumi. Come scrive Walter Benjamin, la moda «va dietro a tutto», è per sua natura onnivora [9]. Mentre però l’abbigliarsi è una costante antropologica, risponde a un bisogno universalmente sentito dall’essere umano fin dagli albori della sua storia, il vestire alla moda è invece il risultato di varianti socioeconomiche e culturali che interagiscono con le motivazioni originarie del coprirsi, vale a dire le esigenze individuali e sociali, gli intenti estetici e pratici. Si manifesta in un preciso momento storico, è circoscritto dapprima solo ad alcune categorie di persone e a particolari società, e poi si estende gradualmente con caratteristiche diverse rispetto al più generale fenomeno dell’abbigliamento. È assente nei Paesi poveri ove l’economia mira a soddisfare ancora i bisogni primari e, in mancanza dei presupposti del consumismo, è osservabile una sostanziale stabilità nel modo di vestire.
Il fenomeno della moda storicamente precede l’uso che nella Francia del XVIII secolo si faceva di questo termine. È già presente nelle corti rinascimentali della seconda metà del XIV secolo, ove le informazioni in tale ambito venivano scambiate attraverso bambole chiamate ‘pupe’, vestite secondo le ultime novità. Queste, un po’ come le moderne barbie, costituirono dei veri e propri modelli, le prime forme di promozione abbigliamentare quantunque ancora circoscritta al solo mondo aristocratico. La radice storica della moda va individuata nella mutata realtà economica, sociale e culturale del tardo Medioevo, quando alla graduale dissoluzione dell’economia naturale subentrò la nuova e rivoluzionaria economia monetaria. Questa, dall’Italia diffusasi in tutta l’Europa, favorì il formarsi di una ricca borghesia o aristocrazia del denaro fondata sul talento, sulla capacità del singolo e non più sui privilegi dinastici. Iniziarono così ad affermarsi come valori culturali, strutturalmente connessi con il sorgere della società moderna, l’esaltazione della individualità, la sua emancipazione dall’ordine immutabile della tradizione, e un sempre più diffuso e intenso desiderio, sconosciuto in precedenza, per il nuovo.
Jacob Burckhardt sostiene che il Rinascimento permise all’essere umano «di emergere, di essere, e di apparire, diverso dagli altri» [10]. A differenza del Medioevo, la celebrità poteva essere «guadagnata col merito personale» e non di casta [11]. Ciò costituì un’opportunità, prima impensata, di porre in luce i pregi individuali e favorì il raffinarsi della vita sociale pure nell’ambito della moda, come prova il fatto che «in nessun luogo si tenne del vestire quel conto che si teneva in Italia» [12]. Tali moderni valori, affermatisi grazie all’Umanesimo e al Rinascimento, minarono le ferree barriere della distinzione di classe, fino ad allora invalicabili, fondate sulla convinzione che anche il lusso fosse un diritto di pochi. Consentirono alla moda di liberare l’individuo dai vincoli delle leggi suntuarie medioevali e di estendere in senso egualitario la possibilità di soddisfare la sete di novità e di eleganza. Gilles Lipovetsky, richiamandosi a questi concetti, sostiene che «la moda è storicamente fondata sulla rivendicazione, l’affermazione e la legittimazione della identità personale». Sottolinea l’incidenza fondamentale che tale «estasi frivola dell’Io» ha significato per la cultura occidentale: «Una caratteristica importante dell’uomo moderno si è affermata nel cuore di un mondo dominato dai valori gerarchici: l’individualismo del gusto, coevo dell’individualismo economico e religioso, precedente l’individualismo ideologico dell’era egualitaria» [13].
 Nel corso dei secoli, fino alla fine del Medioevo, si erano già verificati cambiamenti nel modo di abbigliarsi. Si trattò comunque non propriamente di mode quanto piuttosto di mutamenti di stili, ciascuno dei quali era durato relativamente a lungo e aveva influenzato i vari settori della cultura. Quale fenomeno di rilievo, sebbene limitato ancora a una cerchia ristretta, la moda si affermò solo nel XVI secolo, quando le fogge del vestire dei prìncipi furono sottoposte a una incessante innovazione e divennero modelli di abbigliamento profano. Le scoperte geografiche, a fine del XV e inizio del XVI secolo, e i commerci con Paesi geograficamente remoti avevano favorito la conoscenza di mondi diversi, l’importazione di prodotti, anche tessili, un ampliamento dell’orizzonte culturale e scientifico. La curiosità per il nuovo, non più osteggiato con diffidenza quale minaccia per l’ordine costituito, e la voglia di appropriarsene come fonte di appagamento delle passioni, furono fattori che senza dubbio influirono positivamente sui cambiamenti nell’ambito della moda abbigliamentare. Le corti principesche rimasero tuttavia ancora il luogo privilegiato di tali mutamenti, a cui la borghesia poté più facilmente accedere solo con il graduale consolidarsi del proprio potere economico e sociale.
Nel corso dei secoli, fino alla fine del Medioevo, si erano già verificati cambiamenti nel modo di abbigliarsi. Si trattò comunque non propriamente di mode quanto piuttosto di mutamenti di stili, ciascuno dei quali era durato relativamente a lungo e aveva influenzato i vari settori della cultura. Quale fenomeno di rilievo, sebbene limitato ancora a una cerchia ristretta, la moda si affermò solo nel XVI secolo, quando le fogge del vestire dei prìncipi furono sottoposte a una incessante innovazione e divennero modelli di abbigliamento profano. Le scoperte geografiche, a fine del XV e inizio del XVI secolo, e i commerci con Paesi geograficamente remoti avevano favorito la conoscenza di mondi diversi, l’importazione di prodotti, anche tessili, un ampliamento dell’orizzonte culturale e scientifico. La curiosità per il nuovo, non più osteggiato con diffidenza quale minaccia per l’ordine costituito, e la voglia di appropriarsene come fonte di appagamento delle passioni, furono fattori che senza dubbio influirono positivamente sui cambiamenti nell’ambito della moda abbigliamentare. Le corti principesche rimasero tuttavia ancora il luogo privilegiato di tali mutamenti, a cui la borghesia poté più facilmente accedere solo con il graduale consolidarsi del proprio potere economico e sociale.
La successiva pubblicazione dei figurini di moda sui primi giornali segnò il passaggio a mezzi di informazione molto più accessibili delle rinascimentali ‘pupe’. L’ideazione e la diffusione dello stile si spostarono pian piano dalla corte al couturier fino a giungere, nella seconda metà del XIX secolo, alla nascita della haute couture. L’eleganza elitaria di quest’arte stimolò poi il sorgere, accanto alle rinomate sartorie, di un nuovo mercato della confezione affidato alle sarte. Cominciarono a delinearsi quindi due concezioni molto differenti dell’abbigliamento e della relativa modalità di progettazione, con due storie cronologicamente diverse: l’haute couture come moda esclusiva di lusso, inizialmente solo femminile, e la moda dei ceti meno abbienti che evolverà nella produzione industriale fino all’odierno prêt-à-porter.
Lo stretto rapporto tra struttura sociale e modalità di cura dell’aspetto esteriore è stato posto in luce, nella seconda metà del XIX e all’inizio del XX secolo, da vari studiosi. Herbert Spencer, ad esempio, sottolinea la sostanziale differenza tra comportamenti cerimoniali e moda, l’importanza del graduale processo di transizione dalle «imitazioni reverenziali» alle «imitazioni emulative» [14]. Le prime sono espressione di una ossequiosa sottomissione e intendono far risaltare le disuguaglianze sociali, le seconde invece denotano una relativa indipendenza, la volontà di rimpiazzare la parassitaria aristocrazia del tempo, di competere con questa anche nell’abbigliamento. Thorstein Veblen prende atto che, con l’attenuarsi delle differenze di classe, le linee di confine nella scala sociale siano diventate «imprecise e mobili». I ceti inferiori cercano di esprimere la loro aspirazione a una posizione superiore, inizialmente proprio con l’imitazione dei segni esteriori, innanzitutto vestimentari. A tale tendenza, che rischiava di annullare le differenze simboliche sartoriali, i ceti più elevati hanno reagito con l’emanazione di nuove leggi suntuarie e adottando una nuova moda. Questa consentiva loro di recuperare il valore simbolico di distinzione di classe e nello stesso tempo diffondeva un nuovo «ideale di onorabilità» la cui «influenza costrittiva» agiva verticalmente, fino al livello più basso della struttura sociale [15]. Tale duplice e consecutivo movimento di imitazione e innovazione è stata la molla determinante di una crescente creazione di nuovi prodotti e di un loro consumo sempre più generalizzato.
Georg Simmel va oltre tale paradigma interpretativo classico. Già a fine del XIX secolo pone la diffusione della moda in stretto rapporto con un fattore nuovo: l’affermazione dell’economia monetaria. È questa infatti che consente di accelerare «in modo rilevante» la dinamica di imitazione e distinzione rendendo «più frenetica» tanto «la caccia all’imitazione» nelle classi inferiori quanto «la fuga verso il nuovo» in quelle superiori [16]. Egli constata come l’ideazione delle innovazioni estetico-formali della moda sia sempre più integrata nell’organizzazione oggettiva del lavoro tipica dell’economia moderna. Non dipende più solo dal carattere personale, dal capriccio o dall’esigenza particolare di singoli individui e gruppi.
 È Werner Sombart che approfondisce per la prima volta l’importanza di tale fenomeno per il sistema di produzione industriale, lo collega esplicitamente alla diffusione dei consumi, ai bisogni di massa. Nell’ambito dell’efficace strategia del capitalismo maturo, la moda «costringe […] un gran numero di persone a uniformare i propri bisogni, così come a mutarli prima di quanto il singolo consumatore riterrebbe necessario se egli agisse in modo indipendente» [17]. Permette agli imprenditori di accrescere la dinamica dei consumi e di estenderli gradualmente a tutti gli strati sociali. La «forza motrice» [18] del ritmo vivace assunto dalla moda viene individuata non più nei ceti benestanti, ma nella produzione industriale. La moda, precisa Sombart, è «la più amata creatura del capitalismo; ha tratto origine dalla sua più intima natura e ne esprime la tipicità come pochi altri fenomeni della vita sociale del nostro tempo» [19].
È Werner Sombart che approfondisce per la prima volta l’importanza di tale fenomeno per il sistema di produzione industriale, lo collega esplicitamente alla diffusione dei consumi, ai bisogni di massa. Nell’ambito dell’efficace strategia del capitalismo maturo, la moda «costringe […] un gran numero di persone a uniformare i propri bisogni, così come a mutarli prima di quanto il singolo consumatore riterrebbe necessario se egli agisse in modo indipendente» [17]. Permette agli imprenditori di accrescere la dinamica dei consumi e di estenderli gradualmente a tutti gli strati sociali. La «forza motrice» [18] del ritmo vivace assunto dalla moda viene individuata non più nei ceti benestanti, ma nella produzione industriale. La moda, precisa Sombart, è «la più amata creatura del capitalismo; ha tratto origine dalla sua più intima natura e ne esprime la tipicità come pochi altri fenomeni della vita sociale del nostro tempo» [19].
La fruizione ormai generalizzata, a prezzi accessibili, dei beni di consumo inganna su una democrazia apparentemente concreta, ma in realtà formale. Il livellamento degli status e dei simboli di status tradizionali ha significato la ricomposizione delle differenze a livelli qualitativamente diversi, in genere meno appariscenti, più immateriali, come il livello di istruzione e di cultura, il tipo di lavoro e di responsabilità, la partecipazione alle decisioni. Tuttavia, tanto la solidità elitaria della haute couture quanto l’instabilità dei consumi di massa del prêt-à-porter e del low cost attestano tuttora, scrive Pierre Bourdieu, l’esistenza concreta di una stratificazione sociale strutturale. Hanno a fondamento la «dialettica di distinzione e di aspirazione alla distinzione», e questa viene da lui definita «il motore di quella concorrenza che è soltanto la mite, persistente forma di lotta di classe senza fine» [20].
 Pur con un innegabile miglioramento generale del livello di vita sussiste in realtà, nonostante l’apparenza di mobilità sociale, un rapporto piramidale mascherato in cui ai ceti inferiori sono di continuo proposti modelli comportamentali di consumo-dipendenza. L’analisi semiotica rileva come a una relativa stabilità di significati corrisponda oggi una moltiplicazione, uno spostamento e un’usura di significanti creati da una moda che si rinnova sempre più rapidamente. Tale processo desemantizza gli oggetti acquistati, li espropria della funzione di essere ‘significanti’, latori cioè di ‘significati’. Questi, grazie a una pubblicità pervasiva, vengono immediatamente trasferiti ad altri prodotti appena immessi sul mercato che diventano così i nuovi significanti, anch’essi tuttavia di brevissima durata. Quanto più rapida è l’usura dei significanti, tanto più frenetica diventa la ricerca del nuovo celebrato come obiettivamente bello.
Pur con un innegabile miglioramento generale del livello di vita sussiste in realtà, nonostante l’apparenza di mobilità sociale, un rapporto piramidale mascherato in cui ai ceti inferiori sono di continuo proposti modelli comportamentali di consumo-dipendenza. L’analisi semiotica rileva come a una relativa stabilità di significati corrisponda oggi una moltiplicazione, uno spostamento e un’usura di significanti creati da una moda che si rinnova sempre più rapidamente. Tale processo desemantizza gli oggetti acquistati, li espropria della funzione di essere ‘significanti’, latori cioè di ‘significati’. Questi, grazie a una pubblicità pervasiva, vengono immediatamente trasferiti ad altri prodotti appena immessi sul mercato che diventano così i nuovi significanti, anch’essi tuttavia di brevissima durata. Quanto più rapida è l’usura dei significanti, tanto più frenetica diventa la ricerca del nuovo celebrato come obiettivamente bello.
Roland Barthes focalizza molto bene tale tema sostenendo che fra l’oggetto e il suo utente viene interposto un grande spreco di parole, di immagini e di sensi per una ragione di ordine economico: «Calcolatrice, la società industriale è condannata a formare dei consumatori che non calcolino; se produttori e compratori dell’indumento avessero una coscienza identica, l’indumento non si comprerebbe (e non si produrrebbe) che secondo i tempi, lentissimi, della sua usura; la Moda, come tutte le mode, poggia su una disparità delle due coscienze: l’una deve essere estranea all’altra» [21].
Le merci, non essendo più acquistate primariamente per il loro valore d’uso e per la loro possibile durata, sono perciò definite in misura crescente dalla condanna all’effimero, dalla obsolescenza calcolata, da uno spreco indispensabile per la produzione. A tal fine la pubblicità, tramite i suoi messaggi subliminali, assume il ruolo di potente strumento di socializzazione al nuovo. Non mira a incrementare ma al contrario, nota Jean Baudrillard, a «diminuire il valore d’uso degli oggetti, il loro valore/tempo, assoggettandolo al loro valore/moda e al rinnovamento accelerato» [22]. In un’accurata messinscena i beni di consumo, oggi in gran parte proposti on line, vengono permanentemente visualizzati e resi virtualmente disponibili per chiunque, a livello planetario. Sebbene non tutti potranno comperarli, tutti comunque ne resteranno affascinati, ne riconosceranno inconsciamente la valenza feticistica. Ancora all’inizio dell’era televisiva, da profeta della nostra epoca, Guy Debord parlava già di un consumo che da materiale, primario, gradualmente si smaterializzava, la merce si spogliava della sua materialità per trasformarsi sempre più in un’astrazione. Diventava consumo di spettacolo e trasformava il consumatore reale in «consumatore di illusioni» [23].
La vera essenza delle merci è divenuta la valenza estetico-simbolica, e ciò ha inevitabilmente portato, anche per ragioni di concorrenza, ad affinare l’arte della comunicazione. Il progresso della tecnica e la diffusione della prosperità hanno fatto sorgere dunque la necessità di ‘educare’ i lavoratori alla civiltà dei consumi attraverso una nuova cultura, denominata ‘mass-culture’, il cui tratto dominante è di essere una cultura di svago, profondamente permeata di erotismo. Nel rituale dello shopping i nuovi beni sono infatti percepiti come irrinunciabili proprio perché ad essi vengono attribuiti significati che rispondono a esigenze e aspettative presenti a diversi livelli di consapevolezza psichica. Agendo sulle emozioni, sul lato non-logico, onirico delle masse, vengono collegati alla mistificante promessa di giovinezza, avvenenza e sensualità, di distinzione e successo nei rapporti interpersonali. Così, ad esempio, l’ideale di bellezza proposto da una martellante pubblicità favorisce per lo più una percezione negativa di sé e quindi induce all’acquisto di indumenti e cosmetici cui viene assegnato un vero valore salvifico, magico.
L’attuale società tecnologicamente avanzata, caratterizzata da una fredda e livellante razionalità, non ha cancellato il diffuso bisogno del magico, da Marcel Mauss definito il «regno del desiderio». Tale esigenza, in maniera insospettata e sorprendente, si combina molto bene con la modernità. La presentazione sotto forma di spettacolo dell’odierna cultura di massa cela gli stessi processi psicologici che operano nella magia o nella religione, ove «l’immaginario è percepito come altrettanto reale, se non addirittura più reale del reale» [24]. L’abbigliarsi fa sognare. Se poi s’indossano capi associati più o meno consapevolmente a quelli portati da personalità famose, da dive e star dello spettacolo e dello sport, è un po’ come divenire partecipi, appropriarsi delle loro qualità desiderabili.
 Forse una delle ragioni del crescente potere della moda sta proprio in tale temporaneo annullamento del mondo ordinario, in questa funzione compensatrice, catartica, magica. Si pensi alla possibilità di recitare persone differenti che spiega nella donna la sua incertezza su che cosa indossare, la sua sensazione di ‘non avere nulla da mettersi’ pur dinanzi a un ricco guardaroba. Un tale stato d’animo, che esalta il desiderio, incoraggia il ludico e creativo comportamento camaleontico di costruirsi, anche più volte al giorno, identità diverse, mutevoli: ogni volta si ha l’impressione di incontrare una donna differente.
Forse una delle ragioni del crescente potere della moda sta proprio in tale temporaneo annullamento del mondo ordinario, in questa funzione compensatrice, catartica, magica. Si pensi alla possibilità di recitare persone differenti che spiega nella donna la sua incertezza su che cosa indossare, la sua sensazione di ‘non avere nulla da mettersi’ pur dinanzi a un ricco guardaroba. Un tale stato d’animo, che esalta il desiderio, incoraggia il ludico e creativo comportamento camaleontico di costruirsi, anche più volte al giorno, identità diverse, mutevoli: ogni volta si ha l’impressione di incontrare una donna differente.
L’odierna estetica del fascino femminile è comunque ben distante da quella della società benestante ottocentesca descritta da Veblen, quando la cura dell’apparire, l’esibizione vistosa di consumo e agiatezza della donna, considerata proprietà dell’uomo, serviva a porre in risalto la capacità di spendere del proprio ‘padrone’. Tale estetica della sottomissione e dell’oggettualizzazione sessuale è stata progressivamente superata grazie alla grande ondata di emancipazione femminile dei primi decenni del secolo scorso e alla capacità di autonomia conquistata, a caro prezzo, dalle donne durante i periodi bellici. In Europa seguì poi, negli anni ’50, una nuova concezione di femminilità che si richiamava a Bette Davis, a Barbara Standwyck e a Marlene Dietrich. L’arte di attrarre l’attenzione altrui divenne pian piano l’attributo di ogni donna, non costituì più qualcosa di moralmente equivoco che si addiceva alle prostitute, o un fatto esclusivo di poche eccezioni quali le signore dell’alta società, le mannequin e le dive del cinema. In una società in cui le posizioni-chiave del potere politico, economico, culturale e religioso erano da tempo ancora solo nelle mani degli uomini, per farsi valere la donna ha sempre più utilizzato anche il potere seduttivo della propria presenza fisica. Con il riconoscimento ufficiale della parità di genere, in un percorso non semplice, sta ora conquistando gli stessi diritti dell’uomo, la propria dignità di soggetto.
 La società dello spettacolo sollecita oggi ambedue i sessi a recitare un ruolo, a presentarsi agli altri come se il proprio apparire, la propria messinscena, avessero una funzione attiva nella dinamica dei rapporti sociali. Il ‘performing self’ risulta consistere essenzialmente nella propria immagine riflessa negli occhi altrui. Questa viene così ad assumere il valore di un test giornaliero di abilità attraverso cui, in una interazione strategica, non solo si cerca di esibire il meglio di sé, ma pure di controllare le risposte altrui. L’importanza centrale assegnata alla sensazione di fascino, di efficienza da trasmettere ovunque, non solo in ambito professionale, e i sentimenti di solitudine e di vuoto che tuttavia caratterizzano in misura crescente la vita odierna, stanno creando una massa di individui fondamentalmente narcisisti, asociali. Il culto prioritario per la propria rappresentazione è in genere autoreferenziale, viene prevalentemente finalizzato a una socialità teatrale che simula la comunicazione, la rende possibile solo a livello di facciata.
La società dello spettacolo sollecita oggi ambedue i sessi a recitare un ruolo, a presentarsi agli altri come se il proprio apparire, la propria messinscena, avessero una funzione attiva nella dinamica dei rapporti sociali. Il ‘performing self’ risulta consistere essenzialmente nella propria immagine riflessa negli occhi altrui. Questa viene così ad assumere il valore di un test giornaliero di abilità attraverso cui, in una interazione strategica, non solo si cerca di esibire il meglio di sé, ma pure di controllare le risposte altrui. L’importanza centrale assegnata alla sensazione di fascino, di efficienza da trasmettere ovunque, non solo in ambito professionale, e i sentimenti di solitudine e di vuoto che tuttavia caratterizzano in misura crescente la vita odierna, stanno creando una massa di individui fondamentalmente narcisisti, asociali. Il culto prioritario per la propria rappresentazione è in genere autoreferenziale, viene prevalentemente finalizzato a una socialità teatrale che simula la comunicazione, la rende possibile solo a livello di facciata.
L’individuo «ossessionato dalle apparenze … e dal giudizio che gli altri danno delle sue apparenze», osserva Bourdieu, si sente «tutt’uno con le apparenze … è sempre incline a una visione berkeleiana del mondo sociale, ridotto in tal modo a un teatro, nel quale l’essere è sempre e solo un essere percepito» [25]. Tale tendenza a rappresentare il personaggio scelto è del tutto evidente sul palcoscenico di particolari strade-passerelle delle grandi città e in occasione di particolari eventi. Questa attitudine di ebbrezza narcisistica, di iperattenzione per l’io corporeo avvertita sempre più come un imperativo categorico, viene oggi soddisfatta, in particolare dalle nuove generazioni, anche attraverso il selfie. L’immagine immessa in rete, attraverso la sua indifferenziata moltiplicazione, si trasforma però in un prodotto di consumo e la sua qualità tende a coincidere con la sua quantità.
Non sono più solo le femmine a scrutarsi in modo ipercritico nello specchio, in misura crescente i maschi considerano ormai la cura del proprio apparire come irrinunciabile nella competizione sociale e per l’affermazione della propria individualità. Tale scrupolosa e spesso ansiosa attenzione per l’aspetto esteriore, per il tocco seduttivo, una costante tipica del fenomeno abbigliamentare, nel tempo si è estesa alla presentazione delle merci. Queste in genere non vengono più acquistate ‘nude’, ben visibili nella loro materialità, bensì ‘vestite’ con contenitori i cui materiali, forme e colori mirano a sedurre i consumatori. La ‘confezione’ – l’abbigliamento e il packaging – la percezione esteticamente avvincente della persona e del prodotto è divenuta un fatto generalizzato, ha assunto un peso determinante nella comunicazione. In ambedue i casi l’involucro agisce sulle emozioni, sulla suggestione e mira essenzialmente a catturare l’interesse, il consenso e l’ammirazione, a sollecitare la desiderabilità di ciò che viene celato.
 Ernst Bloch, in un accenno a tale tematica, riferendosi alle varie modalità con cui l’essere umano cerca di rendere più attraente la propria figura, afferma che queste «aiutano per così dire il sogno di sé stessi a uscire dalla caverna». In tal modo tanto la donna quanto il suo corteggiatore si fanno costruzione artificiale per il desiderio dell’altro e cercano di vendere il loro lato migliore: «L’io si trasforma in merce». Nella logica del mercato capitalistico infatti, «chi si offre in vendita deve piacere», e «lo specchio non gli riflette nemmeno il modo in cui egli desidera sé stesso, bensì appunto come viene desiderato» [26]. L’attrattiva per l’altro, come la voglia di shopping, sono sempre più stimolate da questa operazione di mercato e conseguentemente da una surrogatoria valenza feticistica, dal «sex-appeal dell’inorganico» [27] che, nota Benjamin, «abbatte le barriere fra il mondo organico e quello inorganico» [28].
Ernst Bloch, in un accenno a tale tematica, riferendosi alle varie modalità con cui l’essere umano cerca di rendere più attraente la propria figura, afferma che queste «aiutano per così dire il sogno di sé stessi a uscire dalla caverna». In tal modo tanto la donna quanto il suo corteggiatore si fanno costruzione artificiale per il desiderio dell’altro e cercano di vendere il loro lato migliore: «L’io si trasforma in merce». Nella logica del mercato capitalistico infatti, «chi si offre in vendita deve piacere», e «lo specchio non gli riflette nemmeno il modo in cui egli desidera sé stesso, bensì appunto come viene desiderato» [26]. L’attrattiva per l’altro, come la voglia di shopping, sono sempre più stimolate da questa operazione di mercato e conseguentemente da una surrogatoria valenza feticistica, dal «sex-appeal dell’inorganico» [27] che, nota Benjamin, «abbatte le barriere fra il mondo organico e quello inorganico» [28].
La logica del marketing. propria della messinscena delle merci, in realtà sta contagiando mentalmente l’uomo moderno. Favorisce la riduzione del corpo a inanimato mannequin cui gli abiti vengono sovrapposti per essere esposti e il cui fascino è tutto nelle qualità effimere, nelle parvenze, nello spettacolo. Inoltre il gioco erotico delle vesti, simulando la sessualità, tende a sottrarla al suo fine naturale e risolverla in un gioco desessualizzato, puramente estetico. Si pensi alle testimonial di professione che incarnano l’eleganza esclusivamente a motivo del saper apparire, il cui corpo è solo forma e non sollecita più il desiderio. A tali giovani ragazze non viene richiesto nessun talento, nessuna specifica qualità individuale, a parte il bell’aspetto e l’essere in grado di avere una postura che faccia risaltare il vestito che indossano, di cui promuovono il marchio. La loro funzione è solo quella di richiamare l’attenzione dei consumatori, di essere locandine ambulanti, provvisorie, costantemente rimpiazzabili. La riduzione del corpo a oggetto di consumo implica di fatto il rischio che le stesse persone, come le merci, siano sottoposte al cannibalismo dell’usura comunicativa, dell’obsolescenza, vale a dire che in tempi sempre più brevi vengano sostituite da altre ‘apparenze’ più giovani e seducenti.
Si va dunque affermando una nuova concezione della bellezza che dipende sempre meno dalle qualità intrinseche della persona e sempre più dalle esigenze del marketing proprie della dinamica dei consumi. Tale perversione della performance costituisce la moderna forma di alienazione dell’essere umano, attesta un’innovazione del tutto sovversiva della moderna estetica, vale a dire la crescente emancipazione dei significanti dai significati. La ‘confezione’ viene sempre più considerata e vissuta come dimensione autonoma, svincolata dalla funzione di involucro di qualcosa di più importante: sempre meno le apparenze rivestono un contenuto, rimandano ad esso, e in misura crescente invece si spacciano esse stesse per contenuto.
La completa identificazione con la propria messinscena mutila però l’essere umano, lo riduce a una sola dimensione, a menzogna, e lo rende inaccessibile a sé stesso e anche agli altri. La realtà umana, la sua vitale unità psicosomatica, viene negata dalla rimozione della coscienza della simultanea e conflittuale presenza della maschera (l’io ideale) e della nudità (l’io reale). Solo tale consapevolezza nella recitazione del ruolo consentirebbe di non assumere le identificazioni per identità, la maschera come proprio elemento costitutivo, il ‘modus’ dell’apparire come l’essere.
Moda e arte
La moda della haute couture crea abiti e accessori estremamente preziosi, la cui raffinata ideazione ed esecuzione manuale di altissima qualità è simile a quella delle opere d’arte. Come queste, non sono caratterizzati dalla riproduzione tecnica, ma dall’unicità e irripetibilità. La convinzione dell’esistenza di un’affinità tra le creazioni artistiche e quelle della haute couture era già esplicita nelle parole con cui il primo creatore parigino di moda, fondatore della haute couture, Charles Frédérich Worth, definì il proprio lavoro: «Sono un grande artista, ho i colori di Delacroix e compongo. Une toilette vaut un tableau» [29].
I grandi sarti tuttavia, fino alla metà del XX secolo, per quanto creativi e capaci, si considerarono per lo più dei semplici artigiani e non osarono paragonarsi con il mondo dell’arte. La svolta si verificò agli inizi degli anni ’60 quando, con l’avvento delle Neo-avanguardie, a cominciare dalla Pop art, le creazioni sartoriali iniziano a seguire analoghe modalità di valorizzazione e perciò la firma dell’artista diviene pari alla griffe del capo di moda. In proposito Bourdieu scrive che, esattamente come la firma di un’artista su un oggetto, il label su un prodotto di moda lo carica di valore, determina «una metamorfosi quasi magica» che lo distingue nettamente e lo immette in una strategia simbolica di mercato. Così ad esempio, il capo d’abbigliamento e il profumo di uno stilista famoso, quantunque nella qualità e modalità di produzione siano del tutto identici ad altri beni di consumo simili, se portano il label si trasformano in prodotti di lusso, modificano il loro valore economico e simbolico. Egli definisce questo mutamento, tale «transfert di valore simbolico […] un caso particolare di alchimia sociale, un processo di transubstanziazione, che di certo lascia intatto il prodotto nella sua materialità, ma senza dubbio cambia radicalmente la sua qualità sociale» [30].
 Tanto le creazioni artigianali della haute couture, esclusive, elitarie, quanto i capi industrialmente prodotti in vari casi acquisiscono dignità storica e culturale una volta che, svincolati dalla funzione d’uso, sono esposti in un ambiente estraneo a quello originario, rispettivamente in musei di arte moderna e di cultura popolare. Sono proprio le istituzioni museali a celebrarne ufficialmente l’appartenenza al mondo della cultura artistica e materiale, ad assegnare loro una dimensione che le affranca dalla caducità, dalla temporalità, dalla obsolescenza propria dei beni di consumo. Grandi firme della haute couture collaborano con artisti famosi, interagiscono con l’ambito dell’arte contemporanea collezionando opere d’arte. Alcune, rivolgendosi ad archistar come Bernard Arnault, aprono spazi per mostre d’arte in cui espongono le loro creazioni e fanno sfilare le modelle. Musei d’arte di fama internazionale, quali il Victoria & Albert Museum di Londra, il Metropolitan Museum of Arts di New York, il Louvre a Parigi, gli Uffizi a Firenze, la Neue Nationalgalerie di Berlino, attribuiscono sempre più spazio alla moda. Ad esempio, cinque anni dopo la morte di Gianni Versace (1997), al Victoria & Albert Museum gli è stata allestita una grande mostra, dal significativo titolo ‘The art and craft of Gianni Versace’, per celebrare il pregio artistico delle sue creazioni. In questo museo, nel 2014 è stata organizzata una esposizione ‘The glamour of Italian fashion 1945-2014’, sullo stile italiano. Il MET di New York, nel 2013, ha dedicato una grande mostra al sovversivo movimento musicale ed estetico dei punk degli anni ’70.
Tanto le creazioni artigianali della haute couture, esclusive, elitarie, quanto i capi industrialmente prodotti in vari casi acquisiscono dignità storica e culturale una volta che, svincolati dalla funzione d’uso, sono esposti in un ambiente estraneo a quello originario, rispettivamente in musei di arte moderna e di cultura popolare. Sono proprio le istituzioni museali a celebrarne ufficialmente l’appartenenza al mondo della cultura artistica e materiale, ad assegnare loro una dimensione che le affranca dalla caducità, dalla temporalità, dalla obsolescenza propria dei beni di consumo. Grandi firme della haute couture collaborano con artisti famosi, interagiscono con l’ambito dell’arte contemporanea collezionando opere d’arte. Alcune, rivolgendosi ad archistar come Bernard Arnault, aprono spazi per mostre d’arte in cui espongono le loro creazioni e fanno sfilare le modelle. Musei d’arte di fama internazionale, quali il Victoria & Albert Museum di Londra, il Metropolitan Museum of Arts di New York, il Louvre a Parigi, gli Uffizi a Firenze, la Neue Nationalgalerie di Berlino, attribuiscono sempre più spazio alla moda. Ad esempio, cinque anni dopo la morte di Gianni Versace (1997), al Victoria & Albert Museum gli è stata allestita una grande mostra, dal significativo titolo ‘The art and craft of Gianni Versace’, per celebrare il pregio artistico delle sue creazioni. In questo museo, nel 2014 è stata organizzata una esposizione ‘The glamour of Italian fashion 1945-2014’, sullo stile italiano. Il MET di New York, nel 2013, ha dedicato una grande mostra al sovversivo movimento musicale ed estetico dei punk degli anni ’70.
La moda viene accolta dunque non solo come arte applicata, ma anche come autentica forma d’arte. Questo è pure il caso di Roberto Capucci che ha creato preziosi abiti definiti vere e proprie opere d’arte, architetture e sculture oniriche in tessuto, esposte nei più importanti musei e gallerie, e per manifestazioni artistiche di rilevanza internazionale come la Biennale d’arte di Venezia. Capucci è salito in cattedra, nella prestigiosa università di Oxford, per tenere una lezione sulla sua avventura nel mondo della moda. Le stesse vetrine elitarie della haute couture, le tradizionali sfilate, potrebbero diventare ottime opportunità di rivalutazione di tale fenomeno come parte integrante di una realtà culturale più complessa. Queste, oltre a favorire la comunicazione fra i sessi facendo quindi sfilare lei e lui sulla stessa passerella, dovrebbero coinvolgere il mondo musicale, letterario, le varie forme d’arte, valorizzare il contesto storico-architettonico delle città in cui vengono organizzate, diventare sempre più veri e stimolanti eventi artistici.
In realtà moda e arte tendono a contaminarsi. Da una parte la prima, vale a dire il mondo dell’effimero, aspira paradossalmente ad appropriarsi dell’immortalità propria dell’arte. Dall’altra quest’ultima tende oggi a trasformarsi in prodotto da consumare, rischia di perdere la libertà del suo essere ‘priva di scopo’ e, come la moda, viene sollecitata a rinnovarsi di continuo nell’intento di stupire e sedurre un pubblico sempre più vasto.
La moda celebra il cambiamento, diffonde l’idea di un’inarrestabile mutabilità del bello e conseguentemente spaccia di volta in volta l’ultima novità, non sempre il meglio, come la più bella. È per sua stessa natura deviante, infedele, trasgressiva e ciò la rende paradossalmente più seduttiva, ancor più di moda. Il suo carattere effimero e mutevole, precisa Simmel, permea uno spazio sempre più ampio, pure «le forme sociali, […] i giudizi estetici, tutto lo stile in cui l’essere umano si esprime» [31]. La moda interpreta efficacemente una «tendenza culturale» ben precisa, quella appunto della modernità, contraddistinta dal «progressivo indebolirsi delle convinzioni grandi, tenaci, incontestabili» [32]. Appunto perché partecipa inevitabilmente al divenire storico, è un indicatore dei processi socioculturali in atto, non si limita a rimodellare i corpi e non è perciò riducibile solo a criteri stilistici formali. In termini simili parla Benjamin: «L’interesse più vivo» che la filosofia dovrebbe nutrire nei confronti della moda, del suo «grande fascino», sta «nelle sue straordinarie anticipazioni» rispetto allo ’spirito del tempo’, nel fatto che essa non segue i mutamenti che avvengono nella società, ma li precede [33].
Si pensi al movimento hippy degli inizi anni ’60 che, sebbene inizialmente guardato con grande diffidenza, ispirò il mondo della moda, della musica, del cinema e della salute alimentare. I giovani che vi aderirono sognavano una cultura alternativa a quella ufficiale, esprimevano il rifiuto della guerra, il loro ideale di pace e di totale libertà indossando anche vestiti cuciti con stoffe semplici dalle forme inusuali e dai colori molto vivi, decorate con fiori, da cui il nome ‘figli dei fiori’. Designer attenti a captare le novità espressive di tale movimento di controcultura si appropriarono dei motivi abbigliamentari di questi giovani ribelli per creare, senza più alcun nesso con le motivazioni iniziali, capi entrati a far parte della moda ufficiale. Il movimento di contestazione giovanile del ’68 rappresentò poi una vera rivoluzione politica, sociale e culturale. Non i divi, ma i giovani contestatori divennero il riferimento per le generazioni adulte a loro più vicine per età. Proprio questo fenomeno di ammirazione ed esaltazione della giovinezza favorì un mutamento nello stile di vita e pure nel modo anticonformistico di abbigliarsi. La moda ufficiale recepì i nuovi codici vestimentari dei sessantottini e, mescolando classico e sportivo, si giovanilizzò nelle linee, nei colori, nelle stoffe, nelle fantasie inedite e negli accessori. Intaccò l’uniformità del vestito grigio maschile e favorì la diffusione della minigonna, l’inizio questa di una graduale ‘scoperta’ del corpo femminile.
La postmodernità, prosecuzione e superamento della modernità, secondo Jean-François Lyotard afferma un’idea di razionalità plurivoca e diversificata, e interpreta in senso positivo la frammentazione del mondo contemporaneo. L’instabilità, il carattere non vincolante, continuamente mutevole, vengono considerati aspetti intrinseci e costitutivi del reale da accogliere senza più alcuna nostalgia per l’unità perduta della ragione moderna. Non il consenso, ma il dissenso produce nuovo sapere e ci dà la possibilità di comprendere la società postmoderna. Non c’è alcuna verità, ma una molteplicità di linguaggi che nella vita di ogni giorno si intrecciano e si esprimono pure nelle pratiche culturali delle avanguardie. Il campo letterario, musicale, artistico, architettonico e soprattutto abbigliamentare sono infatti definiti da un nuovo sentire estetico, dalla frattura con l’ideale classico della bellezza intesa come armonia delle parti.
 Nell’epoca postmoderna le forme espressive della tradizione vengono decanonizzate, decostruite in geometrie instabili, in forme pure, disarticolate, dissonanti, asimmetriche, frammentate, ibridate. Queste segnalano visivamente la convivenza fantastica di razionale e irrazionale, di reale e irreale, di ordine e disordine, una cultura e un’estetica della permissività, del paradosso. L’assenza di certezze, il forte senso di precarietà hanno favorito la voglia di godere ciò che offre l’istante, il presente. In tale contesto stravaganza, trasgressione, dissacrazione, ambiguità androgina assumono un ruolo sempre maggiore nelle novità di tante mode giovanili. Queste si fanno beffa della tradizione, dei canoni estetici ed etici esistenti che parte delle nuove generazioni percepisce come estranei alla loro sensibilità, alla loro concezione della corporeità.
Nell’epoca postmoderna le forme espressive della tradizione vengono decanonizzate, decostruite in geometrie instabili, in forme pure, disarticolate, dissonanti, asimmetriche, frammentate, ibridate. Queste segnalano visivamente la convivenza fantastica di razionale e irrazionale, di reale e irreale, di ordine e disordine, una cultura e un’estetica della permissività, del paradosso. L’assenza di certezze, il forte senso di precarietà hanno favorito la voglia di godere ciò che offre l’istante, il presente. In tale contesto stravaganza, trasgressione, dissacrazione, ambiguità androgina assumono un ruolo sempre maggiore nelle novità di tante mode giovanili. Queste si fanno beffa della tradizione, dei canoni estetici ed etici esistenti che parte delle nuove generazioni percepisce come estranei alla loro sensibilità, alla loro concezione della corporeità.
Di fatto sono proprio le loro pulsioni che rendono i giovani i veri artefici delle nuove tendenze. Chi fa parte delle subculture giovanili, con la propria performance dissacrante di un corpo innovativamente abbigliato, non si chiede ‘che cosa’ sia bello sulla base di criteri valutativi di carattere culturale, filosofico, stilistico, commerciale. ‘Bello’ diviene ciò che in un determinato momento storico un gruppo riconosce come ‘significante’ per esprimere in modo provocatorio, giocando sull’imprevedibile e sugli eccessi, nuovi valori. Tale ‘significante’ agisce da collante per la coesione di gruppo proprio perché è il risultato di una condivisione emotiva. In realtà il modo di vestire, si pensi anche al mondo dello sport, favorisce spesso l’aggregazione, crea comunanze che legano, quello «spazio sociale» trasversale di cui parla Bourdieu, contraddistinto oggi da una certa mobilità, meno deterministico del concetto marxiano di classe e weberiano di ceto.
L’anticonformismo che nasce dal basso come fenomeno marginale può tuttavia trasformarsi in una nuova moda, in conformismo. Stilisti attenti a ciò che accade nella vita reale di ogni giorno, al nuovo che emerge dalla ‘cultura di strada’, traggono spesso ispirazione proprio dalle creative novità indumentari del mondo giovanile. Queste vengono accuratamente rielaborate e poi riproposte per il mercato della moda, svuotate però dell’originario significato trasgressivo. L’alto e il basso delle forme abbigliamentari di solito si alimentano reciprocamente e ciò fa sì che le fugaci innovazioni in tale ambito vengano irrorate dalla linfa vitale che sgorga dal radicamento in una realtà culturale e sociale sempre in divenire.
Umberto Eco, già negli anni ’60, sfidando i pregiudizi della ‘cultura alta’ considerava temi degni di studio da parte della semiotica, rivelatori di cambiamenti profondi, i fenomeni della vita quotidiana. Tra questi include esplicitamente l’abbigliamento. Al «linguaggio articolato» dei suoi codici vestimentari fluttuanti assegna un innegabile valore culturale al punto da affermare: «nessuno stupore che possa esistere una scienza della moda come comunicazione» [34]. Bourdieu, nelle pagine in cui tratta il rapporto tra moda e cultura, parla di «utilità scientifica dell’indagine scientifica di oggetti privi di dignità». Evidenzia, nonostante la reputazione di frivolezza, l’importanza che la tradizione sociologica attribuisce al tema «molto affascinante» della moda e la sua valenza filosofica. All’interrogativo che Mauss pone a conclusione del suo saggio sulla magia, se cioè il discorso etnologico riguardi prevalentemente i popoli lontani, in condizioni di vita primitive, e molto meno le nostre società, Bourdieu risponde concretamente con le sue analisi sulla haute couture. Queste mettono in luce l’«equivalente magico» nel moderno fenomeno della moda e lo riconoscono come tema culturalmente significativo [35]. Lipovetsky critica «il silenzio dell’intellighenzia» sulla moda, nonostante questo fenomeno abbia invaso nuovi campi, attragga l’interesse di tutti i ceti sociali e di tutte le età, e sia ormai un frequente tema dei media. Egli constata che la moda purtroppo «non è di moda tra gli intellettuali … non merita indagini problematiche; riguarda la superficie, dunque scoraggia l’approccio concettuale; suscita un riflesso critico prima che studi obiettivi» [36].
 Di un periodo storico complesso come l’attuale – particolarmente caratterizzato da mutamenti sempre più celeri ed epocali e da assenza di punti certi di riferimento – la moda è forse l’interprete più fedele. Ha assunto la funzione di sismografo socioculturale una volta assegnata all’arte. Registra le più fini e quasi impercettibili vibrazioni e le rappresenta visivamente prima che esse possano divenire trend. Benché il peso della moda sia divenuto gradualmente rilevante in ambito culturale, sociale ed economico, parte del mondo accademico guarda tuttora ad essa con diffidenza e a volte persino con arrogante disprezzo. Il riconoscimento di una dignità culturale e legittimazione scientifica di tale fenomeno favorirebbe invece una sua comprensione più profonda e rimuoverebbe il rischio di lasciarsi abbagliare solo dalla seduzione del suo spettacolo.
Di un periodo storico complesso come l’attuale – particolarmente caratterizzato da mutamenti sempre più celeri ed epocali e da assenza di punti certi di riferimento – la moda è forse l’interprete più fedele. Ha assunto la funzione di sismografo socioculturale una volta assegnata all’arte. Registra le più fini e quasi impercettibili vibrazioni e le rappresenta visivamente prima che esse possano divenire trend. Benché il peso della moda sia divenuto gradualmente rilevante in ambito culturale, sociale ed economico, parte del mondo accademico guarda tuttora ad essa con diffidenza e a volte persino con arrogante disprezzo. Il riconoscimento di una dignità culturale e legittimazione scientifica di tale fenomeno favorirebbe invece una sua comprensione più profonda e rimuoverebbe il rischio di lasciarsi abbagliare solo dalla seduzione del suo spettacolo.
L’amore per la superficie, la componente ludica, erotica ed estetica proprie della cura dell’aspetto esteriore dovrebbero infatti poter convivere con la dimensione più sotterranea dell’esistenza: l’apparire e l’essere sono lati della vita differenti ma non l’un l’altro estranei, sono antropologicamente complementari.
Dialoghi Mediterranei, n. 55, maggio 2022
Note
[1] G. Simmel, Filosofia del denaro (1900), a cura di A. Cavalli e L. Perucchi, UTET, Torino 1984: 88. I concetti esposti nel presente articolo sono per lo più ampiamente trattati dall’autore nei suoi scritti sul tema.
[2] Ivi: 87.
[3] G. Semper, Der Stil, I-II, Frankfurt a. M. 1860, München 1863, II: 487.
[4] G. Semper, Über Baustile (1869), ripubblicato in M. e H. Semper (a cura di), Kleine Schriften von Gottfried Semper, Spermann, Berlin & Stuttgart 1884: 404
[5] R.B. Cialdini, Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire sì (1984), tr. it. di G. Noferi, Giunti, Firenze 1989: 132-133.
[6] P.P. Pasolini, 7 gennaio 1973. Il “Discorso” dei capelli, in Id., Scritti corsari, pref. di A. Berardinelli, Garzanti, Milano 1990: 5-6.
[7] G. Semper, Über das Verhältnis der dekorativen Künste zur Architektur, in Kleine Schriften, cit.: 350.
[8] G. Semper, Der Stil, cit., I: 210. Sul tema, cfr. N. Squicciarino, Utilità e Bellezza. Formazione artistica ed arti applicate in Gottfried Semper, Armando, Roma 2009: 423-436 in particolare.
[9] W. Benjamin, I “passages” di Parigi (1927-40), in Opere complete di Walter Benjamin, I-IX, a cura di R. Tiedemann e H. Schweppenhäuser, ed. it. a cura di E. Ganni, Einaudi, Torino 2000: IX, 72.
[10] J. Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia (1860), tr. it. di D. Valbusa, intr. di E. Garin, Sansoni, Firenze 19806: 126.
[11] Ivi: 143.
[12] Ivi: 338.
[13] G. Lipovetsky, L’impero dell’effimero. La moda nelle società d’oggi (1987), tr. it. di S. Atzeni, Milano, Garzanti, 1989: 45-46.
[14] H. Spencer, Principi di sociologia (1879), I-II, a cura di F. Ferrarotti, Torino, UTET, 1967: I, 1048.
[15] Th. Veblen, La teoria della classe agiata (1899), tr. it. di F. Ferrarotti, Einaudi, Torino 1949: 84.
[16] G. Simmel, La moda (1895), a cura di D. Formaggio e L. Perucchi, Editori Riuniti, Roma 1985: 19.
[17] W. Sombart, Il capitalismo moderno (1902-1908), tr. it., parziale, di K. Pedretti Andermann, a cura di A. Cavalli, UTET, Torino 1967: 228.
[18] W. Sombart, Wirtschaft und Mode (1902), in S. Bovenschen (a cura di), Die Listen der Mode, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1986: 99.
[19] Ivi: 104.
[20] P. Bourdieu, Der Modeschöpfer und seine Marke. Beitrag zu einer Theorie der Magie (1975), tr. ted. di M. Tillmannin, in Id., Kunst und Kultur, 12.3, a cura di F. Schultheis e S. Egger, UVK Verlagsgesellschaft, München-Konstanz 2013: 580.
[21] R. Barthes, Sistema della Moda (1967), tr. it. di L. Lonzi, Einaudi, Torino 1970: XV-XVI.
[22] J. Baudrillard, La società dei consumi: i suoi miti e le sue strutture (1974), tr. it. di G. Gozzi e P. Stefani, il Mulino, Bologna, 1976: 49-50.
[23] G. Debord, La società dello spettacolo (1967), introduzione di C. Freccero e D. Strumia, Baldini & Castoldi, Milano 1977: 72.
[24] E. Morin, L’industria culturale. Saggio sulla cultura di massa (1962), tr. it. di G. Guglielmi, il Mulino, Bologna 1974: 72.
[25] P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto (1979), tr. it. di G. Viale, il Mulino, Bologna 1983: 256-257
[26] E. Bloch, Il principio speranza (1954-59), I-III, tr. it. di E. De Angelis e T. Cavallo, intr. di R. Bodei, Garzanti, Milano 1994: I, 397-398.
[27] W. Benjamin, I “passages” di Parigi, cit.: 84.
[28] Ivi: 74.
[29] M. Simon, Mode et Peinture. Le Second Empire et l’Impressionisme, postfazione di V. Westwood, Paris, Hazan, 1995: 128.
[30] P. Bourdieu, Der Modeschöpfer und seine Marke, cit.: 548-549; cfr.: 533.
[31] G. Simmel, La moda, cit.: 18.
[32] Ivi: 28-29.
[33] W. Benjamin, I “passages” di Parigi, cit.: 68.
[34] U. Eco, L’ abito parla il monaco, in AA.VV., Psicologia del vestire, Bompiani, Milano 1972: 14. Se ne fosse stato al corrente, Umberto Eco avrebbe senza alcun dubbio biasimato il boicottaggio, da parte della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, dell’innovativo Corso di Laurea ‘Cultura e Stilismo della Moda’. Questo mirava ad offrire un fondamento culturale e storicoartistico all’apprendimento pratico nei laboratori di design di moda. Sebbene fosse un corso promettente – aveva raggiunto circa 450 iscritti e avrebbe potuto aprire l’istituzione universitaria al mondo artigianale e imprenditoriale, alla moderna ‘società dell’immagine’ – è stato disattivato nel 2009 con l’ottusa giustificazione che «tale tipo di formazione non ha nulla a che fare con la tradizione culturale della Facoltà».
[35] P. Bourdieu, Haute Couture und Haute Culture (1974), in Id., Kunst und Kultur, cit.: 581-582.
[36] G. Lipovetsky, L’impero dell’effimero, cit.: 7.
_____________________________________________________________
Nicola Squicciarino, dopo la laurea in Filosofia, ha proseguito i suoi studi come borsista presso le Università di Basilea e di Tubinga. È stato docente all’Università di Firenze e, negli anni prima di andare in pensione, anche alla Luiss di Roma. Ha inizialmente pubblicato saggi di carattere prevalentemente filosofico, e poi monografie su Georg Simmel e Gottfried Semper. In un approccio interdisciplinare, ha scritto pure sull’abbigliamento e la moda come testimoniano i suoi ultimi due lavori: Significati dell’abbigliarsi. L’apparire non esclude l’essere (2017), e Arte tessile, abbigliamento e architettura in Gottfried Semper (2019).
______________________________________________________________














