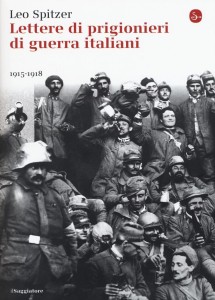Scritture in tumulto
Le mie ricerche sulle tradizioni popolari hanno spesso dovuto affrontare la questione delle scritture popolari come uno dei temi ricorrenti, ma non tanto per l’aspetto documentario – ovvio – di esse, bensì per la loro natura di ‘voci’ degli altri, espresse in un codice che di questi ‘altri’ non era proprio. Da sempre ho trovato nelle scritture popolari un aspetto espressivo, comunicativo ed estetico che si manifesta in modalità diverse da quelle della scrittura colta, letteraria, ufficiale, pubblica, professionale. E mentre è ovvio (almeno dopo gli studi di Leo Spitzer sulle lettere dei soldati italiani prigionieri durante la prima guerra mondiale: Lettere di prigionieri di guerra italiani, 1915-1918, edito nel 1921) che le scritture popolari documentano la storia dell’alfabetizzazione, i modi della coniugazione delle lingue nazionali e scolastiche con le forme d’uso corrente, non è mai stato altrettanto ovvio che le scritture popolari abbiano potenza espressiva, e quindi non debbano essere considerate ‘al di sotto della norma’, ma invece una modalità diversa e originale di una possibile e molteplice altra norma. Al massimo queste scritture sono state considerate ‘selvagge’, in un certo senso analoghe all’arte dei folli, documentata e curata nel museo Collection de l’art brut di Losanna. Scritture naif, zone di intersezione tra oralità e scrittura. Attribuzioni generiche e per lo più sbagliate. O almeno non in grado di rappresentare la gamma ampia di esse.
Nella seconda metà degli anni Novanta, tra convegni di Rovereto e iniziative dell’Archivio Diaristico di Pieve S. Stefano, ho cercato – quasi con furia – di dare risposta a questi problemi. In quel periodo mi resi conto della grande forza espressiva della soggettività individuale che si trova in queste scritture. Della potenza di connessione tra individualità e socialità. E cercai di proporre alcuni esempi paradigmatici: come nel caso di due scritture contigue, per territorio e per età, di due autori della provincia di Arezzo, un contadino e un carbonaio (Luigi Franci, Agostino Magni, in E qui a parlar conviene a cura di Dante Priore e Carlo Fabbri, Terranuova Bracciolini, AR, 1992). In quell’occasione tentai un nesso tra tipologie lavorative, filosofie della vita e stili. Il carbonaio, nella grande voglia di scrivere la sua fantastica vita con i pochi mezzi a sua disposizione, rompeva la tradizione scritturale con suggestioni magiche, tanto che nelle descrizioni che lui faceva del suo mestiere – basato sul fuoco – mi parve di vedere una analogia con D’Annunzio. Il contadino che, per mancanza di donne nella sua famiglia colonica, deve interpretare la parte della ‘massaia’, racconta con serenità e saggezza la sua storia di marginalità, che non esclude però qualche privilegio, mi aveva fatto cogliere delle attinenze con Fogazzaro. Quindi delle ‘poetiche’ più che delle letterature regionali di riferimento. Gli scrittori popolari scriveranno pure in modo ‘scontroso e aspro’, ma le loro opere non sono solo conati indecifrabili, accettabili per pietas, ma contengono ‘poetiche e stili’.
 In una lettera che inviai a Anna Iuso il 24 novembre 1997, in preparazione di un seminario a Pieve Santo Stefano, cercai di fare un bilancio dei temi della scrittura popolare nella storia dell’Italia unita. In un ampio saggio, che non ho mai pubblicato, cercai di riprendere questi nodi con due esempi. Il primo è affrontato dal testo con cui Tullio De Mauro commentò nel 1970 le Lettere da una tarantata, della antropologa Annabella Rossi, che con Ernesto De Martino aveva partecipato alla ricerca sul tarantismo in provincia di Lecce. L’altro è in evidenza nella presentazione che Natalia Ginzburg fece del memoriale di Egidio Mileo, Il salumificio, vincitore del premio Pieve 1992, in cui faceva riferimento a due grandi scrittori, Thomas Bernhard e Federigo Tozzi, proponendo analogie con Mileo.
In una lettera che inviai a Anna Iuso il 24 novembre 1997, in preparazione di un seminario a Pieve Santo Stefano, cercai di fare un bilancio dei temi della scrittura popolare nella storia dell’Italia unita. In un ampio saggio, che non ho mai pubblicato, cercai di riprendere questi nodi con due esempi. Il primo è affrontato dal testo con cui Tullio De Mauro commentò nel 1970 le Lettere da una tarantata, della antropologa Annabella Rossi, che con Ernesto De Martino aveva partecipato alla ricerca sul tarantismo in provincia di Lecce. L’altro è in evidenza nella presentazione che Natalia Ginzburg fece del memoriale di Egidio Mileo, Il salumificio, vincitore del premio Pieve 1992, in cui faceva riferimento a due grandi scrittori, Thomas Bernhard e Federigo Tozzi, proponendo analogie con Mileo.
 De Mauro suggerisce, anzi argomenta, che la scrittura di Anna Di Nardò, la tarantata che scrive ad Annabella Rossi, non è una modalità inferiore e scorretta della lingua italiana, ma una forma di italiano popolare dotata di una particolare ed esplicita forza espressiva. La sua dimostrazione è netta: volge in italiano corretto una lettera della tarantata e mostra così come il testo viene banalizzato, si attenua e perde la sua forza espressiva. Un’argomentazione magistralmente costruita. Quanto al contadino di Arezzo Luigi Franci, che ho citato più sopra, si tratta di un uomo con scarsa scolarizzazione, che costruisce una scrittura animata dalla volontà di trasmettere la propria storia, con una forza, adeguata al bisogno di prendere la parola, che fa impallidire le scritture ‘educate’. In quel mio saggio inedito, prima citato, avevo proposto un significativo sottotitolo: La scrittura popolare nella tradizione italiana; con una postilla sul perché si può preferire Luigi Franci a Susanna Tamaro.
De Mauro suggerisce, anzi argomenta, che la scrittura di Anna Di Nardò, la tarantata che scrive ad Annabella Rossi, non è una modalità inferiore e scorretta della lingua italiana, ma una forma di italiano popolare dotata di una particolare ed esplicita forza espressiva. La sua dimostrazione è netta: volge in italiano corretto una lettera della tarantata e mostra così come il testo viene banalizzato, si attenua e perde la sua forza espressiva. Un’argomentazione magistralmente costruita. Quanto al contadino di Arezzo Luigi Franci, che ho citato più sopra, si tratta di un uomo con scarsa scolarizzazione, che costruisce una scrittura animata dalla volontà di trasmettere la propria storia, con una forza, adeguata al bisogno di prendere la parola, che fa impallidire le scritture ‘educate’. In quel mio saggio inedito, prima citato, avevo proposto un significativo sottotitolo: La scrittura popolare nella tradizione italiana; con una postilla sul perché si può preferire Luigi Franci a Susanna Tamaro.
Per me un esempio significativo è – tra gli scrittori di successo – Susanna Tamaro col suo romanzo epistolare Va dove ti porta il cuore. Spesso ho detto polemicamente che i suoi scritti sembrano usciti dalla penna di una ragazza della terza liceo. Corretti e privi di energia espressiva.
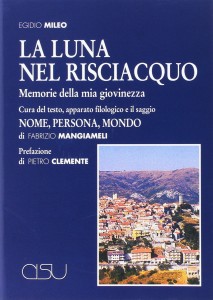 Il caso di Egidio Mileo è più complesso da argomentare. Anche perché Egidio, contadino e poi muratore lucano, imprenditore mancato, ha scritto più di un libro, sollecitato anche dalla attenzione che un gruppo di antropologi ebbe per le sue narrazioni (dopo Il salumificio edito da Giunti nel 1992, pubblicò La luna nel risciacquo, edito da CISU nel 2004, e Vivere e scrivere dalla Basilicata. Storie di andata e ritorno edito da Giannatelli nel 2017).
Il caso di Egidio Mileo è più complesso da argomentare. Anche perché Egidio, contadino e poi muratore lucano, imprenditore mancato, ha scritto più di un libro, sollecitato anche dalla attenzione che un gruppo di antropologi ebbe per le sue narrazioni (dopo Il salumificio edito da Giunti nel 1992, pubblicò La luna nel risciacquo, edito da CISU nel 2004, e Vivere e scrivere dalla Basilicata. Storie di andata e ritorno edito da Giannatelli nel 2017).
Natalia Ginzburg attribuiva a Mileo una forza espressiva simile a quella di Bernhard o di Tozzi, senza poi riconoscerne la natura di campo letterario ‘altro’. Anche lei in fondo viveva la contraddizione tra riconoscimento e negazione. Mileo non era affatto un semicolto che mescolava – come i più pigri lettori della scrittura popolare sostengono – oralità e scrittura. Mileo leggeva, anche se da uomo della strada, e meditava sulle esperienze. Aveva fatto dei corsi per corrispondenza, era stato telescriventista, e poi era lettore della Bibbia e di Manzoni. Cercava nei suoi scritti una forma, uno stile, mentre la sua ‘poetica’ era evidente a chiunque lo leggesse. Una narrazione lenta, ricca di intermezzi moraleggianti, ma ‘unica’ nel raccontare la sua vita di bambino e di adulto dentro un mondo locale. Nel narrare la storia di un individuo del Novecento che non è né operaio, né artista, né politico, un tipo di esperienza che non è né prevista né sintetizzata in nessuna opera di sociologia o di letteratura. Dicevo in quelle pagine che la unicità dell’opera di Mileo è anche la garanzia della ‘professionalità’ della sua scrittura; “professionale” e unica nell’esprimere il suo mondo, ad altri inaccessibile e inconoscibile senza le sue pagine. Dopo quegli anni non mi sono più occupato di questi temi. Ma ancora mi ci imbatto. A distanza ora cerco di avvantaggiarmi con una postura più riflessiva.
 Confini, margini, pensieri selvaggi
Confini, margini, pensieri selvaggi
Forse ci serve una riflessione sui confini tra i generi: epistolari e scritture narrative, memoriali e romanzi. Dove è la soglia? Una delle soglie sta nel tema proposto da Philippe Lejeune ne Il patto autobiografico e riguarda per l’appunto il patto stesso. Lo scrittore professionale colto usa certamente la sua vita, la sua esperienza, per costruire racconto, ma non racconta la sua vita. Gli scrittori popolari, gli autobiografi, scrittori della propria vita, invece chiedono al lettore di credere che quel che leggono è una vita vera, non tanto la verità che è un’altra cosa, ma la propria rappresentazione della vita vissuta.
In un mio scritto ho suggerito l’idea che la scrittura autobiografica si produca in una dialettica ‘tra dolore e pudore’. A Pieve tante volte ci si commuove per questo implicito patto, che talora interferisce anche nei giorni del Premio Saverio Tutino con un peso doloroso (il caso della donna che rinunciò al premio per paura del marito, l’imbarazzo dei parenti di una donna ricoverata nell’Ospedale Psichiatrico, della madre di una anoressica con una storia drammatica). Questo patto autobiografico apre a una maggiore condivisione tra autore e lettore, allo stupore e all’accoglienza morale. Per ciò che mi riguarda non ci sono romanzi che abbia letto nell’età matura che mi abbiano coinvolto come le storie lette a Pieve: Margherita Ianelli, Francesco Stefanile, e tanti altri, sono persone che ho incontrato, le cui storie, inconsuete, imprevedibili, mi hanno coinvolto profondamente. Può succedere anche leggendo della letteratura, ma avviene più fortemente con la scrittura popolare.
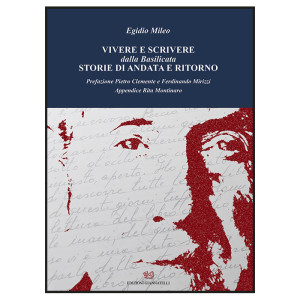 Ecco come ho descritto questo processo nel numero 1 della Rivista Primapersona, alla sua nascita: «Entrando in un oggetto culturale (la scrittura di un altro) che diventa soggetto, l’antropologo (ma anche il lettore) produce su di sé un movimento inverso, è spinto a confrontarsi, a riflettere su di sé e quindi a trasformare sé stesso da soggetto in oggetto vedendosi come ‘essere culturale’ al pari di quello sul quale indaga (o la cui storia legge)…» (P. Clemente, Facendo didattica in “Primapersona”, n.1, 1998). Sempre in quelle pagine avevo proposto di considerare gli autobiografi come «guide ermeneutiche dei loro mondi». Essi aiutano a capire e a immaginare la guerra, la malattia, il viaggio, l’amore, il dolore, dentro mondi reali, visti da dentro la loro vita.
Ecco come ho descritto questo processo nel numero 1 della Rivista Primapersona, alla sua nascita: «Entrando in un oggetto culturale (la scrittura di un altro) che diventa soggetto, l’antropologo (ma anche il lettore) produce su di sé un movimento inverso, è spinto a confrontarsi, a riflettere su di sé e quindi a trasformare sé stesso da soggetto in oggetto vedendosi come ‘essere culturale’ al pari di quello sul quale indaga (o la cui storia legge)…» (P. Clemente, Facendo didattica in “Primapersona”, n.1, 1998). Sempre in quelle pagine avevo proposto di considerare gli autobiografi come «guide ermeneutiche dei loro mondi». Essi aiutano a capire e a immaginare la guerra, la malattia, il viaggio, l’amore, il dolore, dentro mondi reali, visti da dentro la loro vita.
Inoltre le scritture autobiografiche della gente comune sono spesso scritture uniche nella vita degli autori. In questo si coglie il senso non tanto del non essere dei professionisti della scrittura, ma piuttosto quello di essere i protagonisti di un altro fenomeno sociale e creativo, che non appartiene al sistema letterario, anche se questo è il mondo in cui lo includiamo e il sistema di parametri con cui lo leggiamo. Quindi non penso che Vincenzo Rabito siciliano autore di Terra matta sia un caso eccezionale per cui lo si pubblica da Einaudi, mentre invece Giuseppe Anice trovatello piemontese autore de Il vaccaretto, che non viene pubblicato, è scarso o banale. Entrambi finalisti al Premio Pieve, questi testi sono scritture uniche della propria vita, fioriture che rappresentano mondi privi della parola, e che aprono, a modo loro, varchi di conoscenza e di poesia. Fioriture come quella dell’agave che avviene una sola volta, e dopo la pianta muore.
La rappresentatività umana, individuale e sociale contenuta in queste scritture è poderosa, incomparabile con la letteratura. Forse è un’altra letteratura. Penso che le scritture popolari non sono letteratura di serie B o C. Sono un altro mondo parallelo e distante con molti punti di intersezione ma anche molte differenze.
 In questa sfera di scrittura, segnata dal patto autobiografico, sono temi importanti e – a loro modo – straordinari quelli della morte, della memoria e della smemoratezza. George Semprun ha scritto la sua memoria dei campi di sterminio all’insegna di un titolo che colpisce: La scrittura o la vita (1994). A Pieve, guidati anche dalla sua riflessione, abbiamo visto tanti altri casi di storie ricostruite dopo la tragedia e il dolore che, solo dopo molti anni, hanno trovato la capacità di raccontare. Così Francesco Stefanile, in Davai Bistré. Diario di un fante in Russia, 1942-45, vincitore del Premio Pieve, scrisse decenni dopo la sua esperienza dei campi russi di prigionia, dal suo casello sull’autostrada, scrisse per i nipoti, perché non ci sia più la guerra, per lasciare una eredità in presenza della morte.
In questa sfera di scrittura, segnata dal patto autobiografico, sono temi importanti e – a loro modo – straordinari quelli della morte, della memoria e della smemoratezza. George Semprun ha scritto la sua memoria dei campi di sterminio all’insegna di un titolo che colpisce: La scrittura o la vita (1994). A Pieve, guidati anche dalla sua riflessione, abbiamo visto tanti altri casi di storie ricostruite dopo la tragedia e il dolore che, solo dopo molti anni, hanno trovato la capacità di raccontare. Così Francesco Stefanile, in Davai Bistré. Diario di un fante in Russia, 1942-45, vincitore del Premio Pieve, scrisse decenni dopo la sua esperienza dei campi russi di prigionia, dal suo casello sull’autostrada, scrisse per i nipoti, perché non ci sia più la guerra, per lasciare una eredità in presenza della morte.
Le scritture autobiografiche, diversamente da quelle letterarie, sono degli straordinari graffiti dell’unicità delle vite. Ce lo racconta, ragionando su altre questioni, Luca Rastello, un giornalista straordinario, autore di réportage dai luoghi difficili del mondo, che ha realizzato un libro scritto guardando in faccia la morte, uscito postumo, Dopodomani non ci sarà. Sull’esperienza delle cose ultime (Chiarelettere, 2018), che richiama anche a uno scritto di Jacques Derrida, Ogni volta unica la fine del mondo (2005).
Non c’è opera letteraria che ci porti così vicino alle ragioni della memoria, alla necessità di ricordare tante storie per sottrarsi alla storia fatta dal potere, alla dimenticanza delle vite degli ‘altri’, dei senza parola, della gente della vita ordinaria come queste scritture cui Pieve Santo Stefano dà asilo. Un autore come Rabito è rappresentativo di tutto un mondo di riferimento, negato alla scrittura e privo di voce. Si è sottratto al silenzio delle classi subalterne siciliane e ha lottato con tutta la forza per ‘essere nella storia’. Così facendo – lui come altri – ha aperto un cratere nella tradizione letteraria convenzionale, l’ha travolta con la lava scorretta delle sue interpunzioni, dei suoi ricordi, dei suoi sentimenti, della sua pre-moralità, dei suoi istinti, della sue esperienze. A nome anche di tanti altri. Non è scrittura naif o folle, è forza espressiva di una scrittura estrema, di un fenomeno che si costituisce nel secolo della masse e degli individui, forzando l’evidenza che a molti – anche in questo secolo – la parola pubblica non è consentita. Queste storie grammaticalmente e politicamente scorrette ‘sono state raccontate’, e con il loro ‘esserci nella storia’ hanno mostrato che le discipline della conoscenza debbono ascoltarle con umiltà e usarle come guide in mondi che altrimenti restano ignoti. Hanno mostrato anche che le vite degli esseri umani sono più varie e ricche di quanto si riesca ad immaginare in letteratura. Per la gran parte di queste scritture della vita vale quel che è stato scritto poeticamente per l’agave, ognuno cerchi le sue metafore (in Antonio Prete, Prosodia della natura, 1993):
«Un’agave immobile sul muretto di pietra, ferita: l’aridità come linfa della solitudine. Fiorire – d’un fiore alto, solenne – è per l’agave il sogno di una vita: l’attesa è ripagata dalla fierezza svettante dell’addio».
Dialoghi Mediterranei, n. 42, marzo 2020
____________________________________________________________________________
Pietro Clemente, già professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); membro della redazione di LARES, e della redazione di Antropologia Museale, collabora con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Tra le pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il patrimonio culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. Faldini, E. Pili, a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea (2011); Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013); Le culture popolari e l’impatto con le regioni, in M. Salvati, L. Sciolla, a cura di, “L’Italia e le sue regioni”, Istituto della Enciclopedia italiana (2014).
_______________________________________________________________