Gli arabi hanno senso dell’umorismo? A giudicare dall’immagine veicolata dai mass-media che li rappresenta ostili, arrabbiati con tutti, pronti a farsi saltare e far saltare in aria gli altri per la causa dell’Islam, si direbbe che non l’abbiano. Basta vedere ciò che è successo con Charlie Hebdo o con chi osa ridere o ironizzare sulla religione o sui sovrani e i governanti. Ma quest’immagine dell’arabo non corrisponde al vero e ce lo conferma una recente ricerca sull’umorismo presso gli arabi condotta da Angelo Villa e Paolo Branca che porta il titolo La vita è un cetriolo, alla scoperta dell’umorismo arabo, pubblicata da Ibis (2020).
Il libro è diviso in due parti. La prima che possiamo chiamare “teorica”, per non dire accademica a cura di Angelo Villa, si articola in cinque sezioni intitolate Dio sorride, Dio t’ascolta; O della leggerezza; Sull’automatismo; Il paradigma freudiano; L’imprevedibile, l’incollocabile. La seconda parte dal titolo Semantica dell’eufemismo e giochi oppositivi, scritta da Paolo Branca, alterna nei suoi vari sottotitoli presentazioni di contesti e situazioni seguite da una esemplificazione o scelta di vignette o barzellette tipiche di quel determinato contesto o situazione. In questa seconda parte Paolo Branca si rivela un profondo conoscitore del mondo arabo e della sua cultura ed esperto nel campo dell’umorismo arabo. Tant’è che, oltre ad essere docente di lingua e letteratura araba e di islamistica all’Università Cattolica di Milano, è autore di numerose pubblicazioni sul mondo arabo e sull’Islam e nello specifico sull’umorismo degli arabi in un libro dal titolo significativo Il sorriso della Mezzaluna con Barbara de Poli e Patrizia Zanella (Carocci, Roma 2011).
Parlando del riso non si può fare a meno di iniziare con la tragedia, in un gioco oppositivo che mette a confronto due strumenti di cui si serve l’uomo per sconfiggere l’impossibile, il destino che lo sovrasta e lo schiaccia, la minaccia che incombe e tenta di distruggerlo. L’eroe della tragedia, pur conscio della propria impotenza, lo affronta con una sovrumana determinatezza e muore in silenzio, lo scaltro “Joha” ne ride, lo ridicolizza, lo dissacra. Ecco alcune contrapposizioni che servono a illustrare le due metà della faccia umana, come la maschera teatrale che per metà ride e per metà piange:
«La tragedia rispetta l’ordine dei legami che reggono il mondo, anche quando li contesta. Il riso è spesso irriverente. (…) L’eroe tragico è pietrificato nel suo silenzio, il comico è qualcuno che non tace. (…) Il tragico fonda e rifonda la civile convivenza della città, il riso anela a una complicità occasionale, rapsodica e non obbligatoriamente etica. (…) Il tragico finisce per esaltare l’impossibile, il riso lo sminuisce. (…) La tragedia può argomentare più di un pensiero sino a promuovere una riflessione filosofica, il riso puo’ demolirla, rendendola ridicola» (Villa 2020: 16-17).
 La domanda iniziale se gli arabi abbiano senso dell’umorismo è ovviamente retorica e non ha bisogno di una risposta. Tutti i popoli, tutte le comunità e anche i singoli individui hanno il proprio senso dell’umorismo. Il gioco oppositivo non è tanto quello tra tragedia e commedia quanto tra pianto e riso, cioè tra due manifestazioni umane che coinvolgono sia la mente che il fisico: l’essere umano è continuamente oscillante tra pianto e riso, e talvolta nella medesima circostanza, “rido per non piangere” ha detto qualcuno. Un proverbio tunisino dice “troppe disgrazie portano al riso”. Il riso è una terapia contro il dolore provocato dalle disgrazie, è uno sfogo alla portata di tutti, ed è gratuito. Esprime la gioia di vivere e presenta il lato positivo delle cose, come nel detto egiziano citato da Paolo Branca “kull ta’khira fiha khira”, come a dire che non tutto il male vien per nuocere. Il riso relativizza il dramma, lo esorcizza e restaura l’ottimismo. Non a caso anche nelle circostanze più drammatiche, come la morte di qualcuno, scappa quasi sempre una risata, come nella visita del consolo nei Malavoglia di Giovanni Verga «Né visita di morto senza riso, né sposalizio senza pianto».
La domanda iniziale se gli arabi abbiano senso dell’umorismo è ovviamente retorica e non ha bisogno di una risposta. Tutti i popoli, tutte le comunità e anche i singoli individui hanno il proprio senso dell’umorismo. Il gioco oppositivo non è tanto quello tra tragedia e commedia quanto tra pianto e riso, cioè tra due manifestazioni umane che coinvolgono sia la mente che il fisico: l’essere umano è continuamente oscillante tra pianto e riso, e talvolta nella medesima circostanza, “rido per non piangere” ha detto qualcuno. Un proverbio tunisino dice “troppe disgrazie portano al riso”. Il riso è una terapia contro il dolore provocato dalle disgrazie, è uno sfogo alla portata di tutti, ed è gratuito. Esprime la gioia di vivere e presenta il lato positivo delle cose, come nel detto egiziano citato da Paolo Branca “kull ta’khira fiha khira”, come a dire che non tutto il male vien per nuocere. Il riso relativizza il dramma, lo esorcizza e restaura l’ottimismo. Non a caso anche nelle circostanze più drammatiche, come la morte di qualcuno, scappa quasi sempre una risata, come nella visita del consolo nei Malavoglia di Giovanni Verga «Né visita di morto senza riso, né sposalizio senza pianto».
La gioia che c’è nel riso non è solo gioia della mente o allegria, è anche gioia del corpo: «Il riso è una gioia del corpo … un piacere che inventa un ponte tra la mente e il fisico… un piacere che parte dalla testa e coinvolge felicemente il corpo stesso». Ma che cosa provoca il riso? Si può ridere di tutto o ridere di qualcuno? E se questo ‘tutto’ ingloba anche la religione o simboli religiosi ritenuti sacri o tocca la politica in Paesi dove chi detiene il potere non permette che si prenda per oggetto di derisione o di scherno quelle figure sacre o i potenti che governano? È questa stessa domanda che Angelo Villa si pone nella parte che riguarda il riso e la religione intitolata Dio che sorride, Dio che ascolta.
«Come può risultare compatibile il riso con la religione in generale? E più nello specifico in una cultura, come quella araba, profondamente intessuta dal discorso religioso, e politicamente retta da regimi poco inclini a lasciare spazio di democrazia istituzionale? (…) qualcuno o più d’uno… può ben essere indotto a supporre che il riso e l’Islam siano tra loro incompatibili. Niente di più falso, ovviamente» (Villa 2020: 25-16).
L’argomento del riso nel suo rapporto con la religione e con le Sacre Scritture non è nuovo. Ci ricordiamo tutti del dibattito acceso tra Jorge e Guglielmo da Baskerville nel Nome della rosa sulla questione se Cristo abbia mai riso. In due episodi Umberto Eco mette sulla bocca dei suoi personaggi le sue idee sul riso e attraverso le opposte ragioni tocca la tematica del riso come tale, come reazione fisiologica davanti a spettacoli o immagini che inducono al riso, come davanti alle miniature di Adelmo, e come strumento di conoscenza e di interpretazione anche di testi ritenuti incompatibili con il riso. Nelle due figure di Jorge e di Guglielmo si rivela la perenne contrapposizione tra tolleranza e intolleranza, fanatismo e moderazione, apertura e chiusura mentale, che ha sempre caratterizzato il cammino umano e che tuttora divide il mondo arabo tra fanatici ostili a qualsiasi libertà d’espressione riguardo al Corano, al profeta e ai suoi compagni, e musulmani modernisti e moderati che vorrebbero riformare l’Islam per adattarlo alle esigenze dell’epoca contemporanea.
Ma le pagine del romanzo dedicate al riso e che sicuramente riprendono idee già sviluppate nelle trattazioni di filosofi dell’Antichità greca e romana e nelle Sacre Scritture, esaminano la questione del riso da varie angolazioni, da quella naturale a quella filosofica e religiosa. Si inizia col ribadire che il riso è “proprio dell’uomo”, o come dice Al Akkad nel suo libro su Joha, «l’uomo è un animale ridente allo stesso modo che diciamo che è un animale parlante» (Akkad 1957: 36). Il confronto tra i due personaggi nasce appunto dal ridere dei monaci nello scriptorium davanti alle immagini di «un mondo rovesciato rispetto a quello cui ci hanno abituati i nostri sensi» (Eco 1980: 84).
Noi non ridiamo della natura in sé o degli animali e delle cose come sono nella loro concretezza reale, ne ridiamo quando si presentano diversamente da come li conosciamo. Se ridiamo senza motivo, il riso sarà ridotto alla sua dimensione puramente fisiologica e meccanica, e quindi privo di senso. Secondo Bergson, «Gli atteggiamenti, i gesti e i movimenti del corpo umano sono ridicoli nell’esatta misura in cui tale corpo ci fa pensare a un semplice meccanismo» (Bergson 1990: 27). La meccanicità o ‘l’automatismo”, teorizzati dal filosofo francese, tolgono al riso la sua valenza sociale, perché «il riso partecipa di una dimensione sociale che gli è esclusiva, il riso è sempre un riso di gruppo, suppone una condivisione che è fatta di complicità, di comunanza di linguaggi». Non è quindi una semplice espressione gestuale, un movimento puramente corporale, è nello stesso tempo espressione di un corpo e di una mente o di una coscienza. Anche se ridiamo da soli lo facciamo perché affiora il ricordo di una barzelletta, o un’immagine vista prima, o un’espressione di qualcuno che ci riporta a quella di un’altra persona che aveva provocato la nostra ilarità. Quel ricordo rimosso, per dirla con le parole di Freud, genera il riso o il sorriso di cui altri non ne capiranno la ragione, e magari ci chiederanno perché ridiamo.
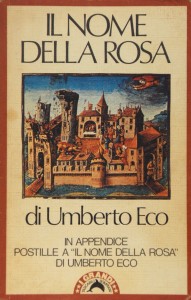 Per riprendere la questione del riso nel suo rapporto con la religione e sempre riferendomi a Eco ne Il nome della rosa, occorre andare alle pagine del secondo giorno – Terza, quando Jorge dice: «Gesù Nostro Signore non raccontò mai commedie né favole, ma solo limpide parabole che allegoricamente ci istruiscono su come guadagnarci il paradiso, e così sia». Al che poi risponde Guglielmo: «Mi chiedo… perché siate tanto contrario a pensare che Gesù abbia mai riso» (Eco 1980: 137). Seguono poi argomentazioni pro e contro il riso, appoggiandosi ognuno alle vicende dei santi del passato e come anche loro sono stati sorpresi a pronunciare risposte argute e a ridicolizzare anche i loro aguzzini con motti di spirito. Dice Guglielmo:
Per riprendere la questione del riso nel suo rapporto con la religione e sempre riferendomi a Eco ne Il nome della rosa, occorre andare alle pagine del secondo giorno – Terza, quando Jorge dice: «Gesù Nostro Signore non raccontò mai commedie né favole, ma solo limpide parabole che allegoricamente ci istruiscono su come guadagnarci il paradiso, e così sia». Al che poi risponde Guglielmo: «Mi chiedo… perché siate tanto contrario a pensare che Gesù abbia mai riso» (Eco 1980: 137). Seguono poi argomentazioni pro e contro il riso, appoggiandosi ognuno alle vicende dei santi del passato e come anche loro sono stati sorpresi a pronunciare risposte argute e a ridicolizzare anche i loro aguzzini con motti di spirito. Dice Guglielmo:
«E allora vedete che talora, per minare la falsa autorità di una proposizione assurda che ripugna alla ragione, anche il riso può essere uno strumento giusto. Spesso il riso serve anche a confondere i malvagi e far rifulgere la loro stoltezza. Si racconta di San Mauro che i pagani lo posero nell’acqua bollente ed egli si lamentò che il bagno fosse troppo freddo; il governatore pagano mise stoltamente la mano nell’acqua per controllare, e si ustionò. Bella azione di quel santo martire che ridicolizzò i nemici della fede» (Eco 1980: 140).
E quando Jorge infastidito gli dice: «… Ma voi sapete che Cristo non rideva mai», il frate francescano gli risponde:
«Non ne sono sicuro. Quando invita i farisei a gettare la prima pietra, quando chiede di chi sia l’effige sulla moneta da pagare in tributo, quando gioca con le parole e dice “Tu es petrus”, io credo che egli dicesse cose argute, per confondere i peccatori, per sostenere l’animo dei suoi…Persino Dio quando dice a Gerusalemme “nudavi femora contra faciem tuam”, si esprime per arguzie, per confondere coloro che vuol punire» (ivi: 140)
Sotto il titolo Dio sorride, Dio t’ascolta, Angelo Villa affronta il riso nel suo rapporto con Dio, i profeti e i testi sacri. Parte da Abramo, capostipite delle tre religioni monoteiste, e narra l’episodio in cui Abramo si lamenta con Dio: «Ecco a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà il mio erede» (Gen. 15,3). E siccome la promessa del Divino non si realizza e gli anni avanzano, Abramo è costretto ad accoppiarsi con Agar, la schiava di Sara e da lei gli nasce un figlio, Ismaele, da cui discendono gli arabi. Alla venerabile età di novant’anni, Dio annuncia a Abramo che benedirà sua moglie e da lei avrà un figlio. La prima reazione di Abramo è quella di ridere ma celando il riso per non mancare di rispetto a Dio. «Abramo, dunque, ride. Ma anche Sara ha una reazione analoga all’annuncio divino (…) avvizzita come sono dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!» (Gen.18,11). Il riso, non celato, di Sara ha urtato Dio: «Perché Sara ha riso dicendo: Potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C’è forse qualcosa impossibile per il Signore? (Gen.18, 13-14) (…) Allora Sara negò: ‘Non ho riso!’ e Dio ribatte ‘Sì , hai proprio riso’» (Gen. 18,15).
Dal riso di Sara nasce Isacco, che significa “Dio sorride” e così Sara commenta la venuta al mondo di Isacco: «motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà, sorriderà di me» (Gen. 21,6). Ismaele e Isacco sono le due facce inseparabili di Dio poiché dalla sua volontà sono nati il figlio di Agar e quello di Sara.
«Il dio che t’ascolta è il confidente dell’umana sventura, il partner silenzioso delle sue angosce, in una parola, è il dio più vicino alla nostra fragilità (…) E’ il dio del dolore, quello che dovrebbe asciugare le nostre lacrime, quietare i nostri lamenti (…) Il dio che t’ascolta, il dio del dolore, è anche il dio che ride, il dio della gioia. Separare l’uno dall’altro vuol dire non solo scomporre, disarticolare l’enigma dell’alterità, ma anche i riflessi stessi della complessità propria alla realtà del vivere, alle sue contraddizioni, ai suoi risvolti. Il dio che t’ascolta è, anche, il dio che ride» (Villa 2020: 34-35).
La tradizione religiosa ha finito per dare il sopravvento al dio che t’ascolta, occultando quasi interamente il volto del dio che sorride. Ne è testimonianza più che evidente il fondamentalismo attuale che ci presenta il volto di un Dio implacabile, severo e addirittura terribile. Nonostante l’abbondanza nel Corano di aggettivi opposti, di un Dio benevolo, tollerante, che perdona e accetta il pentimento sincero, il fanatismo religioso per imporre la sua dittatura teocratica si affida all’immagine di un dio vendicativo simboleggiata dalla spada, “Seifeddin”, pronta a tagliare la testa di chi osa ridere della religione, di Dio e del suo Profeta.
Anche Abbes Mahmud al Akkad, nel suo libro sul riso presso gli arabi, intitolato Joha, Adhahek al Modhkek (Il ridente che fa ridere) pubblicato a Beirut nel 1957, inizia la sezione del riso nei Testi Sacri con la storia di Abramo e Sara, come viene narrata nel Corano. Viene poi la storia di Suleimen che si diceva capisse il linguaggio degli animali. Seguono poi varie storie dove il riso appare spesso come derisione e scherno nei confronti dei profeti, come nella sura El mutaffifin e nella sura ‘Ezzokhrof , dove è evocata la storia di Mosé quando si presentò al cospetto del faraone, e la sura ‘Ennejm’ dove si parla di Noé oggetto di scherno da parte dei suoi concittadini perché costruiva l’arca dove non c’era il mare, e in vari altri luoghi del testo sacro.
Akkad passa poi all’esame del riso nell’Antico Testamento, dal Cantico dei cantici al libro di Isaia e il Libro dei Proverbi, considerato da Akkad come il libro più ricco di allusioni al riso e allo scherno. Ma l’esempio di Sara e Abramo nel Genesi rimane il più significativo poiché Akkad ci ritorna con più insistenza, per poi citare anche Giobbe e tornare un’altra volta ai Cantici. Seguono infine gli esempi tratti dai Vangeli.
Akkad conclude dicendo che queste testimonianze prese dai Testi Sacri sono la migliore lezione sulla natura del riso in contesti così diversi e così lontani l’uno dall’altro nei tempi e nei luoghi, nei caratteri e nelle consuetudini, tale da insegnarci che l’uomo è sempre uomo in ogni tempo e luogo, e che il riso è una caratteristica umana presente in tutti gli uomini.
Devo dire che questo libro di Akkad è per molti versi somigliante al libro oggetto di questa recensione per impostazione e per contenuti. Anche Akkad parte dalla tragedia e la commedia, dai filosofi dell’Antichità greca come Platone, Aristotele, Democrito.. per giungere all’epoca moderna, per esporre tra l’altro le teorie di Spencer, l’automatismo di Bergson, le teorie freudiane. E, infine, racconta numerose barzellette e aneddoti, e si sofferma in particolar modo su Joha e Nasruddin che ritroviamo anche in questo libro di Angelo Villa e Paolo Branca.
Sono alquanto sorpreso di non trovare nessuna menzione del libro di Akkad, precedente di oltre mezzo secolo, né all’interno del testo né nella bibliografia essenziale. Al Akkad è una figura importante nel panorama della letteratura e della critica in Egitto nella prima metà del Novecento ed è stato probabilmente il primo a trattare il riso e l’umorismo presso gli arabi appoggiandosi alle teorie più moderne della sua epoca. La letteratura classica è peraltro ricca di trattazioni sul riso ma sempre alla maniera tradizionale tipica delle “Maqamet” di Badii Azzamen al Hamadhani e di Hariri, o i libri del Jahedh, “Al bukhalaa” (“gli Avari” citato in questo volume) e “al Baien uattabiin” o “Al Aghani” di Abil Faraj al Asfahani …mentre Akkad tratta la questione in una propettiva moderna che mette a confronto antichità e modernità, Occidente e Oriente arabo, quotidiano e sacro, tale da non passare inosservato per chi tratta un aspetto così specifico della cultura araba.
Nella seconda parte del libro scritta da Paolo Branca e intitolata Semantica dell’eufemismo e giochi oppositivi troviamo un’abbondante scelta di storielle, aneddoti, barzellette raggruppati per categorie di contesti. Nel primo gruppo di storielle sotto il titolo Arabi vs resto del mondo… ma anche vs se stessi, come scrive l’autore «prevale l’autoassoluzione o la consolazione di un sorriso amaro, in altre occasioni è invece una rabbia soffocata a esprimersi “contro le donne, il tempo e il governo” come dice una celebre canzone di de Andrè». Oltre a barzellette di vario argomento, uno spazio importante è riservato a quelle che prendono di mira l’abitante del paese confinante o della città vicina, in un atteggiamento da tifosi che denigrano l’altra squadra. Quelli che vengono scherniti qui sono quelli della città di Homs, in Siria, o quelli di Hama o al-Khalil, o ancora Hebron. Abbondano le barzellette su Homs: ne cito giusto tre brevi che mi sono piaciute: «Uno di Homs prende in mano uno specchio e dice pensieroso ‘Io questo l’ho già visto..’ Un amico gli toglie lo specchio dalle mani, guarda e conclude: ‘Ma certo, non vedi che sono io?»; Uno di Hebron vuole iscrivere il figlio a scuola e chiede la retta. ‘sono 3.000 al mese, più 500 per l’autobus’. ‘Ok, lo iscrivo solo al bus’», o ancora «Uno di Homs sta compilando un modulo. Quando arriva alla domanda ‘sesso?’ risponde: due volte alla settimana».
 Queste storielle sul vicino di casa, appartenente a un’altra parrocchia, o abitante di un villaggio limitrofo o una città diversa, sono presenti ovunque, a qualsiasi latitudine, perché ci piace prendere in giro l’altro per sfogare la nostra frustrazione affermando la nostra superiore intelligenza. Mi hanno riportato alla mente le pagine dei Mimi siciliani di Francesco Lanza dove gli abitanti dei paesini si prendono in giro reciprocamente e, se mi ricordo bene, in fondo al volume si trovano alcuni mimi arabi, probabilmente raccolti da Francesco Lanza durante il suo soggiorno in Libia.
Queste storielle sul vicino di casa, appartenente a un’altra parrocchia, o abitante di un villaggio limitrofo o una città diversa, sono presenti ovunque, a qualsiasi latitudine, perché ci piace prendere in giro l’altro per sfogare la nostra frustrazione affermando la nostra superiore intelligenza. Mi hanno riportato alla mente le pagine dei Mimi siciliani di Francesco Lanza dove gli abitanti dei paesini si prendono in giro reciprocamente e, se mi ricordo bene, in fondo al volume si trovano alcuni mimi arabi, probabilmente raccolti da Francesco Lanza durante il suo soggiorno in Libia.
Nella sezione intitolata Non solo coi fanti… in riferimento al motto citato da Angelo Villa nella prima parte Scherza con i fanti, ma lascia stare i santi, ci sono storie e barzellette che prendono di mira profeti come Gesù, Maometto, a dimostrazione che anche loro possiedono un certo umorismo e non sono immuni dal riso, come vorrebbero farci credere le autorità religiose. In tutte le religioni troviamo storielle che tendono a umanizzare figure di santi e mostrarli come individui che ridono e scherzano. La religione e la politica costituiscono due campi minati, e gli arabi devono procedere con cautela, per non dire con i piedi di “piombo”. E se in alcuni Paesi arabi, dopo la caduta delle dittature di Saddam, Assad, Ben Ali e Gheddafi, si parla liberamente dei politici e dei partiti, in altri l’ortodossia religiosa non consente simili libertà. Il “politicamente scorretto” ha perso terreno ma non è completamente vinto. Altre dittature si affacciano, sicuramente peggiori perché il politico e il religioso sono strettamente legati e inseparabili nella loro ideologia.
Il cosiddetto “islam politico” è una minaccia mortale per le libertà individuali, la libertà di culto e di espressione ed è incompatibile con l’idea di democrazia. Non è possibile scherzare sul profeta e sui suoi compagni e di conseguenza non si può ridere oggi di quelli che governano in nome della religione. Alla rivoluzione di Khomeini alla dittatura laica e mafiosa degli Shah, dei Ben Ali e dei Gheddafi, subentra la dittatura teocratica dove le “fatwe” di imam estremisti mettono a repentaglio la vita dei dissidenti politici e laici, considerati “kuffar” e quindi il loro sangue diventa il biglietto d’ingresso nel Paradiso ambìto da giovani esaltati, come è successo ultimamente in Francia con l’insegnante che ha osato mostrare ai suoi allievi una caricatura del profeta. Lo Stato teocratico non controlla solo il tuo pensiero politico, controlla la tua vita stessa: cosa mangi e cosa bevi, come ti vesti, la tua vita sessuale, le tue letture, le tue pratiche religiose, tutto.
Mi ricordo ai tempi di Burghiba di un maestro, il quale scherzando con i suoi colleghi disse ‘Ehi ragazzi, che succederà se Burghiba muore?’, il giorno dopo fu arrestato e cacciato in prigione. Ha perso il lavoro e il diritto di appartenere alla funzione pubblica. Oggi, questo pericolo non c’è più. In compenso, se prima si scherzava con la religione, oggi bisogna stare molto attenti. ‘I muri hanno orecchie’ come si diceva durante il fascismo. E non sono più gli agenti segreti o le spie che ti controllano, ma tutti quelli che ti stanno attorno e che si sono “convertiti”. Ti guardano quando si alzano per andare in moschea per vedere se sei con loro, controllano se fai il Ramadan, o se bevi birra o vino. Non ho mai visto in Tunisia tante donne e ragazze velate, tante moschee piene all’inverosimile, fino a invadere il marciapiede, tante persone semi analfabete riempirsi la bocca di discorsi religiosi e comportarsi come predicatori. Se non sei praticante non sei musulmano. Peggio ancora se parli di filosofia (occidentale), di sociologia, di antropologia.
Ciò non vuol dire che non esistono barzellette sugli imam e sulle pratiche religiose come dimostrano le storielle raccontate in questo libro: «Un fedele sta pregando e chiede: ‘Mio Dio, fa’ diventare il Ramadan come i mondiali di calcio. Uno ogni quattro anni e ogni volta in un paese diverso’». O quest’altra: «Un imam fa prediche tanto lunghe che alla fine i fedeli riescono a farlo sostituire. Il nuovo è invece molto conciso e viene assai lodato, ma per ingraziarsi ancor più l’uditorio afferma: ‘e non è tutto… venerdì prossimo: vacanza!».
 Non può mancare in un libro sul riso una maschera famosa in tutto il bacino mediterraneo e oltre, anche se talvolta prende nomi diversi: è Joha, o Giufà in Sicilia, Nasrudin in Turchia… è la figura dello stolto tanto furbo da fregare gli altri, o del pazzo che si rivela in fondo il più saggio. La letteratura su Joha o Giufà è infinita sia nel mondo arabo che in quello italiano, con storielle e barzellette che si ripetono con varianti per adattarle a varie epoche e luoghi. Inutile cercarne l’origine perché nascono dal carattere delle popolazioni che vivono intorno al Mediterraneo, i quali durante secoli si sono scambiati destini e esperienze di vita tale da far di loro un tutto omogeneo che la pensa in un certo modo e scherza alla stessa maniera.
Non può mancare in un libro sul riso una maschera famosa in tutto il bacino mediterraneo e oltre, anche se talvolta prende nomi diversi: è Joha, o Giufà in Sicilia, Nasrudin in Turchia… è la figura dello stolto tanto furbo da fregare gli altri, o del pazzo che si rivela in fondo il più saggio. La letteratura su Joha o Giufà è infinita sia nel mondo arabo che in quello italiano, con storielle e barzellette che si ripetono con varianti per adattarle a varie epoche e luoghi. Inutile cercarne l’origine perché nascono dal carattere delle popolazioni che vivono intorno al Mediterraneo, i quali durante secoli si sono scambiati destini e esperienze di vita tale da far di loro un tutto omogeneo che la pensa in un certo modo e scherza alla stessa maniera.
«Sono soprattutto l’indole e il carattere specialmente dei popoli dell’Europa meridionale e di quelli del Medio Oriente e del Nordafrica a rappresentare una sorta di continuum antropologico dai tratti sorprendentemente analoghi (…) Le barzellette, al pari dei proverbi, ingiustamente considerati generi ‘minori’di espressione, sono invece il distillato di lunghe esperienze e forniscono dettagli non secondari sulla cultura popolare diffusa e condivisa» (Branca 2020:75-76).
Akkad, nel citato volume Joha, conclude anch’esso il suo libro con le barzellette attribuite a Joha o a Nasruddin o ancora a Abul ghosn, alcune delle quali si ritrovano in questo libro con gli opportuni adattamenti a tempi, luoghi e costumi. Ve ne è una che ricorda la storia di Chichibio nel Decameron e altre simili a quelle raccontate da Paolo Branca, a conferma che le barzellette, i proverbi e le fiabe popolari circolano e non c’è modo sicuro di dire chi li ha inventati per primo. Ad ognuno il suo Joha e lo adatta di volta in volta alla propria realtà e condizione. Non ci è possibile qui dare esempi di tutte le varietà di storie, o illustrare tutte le casistiche. Il lettore le scoprirà da sé leggendo questo libro: ne ricaverà non solo un sicuro divertimento ma molte riflessioni circa la capacità dell’essere umano di ironizzare e di ridere degli altri e di se stesso.
Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020
Riferimenti bibliografici
Abbes Mahmud al Akkad, Joha, Adhahek al Modhkek , Al Maktaba al ‘Asria, Beirut, 1957.
Henri Bergson, Il riso. Saggio sul significato del comico, Feltrinelli, Milano, 1990.
Umberto Eco, Il nome della rosa, Bompiani, Milano, 1980.
Francesco Lanza, Mimi siciliani, Sellerio, Palermo, 1971
Angelo Villa, Paolo Branca, La vita è un cetriolo. Alla scoperta dell’umorismo arabo, Ibis, Como, 2020
___________________________________________________________________________
Ahmed Somai, italianista e traduttore tunisino. Co-autore dei tre primi manuali per l’insegnamento della lingua italiana in Tunisia (1995-1997). Autore di una Bibliografia italiana sulla Tunisia (ed. Finzi), ha curato per la collana “I Classici” i volumi: G. Verga, Vita dei campi; L. Capuana, Il marchese di Roccaverdina. Dalla metà degli anni ’80 è impegnato in una costante attività di traduzione in arabo di opere e autori italiani: I. Calvino, Fiabe italiane, vol.1, Finzi Ed. Tunisi, 1988; G. Bonaviri, Il sarto della stradalunga, Finzi, Tunisi, 1998; N. Ammaniti, Io non ho paura, Cenatra, Tunisi, 2008; di U. Eco ha tradotto in arabo i romanzi: Il nome della rosa (1991); L’isola del giorno prima (2000); Il cimitero di Praga (2014); Numero zero (2017) e i saggi Semiotica e filosofia del linguaggio (2005); Dire quasi la stessa cosa (2012). Co-traduttore e curatore dell’Antologia di Poeti Tunisini tradotti in italiano, Roma-Tunisi, 2018. Ha tradotto ultimamente per l’editore Madar al Islam, Beirut, 2019, La colonia saracena di Lucera di Pietro Egidi.
_______________________________________________________________









