di Paolo Cherchi
La biblioteca di Dante è mutevole più di quanto non lo sia quella di altri autori di cui si conservano documenti materiali, come, ad esempio, quella di Petrarca o di Bembo o anche di Manzoni o di Leopardi. Nel caso di questi ultimi la varietà è data dal numero di volumi che può crescere con il procedere delle ricerche; nel caso di Dante, invece, cambia la qualità dei libri che la compongono, anche se poi rimane sempre una biblioteca virtuale in quanto non abbiamo prova alcuna che sia mai esistita come tale; ed essa muta a seconda della ricostruzione che ne facciamo basandoci sulle sue letture, vere o supposte che siano.
Per i commentatori come Landino i libri che Dante studiava o semplicemente consultava erano i classici, mentre i lettori ottocenteschi accanto ai classici ponevano autori francescani e mistici, e solo a partire dal 1879 riempirono gli scaffali dei volumi di San Tommaso d’Aquino perché in quell’anno Leone XIII con l’enciclica Aeterni Patris proclamò l’Aquinate come il principe degli Scolastici. E a Tommaso s’accompagnano Aristotele, i suoi commentatori e i teologi della Scolastica.
 Nella biblioteca virtuale di Dante c’è però una scansia affatto particolare in cui vediamo pochissimi autori e un’idea fissa. Fu creata quasi esattamente cento anni fa e venne dedicata interamente all’escatologia musulmana, riempita da pochissimi autori. Fra questi si distingue il libro di Miguel Asín Palacios, Dante y la escatología musulmana, uscito a Madrid nel 1919. La risonanza di quest’opera fu immediata e destò vive polemiche, diverse da quelle normali in quanto prive di un vero dialogo perché le difficoltà linguistiche creavano una situazione asimmetrica che concedeva ampio spazio ai pregiudizi: pochi erano i conoscitori della cultura escatologica araba, e i pochi che godevano di questo vantaggio potevano proclamare tesi senza correre il rischio di essere contestati, e dall’altra parte molto più numerosi erano i patrioti che mal sopportavano l’idea che il genio di Dante fosse indebitato ad altri e soprattutto a altri ritenuti estranei alla tradizione culturale cristiana.
Nella biblioteca virtuale di Dante c’è però una scansia affatto particolare in cui vediamo pochissimi autori e un’idea fissa. Fu creata quasi esattamente cento anni fa e venne dedicata interamente all’escatologia musulmana, riempita da pochissimi autori. Fra questi si distingue il libro di Miguel Asín Palacios, Dante y la escatología musulmana, uscito a Madrid nel 1919. La risonanza di quest’opera fu immediata e destò vive polemiche, diverse da quelle normali in quanto prive di un vero dialogo perché le difficoltà linguistiche creavano una situazione asimmetrica che concedeva ampio spazio ai pregiudizi: pochi erano i conoscitori della cultura escatologica araba, e i pochi che godevano di questo vantaggio potevano proclamare tesi senza correre il rischio di essere contestati, e dall’altra parte molto più numerosi erano i patrioti che mal sopportavano l’idea che il genio di Dante fosse indebitato ad altri e soprattutto a altri ritenuti estranei alla tradizione culturale cristiana.
Credo che qualcosa di simile tenga vivo il dibattito ancora ai nostri giorni, ma con una variante: sono sempre pochi i dantisti capaci di leggere l’arabo, ma i patrioti d’una volta hanno rivisto le proprie “lealtà” e ora militano per difendere gli “altri”, per cui prendono per oro colato ciò che i loro specialisti dicono. Questa nuova situazione avrebbe dovuto chiudere il dibattito perché le due parti di una volta convengono ora nel sostenere l’influenza islamica sulla Commedia. Le cose, però, sono andate diversamente dal previsto perché i neofiti non apportano alcun dato veramente nuovo e si basano ancora su quelli presentati dai vecchi specialisti, convinti che una rilettura delle prove che essi adducevano sia sufficiente per dare loro ragione. Non è buona filologia, ma diventa una nuova forma di ortodossia, contro la quale la vecchia guardia ha risposto con l’indifferenza, e non perché accetti le tesi di fondo ma perché ha capito che la vera novità sta nel modo diverso di considerare “l’altro”, e ciò sposta completamente i termini della battaglia che non si fa più a colpi di filologia ma di un’ideologia che arma una sponda del Mediterraneo contro l’altra, entrambe con identità culturali non solo diverse ma in guerra fra di loro.
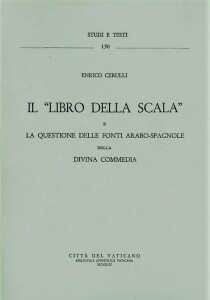 Per uscire dal generico, ricordiamo sommariamente alcuni dati storici della questione. Nel 1919 Asín Palacios pubblicò l’opera che abbiamo ricordato. Le adesioni e le repliche furono numerose e lo stesso Asín Palacios ne diede un ragguaglio puntuale in un volumetto Historia y crítica de una polémica uscito nel 1924. Nel 1949 Enrico Cerulli pubblicò Il libro della scala e la questione delle fonti arabo-spagnole della Divina Commedia (Città del Vaticano) importante per due ragioni: produceva due traduzioni di un testo arabo, sicuramente apocrifo, in cui Maometto narra della sua ascensione al Paradiso sotto la guida dall’arcangelo Gabriele. Una delle due traduzioni è in latino (Parigi, Bibliothèque Nationale) e l’altra in francese (Oxford, Bodleian Library). Esiste anche una traduzione dall’originale in castigliano fatta da un medico Abraham, noto per altre traduzioni dall’arabo. Quelle in latino e in francese sono entrambe dovute a Bonaventura di Siena, notaio e scrivano di Alfonso X di Castiglia. Il colophon della traduzione francese ha la data “maggio 1264”, un anno prima della nascita di Dante. Il contributo di Cerulli apportava nuova linfa alla documentazione fornita da Asín Palacios, e per giunta era accessibile in traduzione.
Per uscire dal generico, ricordiamo sommariamente alcuni dati storici della questione. Nel 1919 Asín Palacios pubblicò l’opera che abbiamo ricordato. Le adesioni e le repliche furono numerose e lo stesso Asín Palacios ne diede un ragguaglio puntuale in un volumetto Historia y crítica de una polémica uscito nel 1924. Nel 1949 Enrico Cerulli pubblicò Il libro della scala e la questione delle fonti arabo-spagnole della Divina Commedia (Città del Vaticano) importante per due ragioni: produceva due traduzioni di un testo arabo, sicuramente apocrifo, in cui Maometto narra della sua ascensione al Paradiso sotto la guida dall’arcangelo Gabriele. Una delle due traduzioni è in latino (Parigi, Bibliothèque Nationale) e l’altra in francese (Oxford, Bodleian Library). Esiste anche una traduzione dall’originale in castigliano fatta da un medico Abraham, noto per altre traduzioni dall’arabo. Quelle in latino e in francese sono entrambe dovute a Bonaventura di Siena, notaio e scrivano di Alfonso X di Castiglia. Il colophon della traduzione francese ha la data “maggio 1264”, un anno prima della nascita di Dante. Il contributo di Cerulli apportava nuova linfa alla documentazione fornita da Asín Palacios, e per giunta era accessibile in traduzione.
Dante conobbe quest’opera, che, a quanto pare ebbe una qualche circolazione visto che Fazio degli Uberti la menziona nel Dittamondo, che però è del 1360 ca., data piuttosto alta per sostenere la possibilità che Dante lo conoscesse. Comunque, la proposta di Cerulli di ridurre a quest’opera l’influsso islamico su Dante aveva una qualche plausibilità: era prima di tutto un’opera organica e linguisticamente accessibile. Cerulli tornò sul problema con Nuove ricerche sul Libro della Scala e la conoscenza dell’Islam in Occidente (Città del Vaticano, 1972). Si riaccese la polemica e questa volta vide calare in campo orientalisti quali Francesco Gabrieli il quale, fin dalla prima apparizione del libro di Cerulli, si disse persuaso che Dante conoscesse il Libro della Scala, che aveva il vantaggio di presentare in un testo unico tutto il materiale che la ricerca di Asín ricostruiva in forma frammentaria.
A confermare la presenza della fonte del Libro della Scala, intervenne Maria Corti che indicò un anello di trasmissione importante, e cioè Brunetto Latini che fu ambasciatore presso Alfonso il Saggio, e dalla Spagna avrebbe portato a Firenze le traduzioni di Bonaventura da Siena [1]. I conti tornavano ed era tutto chiaro: la tesi di Asín Palacios poteva considerarsi accettabile nella sua sostanza se non nella presentazione. Ma ecco che con gran boato riappare in traduzione italiana e le tesi originarie di questa polemica sono tornate alla ribalta. La casa editrice Pratiche di Parma ha pubblicato nel 1994 una traduzione in italiano dell’opera di Asín, e l’ha accompagnata con il volumetto dedicato alla “storia della polemica” dello stesso Asín, e il tutto con l’autorevole prefazione di Carlo Ossola [2].
L’opera ha avuto tanto successo di pubblico che il Saggiatore ha voluto riproporla nel 2005. Poco importava che il contributo filologico del libro fosse stato messo in discussione da autorevoli orientalisti, disposti in linea generale a vedere l’influenza islamica nella Commedia. Il libro di Asín Palacios era così ricco di materiali che offriva a tutti i ricercatori di fonti almeno un qualche lacerto per corroborare la tesi che Dante conosceva in modo “capillare” le tradizioni escatologiche islamiche. E poco importa se queste conoscenze vengono provate da rassomiglianze vaghe che in altre contesti non verrebbero mai considerate come “fonti”. Basti un solo esempio: il “lavaggio del cuore” di Maometto diventa la fonte del gesto di Maometto che si squarcia il petto nel canto 28 dell’Inferno. Ma se dettagli di questa qualità sono considerati come “fonti”, dobbiamo definire in modo nuovo cosa si debba intendere per fonte. Il fatto che il Libro della Scala abbia almeno una “struttura” generale abbastanza simile a quella del viaggio dantesco scandito nelle tappe successive di Inferno, Purgatorio e Paradiso, non costituisce una prova sufficiente per affermare che anche tutto ciò che accade in quel viaggio sia da considerare possibile fonte della Commedia.
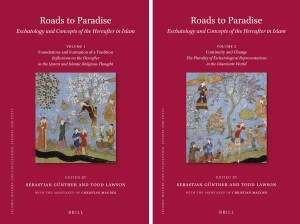 Comunque, nonostante queste considerazioni abbastanza normali in altri contesti, la traduzione del libro di Asín Palacios ha risvegliato il vecchio dibattito, ma con la differenza che oggi l’ambiente culturale è molto diverso da quello di un secolo fa. Oggi è in corso un revisionismo che pone su basi nuove il rapporto islamismo vs cristianesimo nel contesto della rivalutazione delle alterità culturali, delle rivendicazioni di priorità che nel mondo del pensiero e delle scienze spesso indicano il rapporto fra creatore e imitatore. È, tutto sommato, un discorso di politica culturale, anche se nessuno dichiara apertamente tale matrice perché screditerebbe almeno parzialmente le tesi proposte, che, nell’opinione dei propositori, hanno la forza dell’evidenza garantita dal rinvenimento di “fonti”.
Comunque, nonostante queste considerazioni abbastanza normali in altri contesti, la traduzione del libro di Asín Palacios ha risvegliato il vecchio dibattito, ma con la differenza che oggi l’ambiente culturale è molto diverso da quello di un secolo fa. Oggi è in corso un revisionismo che pone su basi nuove il rapporto islamismo vs cristianesimo nel contesto della rivalutazione delle alterità culturali, delle rivendicazioni di priorità che nel mondo del pensiero e delle scienze spesso indicano il rapporto fra creatore e imitatore. È, tutto sommato, un discorso di politica culturale, anche se nessuno dichiara apertamente tale matrice perché screditerebbe almeno parzialmente le tesi proposte, che, nell’opinione dei propositori, hanno la forza dell’evidenza garantita dal rinvenimento di “fonti”.
La rinascita dell’islamismo dantesco coincide con gli studi sul Mediterraneo che con il passare del tempo hanno perso il proposito squisitamente disciplinare storico che ad essi aveva impresso il loro fondatore, Fernand Braudel. Questa linea ideologica si è rafforzata dopo gli studi sull’orientalismo di Said, dopo i lavori sul post-colonialismo e dopo tutte le ricerche sul tema dell’alterità, e non sembra necessario aggiungere che “l’altro” per la cultura europea è per antonomasia l’emigrante delle sponde dalle coste nord-africane. Niente di male, ovviamente, nel fatto che la spinta ideologica abbia animato i nostri studi sui rapporti tra civiltà, visto che ciò sembra inevitabile e addirittura positivo non foss’altro perché stimola ad interrogarsi su dati acquisti e mai veramente sottoposti a ricerche specifiche, convinti di essere al centro di tutto. E aprendoci a tali ricerche scopriamo di non essere stati gli unici a porci al centro di tutto.
Scopriamo, infatti, che gli abitanti della sponda Nord del Mediterraneo non sono gli unici a manipolare i dati in funzione delle pressioni ideologiche, come ha dimostrato egregiamente Elisabetta Benigni [3] la quale, studiando il dibattito fra gli arabi sull’islamismo di Dante, ha visto che gli islamici hanno tradotto Dante e hanno sottolineato con ovvio eccesso quanto questi abbia ripreso, anzi espropriato, dal loro patrimonio culturale. Tutto questo forse è normale e fa anche sorridere per quella componente di patriottismo o di campanilismo che entra in queste rivendicazioni. Ma destano apprensione quando a queste tollerabili debolezze si aggiunge un elemento di colpa da parte cristiana per aver voluto ignorare i debiti verso una cultura perché ritenuta inferiore o addirittura inesistente. Ed è l’elemento nuovo che si è aggiunto recentemente agli studi comparativi che proprio per questo si colorano di ideologia, si tingono di un risentimento anticolonialista che punge gli occidentali con un senso di colpa e li rende propensi a compensare il mondo che avrebbero sfruttato riconoscendogli una priorità e superiorità culturale che rende ancora più grave la colpa dello sfruttamento coloniale.
Quest’ultima variante del virus ideologico non giova certo alla filologia, però tiene viva la polemica. Purtroppo in casi del genere la ricerca scientifica è fortemente condizionata dalle tesi che aspira a dimostrare, e anziché seguire il percorso normale in cui è la ricerca a produrre le tesi e non viceversa, usa la filologia per negare ciò che sostiene la parte opposta. Se una cosa si può imparare da questa polemica è che l’erudizione letteraria procede per cicli, e ripete ciò che ha prodotto dopo averlo scordato. Ricordiamo le vaste ricerche dei nostri maestri positivisti sulle origini orientali e in particolare arabe della novellistica medievale: dopo oltre un secolo di silenzio, il tema è tornato di moda negli ultimi decenni come se fosse assolutamente nuovo.
L’articolo della Benigni ci dimostra come “le influenze arabe” siano un tema che ci accompagna fin dai giorni di Giovanni Maria Barbieri e dagli eruditi del Settecento, e ogni tanto questa materia si “ricicla”. Il caso non è unico e infatti potremmo ricordare tanti altri episodi simili che confermano la regola. In ogni modo, per evitare che questa recente riscoperta dell’influenza araba su Dante eviti di propinarci materiali vecchi come se fossero nuovi, mi permetto avanzare alcune osservazioni che per lo meno possono smussare la spigolosità delle polemiche mostrando che esiste un altro modo di impostare il problema delle fonti arabe di Dante e della cultura medievale in generale.
 Per l’occasione ho ripreso in mano il libro di Asín Palacios che non avevo più riletto integralmente dopo che lo feci vari anni fa in cui mi capitò di tradurre uno studio davvero magistrale di Theodore Silverstein [4], purtroppo sfuggito a quanti si sono occupati del rapporto Dante/Islam. Silverstein aveva fatto negli anni ’30 un’edizione della Visio Pauli, un testo capitale nell’escatologia occidentale, ed era un conoscitore impareggiato di questa materia, e mise a frutto queste sua expertise in una lunga recensione in due puntate dell’edizione del Libro della Scala di Cerulli. In quell’occasione rivide tutta la questione, incluso il libro di Asín, e mostrò che molti degli episodi che Asín e Cerulli ritenevano di origine musulmana erano in realtà già presenti nella tradizione cristiana. Ora è vero che Asín non escludeva categoricamente che ciò potesse essere avvenuto, ma riteneva poi che il mondo musulmano avesse elaborato in modo nuovo questi materiali, che li avesse conservati e li riproponeva in confezioni affascinanti. Egli dice infatti:
Per l’occasione ho ripreso in mano il libro di Asín Palacios che non avevo più riletto integralmente dopo che lo feci vari anni fa in cui mi capitò di tradurre uno studio davvero magistrale di Theodore Silverstein [4], purtroppo sfuggito a quanti si sono occupati del rapporto Dante/Islam. Silverstein aveva fatto negli anni ’30 un’edizione della Visio Pauli, un testo capitale nell’escatologia occidentale, ed era un conoscitore impareggiato di questa materia, e mise a frutto queste sua expertise in una lunga recensione in due puntate dell’edizione del Libro della Scala di Cerulli. In quell’occasione rivide tutta la questione, incluso il libro di Asín, e mostrò che molti degli episodi che Asín e Cerulli ritenevano di origine musulmana erano in realtà già presenti nella tradizione cristiana. Ora è vero che Asín non escludeva categoricamente che ciò potesse essere avvenuto, ma riteneva poi che il mondo musulmano avesse elaborato in modo nuovo questi materiali, che li avesse conservati e li riproponeva in confezioni affascinanti. Egli dice infatti:
«La leggenda islamica del viaggio notturno e dell’ascensione di Maometto non è del tutto originale e indigena del popolo musulmano; a sua volta ha precedenti e modelli in altre civiltà e letterature religiose più antiche. [… ] Diremo dunque, senza affrontarlo direttamente, che nella sua genesi poterono confluire numerose narrazioni similari, probabilmente giudaiche, persiane e cristiane. [...] Nessuno di questi viaggi tuttavia ebbe nelle rispettive letterature uno sviluppo tanto pletorico di amplificazioni come la leggenda islamica che, venendo cronologicamente per ultima, poté utilizzarle tutte o comunque per la maggior parte e fondere in una sola azione di svariati episodi ed elementi che quelle offrivano con molti altri originali e nuovi, frutto spontaneo della fertile immaginazione del popolo musulmano» [5].
La tesi di Asín è seducente, ma produce una costante forma di frustrazione perché tutto ciò che poi avrebbe riscontro nella Commedia viene presentato come avente sempre qualcosa di approssimativo, qualcosa che “rassomiglia” ma che poi non è mai confermata da riscontri cogenti. C’è insomma un costante “press’a poco” che amoreggia con i precisi riscontri testuali o le precise prove filologiche, ma che poi le elude continuamente. Si ha l’impressione, insomma, che se Asín avesse potuto conoscere un’opera come La morfologia della fiaba di Vladimir Propp avrebbe scritto un libro più convincente perché avrebbe capito che le rassomiglianze fra i racconti di un certo tipo sono intrinseche alla natura del racconto di tali materie e non nascono da un rapporto diretto.
Per intenderci, Asín capitalizza quanto più può sul fatto che il Libro della Scala e la Commedia abbiano una struttura di un viaggio scandito sulle tre tappe ricordate, e che la discesa all’Inferno prima di salire al Paradiso sia unica del viaggio di Maometto. Ma se ricordiamo che nel Credo apostolico Cristo «descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos», troviamo che lo schema è addirittura paleocristiano. Lo stesso si può dire di tante altre situazioni. Ad esempio, se Asín avesse conosciuto Propp, probabilmente non avrebbe dato alcun peso all’episodio dell’impedimento del viaggio rappresentato da un diavolo che ha in mano un tizzone ardente: ogni fiaba di viaggio contiene un impedimento, e trattandosi di un ambiente infernale, è normale che ad impersonare l’ostacolo sia un diavolo e che il fuoco sia il più perentorio dei mezzi per bloccare il passo. O prendiamo il caso della donna bellissima che inganna il viator e che in realtà è una bruttissima e fetida donna. È la “femmina balba” la quale secondo Asín ha un antecedente islamico. Ma la bellezza femminina come simbolo di seduzione è presente ovunque nel mondo antico, a cominciare dalle sirene o da Melusina. E anche se prescindiamo da questo modello, troviamo che il disincanto prodotto dal fetore della carne di una donna è anche uno stratagemma medico che si trova ad esempio in un autore come Bernardo Gordonio nel suo Lilium medicinae (datato al 1303) di cui non è stata indicata alcuna fonte araba, anche se gli arabi ebbero una splendida tradizione di studi di medicina. Gordonio dice che per distogliere un innamorato dalla passione per una donna basta che un’accompagnatrice più anziana le tolga da sotto la gonna le bende della mestruazione e le metta sotto gli occhi dell’innamorato: tale vista produce il disinnamoramento e sfata la malia della bellezza che nasconde la lordura [6].
Se poi si rileva che la visione dell’aldilà avviene durante un sogno sia nel Libro della Scala come nella Commedia, si può ricordare che in tutte le culture l’oltrepassare il limite razionale per sconfinare nella visione accade secondo paradigmi antropologici, e cioè sempre nell’oscurità e nei sogni, entrambi simboli archetipici rispettivamente dell’ignoto e della previsione. E se si parla del motivo dell’ascesa comune nei due testi, gli unici mezzi che vengono alla mente o sono le ali o sono le scale: le scale della visione di Giobbe, del San Bernardo del Paradiso dantesco e quella di Maometto rispondono allo stesso principio perché hanno un’identica funzione.
Asín tende a vedere le rassomiglianze come “fonti”, e questa confusione torna a vantaggio di quanti credono che la Commedia debba moltissimo al testo arabo, ma diventa un impedimento serio per chi rilutta a credere in tale influenza. Per uscire dai discorsi generici, soffermiamoci su un caso in cui si rilevano immediatamente le differenze tra una “quasi-fonte” e una fonte che presenta similarità innegabili tra due elementi posti a confronto. È il caso di Bertran de Born [7], il trovatore che esaltò la guerra che si aggira nella valle dei seminatori di discordia tenendo in mano la propria testa mozzata che parla e narra del proprio peccato. Asín Palacios ne indica la fonte:
«L’assassinato quel giorno porterà il suo assassino, tenendo questi in mano, sospesa per i capelli, la propria testa che verserà sangue dalla vena giugulare, e dirà: “O Signore! Domandagli perché mi ha ucciso”» (op. cit.: 163).
 Certamente una scena del genere si imprime nella memoria e le similarità con l’episodio dantesco sembrano innegabili. Tuttavia sono anche ovvie alcune differenze sostanziali: la testa mozzata non è quella che parla (nella fonte islamica non è detto che la testa mozzata parli, e forse per questo la preghiera a Dio è ironica perché il mutilato non potrà neanche confessare il suo delitto). Eppure, nonostante questa differenza la tentazione di vedere tra i due testi un rapporto di dipendenza è più che plausibile. Ma che dire se troviamo il motivo di teste mozzate che parlano in data anteriore a quella del testo islamico? E in effetti queste non mancano, anzi abbondano. Senza dover ricordare la testa di Orfeo teste Virgilio (Geor., IV, 516-527), che, mozzata, continua a cantare, dobbiamo ricordare almeno il caso di San Dionigi, il patrono della Francia, il quale, dopo esser stato decapitato, prese la propria testa e la portò al luogo dove voleva essere sepolto (che poi è Montmartre, ossia il “monte dei martiri”), e mentre effettuava questa trasferta, la testa mozzata del santo pronunciava sermoni penitenziali.
Certamente una scena del genere si imprime nella memoria e le similarità con l’episodio dantesco sembrano innegabili. Tuttavia sono anche ovvie alcune differenze sostanziali: la testa mozzata non è quella che parla (nella fonte islamica non è detto che la testa mozzata parli, e forse per questo la preghiera a Dio è ironica perché il mutilato non potrà neanche confessare il suo delitto). Eppure, nonostante questa differenza la tentazione di vedere tra i due testi un rapporto di dipendenza è più che plausibile. Ma che dire se troviamo il motivo di teste mozzate che parlano in data anteriore a quella del testo islamico? E in effetti queste non mancano, anzi abbondano. Senza dover ricordare la testa di Orfeo teste Virgilio (Geor., IV, 516-527), che, mozzata, continua a cantare, dobbiamo ricordare almeno il caso di San Dionigi, il patrono della Francia, il quale, dopo esser stato decapitato, prese la propria testa e la portò al luogo dove voleva essere sepolto (che poi è Montmartre, ossia il “monte dei martiri”), e mentre effettuava questa trasferta, la testa mozzata del santo pronunciava sermoni penitenziali.
Il martirio di Saint Denis ebbe luogo nel terzo secolo, e la leggenda riferita si formò non molto dopo, visto che ne rimane testimonianza nella Historia Francorum di Gregorio da Tours (sec. VI) e nella Passio SS. Dionysii, Rustici et Eleutherii (sec. VII). Considerando i dati cronologici, e magari tenendo presente il principio del post hoc ergo propter hoc, non è pensabile che il testo islamico dipenda dalla leggenda cristiana? La domanda appena formulata si allarga a considerazioni più vaste. Il tema della testa mozzata che parla è uno dei più diffusi nella tradizione agiografica, ed ebbe una diffusione enorme nell’arte statuaria, costellata di santi che tengono in mano la propria testa recisa dalla daga del carnefice. Uno studioso ha stilato un catalogo di “cefalori” (e “cefaloria” è il termine tecnico con cui si designa il tema) che contiene ben 134 casi solo per la Francia [8] e tutti anteriori all’ottavo secolo quando gli arabi entrarono in Spagna. Questi dati ci lasciano immaginare quanti casi simili potremmo enumerare in Italia fino agli anni in cui fu composta la Commedia. Ci chiediamo allora: Dante trasse veramente ispirazione dalla tradizione islamica avendo in casa propria una tradizione così ricca di esempi? E non solo: considerando la priorità cristiana della leggenda, non è più normale pensare che sia stata la cultura araba a riceverla dai cristiani?
L’episodio di Bertran de Born è non solo uno dei più celebri della Commedia, ma è anche quello che porta l’autore a riflettere sul tipo di pena così orrenda tanto che in quell’occasione usa il termine tecnico di “contrappasso”, indicante il criterio “giuridico” che regola la natura delle punizioni infernali: «così s’osserva in me lo contrapasso» (Inf. 28, 141). È interessante il fatto che i commentatori più antichi di Dante non facciano caso alcuno all’anomalia di una testa mozzata che parla, e probabilmente la familiarità con il motivo dell’acefaloforia non stimolava alcuna riflessione. Sono stati i commentatori moderni – non più attenti alle teste dei santi mozzate o alle “teste parlanti” inventate da Alberto Magno o dal cavaliere catalano che ospita Don Chisciotte – ad accettare senza esitazioni la proposta di una fonte araba perché era l’unica in campo.
Una ricerca filologica che voglia essere libera da pregiudizi dovrebbe esitare prima di optare per una tesi o per l’altra. E se è vero che Dante poteva prendere lo spunto da un episodio come quello narrato nelle leggende arabe e trasformarlo in quello di Bertran de Born senza grandi difficoltà, ci pare che sia più vicino al vero chi pensa che l’autore della Commedia avrebbe scelto di usare un modello meglio noto ai suoi lettori perché avrebbe conseguito un risultato più comprensibile e più efficace. In effetti è molto più economico pensare che Dante avrebbe preferito basare la figura di un dannato sul modello di un santo perché la perversità del dannato ne sarebbe risultata con maggiore immediatezza. Diversamente dalla figura dell’assassinato presente nella versione araba, Bertran de Born è il responsabile del proprio male. La sua figura rovescia quella di un santo facendone quasi una parodia; e per questo egli ha il triste privilegio di pronunciare il nome della legge che regola le punizioni dell’Inferno.
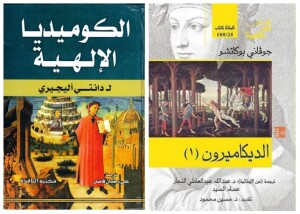 Non so quanti degli episodi riportati da Asín possano essere riconsiderati con un’ottica analoga a quella risultante dall’episodio di Bertran. Bisogna ricordare sempre che non tutte le somiglianze fra due testi letterari sono dovute ad un rapporto diretto di fonte/fruitore. È vero che le fonti presentano elementi simili in due testi, ma non è detto che tutte le somiglianze indichino la presenza di una fonte. Queste possono essere dei “luoghi comuni” o dei “topoi”, quindi senza alcuna paternità precisabile. Possono essere dovute al puro caso o anche alle limitate possibilità dell’immaginazione umana. Ricordiamo il caso riferito da Benedetto Croce [9], il quale in un romanzo di Annie Vivanti trovò l’episodio di un signore che passa la notte con un’amante e l’indomani scopre che questa ha la lebbra. Croce ricordò di aver letto un episodio analogo in un romanzo del Seicento che secoli dopo solo lui conosceva e che la Vivanti sicuramente ignorava: come spiegare allora una somiglianza così flagrante?
Non so quanti degli episodi riportati da Asín possano essere riconsiderati con un’ottica analoga a quella risultante dall’episodio di Bertran. Bisogna ricordare sempre che non tutte le somiglianze fra due testi letterari sono dovute ad un rapporto diretto di fonte/fruitore. È vero che le fonti presentano elementi simili in due testi, ma non è detto che tutte le somiglianze indichino la presenza di una fonte. Queste possono essere dei “luoghi comuni” o dei “topoi”, quindi senza alcuna paternità precisabile. Possono essere dovute al puro caso o anche alle limitate possibilità dell’immaginazione umana. Ricordiamo il caso riferito da Benedetto Croce [9], il quale in un romanzo di Annie Vivanti trovò l’episodio di un signore che passa la notte con un’amante e l’indomani scopre che questa ha la lebbra. Croce ricordò di aver letto un episodio analogo in un romanzo del Seicento che secoli dopo solo lui conosceva e che la Vivanti sicuramente ignorava: come spiegare allora una somiglianza così flagrante?
La risposta di Croce era carica di buon senso: l’immaginazione umana costruisce secondo patterns che producono indipendentemente situazioni analoghe in qualsiasi luogo e tempo. In sostanza è il principio della “poligenesi”, ben noto ai filologi e agli antropologi. Una fonte, intesa come un non dichiarato “prestito” o prelievo materiale da un testo per utilizzarlo in un altro, ha caratteristiche ben note ai filologi i quali, oltre alle coincidenze linguistiche e tematiche, cercano conferme nei rapporti fisici e storici e fra i due testi, proprio per evitare che delle coincidenze fra testi lontanissimi e presenti in aree estranee fra di esse vengano elevati al rango di fonte. Molte delle similarità riscontrate dagli arabisti nella Commedia non hanno quasi mai la cogenza che vorremmo vedere nei rapporti tra fonte e fruitore.
Nelle discussioni sulle fonti arabe di Dante si dimentica sempre che il Nord Africa era profondamente cristianizzato quando vi arrivarono gli arabi portandovi l’Islamismo, ed è verosimile che i nuovi arrivati assorbirono molti degli elementi del folklore legato alla tradizione cristiana. La costa mediterranea dell’Africa era la patria dei Tertulliano, dei Lattanzio, degli Agostino, dei Fulgenzio e di tantissimi altri illustri autori cristiani, ed è pensabile che il contesto culturale in cui vivevano contenesse tutte le credenze giudeo cristiane molto simili a quelle presenti nell’altra costa del Mediterraneo. Non era necessaria la presenza di un testo come quello della Scala di Maometto per spiegare le similarità fra le due culture.
La tradizione cristiana aveva fin dai suoi inizi una cultura escatologica alquanto ricca, e molti di questi elementi riappaiono nella cultura islamica perché ha anch’essa le sue radici nella tradizione della Bibbia. La letteratura giudaica non era certo priva di racconti di visioni, e i cristiani potevano offrirne una dose anch’essa piuttosto nutrita. Con l’invasione araba nel Nord Africa e in Spagna si venne formando un sincretismo culturale che forniva un fondo comune per le due culture, che convissero per secoli anche se poi si svilupparono in modo diverso e perfino ostile. Dibattere ancora oggi quanto una cultura debba all’altra o alle altre è un esercizio sempre utile per la storia delle idee, purché il dibattito venga impostato con il proposito di far luce e non di seminare discordie, altrimenti rischiamo di finire tutti nel cerchio infernale dove Dante mette i seminatori di scismi e di discordie.
Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023
Note
[1] Su tutti questi studi relativi alle più recenti prese di posizione orientano i contributi di V. Contarino, Dante and Islam: History and Analysis of a Controversy, in «Dante Studies», 125 (2007): 37-55; D. De Martino, Influenze islamiche sulla Commedia: una ricerca non conclusa, in F. Crevatin (a cura di), Sguardi sull’aldilà nelle culture antiche e moderne, Trieste, Università degli Studi di Trieste, 2015: 83-96; Attar Samar, An Islamic Paradiso in a Medieval Christian Poem? Dante Divine Comedy Revisited, in S. Günther & T. Lawson, (a cura di), Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam. II, Continuity and Change. The Plurality of Eschatological Representations in the Islamicate World Thought, Leiden – Boston, Brill, 2017: 891-920. Ma è fondamentale, anche per la difesa delle tesi di Asín, la postfazione di Carlo Saccone alla traduzione a cura di Roberto Rossi Testa de Il libro della scala di Maometto, Milano, Studio Editoriale, 1991, e poi Milano, Mondadori, 1999; dello stesso Carlo Saccone (a cura di), Sguardi su Dante da Oriente, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017.
[2] Miguel Asín Palacios, Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella Divina Commedia, traduzione di Roberto Rossi Testa e Younis Tawfik; Introduzione di Carlo Ossola, Torino, Pratiche, 1994, vol. I: 162 e sg. A questo volume viene unita come volume II la traduzione della Historia y crítica de una polémica, uscita indipendentemente nel 1924.
[3] Elisabetta Benigni, Dante and the Construction of a Mediterranean Literary Space, in «Philological Encounters», 2 (2017): 111-138.
[4] Dante and the Legend of the Miʿrāj: The Problem of Islamic Influence on the Christian Literature of the Otherworld, in «Journal of Near Eastern Studies» 11 (1952): 89-110. Il saggio si può leggere tradotto in italiano in Theodore Silverstein, Poeti e filosofi medievali, trad. di Paolo Cherchi e Antonio Illiano, Bari, Adriatica, 1975: 118-183, e poi ristampato in «Critica del Testo», 4 (2001): 569-636.
[5] Miguel Asín Palacios, Dante e l’Islam, cit.: 124 sg.
[6] Per quest’episodio si veda il mio Per la femmina balba (Purgatorio 19), in «Quaderni d’Italianistica», 6 (1985): 228-32.
[7] Mi sono occupato di questo episodio in La testa mozzata parlante di Bertran de Born (Inferno, 28). Problemi di fonti e di ermeneutica, in «Rivista Internazionale di Ricerche Dantesche», 1 (2020): 119-132.
[8] Émile Nourry, Les saints céphalophores. Étude de folklore hagiographique, in Revue de l’Histoire des Religions, 99 (1929): 158-231.
[9] Benedetto Croce, «Appunti di letteratura secentesca. Inedita e rara. “XVII. Riscontri curiosi”, in «La critica. Rivista di Storia e di Cultura», 29 (1931): 73-75.
_____________________________________________________________
Paolo Cherchi, “professor emeritus” della University of Chicago, dove ha insegnato letteratura italiana e spagnola e filologia romanza dal 1965 al 2003, anno in cui è stato chiamato dall’Università di Ferrara come Ordinario di letteratura italiana, e da dove è andato in congedo nel 2009. Si è laureato a Cagliari in filologia romanza, ha conseguito un PhD a Berkley (1966). Si è occupato prevalentemente di letterature romanze nel periodo medievale e rinascimentale. Fra i suoi lavori più recenti ricordiamo Il tramonto dell’onestade (Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016); Petrarca maestro. Linguaggio dei simboli e della storia (Roma, Viella, 2018); Maestri. Memorie e racconti di un apprendistato (Ravenna, Longo, 2019); Ignoranza ed erudizione. L’Italia dei dogmi verso l’Europa scettica e critica (1500-1750) (Padova, libreriauniversitaria.it.edizioni); Quantulacumque lucretiana. Nuove piste di ricerca sulla fortuna di Lucrezio nel tardo Rinascimento (Generis Publishing, 2022); Studi ispanici. Fonti, topoi, intertesti (Milano, Ledizioni, 2022). Nel 2016 è stato cooptato come socio straniero dall’Accademia dei Lincei.
______________________________________________________________








